
Il giovane Giovenale
Di Decimo Giunio Giovenale conosciamo poco. Laziale di Aquino, nasce tra il 50 e il 60. Amico di Marziale, sembra condividi con lui la condizione sociale. Lo stesso amico poeta lo annovera tra i clientes. Sembra abbia scritto le sue opere non più giovane, infatti alcuni riferimenti interni ci fanno pensare alla prima età del principato adottivo. Nessun riferimento nella sua opera ad avvenimenti seguenti il 127, data dopo la quale va certamente posta la sua morte.
Egli è l’ultimo rappresentante del genere satirico che aveva visto in Lucilio, Orazio e Persio degni antecedenti. Ma lui lo reinterpreterà alla luce della sua età, in cui non vi era certamente libertà di parola, accentuando la critica verso vizi generici che sono, dopo l’autore del periodo neroniano e gli epigrammi di Marziale, quasi diventati topoi letterari.

Manoscritto
Satire
Le satire di Giovenale sono sedici, divise in cinque libri:
- dalla I alla V
- VI
- dalla VII alla IX
- dalla X alla XII
- dalla XIII alla XVI
Non sappiamo se tale divisione sia originale o sia frutto di grammatici posteriori, che, nel VI secolo d.C. curarono il testo di Giovenale.
Al di là della divisione, non è possibile individuare un tema per ciascun libro. Ma è bene partire dalle motivazioni che lo hanno spinto a scrivere Satire:
Nella prima, dopo aver criticato i declamatores, giustifica il suo essere autore di satire:
E’ SEMPRE LA SOLITA SOLFA
(1, 1-14)
Semper ego auditor tantum? Numquamne reponam
vexatus totiens rauci Theseide Cordi?
Inpune ergo mihi recitaverit ille togatas,
hic elegos? Inpune diem consumpserit ingens
Telephus aut summi plena iam margine libri
scriptus et in tergo necdum finitus Orestes?
Nota magis nulli domus est sua quam mihi lucus
Martis et Aeoliis vicinum rupibus antrum
Vulcani; quid agant venti, quas torqueat umbras
Aeacus, unde alius furtivae devehat aurum
pelliculae, quantas iaculetur Monychus ornos,
Frontonis platani convolsaque marmora clamant
semper et adsiduo ruptae lectore columnae.
Expectes eadem a summo minimoque poëta.
Succube sarò sempre ad ascoltare? Mai replicherò / vessato tutto il tempo dalla Teseide del rauco Cordo? / Impunemente quello potrà recitare queste / togate e queste elegie? Impunemente avrà consumato il giorno / un Telefo che mai finisce e un non ancora concluso Oreste scritto fino / ai margini del ponderoso libro, anche sul retro? / A nessuno più è nota la sua casa che a me il bosco / di Marte e l’antro vicino alle rupi Eolie / di Vulcano; che cosa facciano i venti, quali ombre torturi / Eaco, da dove furtivamente un altro abbia strappato l’oro / del Vello, Monico che scaglia così tanti frassini, / i platani e marmi rovinati di Frontone urlano / sempre e le colonne rotte dall’assiduo lettore. / Aspetti le stesse cose da un grande o da un infimo poeta.

Altra immagine di Giovenale
Qui Giovenale, sembra riprendere un topos della poesia satirica, che risale sin da Orazio, il rifiuto della poesia alta; nel poeta augusteo tale rifiuto viene risolto con l’excusatio; lo stesso Persio nel suo Coliambo aveva parlato del rifiuto da parte sua di “abbeverarsi” alla fonte del Parnaso; qui è la sua inutilità, da un punto di vista morale, a venir sottolineata; in Giovenale invece a prevalere è l’indignatio, come ci dice nel verso 79: Si natura negat, facit indignatio versum (se manca la natura, l’indignazione fa la poesia)
E’ DIFFICILE NON SCRIVERE SATIRE
(1, 23 -30)
Cum tener uxorem ducat spado, Mevia Tuscum
figat aprum et nuda teneat venabula mamma,
patricios omnis opibus cum provocet unus
quo tondente gravis iuveni mihi barba sonabat,
cum pars Niliacae plebis, cum verna Canopi
Crispinus Tyrias umero revocante lacernas
ventilet aestivum digitis sudantibus aurum
nec sufferre queat maioris pondera gemmae,
difficile est saturam non scrivere.
Quando un languido eunuco prende moglie e Mevia a seno nudo impugna un ferro un per sventrare un cinghiale di Toscana, quando in lusso sfida tutti i patrizi uno che in gioventù col suo rasoio strappava lai alla mia barba dura, quando una canaglia del Nilo, sì Crispino, lo schiavo di Canopo, si drappeggia alle spalle un mantello di Tiro (di porpora) agitando al vento con le dita sudate un anellino estivo come se non potesse sopportare il peso di una gemma più vistosa è difficile non scrivere satire. (Mario Ramous)
L’indignatio di Giovenale nasce dall’esigenza di descrivere il reale così com’è, che a lui sembra permanere anche nel nuovo clima politico dell’impero di Traiano; ma il reale descritto da lui, punta soprattutto il dito verso “una” realtà, a suo parere la più sordida e “malsana”, più che sulla totalità della realtà: altrimenti non riusciremo a capire come, per Plinio il Giovane, tale realtà sia descritta in modo favorevole e positivo, “rinnovata” grazie al nuovo clima culturale basato sulla “libertas”. Ci si potrà soffermare sulle differenze sociali tra la nobilitas di Plinio e il cliens di Giovenale: ma se mai volessimo trovare in lui un difetto è che il suo essere “inferiore” viene additato come se la colpa fosse dei nuovi mores introdotti da tempo immemorabile. Per questo, tuttavia, per non esser colpito dagli strali di chi si sente colpito, rivolgerà lo sguardo nel passato, individuando in esso le “storture” del presente.
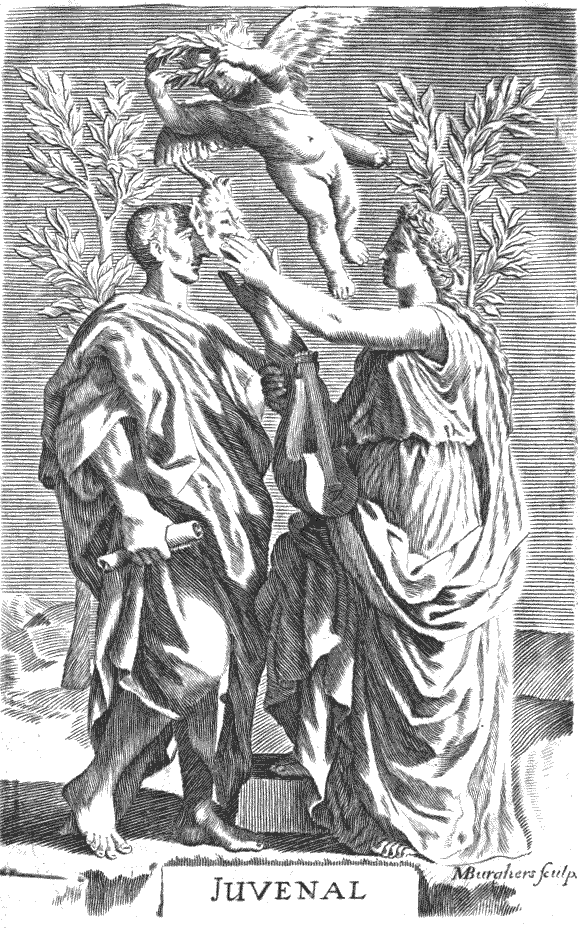
Giovenale riceve la maschera della poesia satirica e l’alloro poetico
La seconda satira si scaglia contro chi nasconde il vizio dietro un’apparente virtù, come per gli omosessuali. Più riuscita la terza nella quale, colta l’occasione del desiderio espresso dall’amico Umbricio di voler lasciare Roma, si lascia andare ad uno sfogo verso la città, ormai che di Romano ha nulla:
DOVE SONO FINITI I ROMANI?
(III, 60 – 72)
(…) Non possum ferre, Quiriti,
Graecam urbem. Quamvis, Achaei quota portio faecis?
Iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes
et linguam et mores et cum tibicine chordas
obliquas nec non gentilia tympana secum
vexit et ad circum iussas prostare puellas.
Ite, quibus grata est picta lupa barbara mitra.
Rusticus ille tuus sumit trechedipna, Quirite,
et ceromatico fert niceteria collo.
Hic alta Sicyone, ast hic Amydone relicta,
hic Andro, ille Samo, hic Trallibus aut Alabandis,
Esquilias dictumque petunt a vimine collem,
viscera magnarum domuum dominique futuri.
Non posso sopportare, o Quiriti, / una città greca. Sebbene, gli Achei quanta proporzione della feccia siano? / Ormai da tempo l’Oronte siro si getta nel Tevere / e ha trascinato la lingua, le abitudini, le corde oblique (dell’arpa) / con il flautista e i timpani gentili con sé / e le fanciulle costrette a prostituirsi vicino al circo. / Andate, (voi) ai quali è gradita la lupa (puttana) con un barbaro mantello dipinto. / Quel tuo figlio contadino indossa i sandali, o Quirita, / e porta distintivi di vittoria sul collo spalmato di cera. / Questo dall’alta Sicione, poi questo dall’abbandonata Amidone, / questo da Andro, quello da Samo, questo da Trallibo o Alabanda, / e si dirigono verso l’ Esquilino e il colle chiamato dal vimini, / viscere di grandi case e futuri padroni.

Roma, saeva urbs (satira III)
Anche in tale piccolo frammento di questa satira sembra che il malessere del poeta e della stessa città vada attribuito all’orientalizzazione avvenuta sin dai tempi degli Scipioni; tale impressione è rafforzata dalla lettura dell’intera satira che si può dire abbia una frattura all’interno di essa: dapprima la descrizione della città come sentina di vizi e malaffare determinato dalla presenza di questi graeculi, la cui presenza esaspera la ricchezza individuale e la presenza delle puttane da loro gestite; dall’altra elogio della campagna e dei piccoli piaceri, dove ancora resiste il mos maiorum; nella quarta satira il soggetto è fortemente sarcastico: si parla di un consilium principis convocato per decidere come preparare un rombo, e nell’ultima satira del I libro, l’accusa della differenza tra un ricco e povero nella scena di un banchetto in cui sono inserite ambedue le figure.
Come precedentemente detto il II libro è interamente occupato dalla VI satira (la più lunga della letteratura latina (661 versi): essa si presenta come una vera e propria requisitoria contro la figura femminile. L’occasione gli è fornita dal desiderio del suo amico Postumo di prender moglie. Ed è proprio all’interno dell’istituzione familiare che Giovenale osserva la sua donna: scappata la Pudicizia, le donne si sono lasciate andare ai piaceri tra i quali quelli sessuali (basti pensare a Messalina che non contenta dei piaceri coniugali, si rifugiava di notte nei bordelli a provare smisurati godimenti), quelli legati ai giochi del circo, al potere che esercitano sui mariti grazie alla loro dote, all’innamoramento verso la cultura e la lingua greca.
LA LETTERATA SACCENTE
(VI, 448 – 456)
Non habeat matrona, tibi quae iuncta recumbit,
dicendi genus, aut curvum sermone rotato
torqueat enthymema, nec historias sciat omnes,
sed quaedam ex libris et non intellegat. Odi
hanc ego quae repetit volvitque Palaemonis artem
servata semper lege et ratione loquendi
ignotosque mihi tenet antiquaria versus
nec curanda viris opicae castigat amicae
verba: soloecismum liceat fecisse marito.

Gli amanti di Messalina
Non abbia la matrona, che si sdraia a fianco a te, / la caratteristica della parola, o con linguaggio artificioso un tortuoso / entimema* rivolti, né conosca tutta la storia, / ma qualcosa, e non comprenda (tutto) dai libri. Io odio / quella che ripete e illustra l’arte di Palamone** / istruita (in essa) sempre dalla legge e secondo le regole del parlare / reciti versi antichissimi a me sconosciuti / e rimproveri ad una amica ignorante parole non da sottolineare / dagli uomini: sia lecito al marito aver fatto (qualche) errore.
*Entimema: sillogismo aristotelico che nasce da una affermazione errata; **grammatica
Anche qui torniamo an topos ben presente nella cultura latina: chi non ricorda con quale disprezzo Cicerone disegna Clodia, tra i cui difetti vi era anche la cultura? è certo questa una delle componenti che disturba il “maschio”, per cui la donna deve solo rispettare la casa e il marito. Ma torniamo al vecchio discorso: dov’erano le donne che sacrificavano se stesse per il bene della famiglia e della patria? Ci ritroviamo ancora una volta nella Roma Repubblicana, a dimostrare come le accuse di Giovenale, oltre ad essere anacronistiche, non sono affatto propositive. Il suo odio, infatti, sembra non sia dato dalla condizione storica, quanto da una pura e semplice misoginia. Questa satira si caratterizza anche per essere una “satira tragica”. Ci dice l’autore stesso che nel descrivere la depravazione femminile ha dovuto far riferimento spesso ai miti del passato: ciò può destare qualche perplessità, perché essi sono e vanno inseriti nel genere della tragedia, ma la differenza tra la sua e quella della tragedia sta nel fatto che la seconda si basa sul mito, lui sulla realtà. Ma forse è anche il caso di dire che nella tarda antichità comincia ad intravedersi qualche mescolamento di genere.
La VII satira, che apre il terzo libro, è complementare a tutte quelle dedicate alla povertà dei clientes, che condividono tali ristrettezze con avvocati, maestri, poeti, di contro all’avarizia dei potenti e agli stratosferici guadagni degli atleti.

Wenceslaus Hollar: Immagine per l’edizione inglese delle Satire di Giovenale
Da tale satira potremo quasi notare un piccolo cambiamento nell’opera di Giovenale, che tuttavia sembra muoversi tra satire in cui continua a stigmatizzare i comportamenti viziosi degli uomini, come l’VIII in cui si scaglia contro chi deturpa la memoria dei propri antenati con una vita dissoluta, sebbene appaia alla fine lo spiraglio di una virtù capace di attribuire la vera nobiltà; la IX in cui si parla di un cliens che si prostituisce al padrone; la XII contro cui si scaglia contro i cacciatori d’eredità e la XV in cui inveisce contro il cannibalismo (episodio avvenuto in Egitto); nelle altre sembra riprendere alcuni temi “più classici” che si possono richiamare alla satira diatribica, come quello della X in cui cerca di individuare il vero significato della preghiera verso gli dei, non certo quello dell’avarizia; o ancora quello del “giusto mezzo”, individuato nel mezzo di un povero pasto, capace tuttavia di soddisfare i convitati ma soprattutto la XIV dove invita i genitori ad aver rispetto verso i propri figli; egli analizza tale rapporto sotto la lente dell’avarizia.
Particolare la XIII, in cui si racconta della truffa subita da un suo amico che aveva prestato del denaro: la satira sembra una “consolatio” rovesciata, ma dove l’intento satirico si appunta sulla stupidità degli uomini e la XVI giunta talmente frammentaria da essere di difficile interpretazione (l’argomento è il privilegio di cui gode la casta militare).
Non si può terminare un discorso su Giovenale se non si ricordano alcune sue espressioni entrate, per così dire, nel linguaggio ordinario come massime; mens sana in corpore sano, panem et circenses, maxima debetur puero reverentia.