
Italo Svevo
Aaron Hector Schmitz nasce, quinto di otto figli, il 19 dicembre 1861 a Trieste da una famiglia di origine ebraica benestante, proveniente dalla Germania: il padre Franz Schmitz, commerciante di vetrami, la madre, italiana, Allegra Moravia.
Nel 1874, viene mandato dal padre a studiare, assieme ai due fratelli Adolfo ed Elio al collegio di Segnitz, in Baviera, dove studia il tedesco e altre materie utili per l’attività commerciale. Dopo quattro anni torna a Trieste e finisce il suo percorso di studi commerciali; ma è già da quando risiedeva in terra germanica, grazie soprattutto a Elio, che morirà a 22 anni, che coltiva un profondo interesse per la cultura letteraria e musicale, cercando d’impare a suonare il violino e leggendo prima i classici tedeschi e successivamente quelli italiani.

Trieste nel 1885
Nel 1880, dopo il fallimento dell’azienda paterna, inizia a lavorare presso la filiale cittadina della Banca Union di Vienna, impiego che, sebbene mai amato, manterrà per diciotto anni. Sono anni in cui maturerà l’amicizia con il pittore Umberto Veruda, mentre inizia una difficile relazione con Giuseppina Zergol: tale esperienza verrà poi descritta nel secondo romanzo. Nello stesso periodo ha inizio la collaborazione con L’Indipendente, giornale d’ispirazione socialista dove pubblica recensioni e saggi teatrali e letterari. Qui riesce anche a far pubblicare, rispettivamente nel 1888 e nel 1890, i suoi racconti Una lotta e L’assassinio di via Belpoggio, scritti in lingua italiana con lo pseudonimo di Ettore Samigli.

La prima pagina de L’indipendente di Trieste nel 1898
Nel 1892, anno in cui muore il padre, avviene la pubblicazione del primo romanzo Una vita, firmato con il definitivo pseudonimo Italo Svevo; l’opera viene sostanzialmente ignorata dalla critica e dal pubblico. Nel ’95 perde la madre e nel ’96 sposa la cugina Livia Veneziani, figlia di un commerciante di vernici per sottomarini cattolico, da cui ha una figlia, Letizia.

Svevo il giorno del suo matrimonio
E’ del 1898 il suo secondo romanzo, Senilità; anche quest’opera passa però quasi sotto silenzio. L’insuccesso letterario lo spinge quasi ad abbandonare del tutto la letteratura. Dimessosi dalla banca, nel 1899 Svevo entra nell’azienda del suocero, accantonando la sua attività letteraria, che diventa marginale e segreta. Costretto per lavoro a numerosi viaggi all’estero, dove si porta un violino senza riuscire a esercitarsi che raramente, ha tuttavia ancora qualche voglia di scrivere e si trova a comporre qualche pagina teatrale e alcune favole, che tuttavia non mostra pubblicamente. Per esigenze lavorative decide di frequentare un corso d’inglese alla Berlitz School di Trieste nel 1907: suo insegnante sarà lo scrittore irlandese James Joyce, che proprio in quegli anni frequentava la città austriaca. Dopo che Joyce ebbe modo di conoscere le due prime opere letterarie di Svevo (non amò particolarmente Una vita, ma rimase entusiasta di Senilità) lo incoraggiò a scrivere un nuovo romanzo. Data intorno al 1910, grazie al cognato, Bruno Veneziani, il suo viaggio a Vienna dove si reca per accompagnarlo per sottoporsi ad una terapia psicoanalitica: in questo modo Italo Svevo entra in contatto con le teorie di Sigmund Freud.

James Joyce
Allo scoppio della prima guerra mondiale, l’azienda nella quale lavora viene chiusa dalle autorità austriache. Durante tutta la durata della guerra lo scrittore rimane nella città natale, mantenendo la cittadinanza austriaca ma cercando di restare il più possibile neutrale di fronte al conflitto; in questo periodo approfondisce la conoscenza della letteratura inglese; e traduce, spinto da un nipote medico, La scienza dei sogni di Sigmund Freud.
Nel 1919 Svevo comincia a scrivere La coscienza di Zeno, poi pubblicato nel 1923, ancora senza successo, fino al 1925, quando lo invia a Joyce che lo propone ai critici italianisti francesi, Valéry Larbaud e Benjamin Crémieux, mentre in Italia Eugenio Montale, in anticipo su tutti, ne afferma la grandezza. Spinto dal successo internazionale comincia il suo quarto romanzo, Il vecchione o Le confessioni del vegliardo, una continuazione de La Coscienza di Zeno, che rimarrà incompiuto a causa della morte dello scrittore, avvenuta nel 1928 a seguito di un incidente stradale.
L’attività letteraria di Italo Svevo (pseudonimo che appare per la prima volta nell’intestazione del suo primo romanzo Una vita) è inserita in un clima per così dire periferico: Trieste è infatti una città di confine, non dell’Italia, ma dell’Impero Austroungarico, che fa della città il suo sbocco marino. Trieste, in quel periodo presenta un vero e proprio crogiolo di etnie e culture che possono essere così sintetizzate:
- Austriaca, etnia che rappresenta in quella città il potere politico ed amministrativo;
- Italiana, formata soprattutto da una borghesia imprenditoriale, fortemente influenzata dal nazionalismo e che costituirà una componente fondamentale dell’irredentismo;
- Ebraica, che si colloca trasversalmente, con una forte cultura identitaria, che detiene il potere finanziario;
- Slava, che costituisce il nerbo del proletariato cittadino.
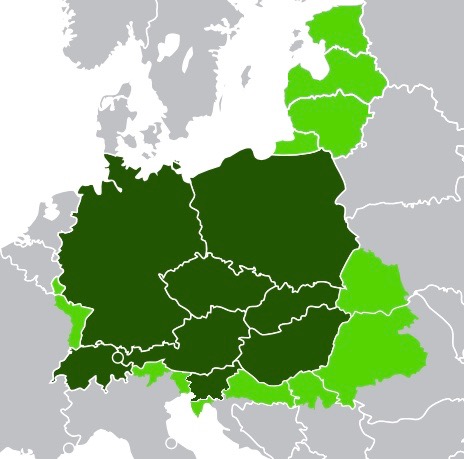
Cartina della Mitteleuropa (in verde scuro i confini politici, in chiaro i culturali)
Da quanto detto è evidente che la città si presenti come un centro la cui vocazione è fortemente cosmopolita, dove si accentrano gli influssi dell’intera cultura europea sebbene vi predominino la cultura tedesca e quella italiana. Trieste potrebbe a buon diritto dirsi uno dei centri di quella cultura mitteleuropea, che vive il suo momento a cavallo della dissoluzione dell’impero asburgico e possiede al suo interno esperienze che, pur differenziate per lingua e cultura, possono essere accomunate da una profonda sfiducia sull’uomo e sulla sua forza d’intervenire nella realtà (si ricordino Robert Musil e il suo Uomo senza qualità, Franz Kafka e il racconto La metamorfosi, Elias Canetti con Autodafé)
Anche Italo Svevo appartiene a buon diritto a questa élite intellettuale, il cui nome, scelto per la pubblicazione del romanzo, vuole appunto indicare la duplicità della sua cultura: italiana da una parte (Italo) e germanica in senso lato (Svevo).
Prima d’iniziare a conoscere l’attività letteraria, ci pare opportuno analizzare le basi culturali entro le quali il nostro sviluppò la sua idea di mondo:
- conosce, per questioni lavorative e culturali ben quattro lingue (oltre il dialetto triestino parlato in famiglia): tedesco, italiano, francese ed inglese. Ciò vuol dire che poté approcciarsi alla maggiore cultura europea in modo diretto, senza l’ausilio di traduzioni;
- la conoscenza e lo studio della filosofia di Arthur Schopenhauer: se per il filosofo tedesco a farci vivere è una sorta di forza vitalistica che ognuno di noi possiede, al di là della nostra volontà, veniamo di conseguenza privati della libertà; ciò dà vita a due tipologie umane: da una parte i “lottatori” (sani, per Svevo), che si gettano nella vita lasciandosi trascinare, in modo irrazionale, da tale forza vitalistica e quindi godendo dei suoi frutti senza chiedersi perché; dall’altra i contemplatori (malati, secondo Svevo), che, sottraendosi talvolta a tale flusso, possono guardarlo criticamente, ma ne deriva una sorta d’infelicità, di uno spostamento alla condizione d’inettitudine, e quindi non riuscendo a godere dei suoi frutti (vedremo poi come maturerà tale concetto nel suo maggiore romanzo);
- la conoscenza della teoria scientifica di Charles Darwin, con la quale raffronta il discorso della selezione naturale sugli animali (e quindi sullo stesso uomo) a quello dei gruppi sociali. Per Svevo non si tratta soltanto di cancellazione delle specie inferiori, ma anche di come esse, talvolta, possono ricrearsi per difendersi. Egli infatti mette sullo stesso piano il concetto schopenhaueriano del contemplatore con quello del debole, che tuttavia trova in sé le motivazioni per esistere;
- l’incontro, grazie al nipote, con la filosofia freudiana: egli non crede affatto al suo effetto terapeutico, ma la trova estremamente efficace per l’analisi degli uomini e quindi dei personaggi letterari (Grande uomo quel Freud, ma più per i romanzieri che per gli ammalati);
- il marxismo (sebbene in misura minore): egli, più che interessarsi alla soluzione rivoluzionaria per l’affermazione del proletariato, crede nell’ “alienazione” che la società capitalistica provoca nell’uomo, con tutte le conseguenze negative che ne derivano.
Vedremo più specificatamente come le componenti culturali entrino a far parte della sua produzione letteraria.

Statua che la città di Trieste ha dedicato all’autore
Come detto esordisce, nel 1892, con il romanzo Una vita:
Alfonso Nitti, giovane intellettuale con aspirazioni letterarie, lascia il paese natale, dove vive con la madre; si trasferisce a Trieste, in affitto presso la famiglia Lamberti, trovando un avvilente impiego come bancario. Come altri suoi colleghi viene invitato a casa del banchiere Maller, e qui conosce Macario, un giovane sicuro di sé con cui Alfonso fa amicizia, e Annetta, figlia di Maller, anch’ella interessata di letteratura, con la quale Alfonso inizia una relazione. Sul punto di sposarla però, fugge, così da poter cambiare vita, e torna al paese d’origine, dove la madre, già gravemente malata, muore. Alfonso torna quindi a Trieste, e decide di vivere una vita di contemplazione, lontano dalle passioni. Tuttavia, alla scoperta che Annetta si è fidanzata con Macario, Alfonso si sente ferito e cerca in tutti i modi di ritornare alla situazione precedente, ma non solo fallisce in questo proposito, bensì riesce persino ad aggravare ulteriormente la situazione. Quando, in seguito all’ennesimo equivoco con la famiglia Maller, si trova a dover sfidare a duello il fratello di Annetta, sceglie di suicidarsi e di porre così fine alla sua vita di disadattato.
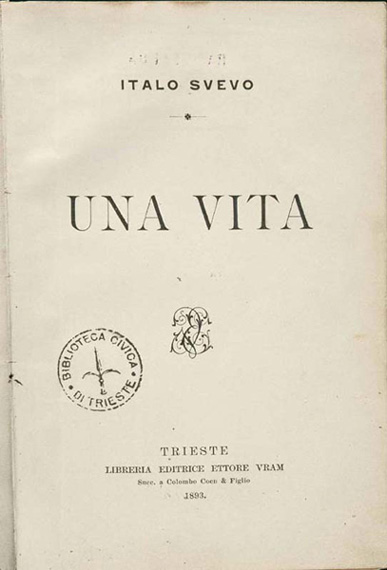
Edizione del 1893
Scritto nel 1888, ma pubblicato nel 1892, il romanzo racconta la vita di Alfonso Nitti, nel quale si possono leggere alcune caratteristiche dello stesso Svevo (prime fra tutte quelle di avere velleità letterarie). Influenzato dai naturalisti francesi Svevo vuole raccontare l’intera esistenza di un piccolo impiegato di provincia, come già aveva descritto, in parte, il nostro Emilio De Marchi, e sceglie come titolo Un inetto (in aptus, cioè inadatto), cambiato dall’editore in Una vita. La scelta definitiva del titolo ricalca quella di un romanzo di Guy De Maupassant e ciò, al di là della scelta dell’editore ci dice i rapporti che l’opera dello scrittore triestino aveva con la cultura naturalista.
Già in questo primo romanzo vediamo come l’elemento schopenhaueriano operi in modo palese nella struttura del racconto. Lo vediamo in questo passo:

Trieste: Riviera di Barcola
IL GABBIANO
La sua compagnia doveva piacere a Macario. La cercava di spesso; qualche sera gli usò anche la gentilezza di andarlo a prendere all’ufficio. Ad Alfonso non sfuggì la causa di quest’affetto improvviso. Lo doveva alla sua docilità e, pensò, anche alla sua piccolezza. Era tanto piccolo e insignificante, che accanto a lui Macario si trovava bene.
Non si compiacque meno di tale amicizia. Le cortesie, anche se comperate a caro prezzo, piacciono.
Non disistimava Macario. Per certe qualità ammirava quel giovine tanto elegante, artista inconscio, intelligente anche quando parlava di cose che non sapeva.
Macario possedeva un piccolo cutter e frequentemente invitò Alfonso a gite mattutine nel golfo. Nella sua vita triste, quelle gite furono per Alfonso vere feste. In barca gli era anche più facile di dare il suo assenso alle asserzioni di Macario e in gran parte non le udiva. Si trovava ancora sempre alla conquista della solida salute che gli occorreva, riteneva, per sopportare la dura vita di lavoro a cui faceva proponimento di sottoporsi, e gli effluvi marini dovevano aiutarlo a trovarla.
Una mattina soffiava un vento impetuoso e alla punta del molo, ove si trovavano per attendere la barca che doveva venirli a prendere, Alfonso propose a Macario di tralasciare per quella mattina la gita che gli sembrava pericolosa. Macario si mise a deriderlo e non ne volle sapere.
Il cutter si avvicinava. Piegato dalle vele bianche gonfiate dal vento, sembrava ad ogni istante di dover capovolgersi e di raddrizzarsi all’ultimo estremo sfuggendo al pericolo imminente. Alfonso da terra era colto da quei tremiti nervosi che si hanno al vedere delle persone in pericolo di cadere e fu solo per la paura delle ironie di Macario che non seppe lasciarlo partir solo.
Ferdinando, un facchino ch’era stato marinaio, dirigeva la barca. Lasciò il posto al timone a Macario il quale sedette dopo toltasi la giubba quasi per prepararsi a grandi fatiche: «Ora fuoco alla macchina,» gridò a Ferdinando.
Ferdinando scese a terra e trascinò il cutter per l’albero di prora da un angolo del molo all’altro; poi, un piede puntellato a terra, l’altro sul cutter, lo spinse al largo.
Alfonso lo guardò tremando; temeva di vederlo piombare in acqua e, per quanto piccolo, l’imminenza di un pericolo lo faceva sussultare.
«Che agile!» disse a Ferdinando.
Gli pareva d’essere in mano sua e aveva il desiderio quasi inconscio d’amicarselo. Ferdinando alzò il capo, giovanile ad onta del grigio nella barba e della calvizie abbastanza inoltrata, e ringraziò. Non essendo suo il mestiere, ci teneva molto ad apparire abile. Comprese però male lo scopo della raccomandazione. Trasse con forza a sé la vela e la fissò, aiutando poscia a tenderla con tutto il peso del suo corpo. Immediatamente il vento che pareva sorgesse allora la gonfiò e la barca si piegò con veemenza proprio dalla parte ove sedeva Alfonso.
S’era proposto di far mostra di grande sangue freddo, ma i propositi non bastarono all’improvviso spavento. Poté trattenersi dal gridare ma balzò in piedi e si gettò dall’altra parte sperando di raddrizzare la barca con il suo peso. Si tranquillò alquanto sentendosi più lontano dall’acqua e sedette afferrandosi con le mani alla banchina.
Macario lo guardò con un leggero sorriso. Si sentiva bene nella sua calma accanto ad Alfonso e per rendere più evidente il distacco tenne il cutter sotto la piena azione del vento. Alfonso vide il sorriso e volle prendere l’aspetto di persona calma. Segnalò a Macario all’orizzonte delle punte bianche di montagne di cui non si vedevano le basi.
Passando accanto al faro poté misurare la rapidità con la quale tagliavano l’acqua; diede un balzo sembrandogli che la barca andasse a sfracellarsi sui sassi che la contornavano.
«Sa nuotare?» gli chiese Macario con tranquillità. «Alla peggio ritorneremo a casa a nuoto. Ma», e finse grande preoccupazione «anche se si sentisse andare a fondo non si aggrappi a me perché saremmo perduti in due. Penseremo a lei io e Nando. Nevvero, Nando?
Ridendo sgangheratamente, costui lo promise.
Coi suoi modi da pensatore, Macario si dilungò in considerazioni sugli effetti della paura. Ogni dieci parole alzava la mano aristocratica, l’arrotondava e tutti i sottintesi che quel gesto segnava, cui nel vuoto della mano creava il posto, Alfonso lo sapeva, dovevano andare a colpire lui e la sua paura.
«Muore maggior numero di persone per paura che per coraggio. Per esempio in acqua, se vi cadono, muoiono tutti coloro che hanno l’abitudine di afferrarsi a tutto quello che loro è vicino», e fece una strizzatina d’occhio verso le mani di Alfonso che si chiudevano nervosamente sulla banchina. E passarono accanto al verde Sant’Andrea senza che Alfonso potesse padroneggiarsi. Guardava, ma non godeva.
La città, quando al ritorno la rivide, gli parve triste. Sentiva un grande malessere, una stanchezza come se molto tempo prima avesse fatto tanta via e che poi non lo si fosse lasciato riposare mai più. Doveva essere mal di mare e provocò l’ilarità di Macario dicendoglielo.
«Con questo mare!»
Infatti il mare sferzato dal vento di terra non aveva onde. Vi erano larghe strisce increspate, altre incavate, liscie liscie precisamente perché battute dal vento che sembrava averci tolto via la superficie. Nella diga c’era un romoreggiare allegro come quello prodotto da innumerevoli lavandaie che avessero mosso i loro panni in acqua corrente.
Alfonso era tanto pallido che Macario se ne impietosì e ordinò a Ferdinando di accorciare le vele.
Si era in porto, ma per giungere al punto di partenza si dovette passarci dinanzi due volte. Si udivano i piccoli gridi dei gabbiani. Macario per distrarlo volle che Alfonso osservasse il volo di quegli uccelli, così calmo e regolare come la salita su una via costruita, e quelle cadute rapide come di oggetti di piombo. Si vedevano solitarii, ognuno volando per proprio conto, le grandi ali bianche tese, il corpicciuolo sproporzionatamente piccolo coperto da piume leggiere.
«Fatti proprio per pescare e per mangiare», filosofeggiò Macario. «Quanto poco cervello occorre per pigliare pesce! Il corpo è piccolo. Che cosa sarà la testa e che cosa sarà poi il cervello? Quantità da negligersi! Quello ch’è la sventura del pesce che finisce in bocca del gabbiano sono quelle ali, quegli occhi, e lo stomaco, l’appetito formidabile per soddisfare il quale non è nulla quella caduta così dall’alto. Ma il cervello! Che cosa ci ha da fare il cervello col pigliar pesci? E lei che studia, che passa ore intere a tavolino a nutrire un essere inutile! Chi non ha le ali necessarie quando nasce non gli crescono mai più. Chi non sa per natura piombare a tempo debito sulla preda non lo imparerà giammai e inutilmente starà a guardare come fanno gli altri, non li saprà imitare. Si muore precisamente nello stato in cui si nasce, le mani organi per afferrare o anche inabili a tenere».
Alfonso fu impressionato da questo discorso. Si sentiva molto misero nell’agitazione che lo aveva colto per cosa di sì piccola importanza.
«Ed io ho le ali?» chiese abbozzando un sorriso.
«Per fare dei voli poetici sì!» rispose Macario, e arrotondò la mano quantunque nella sua frase non ci fosse alcun sottinteso che abbisognasse di quel cenno per venir compreso.
Nella scena vediamo i due personaggi, amici dall’indole contrapposta, attraverso i quali possiamo individuare le due tipologie schopenhaueriane già citate:
- Alfonso è il contemplatore, colui che guarda la vita dall’esterno, non riuscendo a partecipare ad essa. Non è solo la paura a frenarlo, quanto il rendersi conto di non saper “volare” (come gli dice Macario) e la paura che tale incapacità venga letta, capita, facendone un perdente, un inetto, appunto;
- Macario è il lottatore, non pensa agisce. Si mostra sempre padrone delle azioni che compie e la voluptas vivendi non riesce a frenarlo: egli è il gabbiano dalla testa piccola ma dal corpo grande, che risponde, senza chiederselo ai bisogni della vita.
E’ evidente che in una struttura così le coordinate ti tipo naturalistico vengano infrante: permane la narrazione in terza persona, la descrizione degli ambienti, l’analisi sociale, ma a dominare è l’approfondimento psicologico del comportamento di Alfonso, che appare un inetto (oggi potremo dire un disadattato) più per scelta che determinato da circostanze esterne.
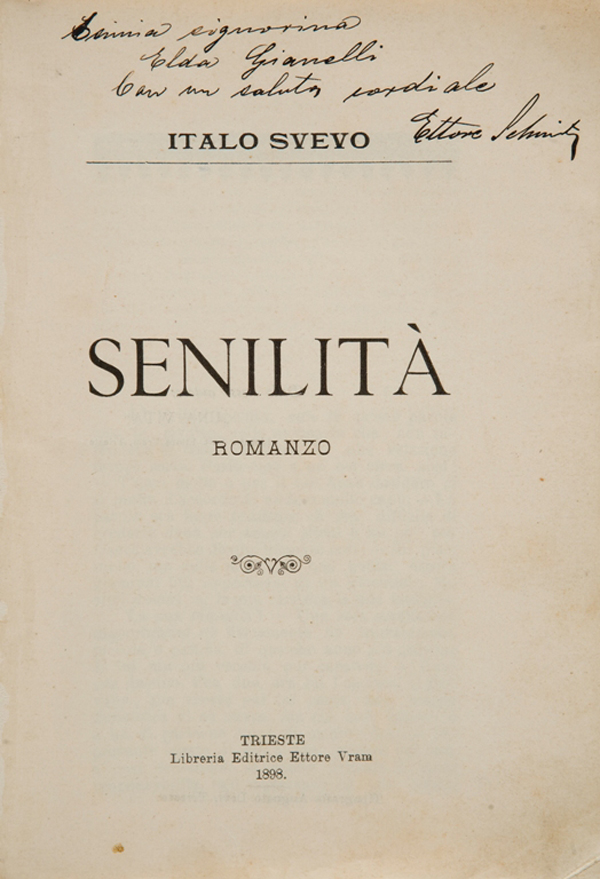
Prima edizione di Senilità con dedica dell’autore
La sua figura permane nella narrativa sveviana e appare approfondita nel secondo romanzo, pubblicato nel 1898, Senilità, passato sotto il più completo silenzio e che farà sì che, almeno pubblicamente, il nostro abbandoni ogni velleità letteraria.
A trentacinque anni, autore di un romanzo ormai dimenticato, Emilio Brentani pare rassegnato a un’esistenza grigia, accanto alla sorella Amalia, non più giovane né bella, ma semplice e buona. Incontra Angiolina, una popolana che non si potrebbe dire “per bene”, ma che è vivace e intelligente. Intreccia con lei una relazione, ma non riesce a contenerla nei suoi limiti naturali; si sforza invece di attribuirle n contenuto che l’indole morale di Angiolina non sostiene. Coinvolge nella vicenda l’amico Balli, artista allegro e spensierato, col risultato che di lui s’innamorano sia l’amante sia la sorella: Angiolina gli si dà, Amalia cerca do stordirsi con l’etere e, intossicata, muore. Emilio si acquieterà nell’arida inerzia della senilità.
Il romanzo riprende e approfondisce tematiche già apparse in Una vita: anche qui vi è un autobiografismo di fondo: Emilio Brentani, oltre che essere un “fratello” dell’inettitudine di Alfonso Nitti, è anche l’alter-ego di Italo Svevo (si pensi che è un letterato con alle spalle un romanzo che gli aveva procurato una certa notorietà all’interno della cittadina triestina); l’incontro tra personalità differenti: il protagonista con il Balli (la cui figura appare modellata sul reale amico di Svevo, il pittore Umberto Veruda), l’uso ancora della terza persona.
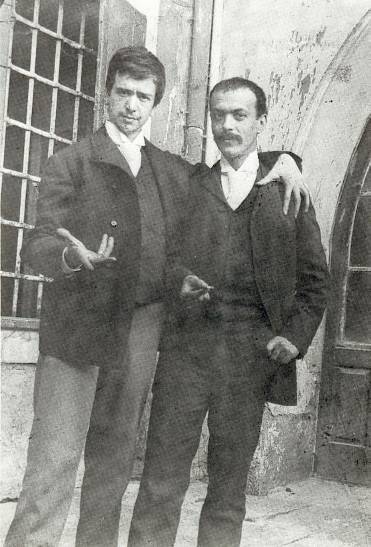
Umberto Veruda e Italo Svevo (1890 circa)
Tuttavia il secondo romanzo sveviano appare già a Montale un vero capolavoro: la complicazione del binomio tra “lottatori” e “contemplatori” si arricchisce con le figure di femminili di Amalia ed Angiolina. Il loro ingresso forma un perfetto quadrilatero in cui si specchiano i protagonisti:
Emilio Angiolina
Balli Amalia
Ma il quadrilatero potrebbe leggersi anche in modo chiasmatico non soltanto per la similarità delle “categorie sveviane”, ma perché, narrativamente, Emilio vuol far di Angiolina una donna ideale, buona e pura come sua sorella; Stefano la tratta per quel che è ed ottiene da lei quel corpo, senza rifletterci più di quanto fosse necessario. E’ che Emilio è “senile”, non per età, ma per propensione psichica: non agisce e come tutti coloro che, non agendo, guardano la vita, nel momento in cui essa s’impossessa di lui lo soggioga.
UNA RELAZIONE NON TROPPO SERIA
Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in una relazione troppo seria. Parlò cioè a un dipresso così: «T’amo molto e per il tuo bene desidero ci si metta d’accordo di andare molto cauti.» La parola era tanto prudente ch’era difficile di crederla detta per amore altrui, e un po’ più franca avrebbe dovuto suonare così: «Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrai essere giammai più importante di un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, la mia famiglia.»
La sua famiglia? Una sola sorella non ingombrante né fisicamente né moralmente, piccola e pallida, di qualche anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse per destino. Dei due, era lui l’egoista, il giovane; ella viveva per lui come una madre dimentica di se stessa, ma ciò non impediva a lui di parlarne come di un altro destino importante legato al suo e che pesava sul suo, e così, sentendosi le spalle gravate di tanta responsabilità, egli traversava la vita cauto, lasciando da parte tutti i pericoli ma anche il godimento, la felicità. A trentacinque anni si ritrovava nell’anima la brama insoddisfatta di piaceri e di amore, e già l’amarezza di non averne goduto, e nel cervello una grande paura di se stesso e della debolezza del proprio carattere, invero piuttosto sospettata che saputa per esperienza.
La carriera di Emilio Brentani era più complicata perché intanto si componeva di due occupazioni e due scopi ben distinti. Da un impieguccio di poca importanza presso una società di assicurazioni, egli traeva giusto il denaro di cui la famigliuola abbisognava. L’altra carriera era letteraria e, all’infuori di una riputazioncella, – soddisfazione di vanità più che d’ambizione – non gli rendeva nulla, ma lo affaticava ancor meno. Da molti anni, dopo di aver pubblicato un romanzo lodatissimo dalla stampa cittadina, egli non aveva fatto nulla, per inerzia non per sfiducia. Il romanzo, stampato su carta cattiva, era ingiallito nei magazzini del libraio, ma mentre alla sua pubblicazione Emilio era stato detto soltanto una grande speranza per l’avvenire, ora veniva considerato come una specie di rispettabilità letteraria che contava nel piccolo bilancio artistico della città. La prima sentenza non era stata riformata, s’era evoluta.
Per la chiarissima coscienza ch’egli aveva della nullità della propria opera, egli non si gloriava del passato, però, come nella vita così anche nell’arte, egli credeva di trovarsi ancora sempre nel periodo di preparazione, riguardandosi nel suo più segreto interno come una potente macchina geniale in costruzione, non ancora in attività. Viveva sempre in un’aspettativa non paziente, di qualche cosa che doveva venirgli dal cervello, l’arte, di qualche cosa che doveva venirgli di fuori, la fortuna, il successo, come se l’età delle belle energie per lui non fosse tramontata.
Angiolina, una bionda dagli occhi azzurri grandi, alta e forte, ma snella e flessuosa, il volto illuminato dalla vita, un color giallo di ambra soffuso di rosa da una bella salute, camminava accanto a lui, la testa china da un lato come piegata dal peso del tanto oro che la fasciava, guardando il suolo ch’ella ad ogni passo toccava con l’elegante ombrellino come se avesse voluto farne scaturire un commento alle parole che udiva. Quando credette di aver compreso disse: «Strano» timidamente guardandolo sottecchi. «Nessuno mi ha mai parlato così.» Non aveva compreso e si sentiva lusingata al vederlo assumere un ufficio che a lui non spettava, di allontanare da lei il pericolo. L’affetto ch’egli le offriva ne ebbe l’aspetto di fraternamente dolce.
Fatte quelle premesse, l’altro si sentì tranquillo e ripigliò un tono più adatto alla circostanza. Fece piovere sulla bionda testa le dichiarazioni liriche che nei lunghi anni il suo desiderio aveva maturate e affinate, ma, facendole, egli stesso le sentiva rinnovellare e ringiovanire come se fossero nate in quell’istante, al calore dell’occhio azzurro di Angiolina. Ebbe il sentimento che da tanti anni non aveva provato, di comporre, di trarre dal proprio intimo idee e parole: un sollievo che dava a quel momento della sua vita non lieta, un aspetto strano, indimenticabile, di pausa, di pace. La donna vi entrava! Raggiante di gioventù e bellezza ella doveva illuminarla tutta facendogli dimenticare il triste passato di desiderio e di solitudine e promettendogli la gioia per l’avvenire ch’ella, certo, non avrebbe compromesso.
Egli s’era avvicinato a lei con l’idea di trovare un’avventura facile e breve, di quelle che egli aveva sentito descrivere tanto spesso e che a lui non erano toccate mai o mai degne di essere ricordate. Questa s’era annunziata proprio facile e breve. L’ombrellino era caduto in tempo per fornirgli un pretesto di avvicinarsi ed anzi – sembrava malizia! – impigliatosi nella vita trinata della fanciulla, non se n’era voluto staccare che dopo spinte visibilissime. Ma poi, dinanzi a quel profilo sorprendentemente puro, a quella bella salute – ai rétori corruzione e salute sembrano inconciliabili – aveva allentato il suo slancio, timoroso di sbagliare e infine s’incantò ad ammirare una faccia misteriosa dalle linee precise e dolci, già soddisfatto, già felice.
Ella gli aveva raccontato poco di sé e per quella volta, tutto compreso del proprio sentimento, egli non udì neppure quel poco. Doveva essere povera, molto povera, ma per il momento – lo aveva dichiarato con una certa quale superbia – non aveva bisogno di lavorare per vivere. Ciò rendeva l’avventura anche più gradevole, perché la vicinanza della fame turba là dove ci si vuol divertire. Le indagini di Emilio non furono dunque molto profonde ma egli credette che le sue conclusioni logiche, anche poggiate su tali basi, dovessero bastare a rassicurarlo. Se la fanciulla, come si sarebbe dovuto credere dal suo occhio limpido, era onesta, certo non sarebbe stato lui che si sarebbe esposto al pericolo di depravarla; se invece il profilo e l’occhio mentivano, tanto meglio. C’era da divertirsi in ambedue i casi, da pericolare in nessuno dei due.
Angiolina aveva capito poco delle premesse, ma, visibilmente, non le occorrevano commenti per comprendere il resto; anche le parole più difficili avevano un suono di carattere non ambiguo. I colori della vita risaltarono sulla bella faccia e la mano di forma pura, quantunque grande, non si sottrasse a un bacio castissimo d’Emilio.
Si fermarono a lungo sul terrazzo di S. Andrea e guardarono verso il mare calmo e colorito nella notte stellata, chiara ma senza luna. Nel viale di sotto passò un carro e, nel grande silenzio che li circondava, il rumore delle ruote sul terreno ineguale continuò a giungere fino a loro per lunghissimo tempo. Si divertirono a seguirlo sempre più tenue finché proprio si fuse nel silenzio universale, e furono lieti che per tutt’e due fosse scomparso nello stesso istante. «Le nostre orecchie vanno molto d’accordo,» disse Emilio sorridendo. Egli aveva detto tutto e non sentiva più alcun bisogno di parlare. Interruppe un lungo silenzio per dire: «Chissà se quest’incontro ci porterà fortuna!» Era sincero. Aveva sentito il bisogno di dubitare della propria felicità ad alta voce.
«Chissà?» replicò essa con un tentativo di rendere nella propria voce la commozione che aveva sentita nella sua. Emilio sorrise di nuovo ma di un sorriso che credette di dover celare. Date le premesse da lui fatte, che razza di fortuna poteva risultare ad Angiolina dall’averlo conosciuto?
Il romanzo inizia subito in medias res presentandoci tre focalizzazioni:
- narratore esterno, che interviene “ironizzando” sia su Emilio che Angiolina;
- Emilio, che dice bugie a se stesso, ma al contempo “capisce” i suoi limiti: potremo definirlo sull’orlo di un crinale in cui ciò che desidera cerca di pianificarlo, ma proprio la pianificazione ed il raziocinio con cui tenta di dirigere se stesso, lo conduce ad una inevitabile sconfitta (e qui interviene l’ironia del narratore)
- Angiolina è semplice, ma più direttamente è ignorante; non capisce quello che lui dice e lo interpreta a modo suo. Il problema che il suo modo, proprio perché non pianifica nulla, ma vive, risulta certamente a proprio vantaggio.

Terrazzo sul mare a Trieste (1910)
Emilio ci dice da subito che vuole un’avventura con una ragazza facile, a tale scopo premette a lei impegni che gli impediscono una relazione “impegnativa”: le dice che ha una famiglia da mantenere ed un lavoro. Già con il parlare della famiglia egli dice una bugia, ma più che dirla ad Angiolina sembra dirla a se stesso: Amalia, pur fragile, cui egli sente un dovere paterno, è nella realtà colei che gli fa da madre, che lo accudisce nel vero senso della parola, accettando le sue confidenze. L’altra bugia è nell’aspirazione letteraria: è consapevole dell’insuccesso toccatogli, ma vive sempre come nell’attesa che un guizzo d’ispirazione lo porti alla grande opera: ma, dentro di lui sa che ciò non avverrà mai. Non dimentichiamoci, per ultimo, che ciò che Emilio tenta è d’imitare i “sani”, non di “vivere come i sani”: c’è già nel suo atteggiamento un fondo di “malattia” che lo contraddistinguerà per l’intera vicenda. Il prossimo brano ci racconta quel che succede, nell’animo di Emilio, dopo aver lasciato per la prima volta Angiolina, anche su consiglio del Balli, per un palese tradimento:
DESIDERIO E SOGNO
Tanto il suo dolore quanto il suo rimorso divennero miti, miti. Gli elementi di cui si componeva la sua vita erano gli stessi, ma s’erano attenuati quasi visti attraverso una lente fosca che li privasse di luce e di violenza. Una grande calma e una grande noia incombevano su lui. Aveva percepito con piena chiarezza quanto strana fosse stata in lui l’esagerazione sentimentale, e al Balli che lo studiava con qualche ansietà, disse, credendo d’essere sincero: «Sono guarito.»
Poteva crederlo perché non si poteva pretendere ch’egli ricordasse esattamente lo stato d’animo in cui s’era trovato prima di aver conosciuta Angiolina. La differenza era tanto piccola! Aveva sbadigliato meno, e non aveva conosciuto l’impaccio doloroso che lo coglieva quando si trovava accanto ad Amalia.
Anche la stagione era molto fosca. Da settimane non s’era visto raggio di sole, e perciò, quando egli pensava ad Angiolina, associava nel suo pensiero la dolce faccia, il caldo color dei capelli biondi, all’azzurro del cielo, alla luce del sole, tutte cose ch’erano scomparse insieme dalla sua vita. Egli era però giunto alla convinzione che l’abbandono di Angiolina fosse stato molto salutare per lui. «È preferibile d’essere liberi» diceva con convinzione.
Tentò anche di approfittare della riconquistata libertà. Sentiva e si doleva d’essere inerte, e ricordava che, anni prima, l’arte gli aveva colorita la vita sottraendolo all’inerzia in cui era caduto dopo la morte del padre. Aveva scritto il suo romanzo, la storia di un giovane artista il quale da una donna veniva rovinato nell’intelligenza e nella salute. Nel giovane aveva rappresentato se stesso, la propria ingenuità e la propria dolcezza. Aveva immaginato la sua eroina secondo la moda di allora: un misto di donna e di tigre. Del felino aveva le movenze, gli occhi, il carattere sanguinario. Non aveva mai conosciuta una donna e l’aveva sognata così, un animale ch’era veramente difficile fosse mai potuto nascere e prosperare. Ma con quale convinzione l’aveva descritta! Aveva sofferto e goduto con essa sentendo a volte vivere anche in sé quell’ibrido miscuglio di tigre e di donna.
Riprese ora la penna e scrisse in una sola sera il primo capitolo di un romanzo. Trovava un nuovo indirizzo d’arte al quale volle conformarsi, e scrisse la verità. Raccontò il suo incontro con Angiolina, descrisse i propri sentimenti, – subito però quelli degli ultimi giorni – violenti e irosi, l’aspetto di Angiolina ch’egli vide al primo incontro guastato dall’animo basso e perverso, e infine il magnifico paesaggio che aveva contornato agli esordii il loro idillio. Stanco e annoiato, abbandonò il lavoro, contento di aver steso in una sola sera tutto un capitolo.
La sera appresso si rimise al lavoro avendo nella mente due o tre idee che dovevano bastare per una sequela di pagine. Prima però rilesse il lavoro fatto: «Incredibile!» mormorò. L’uomo non somigliava affatto a lui, la donna poi conservava qualche cosa della donna-tigre del primo romanzo, ma non ne aveva la vita, il sangue. Pensò che quella verità che aveva voluto raccontare era meno credibile dei sogni che anni prima aveva saputi gabellare per veri. In quell’istante si sentì sconsolatamente inerte, e ne provò un’angoscia dolorosa. Depose la penna, richiuse tutto in un cassetto, e si disse che l’avrebbe ripreso più tardi, forse già il giorno appresso. Questo proposito bastò a tranquillarlo; ma non ritornò più al lavoro. Voleva risparmiarsi ogni dolore e non si sentiva forte abbastanza per studiare la propria inettitudine e vincerla. Non sapeva più pensare con la penna in mano. Quando voleva scrivere, si sentiva arrugginire il cervello, e rimaneva estatico dinanzi alla carta bianca, mentre l’inchiostro s’asciugava sulla penna.

Trieste ai tempi di Svevo
Gli venne il desiderio di rivedere Angiolina. Non prese la decisione di andarla a cercare; s’era detto soltanto che ora veramente non ci sarebbe stato alcun pericolo a rivederla. Anzi, se si fosse voluto attenere esattamente alle parole che aveva dette lasciandola, sarebbe dovuto andare subito da lei. Non era forse calmo abbastanza per stringerle la mano da amico? Comunicò questo suo proposito al Balli, e in questa forma: «Vorrei soltanto vedere se, riavvicinandola, saprei contenermi da persona più accorta.»
Il Balli aveva riso troppo spesso dell’amore di Emilio per non credere ora nella sua perfetta guarigione. Per di più, da qualche giorno, egli stesso aveva il più vivo desiderio di rivedere Angiolina. Aveva immaginato una figura su quei tratti e con quei vestiti. Lo raccontò ad Emilio il quale gli promise che con le prime parole che avrebbe rivolte alla fanciulla, l’avrebbe pregata di posare per il Balli. Non v’era da dubitare della sua guarigione. Ormai egli non era neppur geloso del Balli.
Parve poi che il Balli pensasse ad Angiolina non meno di Emilio stesso. Aveva dovuto distruggere un bozzetto su cui aveva spesi sei mesi di lavoro. Anch’egli era in un periodo d’esaurimento e non ritrovava in sé altra idea che quella nata la prima sera in cui Emilio gli aveva fatto conoscere Angiolina. Una sera, lasciando Emilio, gli chiese: «Tu non ti sei ancora riavvicinato?» Non voleva essere lui a riunirli, ma voleva sapere se Emilio non si fosse rappattumato con Angiolina a sua insaputa. Sarebbe stato un tradimento!
La calma d’Emilio era aumentata ancora. Tutti gli permettevano di fare quello ch’egli voleva ed egli in fondo non voleva niente. Proprio niente. Avrebbe cercato di rivedere Angiolina perché voleva provarsi a parlare e pensare con calore. Doveva venirgli dal di fuori il calore ch’egli non aveva trovato in sé, e sperava di vivere il romanzo che non sapeva scrivere.
La sola inerzia gl’impedì d’andare a cercare la fanciulla. Gli sarebbe piaciuto che altri si fosse incaricato di riunirli, e pensò perfino che avrebbe potuto invitare il Balli a farlo. Tutto infatti sarebbe stato più facile e più semplice se il Balli si fosse procurato da solo la modella, e gliel’avesse poi consegnata quale amante. Ci avrebbe pensato. Esitava soltanto perché non voleva concedere al Balli una parte importante nel proprio destino.
Importante? Oh, Angiolina rimaneva sempre una persona molto importante per lui. In proporzione al resto se non altro. Tutto era tanto insignificante, ch’ella tutto dominava. Ci pensava continuamente come un vecchio alla propria giovinezza. Come era stato giovane quella notte in cui avrebbe dovuto uccidere per tranquillarsi! Se avesse scritto invece di arrovellarsi prima sulla via e poi altrettanto affannosamente nel letto solitario, avrebbe certo trovata la via all’arte che più tardi aveva cercata invano. Ma tutto era passato per sempre. Angiolina viveva, ma non poteva più dargli la giovinezza.
Una sera, accanto al Giardino Pubblico, la vide camminare dinanzi a sé. La riconobbe al noto passo. Ella teneva sollevate le gonne per preservarle dalla fanghiglia, e, alla luce di un gramo fanale, egli vide rilucere le scarpe nere di Angiolina. Ne fu subito turbato. Ricordò che al culmine della sua angoscia amorosa, egli aveva pensato che il possesso di quella donna gli avrebbe data la guarigione. Ora invece pensò: «Mi animerebbe!»
«Buona sera, signorina» disse con quanta calma poté trovare nell’affanno del desiderio che lo colse dinanzi a quella faccia da bambino roseo, con gli occhi grandi dai contorni precisi, che parevano tagliati allora allora. Ella si fermò, afferrò la mano che le era stata offerta e rispose lieta e serena al saluto: «Come sta? È tanto che non ci vediamo.»
Egli rispose, ma era distratto dal proprio desiderio. Aveva forse fatto male a dimostrare tanta serenità, e, peggio, a non aver pensato al contegno da seguire per arrivare subito dove voleva, alla verità, al possesso. Le camminò accanto tenendola per mano, ma, dopo scambiate quelle prime frasi da persone che sono liete di ritrovarsi, egli tacque esitante. Il tono elegiaco usato altre volte con piena sincerità, sarebbe stato fuori di posto, ma anche un’indifferenza troppo grande non l’avrebbe portato allo scopo.
«Mi ha perdonato, signor Emilio?» disse lei fermandosi e gli porse da stringere anche l’altra mano. L’intenzione era stata ottima e il gesto sorprendentemente originale per Angiolina.
Egli trovò: «Sa che cosa io non le perdonerò mai? Di non aver fatto alcun tentativo per riavvicinarsi a me. Tanto poco le importava di me?» Era sincero e s’accorse ch’egli cercava inutilmente di far la commedia. Forse la sincerità gli sarebbe servita meglio di qualunque finzione.
Ella si confuse un poco e, balbettando, assicurò che se egli non si fosse avvicinato, l’indomani ella gli avrebbe scritto. «Già, in fondo che cosa ho fatto?» e non ricordava d’aver chiesto scusa poco prima.
Emilio credette opportuno mostrarsi dubbioso. «Debbo crederle?» Disse poi un rimprovero: «Con un ombrellaio!»
La parola li fece ridere di gusto entrambi. «Geloso!» esclamò lei stringendo la mano che continuava a tenere «geloso di quel sudicio uomo!». Infatti se egli aveva fatto bene a rompere la relazione con Angiolina, certo aveva avuto torto di cogliere a pretesto quella stupida storia con l’ombrellaio. L’ombrellaio non era il più temibile dei suoi rivali. E perciò ebbe lo strano sentimento che doveva imputare a se stesso tutti i mali che lo avevano colpito dacché aveva abbandonata Angiolina.
Ella tacque lungamente. Non poteva essere di proposito, perché per Angiolina sarebbe stata un’arte troppo fine. Ella taceva probabilmente perché non trovava altre parole per scolparsi, e camminarono in silenzio uno accanto all’altra nella notte strana e fosca, il cielo tutto coperto di nubi sbiancate in un solo punto dalla luce lunare.
Arrivarono dinanzi alla casa d’Angiolina ed ella si fermò, forse per prendere congedo. Ma egli la costrinse a procedere: «Camminiamo ancora, ancora, così muti!» Allora, naturalmente, ella lo compiacque e continuò a camminare tacendo a lui da canto. Ed egli l’amò di nuovo, da quell’istante, o da quell’istante ne fu consapevole. Gli camminava accanto la donna nobilitata dal suo sogno ininterrotto, da quell’ultimo grido d’angoscia ch’egli le aveva strappato lasciandola, e che per lungo tempo l’aveva personificata tutta; persino dall’arte, perché ormai il desiderio fece sentire ad Emilio d’aver accanto la dea capace di qualunque nobiltà di suono o di parola. Oltrepassata la casa d’Angiolina, essi si trovarono sulla via deserta e oscura chiusa dalla collina da una parte, dall’altra da un muricciuolo che la separava dai campi. Ella vi sedette ed egli s’appoggiò a lei cercando la posizione che aveva preferita in passato, durante i primi tempi del loro amore. Gli mancava il mare. Nel paesaggio umido e grigio imperò la biondezza d’Angiolina, l’unica nota calda, luminosa.
Era tanto tempo ch’egli non sentiva quelle labbra sulle sue che n’ebbe una commozione violenta. «Oh, cara e dolce!» mormorò baciandole gli occhi, il collo e poi la mano e le vesti. Ella lo lasciò fare dolcemente, e tanta dolcezza era talmente inaspettata ch’egli si commosse e pianse prima con sole lagrime, poi con singhiozzi. Gli pareva che non fosse dipeso che da lui di continuare per tutta la vita quella felicità. Tutto si scioglieva, tutto si spiegava. La sua vita non poteva più consistere che di quel solo desiderio.
«Tanto bene mi vuoi?» mormorò essa commossa e meravigliata. Anche lei aveva delle lagrime agli occhi. Gli raccontò che l’aveva visto sulla via, pallido e smunto, sul volto i segni evidenti della sua sofferenza, e le si era stretto il cuore dalla compassione. «Perché non sei venuto prima?» gli chiese rimproverandolo.
S’appoggiò a lui per discendere dal muricciuolo. Egli non capiva perché ella troncasse quella dolce spiegazione ch’egli avrebbe voluto continuare in eterno. «Andiamo a casa mia» disse ella, risoluta. Egli ebbe le vertigini e l’abbracciò e baciò non sapendo come dimostrarle la propria riconoscenza. Ma la casa d’Angiolina era lontana e, camminando, Emilio si ritrovò intero con i suoi dubbi e la sua diffidenza. Se quell’istante l’avesse legato per sempre a quella donna? Fece le scale lentamente e tutt’ad un tratto le domandò: «E Volpini?»
Ella esitò e si fermò: «Volpini?» Poi, risoluta, superò i pochi scalini che la dividevano da Emilio. Si appoggiò a lui, nascose la faccia sulla sua spalla con un’affettazione di pudore che gli ricordò l’antica Angiolina e la sua serietà da melodramma, e gli disse: «Nessuno lo sa, neppure mia madre.» Un po’ alla volta ricompariva tutto il vecchio bagaglio, anche la dolce madre. Ella s’era data al Volpini; costui l’aveva voluto, l’aveva anzi posto a condizione per continuare i loro rapporti. «Sentiva che non era amato» bisbigliava Angiolina «e volle una prova d’amore.» Essa non aveva ottenuto in compenso altra garanzia all’infuori di una promessa di matrimonio. Fece, con la solita sconsideratezza, il nome di un giovane avvocato il quale le aveva dato il consiglio d’accontentarsi di quella promessa perché la legge puniva la seduzione in quelle forme.
Così allacciati, quelle scale non terminavano più. Ogni scalino rendeva Angiolina più simile alla donna ch’egli aveva fuggita. Perché ora ciarlava, incominciando già ad abbandonarsi. Ora poteva essere finalmente sua perché – questo era detto e ridetto – era per lui ch’ella s’era data al sarto. A quella responsabilità non si sfuggiva più neppure rinunziando a lei. Ella aperse la porta e, per il corridoio oscuro, lo diresse alla propria stanza. Da un’altra s’udì la voce nasale della madre: «Angiolina! sei tu?»
«Sì« rispose Angiolina trattenendo una risata. «Mi corico subito. Addio, mamma.»
Accese una candela e si levò il mantello e il cappello. Poi gli si abbandonò o, meglio, lo prese.
Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata. In quella memorabile sera egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte nell’intima sua natura. Era sparita la sconsolata inerzia che l’aveva spinto a ricercare Angiolina, ma erasi anche annullato l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. Il maschio era oramai soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli veramente non ne aveva sentita altra. Aveva posseduto la donna che odiava, non quella ch’egli amava. Oh, ingannatrice! Non era né la prima, né – come voleva dargli ad intendere – la seconda volta ch’ella passava per un letto d’amore. Non valeva la pena di adirarsene perché l’aveva saputo da lungo tempo. Ma il possesso gli aveva data una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. “Non sognerò mai più” pensò uscendo da quella casa. E poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari: “Forse non ci ritornerò mai più.” Non era una decisione. Perché l’avrebbe dovuta prendere? Il tutto mancava d’importanza.

Anthony Franciosa e Claudia Cardinale interpretano Emilio e Angiolina nel film “Senilità” di Mauro Bolognini del 1962
Emilio, all’inizio del brano, si sente guarito dall’amore, anzi il voler rivedere Angiolina vuol dire che ormai l’innamoramento è cessato e il fatto non dovrebbe arrecarle nessun dolore. Eppure la sua decisione egli la deve prendere solo perché gli altri glielo permettono (Tutti gli permettevano di fare quello ch’egli voleva ed egli in fondo non voleva niente. Proprio niente.). Allo stesso modo egli, che decide di rivedere la ragazza, non la cerca (La sola inerzia gl’impedì d’andare a cercare la fanciulla), ma solo il caso gli permette di rincontrarla. L’incostanza di Emilio si rivela sin da subito (Ne fu subito turbato): si è riempito la testa di bugie e ciò lo dimostra “riamandola”, in un solo attimo: La sua inerzia viene riempita dai suoi occhi azzurri, dai capelli biondi, ma soprattutto dal suo agire. Emilio non porta Angiolina a letto: (Poi gli si abbandonò o, meglio, lo prese.) e l’azione che da donna trasforma la ragazza in femmina, gli fa cambiare un’altra volta la concezione che Emilio ha di lei; la vede forse nella più cruda realtà e l’ideale che si era fatto cade miseramente tra le sfatte lenzuola. Ancora una volta il protagonista (vecchio nell’anima, senile, dunque) non riesce a cogliere la vita: la sente, l’analizza; ma la grandezza di Svevo è proprio in questa lotta che l’uomo contemplatore fa contro questa vita, la voglia d’essere di essere lottatore e l’incapacità di riuscirci.
 Locandina del film del 1962
Locandina del film del 1962
Siamo arrivati, nell’economia del romanzo, alla malattia d’Amalia (potremo dire alla morte cercata attraverso l’etere, per dimenticare la sua inettitudine al vivere). Vicino a lei la signora Elena e Stefano Balli, che si dimostra veramente legato nel vincolo d’amicizia ad Emilio. Quest’ultimo ha un ultimo appuntamento con Angiolina e, nonostante il tragico momento, decide di andare per mettere fine alla storia, cercando di essere calmo e rassegnato:

Emilio ed Amalia
L’ADDIO DEFINITIVO
L’aria rigida della sera lo scosse, lo refrigerò fino in fondo all’anima. Lui usare delle violenze ad Angiolina! Perché era lei la causa della morte d’Amalia? Ma quella colpa non poteva esserle rimproverata. Oh, il male avveniva, non veniva commesso. Un essere intelligente non poteva essere violento perché non v’era posto a odii. Per l’antica abitudine di ripiegarsi su se stesso e analizzarsi, gli venne il sospetto che forse il suo stato d’animo era risultato dal bisogno di scusarsi e di assolversi. Ne sorrise come di cosa comicissima. Come erano stati colpevoli lui e Amalia di prendere la vita tanto sul serio!
Alla riva, dopo di aver guardato l’orologio, si fermò. Qui il tempo appariva peggiore che non in città. Al sibilare del vento si univa imponente il clamore del mare, un urlo enorme composto dall’unione di varie voci più piccole. La notte era fonda; del mare non si vedeva che qua e là biancheggiare qualche onda che il caos aveva voluto infranta prima di giungere a terra. Sui battelli, alla riva, si era sull’attenti e si vedeva qualche figura di marinaio, in alto, su quegli alberi che facevano la solita varia danza nelle quattro direzioni, lavorare nella notte e nel pericolo.
Ad Emilio parve che quel tramestìo si confacesse al suo dolore. Vi attingeva ancora maggiore calma. L’abito letterario gli fece pensare il paragone fra quello spettacolo e quello della propria vita. Anche là, nel turbine, nelle onde di cui una trasmetteva all’altra il movimento che aveva tratto lei stessa dall’inerzia, un tentativo di sollevarsi che finiva in uno spostamento orizzontale, egli vedeva l’impassibilità del destino. Non v’era colpa, per quanto ci fosse tanto danno.
Accanto a lui un grosso marinaio piantato solidamente sulle gambe coperte di stivaloni, urlò verso il mare un nome. Poco dopo gli rispose un altro grido; egli allora si gettò su una colonna vicina, ne slegò una gomena che v’era attortigliata, l’allentò e la saldò di nuovo. Lentamente, quasi impercettibilmente, uno dei maggiori bragozzi si allontanò dalla riva ed Emilio comprese ch’era stato attaccato ad una boa vicina per salvarlo dalla terra. Il grosso marinaio prese ora tutt’altra attitudine; s’era appoggiato alla colonna, aveva accesa la pipa e in quel diavoleto si godeva il suo riposo.
Emilio pensò che la sua sventura era formata dall’inerzia del proprio destino. Se, una volta sola nella sua vita, egli avesse avuto da slegare e riannodare in tempo una corda; se il destino di un bragozzo, per quanto piccolo, fosse stato affidato a lui, alla sua attenzione, alla sua energia; se gli fosse stato imposto di forzare con la propria voce i clamori del vento e del mare, egli sarebbe stato meno debole e meno infelice.
Andò all’appuntamento. Il dolore sarebbe ritornato subito dopo; per il momento egli amava ad onta di Amalia. Non c’era dolore in quell’ora in cui egli poteva fare proprio quello che la sua natura esigeva. Assaporava con voluttà quel sentimento calmo di rassegnazione e di perdono. Non pensò nessuna frase per comunicare il suo stato d’animo ad Angiolina; anzi il loro ultimo abboccamento doveva esserle assolutamente inesplicabile, ma egli avrebbe agito come se qualche essere più intelligente fosse stato presente a giudicare lui e lei.
Il tempo s’era risolto in un vento freddo e violento, ma continuo, uguale; nell’aria non c’era più alcuna lotta.
Angiolina gli venne incontro dal viale di Sant’Andrea. Vedendolo esclamò con grande stizza – una stonatura dolorosa nello stato d’animo di Emilio: «Son qui da mezz’ora. Ero in procinto di andarmene.»
Egli, dolcemente, la trasse accanto ad un fanale e le fece vedere l’oriuolo che segnava precisamente l’ora stabilita per l’appuntamento. «Allora mi sono ingannata» disse ella, non molto più dolcemente. Mentre egli andava studiando il modo con cui dirle che quello sarebbe stato l’ultimo loro incontro, ella si fermò e gli disse: «Per questa sera dovresti lasciarmi andare. Ci vedremo domani; fa freddo e poi…»
Egli fu strappato all’indagine che sempre continuava su se stesso e la guardò, la osservò; comprese subito che non era il freddo che le faceva desiderare d’andarsene. Lo colpì inoltre di trovarla vestita con maggior accuratezza del solito. Un vestito bruno che non le aveva mai visto, elegantissimo, sembrava tirato fuori per qualche grande occasione; anche il cappello gli sembrò nuovo, e osservò persino delle scarpettine poco adatte per camminare a Sant’Andrea con quel tempo. «E poi?» ripeté egli fermandosele accanto e guardandola negli occhi.
«Senti, voglio dirti tutto» disse lei assumendo un aspetto di confidenza risoluta, assolutamente fuori di posto e continuò imperterrita, senz’accorgersi che lo sguardo di Emilio si faceva sempre più torvo: «Ho ricevuto un dispaccio dal Volpini con cui m’annunzia il suo arrivo. Non so che cosa egli voglia da me; ma a quest’ora, certo, si trova già a casa mia.»
Ella mentiva, non v’era alcun dubbio. Il Volpini cui, nella mattina, egli aveva scritto quella lettera, eccolo che, prima di riceverla, arrivava, contrito, a chiedere scusa. Sconvolto, rise triste: «Come? Colui che ieri ti scrisse quella lettera, oggi capita a ritirarla in persona ed anzi ti avvisa la sua venuta telegraficamente. Grandi affari! Grandi affari! Da dover ricorrere al telegrafo! E se tu ti ingannassi e in luogo del Volpini fosse un altro?»
Ella sorrise ancora sicura di sé: «Ah, a te è stato raccontato dal Sorniani, che due sere fa mi ha visto a ora tarda sulla via, accompagnata da un signore? Avevo lasciata la casa dei Deluigi in quel momento, e avendo paura di camminar sola di notte, quella compagnia mi riuscì comoda.» Egli non l’udiva, ma l’ultima frase di quella ch’ella credeva fosse una giustificazione, la udì e, per la sua stranezza, la ritenne: «Quello era un Deo gratias qualunque.» Poi continuò: «Peccato che ho dimenticato a casa il dispaccio. Ma se non mi vuoi credere, tanto peggio. Non vengo forse sempre puntuale a tutti gli appuntamenti? Perché oggi avrei da inventare delle frottole per mancarvi?»
«È facile capirlo!» disse Emilio ridendo rabbiosamente. «Oggi tu hai un altro appuntamento. Vattene presto! C’è qualcuno che t’attende.» –
«Ebbene, se credi di me questa cosa, è meglio ch’io me ne vada!» Parlava risoluta, ma non si mosse.
Le parole fecero a lui lo stesso effetto come se fossero state accompagnate dall’atto immediato. Ella voleva lasciarlo! «Aspetta prima un istante, che ci spieghiamo!» Anche nell’ira enorme che lo pervadeva tutto, egli pensò un momento se non fosse tuttavia possibile di ritornare allo stato di calma rassegnata in cui s’era trovato poco prima. Ma non sarebbe stato giusto di atterrarla e calpestarla? L’afferrò per le braccia per impedirle di andare, s’appoggiò al fanale che aveva dietro di sé e avvicinò la propria faccia sconvolta a quella di lei rosea e tranquilla. «È l’ultima volta che ci vediamo!» urlò.
«Sta bene, sta bene» disse ella occupata soltanto a liberarsi di quella stretta che le faceva male.
«E sai perché? Perché tu sei una…» Esitò un istante, poi urlò quella parola che persino alla sua ira era sembrata eccessiva, la urlò vittorioso, vittorioso del suo stesso dubbio.
«Lasciami» gridò ella sconvolta dalla rabbia e dalla paura «lasciami o chiamo aiuto.»
«Tu sei una…» replicò egli che finalmente, vedendola irritata, poteva rinunziare a percuoterla. «Ma credi dunque che io da lungo tempo non mi sia accorto con chi abbia avuto da fare? Quando ti trovavo vestita da serva, sulle scale di casa tua – rammentò quella sera in tutti i particolari – con quello scialle grezzamente colorito sulla testa, le braccia calde di alcova, pensai subito la parola che ora t’ho detta. Non volli dirtela e giuocherellai con te come facevano tutti gli altri, Leardi, Giustini, Sorniani e… e… il Balli.
«Il Balli!» rise ella urlando per farsi udire attraverso al rumore del vento e della voce d’Emilio. «Il Balli si vanta; non è vero niente.»
«Perché lui non volle, quello sciocco, per riguardo a me come se a me potesse importare che t’abbia posseduta un uomo di meno, te…» e per la terza volta le disse quella parola. Ella raddoppiò gli sforzi per svincolarsi, ma lo sforzo di trattenerla era ora per Emilio lo sfogo migliore; le cacciava con voluttà le dita nelle braccia morbide. Egli sapeva che il momento in cui l’avrebbe lasciata libera, ella se ne sarebbe andata e tutto sarebbe stato finito, tutto e in modo tanto differente da quello ch’egli aveva sognato.
«Ed io ti ho voluto bene» disse, forse tentando di mitigarsi, ma aggiunse subito: «Sempre però sapevo quello che tu sei. Sai quello che sei?» Oh, aveva trovata infine una soddisfazione bisognava obbligarla a confessare quello ch’ella era: «Di’ su. Che cosa sei?»
Ella ora, apparentemente estenuata, aveva paura; la faccia sbiancata, lo fissava con uno sguardo che chiedeva compassione. Si lasciava scuotere senza resistenza e a lui parve ch’ella stesse per cadere. Allentò la stretta e la sostenne. Tutt’ad un tratto ella si svincolò e si mise a correre disperatamente. Ella dunque aveva mentito ancora! Egli non avrebbe saputo raggiungerla; si chino, cercò un sasso, e non trovandone raccolse delle pietruzze che le scagliò dietro. Il vento le portò e qualcuna dovette colpirla perché ella gettò un grido di spavento; altre furono arrestate dai rami secchi degli alberi e produssero un rumore sproporzionatissimo all’ira che le aveva lanciate.
Che fare ora? L’ultima soddisfazione cui aveva anelato, gli era stata negata. Ad onta di tanta sua rassegnazione tutto intorno a lui rimaneva rude, senza dolcezza; egli stesso era brutale! Le arterie gli battevano dalla sovraeccitazione; in quel freddo egli ardeva d’ira, di febbre, immobile sulle gambe paralitiche e già era rinato in lui l’osservatore calmo che lo rimproverava.
«Non la rivedrò mai più» disse come per rispondere ad un rimprovero. «Mai! Mai!» E quando poté camminare, questa parola gli risuonò nel rumore dei propri passi e nel sibilo del vento sul paesaggio sconsolato. Sorrise da solo ripassando per i luoghi per cui era venuto e ricordando le idee che lo avevano accompagnato a quell’appuntamento. Come rimaneva sorprendente la realtà!
Non andò subito a casa. Gli sarebbe stato impossibile d’atteggiarsi ad infermiere in quello stato d’animo. Il sogno lo possedeva intero, tanto che non avrebbe saputo dire per quali vie fosse poi rincasato. Oh! Se l’abboccamento con Angiolina fosse stato quale egli l’aveva voluto, avrebbe potuto andare diritto al letto d’Amalia senz’alterare neppure l’espressione della propria faccia.
Scoperse una nuova analogia fra la sua relazione con Angiolina e quella con Amalia. Da entrambe egli si distaccava senza poter dire l’ultima parola che avrebbe addolcito almeno il ricordo delle due donne. Amalia non poteva udirla; ad Angiolina egli non aveva saputo dirla.
 Altra locandina del film del 1962
Altra locandina del film del 1962
Il passo inizia mettendo in risalto il senso di colpa: se la relazione con Angiolina non può essere confrontata con la malattia d’Amalia, lo stesso si può dire riguardo la fine del loro rapporto: il male non si decide, avviene. Egli non vuole assumersi nessuna responsabilità, ma tale decisione è determinata dal volersi a sua volta scusare della situazione in cui ha lasciato Amalia. Insomma in lui prevale un senso di rimozione, attraverso cui non basta autoassolversi mentendo sulle reali condizioni. Infatti anche l’autoinganno di dire a se stesso che egli non ha colpa, perché malato, secondo la definizione di Schopenhauer, non può essere valida, in quanto non vi è un rapporto di causa ed effetto tra i due elementi. La descrizione del marinaio è sintomatica: Emilio pensa che se avesse meno pensato alla vita, forse questa stessa gli si sarebbe presentata in forma meno “castrante”: non è così; la vita non si decide come ci appare nell’immagine dell’onda, che si rompe prima di frangersi, è un meccanismo duro, determinato, dalla quale il suo destino non può essere modificato. Anche l’incontro con Angiolina prende una piega inaspettata: lo voleva calmo, rilassante, ma pulsioni interiori lo trasformano in uomo rabbioso; ma questa rabbia, ad osservarla con occhi distaccati, è data dalla non conoscenza della vita e quindi di Angiolina; l’eros seppur vissuto da Emilio è stato idealizzato, tanto che, vissuto realmente lo disgusta. Ci dice Baldi (critico letterario) che alla fine il suo comportamento è da adolescente, con il lancio di pietre verso colei che lo ha deluso. Ma Angiolina è stata la giovinezza, la sua perdita la senilità. L’aveva voluta in bellezza come le era apparsa, ma con l’indole di Amalia, e così gli piace immaginarla:
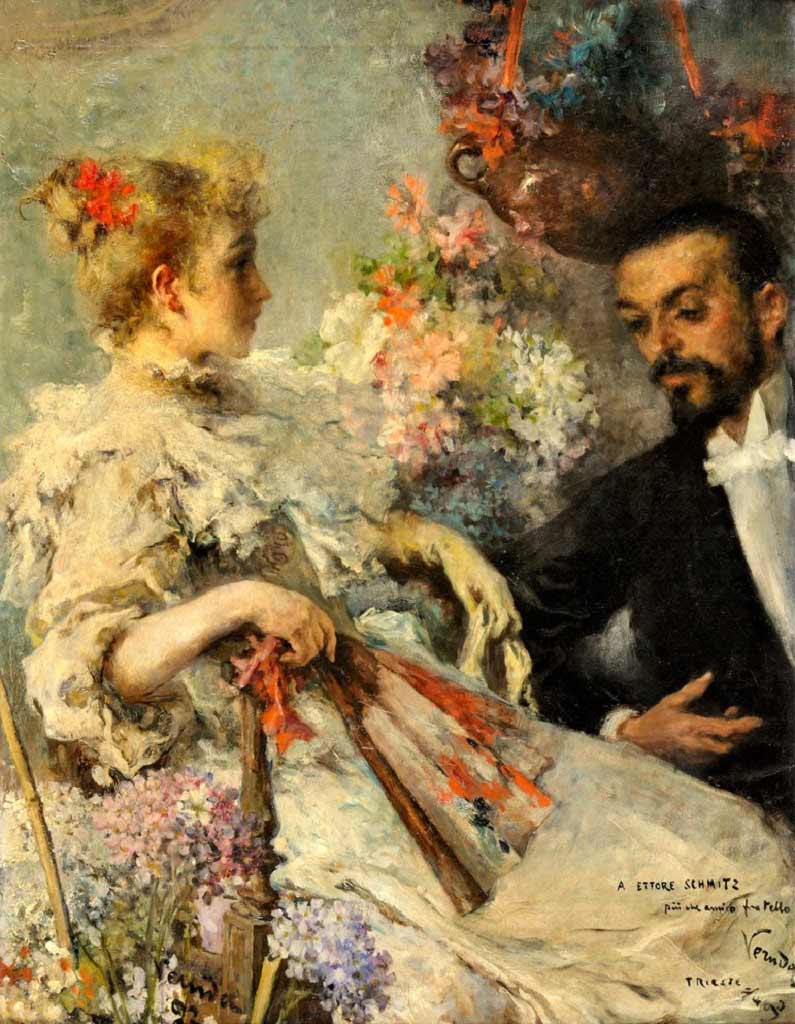 Umberto Veruda: Svevo con la sorella Ortensia
Umberto Veruda: Svevo con la sorella Ortensia
LA METAMORFOSI DI ANGIOLINA
Lungamente la sua avventura lo lasciò squilibrato, malcontento. Erano passati per la sua vita l’amore e il dolore e, privato di questi elementi, si trovava ora col sentimento di colui cui è stata amputata una parte importante del corpo. Il vuoto però finì coll’essere colmato. Rinacque in lui l’affetto alla tranquillità, alla sicurezza, e la cura di se stesso gli tolse ogni altro desiderio. Anni dopo egli s’incantò ad ammirare quel periodo della sua vita, il più importante, il più luminoso. Ne visse come un vecchio del ricordo della gioventù. Nella sua mente di letterato ozioso, Angiolina subì una metamorfosi strana. Conservò inalterata la sua bellezza, ma acquistò anche tutte le qualità d’Amalia che morì in lei una seconda volta. Divenne triste, sconsolantemente inerte, ed ebbe l’occhio limpido ed intellettuale. Egli la vide dinanzi a sé come su un altare, la personificazione del pensiero e del dolore e l’amò sempre, se amore è ammirazione e desiderio. Ella rappresentava tutto quello di nobile ch’egli in quel periodo avesse pensato od osservato. Quella figura divenne persino un simbolo. Ella guardava sempre dalla stessa parte, l’orizzonte, l’avvenire da cui partivano i bagliori rossi che si riverberavano sulla sua faccia rosea, gialla e bianca. Ella aspettava! L’immagine concretava il sogno ch’egli una volta aveva fatto accanto ad Angiolina e che la figlia del popolo non aveva compreso. Quel simbolo alto, magnifico, si rianimava talvolta per ridivenire donna amante, sempre però donna triste e pensierosa. Sì! Angiolina pensa e piange! Pensa come se le fosse stato spiegato il segreto dell’universo e della propria esistenza; piange come se nel vasto mondo non avesse più trovato neppure un Deo gratias qualunque.
E’ passato un anno. Angiolina è scappata con un cassiere infedele di una banca. E’ finita. Ora che non c’è più, la può pensare, immaginare. L’assenza è più semplice da sopportare, così come il ricordo più dolce da pensare. E’ stata infedele, leggera, ignorante, bella certo, ma vuota. Ed è proprio il vuoto, l’immagine esteriore che permane, che immagina riempito dei buoni sentimenti della purezza d’Amalia a farne una sola immagine, cogli occhi rivolti verso “il sol dell’avvenire”, come aveva tentato d’insegnarle, senza alcun risultato. Ma ciò porta Emilio ad autoingannarsi ancora: la mistificazione che fa di Angiolina, vedendola come simbolo del socialismo, non è che l’affermazione di chi non sa vivere o non accetta vivere e di fronte al dolore di questa incapacità continua a mentirsi e a autosuggestionarsi per eliminare i particolari sgradevoli di una realtà e sostituirvi una visione confortante ma falsa.

Svevo
Il capolavoro di Italo Svevo è La coscienza di Zeno, che lo proietta fra i grandi del romanzo europeo.
Zeno Cosini ha deciso di smettere il fumo e tenta, come estrema risorsa, la psicoanalisi. Seguendo il consiglio del medico fissa perciò sulla carta gli episodi della sua vita che gli paiono salienti: il fumo, la penosa fine del padre, che male intendendo un gesto del figlio alza la mano contro di lui proprio un attimo prima di morire; la gelosia per l’amico Guido; il matrimonio con una delle sorelle Malfenti, quella che meno gli piaceva; il suicidio di Guido; la relazione con una povera figliola, di cui, però, si stanca presto. Alla radice di tutti questi avvenimenti c’è una personalità abulica, incapace di vera partecipazione attiva, che diventa simbolo dell’elusiva, inguaribile malattia dell’uomo moderno; mentre nelle ultime righe del romanzo è contenuta la profezia di “una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni” attraverso la quale l’umanità, forse, guarirà dai germi di cui si nutre e troverà la salute in un mondo asettico.
Viene iniziato nel 1919 e pubblicato nel 1923 ed anche questo, come gli altri due, passa assolutamente inosservato. Vogliamo qui ricordare che James Joyce, rimasto a Trieste dal 1904 al 1914, fece lezioni d’inglese a Italo Svevo e ne nacque un’amicizia. Proprio tale amicizia portò Svevo a mandare copia del romanzo allo scrittore irlandese che, impressionato dalla forza della narrazione, lo fece leggere ai parigini, studiosi di italianistica, Valéry Larbaud e Benjamin Crémieux, che definendo il testo di Svevo “libro ammirevole” lo tradussero e lanciarono in Europa. Intanto in Italia anche Eugenio Montale si accorse della capacità dirompente del testo e nel 1926, all’interno della rivista L’Esame scrisse Omaggio a Italo Svevo, iniziando così la sua fortuna critica anche nel nostro paese.

Svevo e Joyce
L’opera è strutturata da sei capitoli, definiti nella trama del libro, preceduti da altri due Prefazione e Preambolo, e seguiti da quello intitolato Psicoanalisi. Già dal titolo l’opera presenza problemi di non facile definizione. Cosa vuol dire, infatti coscienza? Problema posto soprattutto dai traduttori:
- coscienza morale;
- attività psicologica;
- presa di coscienza;
- inconscio;
il problema è che Svevo utilizza tale termine in tutti i significati sopra esposti, non fornendo una spiegazione, pertanto un solo modo di intendere l’opera, ma di lasciare il lettore di fronte all’ambiguità dell’intero testo, ambiguità che prosegue proprio all’inizio dell’opera stessa:

Svevo
PREFAZIONE
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!…
DOTTOR S.
L’incipit non viene lasciato ad un narratore interno (vedremo che questa è la tecnica con cui verrà scritto il romanzo), ma ad un ipotetico dottor S(igmund) il quale ci pone di fronte a tre problemi:
- ciò che leggeremo è il frutto di una terapia psicoanalitica imposta dal medico al paziente al fine di rievocare i fatti salienti della sua vita per fini terapeutici;
- essendo la scrittura di tipo mnemonico razionale, a volte inconscia, e dettata inoltre dall’odio del paziente per il medico, non sapremo mai quanto egli razionalmente voglia dire o nascondere o inventare al terapeuta e quali suoi ricordi, rivelatasi inconsciamente, siano stati invece “censurati”: in una parola, ciò che dice Zeno è fortemente inattendibile;
- se inattendibile è Svevo, altrettanto lo è il medico: un terapeuta non si vendica contro il paziente (tutt’al più lo licenzia) e meno che mai, per deontologia professionale, pubblica il suo diario.
Dopo aver ricordato la difficoltà del ricordo ab ovo, come ci dice nel preambolo, non senza ironia, comincia dal problema per cui ha iniziato la terapia:

Immagine ispirata al fumo di Zeno
IL FUMO
Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia propensione al fumo: «Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero.»
Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella poltrona. Non so come cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non esistono più in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però a commovermi per l’impensato incontro. Tento di ottenere di più e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo.
Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l’altra, mio fratello, di un anno di me più giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto del furto.
Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato.
Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare. Cioè… rubai ancora, ma senza saperlo. Mio padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca, Catina, li buttasse via. Andavo a fumarli di nascosto. Già all’atto d’impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo sapendo quale malessere m’avrebbero procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si contorcesse.
Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia.
(…)
Ricordo di aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché seguito da un forte disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz’ora in una cantina oscura insieme a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella memoria altro che la puerilità del vestito: Due paia di calzoncini che stanno in piedi perché dentro c’è stato un corpo che il tempo eliminò. Avevamo molte sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare di più nel breve tempo. Io vinsi, ed eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi uscimmo al sole e all’aria. Dovetti chiudere gli occhi per non cadere stordito.
Mi rimisi e mi vantai della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora: «A me non importa di aver perduto perché io non fumo che quanto m’occorre».
Ricordo la parola sana e non la faccina certamente sana anch’essa che a me doveva essere rivolta in quel momento. Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi a vent’anni circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento male di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola assoluta! Mi ferì e la febbre la colorì: Un vuoto grande e niente per resistere all’enorme pressione che subito si produce attorno ad un vuoto.
Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto di sigaro in bocca restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante, mi disse: «Non fumare, veh!»
Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: “Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per l’ultima volta”. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: «Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito!»
Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per permettermi di correre alla mia sigaretta.
Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima.
Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo.
Le mie giornate finirono coll’essere piene di sigarette e di propositi di non fumare più e, per dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. La ridda delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si muove tuttavia. Meno violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vecchio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto. Posso anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette… che non sono le ultime.
Sul frontispizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato: “Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!!”.
Era un’ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l’accompagnarono. M’ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza ch’è la vita stessa benché ridotta in un matraccio. Quell’ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo.
Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo ritornai alla legge.
Pur troppo! Fu un errore e fu anch’esso registrato da un’ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro. Fu importante anche questa e mi rassegnavo di ritornare a quelle complicazioni del mio, del tuo e del suo coi migliori propositi, sciogliendo finalmente le catene del carbonio. M’ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia deficienza di abilità manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo a fumare come un turco?
Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l’uomo ideale e forte che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell’igienista vecchio, descritto dal Goldoni, vorrei morire sano dopo di esser vissuto malato tutta la vita?
Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a mie spese le pareti della stanza perché le avevo coperte di date. Probabilmente lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni propositi e non credevo più possibile di formarne in quel luogo degli altri.
Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quand’è l’ultima. Anche le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. L’ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché accendendole si protesta la propria libertà e il futuro di forza e di salute permane, ma va un po’ più lontano.

Un’altra immagine ispirata al fumo di Zeno
Il racconto inizia con un ricordo preciso: la forma del pacchetto (scatoline di cartone) con le aquile bicipiti, chiaramente sigarette austroungariche. Da qui, quasi con un processo analogico, rievoca i primi furti, il senso di nausea che la sigaretta gli procura, le proibizione del medico di fumare e il suo non rispetto.
Nella seconda parte del brano, il sancire in modo perentorio che quella fumata era “l’ultima sigaretta”, il prendere consapevolezza che il sapore dell’ultima, proprio perché ultima, era il più buono e quindi continuare a fumare, in un circolo vizioso che, fino alla scrittura del diario, non ha ancora fine, denota l’inazione come elemento costitutivo della mente di Zeno (anche adesso, anche se lo smettere dal vizio del fumo non sia affatto una necessità, rinuncia a “decidere”).
L’avere iniziato dal fumo vuol dire che è qui che Zeno vede l’inizio della sua nevrosi, di cui il fumo ne è un sintomo. Ma è proprio nel proposito e nel disattendere ad esso che si misura la vera nevrosi di Zeno: consapevole che il fumo fa male, non è disposto però a rinunciarvi, anzi esso sembra alfine l’elemento che lo mette contro il volere del padre e del medico (l’autorità costituita) e il promettere e la successiva smentita alla promessa stessa sembra rinviare ad una ciclicità temporale in cui ciò che accade continua a ripetersi.
Sembra che in questo brano il nostro ironizzi sia sul tempo, come detto prima, ma anche sulla psicoanalisi: il rubare nel panciotto paterno o rubare i sigari lasciati a metà rimandano a un rapporto conflittuale (o edipico dirà il dottor. S) col padre, svelato anche dal rifiuto all’obbedienza quando è malato; indizi troppo palesi, a livello psicoanalitico, che sembrano scritti apposta per far piacere al medico.
Nel IV capitolo Zeno rivive il momento in cui il padre muore. Esso è preceduto dall’analisi del loro rapporto conflittuale, il Cosini vecchio, borghese sano e ben piantato nella realtà, contro un figlio svagato e perlopiù nevrotico. Ma il momento della morte paterna rappresenta per il trentenne Zeno una “vera catastrofe” psichica:

Italo Svevo anziano
LA MORTE DEL PADRE
Una sera della fine di marzo arrivai un po’ più tardi del solito a casa. Niente di male: ero caduto nelle mani di un dotto amico che aveva voluto confidarmi certe sue idee sulle origini del Cristianesimo. Era la prima volta che si voleva da me ch’io pensassi a quelle origini, eppure m’adattai alla lunga lezione per compiacere l’amico.
Piovigginava e faceva freddo. Tutto era sgradevole e fosco, compresi i Greci e gli Ebrei di cui il mio amico parlava, ma pure m’adattai a quella sofferenza per ben due ore. La mia solita debolezza! Scommetto che oggi ancora sono tanto incapace di resistenza, che se qualcuno ci si mettesse sul serio potrebbe indurmi a studiare per qualche tempo l’astronomia.
Entrai nel giardino che circonda la nostra villa. A questa si accedeva per una breve strada carrozzabile. Maria, la nostra cameriera, m’aspettava alla finestra e sentendomi avvicinare gridò nell’oscurità: «È lei, signor Zeno?»
Maria era una di quelle fantesche come non se ne trovano più. Era da noi da una quindicina d’anni. Metteva mensilmente alla Cassa di Risparmio una parte della sua paga per i suoi vecchi anni, risparmi che però non le servirono perché essa morì in casa nostra poco dopo il mio matrimonio sempre lavorando.
Essa mi raccontò che mio padre era ritornato a casa da qualche ora, ma che aveva voluto attendermi a cena. Allorché essa aveva insistito perché egli intanto mangiasse, era stata mandata via con modi poco gentili. Poi egli aveva domandato di me parecchie volte, inquieto e ansioso. Maria mi fece intendere che pensava che mio padre non si sentisse bene. Gli attribuiva una difficoltà di parola e il respiro mozzo. Debbo dire ch’essendo sempre sola con lui, essa spesso s’era fitto in testa il pensiero ch’egli fosse malato. Aveva poche cose da osservare la povera donna nella casa solitaria e – dopo l’esperienza fatta con mia madre – essa s’aspettava che tutti avessero da morire prima di lei.
Corsi alla camera da pranzo con una certa curiosità e non ancora impensierito. Mio padre si levò subito dal sofà su cui giaceva e m’accolse con una grande gioia che non seppe commovermi perché vi scorsi prima di tutto l’espressione di un rimprovero. Ma intanto bastò a tranquillarmi perché la gioia mi parve un segno di salute. Non scorsi in lui traccia di quel balbettamento e respiro mozzo di cui aveva parlato Maria. Ma, invece di rimproverarmi, egli si scusò d’essere stato caparbio.
«Che vuoi farci?» mi disse bonariamente. «Siamo noi due soli a questo mondo e volevo vederti prima di coricarmi.»
Magari mi fossi comportato con semplicità e avessi preso fra le mie braccia il mio caro babbo divenuto per malattia tanto mite e affettuoso! Invece cominciai a fare freddamente una diagnosi: Il vecchio Silva si era tanto mitigato? Che fosse malato? Lo guardai sospettosamente e non trovai di meglio che di fargli un rimprovero: «Ma perché hai atteso finora per mangiare? Potevi mangiare, eppoi attendermi!»
Egli rise assai giovanilmente: «Si mangia meglio in due.»
Poteva questa lietezza essere anche il segno di un buon appetito: io mi tranquillai e mi misi a mangiare. Con le sue ciabatte di casa, con passo malfermo, egli s’accostò al desco e occupò il suo posto solito. Poi stette a guardarmi come mangiavo, mentre lui, dopo un paio di cucchiaiate scarse, non prese altro cibo e allontanò anche da sé il piatto che gli ripugnava. Ma il sorriso persisteva sulla sua vecchia faccia. Soltanto mi ricordo, come se si trattasse di cosa avvenuta ieri, che un paio di volte ch’io lo guardai negli occhi, egli stornò il suo sguardo dal mio. Si dice che ciò è un segno di falsità, mentre io ora so ch’è un segno di malattia. L’animale malato non lascia guardare nei pertugi pei quali si potrebbe scorgere la malattia, la debolezza.
Egli aspettava sempre di sentire come io avessi impiegato quelle tante ore in cui egli m’aveva atteso. E vedendo che ci teneva tanto, cessai per un istante di mangiare e gli dissi secco, secco, ch’io fino a quell’ora avevo discusse le origini del Cristianesimo.
Mi guardò dubbioso e perplesso: «Anche tu, ora, pensi alla religione?»
Era evidente che gli avrei dato una grande consolazione se avessi accettato di pensarci con lui. Invece io, che finché mio padre era vivo mi sentivo combattivo (e poi non più) risposi con una di quelle solite frasi che si sentono tutti i giorni nei caffè situati presso le Università: «Per me la religione non è altro che un fenomeno qualunque che bisogna studiare.»
«Fenomeno?» fece lui sconcertato. Cercò una pronta risposta e aperse la bocca per darla. Poi esitò e guardò il secondo piatto, che giusto allora Maria gli offerse e ch’egli non toccò. Quindi per tapparsi meglio la bocca, vi ficcò un mozzicone di sigaro che accese e che lasciò subito spegnere. S’era così concessa una sosta per riflettere tranquillamente. Per un istante mi guardò risoluto: «Tu non vorrai ridere della religione?»
Io, da quel perfetto studente scioperato che sono sempre stato, con la bocca piena, risposi: «Ma che ridere! Io studio!»
Egli tacque e guardò lungamente il mozzicone di sigaro che aveva deposto su un piatto. Capisco ora perché egli mi avesse detto ciò. Capisco ora tutto quello che passò per quella mente già torbida, e sono sorpreso di non averne capito nulla allora. Credo che allora nel mio animo mancasse l’affetto che fa intendere tante cose. Poi mi fu tanto facile! Egli evitava di affrontare il mio scetticismo: una lotta troppo difficile per lui in quel momento; ma riteneva di poter attaccarlo mitemente di fianco come conveniva ad un malato. Ricordo che quando parlò, il suo respiro mozzava e ritardava la sua parola. È una grande fatica prepararsi ad un combattimento. Ma pensavo ch’egli non si sarebbe rassegnato di coricarsi senza darmi il fatto mio e mi preparai a discussioni che poi non vennero.
«Io» disse, sempre guardando il suo mozzicone di sigaro oramai spento, «sento come la mia esperienza e la scienza mia della vita sono grandi. Non si vivono inutilmente tanti anni. Io so molte cose e purtroppo non so insegnartele tutte come vorrei. Oh, quanto lo vorrei! Vedo dentro nelle cose, e anche vedo quello ch’è giusto e vero e anche quello che non lo è.»
Non c’era da discutere. Borbottai poco convinto e sempre mangiando: «Sì! Papà!»
Non volevo offenderlo.
«Peccato che sei venuto tanto tardi. Prima ero meno stanco e avrei saputo dirti molte cose.»
Pensai che volesse ancora seccarmi perché ero venuto tardi e gli proposi di lasciare quella discussione per il giorno dopo.
«Non si tratta di una discussione» rispose egli trasognato «ma di tutt’altra cosa. Una cosa che non si può discutere e che saprai anche tu non appena te l’avrò detta. Ma il difficile è dirla!»
Qui ebbi un dubbio: «Non ti senti bene?»
«Non posso dire di star male, ma sono molto stanco e vado subito a dormire.»
Suonò il campanello e nello stesso tempo chiamò Maria con la voce. Quand’essa venne, egli domandò se nella sua stanza tutto era pronto. S’avviò poi subito strascicando le ciabatte al suolo. Giunto accanto a me, chinò la testa per offrirmi la sua guancia al bacio di ogni sera.
Vedendolo moversi così malsicuro, ebbi di nuovo il dubbio che stesse male e glielo domandai. Ripetemmo ambedue più volte le stesse parole ed egli mi confermò ch’era stanco ma non malato. Poi soggiunse: «Adesso penserò alle parole che ti dirò domani. Vedrai come ti convinceranno.»
«Papà» dichiarai io commosso «ti sentirò volentieri.»
Vedendomi tanto disposto a sottomettermi alla sua esperienza, egli esitò di lasciarmi: bisognava pur approfittare di un momento tanto favorevole! Si passò la mano sulla fronte e sedette sulla sedia sulla quale s’era appoggiato per porgermi la sua guancia al bacio. Ansava leggermente.
«Curioso!» disse. «Non so dirti nulla, proprio nulla.» Guardò intorno a sé come se avesse cercato di fuori quello che nel suo interno non arrivava ad afferrare.
«Eppure so tante cose, anzi tutte le cose io so. Dev’essere l’effetto della mia grande esperienza.»
Non soffriva tanto di non saper esprimersi perché sorrise alla propria forza, alla propria grandezza.
Io non so perché non abbia chiamato subito il dottore. Invece debbo confessarlo con dolore e rimorso: considerai le parole di mio padre come dettate da una presunzione ch’io credevo di aver più volte constatata in lui. Non poteva però sfuggirmi l’evidenza della sua debolezza e solo perciò non discussi. Mi piaceva di vederlo felice nella sua illusione di essere tanto forte quand’era invece debolissimo. Ero poi lusingato dall’affetto che mi dimostrava manifestando il desiderio di consegnarmi la scienza di cui si credeva possessore, per quanto fossi convinto di non poter apprendere niente da lui. E per lusingarlo e dargli pace gli raccontai che non doveva sforzarsi per trovare subito le parole che gli mancavano, perché in frangenti simili i più alti scienziati mettevano le cose troppo complicate in deposito in qualche cantuccio del cervello perché si semplificassero da sé.
Egli rispose: «Quello ch’io cerco non è complicato affatto. Si tratta anzi di trovare una parola, una sola e la troverò! Ma non questa notte perché farò tutto un sonno, senza il più piccolo pensiero.»
Tuttavia non si levò dalla sedia. Esitante e scrutando per un istante il mio viso, mi disse: «Ho paura che non saprò dire a te quello che penso, solo perché tu hai l’abitudine di ridere di tutto.»
Mi sorrise come se avesse voluto pregarmi di non risentirmi per le sue parole, si alzò dalla sedia e mi offerse per la seconda volta la sua guancia. Io rinunziai a discutere e convincerlo che a questo mondo v’erano molte cose di cui si poteva e doveva ridere e volli rassicurarlo con un forte abbraccio. Il mio gesto fu forse troppo forte, perché egli si svincolò da me più affannato di prima, ma certo fu da lui inteso il mio affetto, perché mi salutò amichevolmente con la mano.
«Andiamo a letto!» disse con gioia e uscì seguito da Maria.
E rimasto solo (strano anche questo!) non pensai alla salute di mio padre, ma, commosso e – posso dirlo – con ogni rispetto filiale, deplorai che una mente simile che mirava a mete alte, non avesse trovata la possibilità di una coltura migliore. Oggi che scrivo, dopo di aver avvicinata l’età raggiunta da mio padre, so con certezza che un uomo può avere il sentimento di una propria altissima intelligenza che non dia altro segno di sé fuori di quel suo forte sentimento. Ecco: si dà un forte respiro e si accetta e si ammira tutta la natura com’è e come, immutabile, ci è offerta: con ciò si manifesta la stessa intelligenza che volle la Creazione intera. Da mio padre è certo che nell’ultimo istante lucido della sua vita, il suo sentimento d’intelligenza fu originato da una sua improvvisa ispirazione religiosa, tant’è vero che s’indusse a parlarmene perché io gli avevo raccontato di essermi occupato delle origini del Cristianesimo. Ora però so anche che quel sentimento era il primo sintomo dell’edema cerebrale.
Maria venne a sparecchiare e a dirmi che le sembrava che mio padre si fosse subito addormentato. Così andai a dormire anch’io del tutto rasserenato. Fuori il vento soffiava e urlava. Lo sentivo dal mio letto caldo come una ninna nanna che s’allontanò sempre di più da me, perché mi immersi nel sonno.
(…)
Poco dopo ero a letto, ma non seppi chiuder occhio. Guardavo nell’avvenire indagando per trovare perché e per chi avrei potuto continuare i miei sforzi di migliorarmi. Piansi molto, ma piuttosto su me stesso che sul disgraziato che correva senza pace per la sua camera.
Quando mi levai, Maria andò a coricarsi ed io restai accanto a mio padre insieme all’infermiere. Ero abbattuto e stanco; mio padre più irrequieto che mai.
Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano lontano la sua ombra, che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il dolore, fu d’uopo che ogni mio sentimento fosse affievolito dagli anni.
L’infermiere mi disse: «Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza!»
Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel momento, ansante più che mai, l’ammalato s’era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio padre di restare almeno per mezz’ora nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere?
Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedì. Poi esclamò: «Muoio!»
E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò egli poté sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi – sebbene per un momento solo – impedito nei movimenti e gli parve certo ch’io gli togliessi anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto!
Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch’egli, moribondo, aveva voluto darmi. Con l’aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto.
Piangendo, proprio come un bambino punito, gli gridai nell’orecchio: «Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato!»
Era una bugia. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo più: «Ti lascerò movere come vorrai.»
L’infermiere disse: «È morto.»
Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo più provargli la mia innocenza!
Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio padre, ch’era sempre fuori di sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con tanta esattezza da colpire la mia guancia. Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? Pensai persino di dirigermi a Coprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi qualche cosa sulle capacità di risolvere e agire di un moribondo. Potevo anche essere stato vittima di un atto provocato da un tentativo di facilitarsi la respirazione! Ma col dottor Coprosich non parlai. Era impossibile di andar a rivelare a lui come mio padre si fosse congedato da me. A lui, che m’aveva già accusato di aver mancato di affetto per mio padre!
Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo, l’infermiere, in cucina, di sera, raccontava a Maria: «Il padre alzò alto alto la mano e con l’ultimo suo atto picchiò il figliuolo.» Egli lo sapeva e perciò Coprosich l’avrebbe risaputo.
Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. L’infermiere doveva anche avergli ravviata la bella, bianca chioma. La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva superbo e minaccioso. Le sue mani grandi, potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano con tanta naturalezza che parevano pronte ad afferrare e punire. Non volli, non seppi più rivederlo. Poi, al funerale, riuscii a ricordare mio padre debole e buono come l’avevo sempre conosciuto dopo la mia infanzia e mi convinsi che quello schiaffo che m’era stato inflitto da lui moribondo, non era stato da lui voluto. Divenni buono, buono e il ricordo di mio padre s’accompagnò a me, divenendo sempre più dolce. Fu come un sogno delizioso: eravamo oramai perfettamente d’accordo, io divenuto il più debole e lui il più forte.
Ritornai e per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia. Immaginavo che mio padre mi sentisse e potessi dirgli che la colpa non era stata mia, ma del dottore. La bugia non aveva importanza perché egli oramai intendeva tutto ed io pure. E per parecchio tempo i colloqui con mio padre continuarono dolci e celati come un amore illecito, perché io dinanzi a tutti continuai a ridere di ogni pratica religiosa, mentre è vero – e qui voglio confessarlo – che io a qualcuno giornalmente e ferventemente raccomandai l’anima di mio padre. È proprio la religione vera quella che non occorre professare ad alta voce per averne il conforto di cui qualche volta – raramente – non si può fare a meno.
Nella prima parte del brano ci viene presentato l’ultimo colloquio tra padre e figlio. Esso muove, sin da subito, da un processo di rimozione: Zeno, pur “sapendo che è malato”, (ciò ci viene detto nelle pagine precedenti) arriva tardi a casa, dove il padre l’aspetta, forse già sapendo che sarà una delle ultime cene fatte insieme. E’ una situazione che pesa a Zeno e Svevo lo sottolinea, dicendo che il protagonista s’aspetta o immagina che lo sguardo paterno sia di rimprovero.
Il modo di Zeno di rapportarsi con il padre è quasi d’irrisione, egli irride alla religione, al cui padre, sul punto di morire sembra rivolgersi, ma non riesce ad aiutarlo quando lo stesso padre vuole comunicargli l’ultima parola, quella che potrebbe racchiudere il significato di un’intera vita da trasmettere al figlio. Non la trova, e forse capisce che non gliela dirà.
La seconda parte del brano (fra le più famose del romanzo) ci descrive l’ultimo atto di vita del papà che si racchiude nel famoso “schiaffo”. Molto presumibilmente si tratta di un fatto involontario. Ma non importa conoscere la verità: interessa sapere come tale gesto sa stato interpretato dall’inconscio di Zeno. Egli vede nello schiaffo paterno un atto punitivo, sia del momento stesso in cui “sembrava” che il figlio gli stesse togliendo l’aria, sia più generalmente per la sua vita di perfetta inettitudine. Non è un caso che la reazione del trentenne Zeno sia di regressione infantile, quasi a volere dire al padre “non lo faccio più”, ma tale regressione non risolve i problemi conflittuali che egli ha con il genitore, anzi l’accentua. Si osservi il modo con cui descrive il padre ormai morto: La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva superbo e minaccioso. Le sue mani grandi, potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano con tanta naturalezza che parevano pronte ad afferrare e punire. E’ ancora un padre potente che lo sovrasta e che gli ha assestato quello schiaffo per punirlo di quel senso di colpa che ora prova perché egli ha desiderato, sin dalla giovane età in cui gli rimproverava il suo fallimento mostrandogli la sua tenace forza e sanità, la sua morte. Dal senso di colpa alla rimozione dello stesso. Dimenticare il padre severo e vederlo debole e buono, e quindi il venir meno ad ogni aspetto conflittuale, io divenuto il più debole e lui il più forte. Solo così può immaginare che quel gesto sia stato involontario e quindi senza colpa e regredendo ancora come un fanciullo, dire al padre che non era colpa sua, ma del dottore. Inoltre può solo ora placare il suo senso di colpa, a cui contrappone una irreligiosità di facciata, ma raccomanda l’anima paterna a Dio, che solo in sua assenza può stare “in pace” nei suoi pensieri.
Altro passo fondamentale è quello del fidanzamento:

Una foto con Svevo giovane, la moglie e la figlia
ZENO SI FIDANZA
Allora avvenne una cosa di minima importanza, ma che fu per me decisiva. Da una stanza abbastanza lontana da noi echeggiarono le urla della piccola Anna. Come si seppe poi, era caduta insanguinandosi le labbra. Fu così ch’io per qualche minuto mi trovai solo con Ada perché tutti uscirono di corsa dal salotto. Guido, prima di seguire gli altri, aveva posto il suo prezioso violino nelle mani di Ada.
«Volete dare a me quel violino?» domandai io ad Ada vedendola esitante se seguire gli altri. Davvero che non m’ero ancora accorto che l’occasione tanto sospirata s’era finalmente presentata.
Ella esitò, ma poi una sua strana diffidenza ebbe il sopravvento. Trasse il violino ancora meglio a sé: «No» rispose, «non occorre ch’io vada con gli altri. Non credo che Anna si sia fatta tanto male. Essa strilla per nulla.»
Sedette col suo violino e a me parve che con quest’atto essa m’avesse invitato di parlare. Del resto, come avrei potuto io andar a casa senz’aver parlato? Che cosa avrei poi fatto in quella lunga notte? Mi vedevo ribaltarmi da destra a sinistra nel mio letto o correre per le vie o le bische in cerca di svago. No! Non dovevo abbandonare quella casa senz’essermi procurata la chiarezza e la calma. Cercai di essere semplice e breve. Vi ero anche costretto perché mi mancava il fiato.
Le dissi: «Io vi amo, Ada. Perché non mi permettereste di parlarne a vostro padre?»
Ella mi guardò stupita e spaventata. Temetti che si mettesse a strillare come la piccina, là fuori. Io sapevo che il suo occhio sereno e la sua faccia dalle linee tanto precise non sapevano l’amore, ma tanto lontana dall’amore come ora, non l’avevo mai vista. Incominciò a parlare e disse qualcosa che doveva essere come un esordio. Ma io volevo la chiarezza: un sì o un no! Forse m’offendeva già quanto mi pareva un’esitazione. Per fare presto e indurla a decidersi, discussi il suo diritto di prendersi tempo: «Ma come non ve ne sareste accorta? A voi non era possibile di credere ch’io facessi la corte ad Augusta!»
Volli mettere dell’enfasi nelle mie parole, ma, nella fretta, la misi fuori di posto e finì che quel povero nome di Augusta fu accompagnato da un accento e da un gesto di disprezzo.
Fu così che levai Ada dall’imbarazzo. Essa non rilevò altro che l’offesa fatta ad Augusta: «Perché credete di essere superiore ad Augusta? Io non penso mica che Augusta accetterebbe di divenire vostra moglie!»
Poi appena ricordò che mi doveva una risposta: «In quanto a me… mi meraviglia che vi sia capitata una cosa simile in testa.»
La frase acre doveva vendicare l’Augusta. Nella mia grande confusione pensai che anche il senso della parola non avesse avuto altro scopo; se mi avesse schiaffeggiato credo che sarei stato esitante a studiarne la ragione. Perciò ancora insistetti:« Pensateci, Ada. Io non sono un uomo cattivo. Sono ricco… Sono un po’ bizzarro, ma mi sarà facile di correggermi.»
Anche Ada fu più dolce, ma parlò di nuovo di Augusta. «Pensateci anche voi, Zeno: Augusta è una buona fanciulla e farebbe veramente al caso vostro. Io non posso parlare per conto suo, ma credo…»
Era una grande dolcezza di sentirmi invocare da Ada per la prima volta col mio prenome. Non era questo un invito a parlare ancora più chiaro? Forse era perduta per me, o almeno non avrebbe accettato subito di sposarmi, ma intanto bisognava evitare che si compromettesse di più con Guido sul conto del quale dovevo aprirle gli occhi. Fui accorto, e prima di tutto le dissi che stimavo e rispettavo Augusta, ma che assolutamente non volevo sposarla. Lo dissi due volte per farmi intendere chiaramente: «io non volevo sposarla». Così potevo sperare di aver rabbonita Ada che prima aveva creduto io volessi offendere Augusta. «Una buona, una cara, un’amabile ragazza quell’Augusta; ma non fa per me».
Poi appena precipitai le cose, perché c’era del rumore sul corridoio e mi poteva essere tagliata la parola da un momento all’altro. «Ada! Quell’uomo non fa per voi. È un imbecille! Non v’accorgeste come sofferse per i responsi del tavolino? Avete visto il suo bastone? Suona bene il violino, ma vi sono anche delle scimmie che sanno suonarlo. Ogni sua parola tradisce il bestione…»
Essa, dopo d’esser stata ad ascoltarmi con l’aspetto di chi non sa risolversi ad ammettere nel loro senso le parole che gli sono dirette, m’interruppe. Balzò in piedi sempre col violino e l’arco in mano e mi soffiò addosso delle parole offensive. Io feci del mio meglio per dimenticarle e vi riuscii.
Ricordo solo che cominciò col domandarmi ad alta voce come avevo potuto parlare così di lui e di lei! Io feci gli occhi grandi dalla sorpresa perché mi pareva di non aver parlato che di lui solo. Dimenticai le tante parole sdegnose ch’essa mi diresse, ma non la sua bella, nobile e sana faccia arrossata dallo sdegno e dalle linee rese più precise, quasi marmoree, dall’indignazione. Quella non dimenticai più e quando penso al mio amore e alla mia giovinezza, rivedo la faccia bella e nobile e sana di Ada nel momento in cui essa m’eliminò definitivamente dal suo destino.
Ritornarono tutti in gruppo intorno alla signora Malfenti che teneva in braccio Anna ancora piangente. Nessuno si occupò di me o di Ada ed io, senza salutare nessuno, uscii dal salotto; nel corridoio presi il mio cappello. Curioso! Nessuno veniva a trattenermi. Allora mi trattenni da solo, ricordando ch’io non dovevo mancare alle regole della buona educazione e che perciò prima di andarmene dovevo salutare compitamente tutti. Vero è che non dubito io non sia stato impedito di abbandonare quella casa dalla convinzione che troppo presto sarebbe cominciata per me la notte ancora peggiore delle cinque notti che l’avevano preceduta. Io che finalmente avevo la chiarezza, sentivo ora un altro bisogno: quello della pace, la pace con tutti. Se avessi saputo eliminare ogni asprezza dai miei rapporti con Ada e con tutti gli altri, mi sarebbe stato più facile di dormire. Perché aveva da sussistere tale asprezza? Se non potevo prendermela neppure con Guido il quale se anche non ne aveva alcun merito, certamente non aveva nessuna colpa di essere stato preferito da Ada!
Essa era la sola che si fosse accorta della mia passeggiata sul corridoio e, quando mi vide ritornare, mi guardò ansiosa. Temeva di una scena? Subito volli rassicurarla. Le passai accanto e mormorai: «Scusate se vi ho offesa!»
Essa prese la mia mano e, rasserenata, la strinse. Fu un grande conforto. Io chiusi per un istante gli occhi per isolarmi con la mia anima e vedere quanta pace gliene fosse derivata.
Il mio destino volle che mentre tutti ancora si occupavano della bimba, io mi trovassi seduto accanto ad Alberta. Non l’avevo vista e di lei non m’accorsi che quando essa mi parlò dicendomi: «Non s’è fatta nulla. Il grave è la presenza di papà il quale, se la vede piangere, le fa un bel regalo.»
Io cessai dall’analizzarmi perché mi vidi intero! Per avere la pace io avrei dovuto fare in modo che quel salotto non mi fosse mai più interdetto. Guardai Alberta! Somigliava ad Ada! Era un po’ di lei più piccola e portava sul suo organismo evidenti dei segni non ancora cancellati dell’infanzia. Facilmente alzava la voce, e il suo riso spesso eccessivo le contraeva la faccina e gliel’arrossava. Curioso! In quel momento ricordai una raccomandazione di mio padre: “Scegli una donna giovine e ti sarà più facile di educarla a modo tuo”. Il ricordo fu decisivo. Guardai ancora Alberta. Nel mio pensiero m’industriavo di spogliarla e mi piaceva così dolce e tenerella come supposi fosse.
Le dissi: «Sentite, Alberta! Ho un’idea: avete mai pensato che siete nell’età di prendere marito?»
«Io non penso di sposarmi!» disse essa sorridendo e guardandomi mitemente, senz’imbarazzo o rossore. «Penso invece di continuare i miei studii. Anche mamma lo desidera.»
«Potreste continuare gli studii anche dopo sposata.»
Mi venne un’idea che mi parve spiritosa e le dissi subito: «Anch’io penso d’iniziarli dopo essermi sposato.»
Essa rise di cuore, ma io m’accorsi che perdevo il mio tempo, perché non era con tali scipitezze che si poteva conquistare una moglie e la pace. Bisognava essere serii. Qui poi era facile perché venivo accolto tutt’altrimenti che da Ada. Fui veramente serio. La mia futura moglie doveva intanto sapere tutto.
Con voce commossa le dissi: «Io, poco fa, ho indirizzata ad Ada la stessa proposta che ora feci a voi. Essa rifiutò con sdegno. Potete figurarvi in quale stato io mi trovi.»
Queste parole accompagnate da un atteggiamento di tristezza non erano altro che la mia ultima dichiarazione d’amore per Ada. Divenivo troppo serio e, sorridendo, aggiunsi: «Ma credo che se voi accettaste di sposarmi, io sarei felicissimo e dimenticherei per voi tutto e tutti.»
Essa si fece molto seria per dirmi: «Non dovete offendervene, Zeno, perché mi dispiacerebbe. Io faccio una grande stima di voi. So che siete un buon diavolo eppoi, senza saperlo, sapete molte cose, mentre i miei professori sanno esattamente tutto quello che sanno. Io non voglio sposarmi. Forse mi ricrederò, ma per il momento non ho che una mèta: vorrei diventare una scrittrice. Vedete quale fiducia vi dimostro. Non lo dissi mai a nessuno e spero non mi tradirete. Dal canto mio, vi prometto che non ripeterò a nessuno la vostra proposta.»
«Ma anzi potete dirlo a tutti!» la interruppi io con stizza.
Mi sentivo di nuovo sotto la minaccia di essere espulso da quel salotto e corsi al riparo. C’era poi un solo modo per attenuare in Alberta l’orgoglio di aver potuto respingermi ed io l’adottai non appena lo scopersi. Le dissi: «Io ora farò la stessa proposta ad Augusta e racconterò a tutti che la sposai perché le sue due sorelle mi rifiutarono!»
Ridevo di un buon umore eccessivo che m’aveva colto in seguito alla stranezza del mio procedere. Non era nella parola che mettevo lo spirito di cui ero tanto orgoglioso, ma nelle azioni.
Mi guardai d’intorno per trovare Augusta. Era uscita sul corridoio con un vassoio sul quale non v’era che un bicchiere semivuoto contenente un calmante per Anna. La seguii di corsa chiamandola per nome ed essa s’addossò alla parete per aspettarmi. Mi misi a lei di faccia e subito le dissi: «Sentite, Augusta, volete che noi due ci sposiamo?»
La proposta era veramente rude. Io dovevo sposare lei e lei me, ed io non domandavo quello ch’essa pensasse né pensavo potrebbe toccarmi di essere io costretto di dare delle spiegazioni. Se non facevo altro che quello che tutti volevano!
Essa alzò gli occhi dilatati dalla sorpresa. Così quello sbilenco era anche più differente del solito dall’altro. La sua faccia vellutata e bianca, dapprima impallidì di più, eppoi subito si congestionò. Afferrò con la destra il bicchiere che ballava sul vassoio.
Con un filo di voce mi disse: «Voi scherzate e ciò è male.
Temetti si mettesse a piangere ed ebbi la curiosa idea di consolarla dicendole della mia tristezza.»
«Io non scherzo,» dissi serio e triste. «Domandai dapprima la sua mano ad Ada che me la rifiutò con ira, poi domandai ad Alberta di sposarmi ed essa, con belle parole, vi si rifiutò anch’essa. Non serbo rancore né all’una né all’altra. Solo mi sento molto, ma molto infelice.»
Dinanzi al mio dolore essa si ricompose e si mise a guardarmi commossa, riflettendo intensamente. Il suo sguardo somigliava ad una carezza che non mi faceva piacere.
«Io devo dunque sapere e ricordare che voi non mi amate?» domandò.
Che cosa significava questa frase sibillina? Preludiava ad un consenso? Voleva ricordare! Ricordare per tutta la vita da trascorrersi con me? Ebbi il sentimento di chi per ammazzarsi si sia messo in una posizione pericolosa ed ora sia costretto a faticare per salvarsi. Non sarebbe stato meglio che anche Augusta m’avesse rifiutato e che mi fosse stato concesso di ritornare sano e salvo nel mio studiolo nel quale neppure quel giorno stesso m’ero sentito troppo male?
Le dissi: «Sì! Io non amo che Ada e sposerei ora voi…»
Stavo per dirle che non potevo rassegnarmi di divenire un estraneo per Ada e che perciò mi contentavo di divenirle cognato. Sarebbe stato un eccesso, ed Augusta avrebbe di nuovo potuto credere che volessi dileggiarla. Perciò dissi soltanto: «Io non so più rassegnarmi di restar solo.»
Essa rimaneva tuttavia poggiata alla parete del cui sostegno forse sentiva il bisogno; però pareva più calma ed il vassoio era ora tenuto da una sola mano. Ero salvo e cioè dovevo abbandonare quel salotto, o potevo restarci e dovevo sposarmi? Dissi delle altre parole, solo perché impaziente di aspettare le sue che non volevano venire: «Io sono un buon diavolo e credo che con me si possa vivere facilmente anche senza che ci sia un grande amore. Questa era una frase che nei lunghi giorni precedenti avevo preparata per Ada per indurla a dirmi di sì anche senza sentire per me un grande amore.
Augusta ansava leggermente e taceva ancora. Quel silenzio poteva anche significare un rifiuto, il più delicato rifiuto che si potesse immaginare: io quasi sarei scappato in cerca del mio cappello, in tempo per porlo su una testa salva.
Invece Augusta, decisa, con un movimento dignitoso che mai dimenticai, si rizzò e abbandonò il sostegno della parete. Nel corridoio non largo essa si avvicinò così ancora di più a me che le stavo di faccia. Mi disse: «Voi, Zeno, avete bisogno di una donna che voglia vivere per voi e vi assista. Io voglio essere quella donna».
Mi porse la mano paffutella ch’io quasi istintivamente baciai. Evidentemente non c’era più la possibilità di fare altrimenti. Devo poi confessare che in quel momento fui pervaso da una soddisfazione che m’allargò il petto. Non avevo più da risolvere niente, perché tutto era stato risolto. Questa era la vera chiarezza.
Fu così che mi fidanzai. Fummo subito festeggiatissimi. Il mio somigliava un poco al grande successo del violino di Guido, tanti furono gli applausi di tutti. Giovanni mi baciò e mi diede subito del tu. Con eccessiva espressione di affetto mi disse: «Mi sentivo tuo padre da molto tempo, dacché cominciai a darti dei consigli per il tuo commercio. La mia futura suocera mi porse anch’essa la guancia che sfiorai. A quel bacio non sarei sfuggito neppure se avessi sposato Ada. «Vede ch’io avevo indovinato tutto», mi disse con una disinvoltura incredibile e che non fu punita perché io non seppi né volli protestare.
Essa poi abbracciò Augusta e la grandezza del suo affetto si rivelò in un singhiozzo che le sfuggì interrompendo le sue manifestazioni di gioia. Io non potevo soffrire la signora Malfenti, ma devo dire che quel singhiozzo colorì, almeno per tutta quella sera, di una luce simpatica e importante il mio fidanzamento.
Alberta, raggiante, mi strinse la mano: «Io voglio essere per voi una buona sorella».
E Ada: «Bravo, Zeno!» Poi, a bassa voce: «Sappiatelo: giammai un uomo che creda di aver fatta una cosa con precipitazione, ha agito più saviamente di voi».
Guido mi diede una grande sorpresa: «Da questa mattina avevo capito che volevate una o l’altra delle signorine Malfenti, ma non arrivavo a sapere quale».
Zeno cerca moglie, o meglio Zeno cerca un padre. Il signor Malfenti, agente di borsa, conosciuto per affari, ne ha tutte le caratteristiche, infatti verso di lui può in qualche modo proiettare il suo odio verso il suocero/padre (non per niente è capace di dare consigli al suo genero e nel contempo fregarlo).
Il signor Malfenti ha quattro figlie, tutte col nome iniziante per A: Ada, Alberta, Augusta ed Anna.
Così come cerca un padre, Zeno allo stesso modo cerca una moglie, sostituta della madre, persa quando lui aveva appena quindici anni. Le quattro ragazze sono quindi interscambiabili, ma questo certo non può ammetterlo né allo psicoanalista né a se stesso. D’altra parte è evidente nella lettura del brano come egli non cerchi di conquistare una donna, ma solo di “ottenere” una moglie.
Il fidanzamento è preceduto da un episodio fortemente significativo, che avviene durante una seduta spiritica, organizzata, tra l’altro, da colui che diventerà il suo antagonista in amore:
Mi piaceva ch’egli continuasse ad occuparsi del tavolino. Oramai era evidente che Ada si rassegnava di portare quasi tutto il mio peso! Se non m’avesse amato non m’avrebbe sopportato. Era venuta l’ora della chiarezza. Tolsi la mia destra dal tavolino e pian pianino le posi il braccio alla taglia: «Io vi amo, Ada!» dissi a bassa voce e avvicinando la mia faccia alla sua per farmi sentire meglio. La fanciulla non rispose subito. Poi, con un soffio di voce, però quella di Augusta, mi disse: «Perché non veniste per tanto tempo?» La sorpresa e il dispiacere quasi mi facevano crollare dal mio sedile. Subito sentii che se io dovevo finalmente eliminare quella seccante fanciulla dal mio destino, pure dovevo usarle il riguardo che un buon cavaliere quale son io, deve tributare alla donna che lo ama e sia dessa la più brutta che mai sia stata creata. Come m’amava! Nel mio dolore sentii il suo amore.
Si tratta di un vero e proprio lapsus freudiano, cioè un conflitto psichico per cui vi è un contrasto tra esigente interne e ciò che volontariamente desideriamo; in altre parole una vera e propria rimozione. Questo è per chiarire che l’atteggiamento di Zeno, alquanto goffo all’interno di casa Malfenti, risponde ad una esigenza già maturata al suo interno, ma della quale non si vuole rendere conto.
Egli chiede ad Ada di sposarlo, ma sa che ciò non potrà mai avvenire: è bella, seria, ha qualità impari rispetto alla debolezza di lui, e ciò gli avrebbe richiesto un continuo sforzo morale, che egli non può sostenere. Alberta, che vuole continuare gli studi, lo avrebbe messo di fronte alle sue responsabilità di eterno studente; appunto l’unica è la non bella Augusta, la quale, tuttavia finirà per essere, per lui, la moglie ideale. E lo è in quanto possiede una salute “malata”, così come la definisce nel IV capitolo, quello dedicato alla sua relazione extraconiugale:

La famiglia di Svevo al completo
LA PERSONIFICAZIONE DELLA SALUTE
Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche settimana dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com’essa amava me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e m’aspettavo che la seguente fosse tutt’altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all’altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche – ciò ch’era la sorpresa – mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi diceva: «Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pur io che sono tanto più ignorante di te!»
Non so più se dopo o prima dell’affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di poter finire col somigliare ad Augusta ch’era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non avevo neppur intravvista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi Ada e Guido. La lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di Augusta.
Altro che il suo rossore! Quando questo sparve con la semplicità con cui i colori dell’aurora spariscono alla luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle su questa terra, quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell’ordine o che altrimenti a tutto rinunziano. Per quanto la sapessi mal fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. Di fronte ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si trattava di spiritismo. Questo poteva essere e poteva perciò esistere anche la fede nella vita.
Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita eterna. Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che tutti dovevano morire, ma ciò non toglieva che oramai ch’eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto breve, breve, breve, che non s’intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu dopo di non essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi dall’infettare chi a me s’era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo movermi come un uomo sano.
Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di natura. Se anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare! Tutt’altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano un’importanza enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, quello da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto.
Di domenica essa andava a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l’immagine del dolore e della morte. Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno.
C’erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per associarmi anche a quel suo rispetto. Poi v’erano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli studii regolari per salvarci quando – Dio non voglia – ci avesse a toccare qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassù e quaggiù, per lei vi sarebbe stata la salvezza.
Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia. E, scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o d’istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio.
Augusta, (come il padre d’altronde) rappresenta le certezza, sicura ad ogni verità precostituita: non domanda il perché delle cose, le vive. A Zeno ciò lo conforterebbe, potrebbe, se così si può dire, approdare anche lui a tutte quelle certezze che la moglie gli mette di fronte: l’istituzione matrimoniale, la Chiesa e lo Stato: se il protagonista ci fosse arrivato, sarebbe diventato un ottimo borghese e padre di famiglia (come il signor Cosini). Ma notiamo come nel narratore Svevo e quindi anche nel protagonista, vi sia quasi una forma d’irrisione nel mettere in rilievo la sua limitatezza culturale: Augusta non ha profondità, non ha pensiero, vive ne presente, contentandosi di ciò che questo presente le offre.
Ma per Svevo, chi rimane ancorato a tale presente, risulterà infine perdente, perché rimarrà inquinato dai veleni, non avendo possibilità di difendersi; ecco allora come la personificazione della salute, alla fine, sia una vera e propria “malattia”. Zeno, rimanendo fuori, cioè sapendo criticare il meccanismo di tale vita, potrà infine salvarsi.
Di vero e proprio atto mancato si parla al VII capitolo, dedicato all’associazione commerciale. Infatti, dopo il suo matrimonio e quello di Ada e Guido, quest’ultimo si dimostra un pessimo uomo d’affari. Giocando in borsa, dilapida il patrimonio lasciatogli dal padre e quindi finge un tentativo di suicidio per ottenere un aiuto finanziario dalla famiglia di lei; oltre agli affari, anche il matrimonio con Ada sembra vada verso una irreparabile crisi. Si rimette a giocare in borsa e le cose, invece di migliorare, peggiorano. Con le dovute precauzioni simula di nuovo un tentativo di suicidio, a cui, questa volta, la moglie non crede. Accortasi del reale pericolo cui corre il marito, nel momento in cui chiama il dottore, è troppo tardi. Tutti i debiti di Guido sono ora sulle spalle di Zeno. Lo stesso assicura a sua cognata il suo aiuto e la partecipazione ai funerali di suo marito:

Vecchia foto di un funerale dei fratelli Alinari
AL FUNERALE
Parlammo insieme per molte ore, ma la proposta del Nilini* di proseguire nel gioco iniziato da Guido, arrivò in ultimo, poco prima del mezzodì e fu subito accettata da me. L’accettai con una gioia tale come se così fossi riuscito di far rivivere il mio amico. Finì che io comperai a nome del povero Guido una quantità di altre azioni dal nome bizzarro: Rio Tinto, South French e così via.
Così s’iniziarono per me le cinquanta ore di massimo lavoro cui abbia atteso in tutta la mia vita. Dapprima e fino a sera restai a misurare a grandi passi su e giù l’ufficio in attesa di sentire se i miei ordini fossero stati eseguiti.
Io temevo che alla Borsa si fosse risaputo del suicidio di Guido e che il suo nome non venisse più ritenuto buono per impegni ulteriori. Invece per varii giorni non si attribuì quella morte a suicidio.
Poi, quando il Nilini finalmente poté avvisarmi che tutti i miei ordini erano stati eseguiti, incominciò per me una vera agitazione, aumentata dal fatto che al momento di ricevere gli stabiliti, fui informato che su tutti io perdevo già qualche frazione abbastanza importante. Ricordo quell’agitazione come un vero e proprio lavoro. Ho la curiosa sensazione nel mio ricordo che ininterrottamente, per cinquanta ore, io fossi rimasto assiso al tavolo da giuoco succhiellando le carte. Io non conosco nessuno che per tante ore abbia saputo resistere ad una fatica simile. Ogni movimento di prezzo fu da me registrato, sorvegliato, eppoi (perché non dirlo?) ora spinto innanzi ed ora trattenuto, come a me, ossia al mio povero amico, conveniva. Persino le mie notti furono insonni.
Temendo che qualcuno della famiglia avesse potuto intervenire ad impedirmi l’opera di salvataggio cui m’ero accinto, non parlai a nessuno della liquidazione di metà del mese quando giunse. Pagai tutto io, perché nessun altro si ricordò di quegli impegni, visto che tutti erano intorno al cadavere che attendeva la tumulazione. Del resto, in quella liquidazione era da pagare meno di quanto fosse stato stabilito a suo tempo, perché la fortuna m’aveva subito assecondato. Era tale il mio dolore per la morte di Guido, che mi pareva di attenuarlo compromettendomi in tutti i modi tanto con la mia firma che con l’esposizione del mio danaro. Fin qui m’accompagnava il sogno di bontà che avevo fatto lungo tempo prima accanto a lui. Soffersi tanto di quell’agitazione, che non giuocai mai più in Borsa per conto mio.
Ma a forza di “succhiellare” (questa era la mia occupazione precipua) finii col non intervenire al funerale di Guido. La cosa avvenne così. Proprio quel giorno i valori in cui eravamo impegnati fecero un balzo in alto. Il Nilini ed io passammo il nostro tempo a fare il calcolo di quanto avessimo ricuperato della perdita. Il patrimonio del vecchio Speier figurava ora solamente dimezzato! Un magnifico risultato che mi riempiva di orgoglio. Avveniva proprio quello che il Nilini aveva preveduto in tono molto dubitativo bensì ma che ora, naturalmente, quando ripeteva le parole dette, spariva ed egli si presentava quale un sicuro profeta. Secondo me egli aveva previsto questo e anche il contrario. Non avrebbe fallato mai, ma non glielo dissi perché a me conveniva ch’egli restasse nell’affare con la sua ambizione.
Anche il suo desiderio poteva influire sui prezzi.
Partimmo dall’ufficio alle tre e corremmo perché allora ricordammo che il funerale doveva aver luogo alle due e tre quarti. All’altezza dei volti di Chiozza, vidi in lontananza il convoglio e mi parve persino di riconoscere la carrozza di un amico mandata al funerale per Ada. Saltai col Nilini in una vettura di piazza, dando ordine al cocchiere di seguire il funerale. E in quella vettura il Nilini ed io continuammo a succhiellare. Eravamo tanto lontani dal pensiero al povero defunto che ci lagnavamo dell’andatura lenta della vettura. Chissà quello che intanto avveniva alla Borsa non sorvegliata da noi? Il Nilini, a un dato momento, mi guardò proprio con gli occhi e mi domandò perché non facessi alla Borsa qualche cosa per conto mio.
«Per il momento» dissi io, e non so perché arrossissi, «io non lavoro che per conto del mio povero amico.» Quindi, dopo una lieve esitazione, aggiunsi: «Poi penserò a me stesso.» Volevo lasciargli la speranza di poter indurmi al giuoco sempre nello sforzo di conservarmelo interamente amico.
Ma fra me e me formulai proprio le parole che non osavo dirgli: “Non mi metterò mai in mano tua!” Egli si mise a predicare.
«Chissà se si può cogliere un’altra simile occasione!» Dimenticava d’avermi insegnato che alla Borsa v’era l’occasione ad ogni ora.
Quando si arrivò al posto dove di solito le vetture si fermano, il Nilini sporse la testa dalla finestra e diede un grido di sorpresa. La vettura continuava a procedere dietro al funerale che s’avviava al cimitero greco. «Il signor Guido era greco?» domandò sorpreso.
Infatti il funerale passava oltre al cimitero cattolico e s’avviava a qualche altro cimitero, giudaico, greco, protestante o serbo.
«Può essere che sia stato protestante!» dissi io dapprima, ma subito mi ricordai d’aver assistito al suo matrimonio nella chiesa cattolica.
«Dev’essere un errore!» esclamai pensando dapprima che volessero seppellirlo fuori di posto.
Il Nilini improvvisamente scoppiò a ridere di un riso irrefrenabile che lo gettò privo di forze in fondo alla vettura con la sua boccaccia spalancata nella piccola faccia.
«Ci siamo sbagliati!» esclamò.
Quando arrivò a frenare lo scoppio della sua ilarità, mi colmò di rimproveri. Io avrei dovuto vedere dove si andava perché io avrei dovuto sapere l’ora e le persone ecc. Era il funerale di un altro!
Irritato, io non avevo riso con lui ed ora m’era difficile di sopportare i suoi rimproveri. Perché non aveva guardato meglio anche lui? Frenai il mio malumore solo perché mi premeva più la Borsa, che il funerale. Scendemmo dalla vettura per orizzontarci meglio e ci avviammo verso l’entrata del cimitero cattolico. La vettura ci seguì. M’accorsi che i superstiti dell’altro defunto ci guardavano sorpresi non sapendo spiegarsi perché dopo di aver onorato fino a quell’estremo limite quel poverino lo abbandonassimo sul più bello.
Il Nilini spazientito mi precedeva. Domandò al portiere dopo una breve esitazione: «Il funerale del signor Guido Speier è già arrivato?»
Il portiere non sembrò sorpreso della domanda che a me parve comica.
Rispose che non lo sapeva. Sapeva solo dire che nel recinto erano entrati nell’ultima mezz’ora due funerali.
Perplessi ci consultammo. Evidentemente non si poteva sapere se il funerale si trovasse già dentro o fuori. Allora decisi per mio conto. A me non era permesso d’intervenire alla funzione forse già cominciata e turbarla.
Dunque non sarei entrato in cimitero. Ma d’altronde non potevo rischiare d’imbattermi nel funerale, ritornando. Rinunziavo perciò ad assistere all’interramento e sarei ritornato in città facendo un lungo giro oltre Servola.
Lasciai la vettura al Nilini che non voleva rinunziare di far atto di presenza per riguardo ad Ada ch’egli conosceva.
Con passo rapido, per sfuggire a qualunque incontro, salii la strada di campagna che conduceva al villaggio. Oramai non mi dispiaceva affatto di essermi sbagliato di funerale e di non aver reso gli ultimi onori al povero Guido. Non potevo indugiarmi in quelle pratiche religiose. Altro dovere m’incombeva: dovevo salvare l’onore del mio amico e difenderne il patrimonio a vantaggio della vedova e dei figli. Quando avrei informata Ada ch’ero riuscito di ricuperare tre quarti della perdita (e riandavo con la mente su tutto il conto fatto tante volte: Guido aveva perduto il doppio del patrimonio del padre e, dopo il mio intervento, la perdita si riduceva a metà di quel patrimonio. Era perciò esatto. Io avevo ricuperata proprio tre quarti della perdita), essa certamente m’avrebbe perdonato di non essere intervenuto al suo funerale.
Quel giorno il tempo s’era rimesso al bello. Brillava un magnifico sole primaverile e, sulla campagna ancora bagnata, l’aria era nitida e sana. I miei polmoni, nel movimento che non m’ero concesso da varii giorni, si dilatavano. Ero tutto salute e forza. La salute non risalta che da un paragone.
Mi paragonavo al povero Guido e salivo, salivo in alto con la mia vittoria nella stessa lotta nella quale egli era soggiaciuto. Tutto era salute e forza intorno a me, anche la campagna dall’erba giovine. L’estesa e abbondante bagnatura, la catastrofe dell’altro giorno, dava ora soli benefici effetti ed il sole luminoso era il tepore desiderato dalla terra ancora ghiacciata.
Era certo che quanto più ci si sarebbe allontanati dalla catastrofe, tanto più discaro sarebbe stato quel cielo azzurro se non avesse saputo oscurarsi a tempo. Ma questa era la previsione dell’esperienza ed io non la ricordai; m’afferra solo ora che scrivo. In quel momento c’era nel mio animo solo un inno alla salute mia e di tutta la natura; salute perenne.
Il mio passo si fece più rapido. Mi beavo di sentirlo tanto leggero.
Scendendo dalla collina di Servola s’affrettò fin qui quasi alla corsa. Giunto al passeggio di Sant’Andrea, sul piano, si rallentò di nuovo, ma avevo sempre il senso di una grande facilità. L’aria mi portava.
Avevo perfettamente dimenticato che venivo dal funerale del mio più intimo amico. Avevo il passo e il respiro del vittorioso. Però la mia gioia per la vittoria era un omaggio al mio povero amico nel cui interesse era sceso in lizza.
*Sensale negli affari commerciali di Guido

La famosa frase che Zeno rivolge a Guido
Il rapporto che Zeno prova per Guido è forte di valenze psicanalitiche e questo passo ce le svela tutte. Lo abbiamo incontrato al tempo del fidanzamento di Zeno: sappiamo che sin da subito gli è apparso come il rivale, colui che gli ha strappato l’amore per la più bella e che a mostrato a lei la sua capacità di perfetto suonatore di Bach col violino, facendo a lui fare una figura ben più penosa come semplice dilettante. E’ il momento forse del massimo odio nei suoi confronti, odio certo provato a livello inconscio, che viene ribaltato nelle più eclatanti proteste d’amicizia. Si dichiara tanto amico di Guido, ma non fa nulla per salvarlo dal suo disastro finanziario (e lo poteva ben fare, lo rimprovera, in seguito, Ada): è come volesse vedere il suo trionfo rispetto al fallimento dell’amico e lo riscattasse, nei confronti di Ada, verso quell’amore sin dall’inizio non accettato.
Ed è proprio l’immane senso di colpa, che, dopo morto, prova nei confronti del cognato, che lo porta a farsi carico di tutti i suoi problemi finanziari: è che Zeno ha una fortuna sfacciata e giocando in Borsa, riesce a recuperare la metà di quanto dilapidato da Guido. E’ talmente preso dai conti finanziari che, presa una carrozza, solo alla fine si rende conto che sta seguendo un funerale sbagliato.
E’ evidente che consciamente può dire che, distratto, ha sbagliato funerale (le carrozze sono tutte nere), ma è certo che consapevolmente al funerale del suo nemico (per non essere scoperto) non voglia andare.
E’ evidente dal senso di gioia che prova ad allontanarsi da quel luogo, dal sentirsi pienamente libero e vitale, lontano da qualsiasi antagonista in vista. Ma sotto è il senso di trionfo che lo eccita: ora può dire a tutta la famiglia Malfenti, che non può perdonare la sua assenza al funerale, che lo ha fatto per salvare la memoria di Guido e la sorte di Ada, che ora è lui l’unico e vero signore della casa che ha preso il posto, in forma anche autorevole, del signor Malfenti.
Ma quando Ada gli dirà la verità, egli inutilmente protesterà la sua innocenza, perché inconsciamente sa che è vera, se da vecchio ancora gli pesa.
La verità della scrittura psicoanalitica sveviana è nell’ultimo capitolo, intitolato Psico-analisi, passo fondamentale per comprendere l’intero romanzo. Egli, dopo aver ricevuto la diagnosi dal dottor S. (alla quale non crede neanche un po’), il complesso edipico, cioè l’innamoramento verso la madre e il desiderio d’ammazzare il padre, decide di smettere la psicoanalisi, convinto di non essere affatto guarito.
LA MEMORIA
Il dottore presta una fede troppo grande anche a quelle mie benedette confessioni che non vuole restituirmi perché le riveda. Dio mio! Egli non studiò che la medicina e perciò ignora che cosa significhi scrivere in italiano per noi che parliamo e non sappiamo scrivere il dialetto. Una confessione in iscritto è sempre menzognera. Con ogni nostra parola toscana noi mentiamo! Se egli sapesse come raccontiamo con predilezione tutte le cose per le quali abbiamo pronta la frase e come evitiamo quelle che ci obbligherebbero di ricorrere al vocabolario! È proprio così che scegliamo dalla nostra vita gli episodi da notarsi. Si capisce come la nostra vita avrebbe tutt’altro aspetto se fosse detta nel nostro dialetto.
Il dottore mi confessò che, in tutta la sua lunga pratica, giammai gli era avvenuto di assistere ad un’emozione tanto forte come la mia all’imbattermi nelle immagini ch’egli credeva di aver saputo procurarmi. Perciò anche fu tanto pronto a dichiararmi guarito.
Ed io non simulai quell’emozione. Fu anzi una delle più profonde ch’io abbia avuta in tutta la mia vita. Madida di sudore quando l’immagine creai, di lagrime quando l’ebbi. Io avevo già adorata la speranza di poter rivivere un giorno d’innocenza e d’ingenuità. Per mesi e mesi tale speranza mi resse e m’animò. Non si trattava forse di ottenere col vivo ricordo in pieno inverno le rose del Maggio? Il dottore stesso assicurava che il ricordo sarebbe stato lucente e completo, tale che avrebbe rappresentato un giorno di più della mia vita. Le rose avrebbero avuto il loro pieno effluvio e magari anche le loro spine.
È così che a forza di correr dietro a quelle immagini, io le raggiunsi. Ora so di averle inventate. Ma inventare è una creazione, non già una menzogna. Le mie erano delle invenzioni come quelle della febbre, che camminano per la stanza perché le vediate da tutti i lati e che poi anche vi toccano. Avevano la solidità, il colore, la petulanza delle cose vive. A forza di desiderio, io proiettai le immagini, che non c’erano che nel mio cervello, nello spazio in cui guardavo, uno spazio di cui sentivo l’aria, la luce ed anche gli angoli contundenti che non mancarono in alcuno spazio per cui io sia passato.
Quando arrivai al torpore che doveva facilitare l’illusione e che mi pareva nient’altro che l’associazione di un grande sforzo con una grande inerzia, credetti che quelle immagini fossero delle vere riproduzioni di giorni lontani. Avrei potuto sospettare subito che non erano tali perché, appena svanite, le ricordavo, ma senz’alcun’eccitazione o commozione. Le ricordavo come si ricorda il fatto raccontato da chi non vi assistette. Se fossero state vere riproduzioni avrei continuato a riderne e a piangerne come quando le avevo avute. E il dottore registrava. Diceva: “Abbiamo avuto questo, abbiamo avuto quello”. In verità, noi non avevamo più che dei segni grafici, degli scheletri d’immagini.
Fui indotto a credere che si trattasse di una rievocazione della mia infanzia perché la prima delle immagini mi pose in un’epoca relativamente recente di cui avevo conservato anche prima un pallido ricordo ch’essa parve confermare. C’è stato un anno nella mia vita in cui io andavo a scuola e mio fratello non ancora. E pareva fosse appartenuta a quell’anno l’ora che rievocai. Io mi vidi uscire dalla mia villa una mattina soleggiata di primavera, passare per il nostro giardino per scendere in città, giù, giù, tenuto per mano da una nostra vecchia fantesca, Catina. Mio fratello nella scena che sognai non appariva, ma ne era l’eroe. Io lo sentivo in casa libero e felice mentre io andavo a scuola. Vi andavo coi singhiozzi nella gola, il passo riluttante e, nell’animo, un intenso rancore. Io non vidi che una di quelle passeggiate alla scuola, ma il rancore nel mio animo mi diceva che ogni giorno io andavo a scuola ed ogni giorno mio fratello restava a casa. All’infinito, mentre in verità credo che, dopo non lungo tempo, mio fratello più giovine di me di un anno solo, sia andato a scuola anche lui. Ma allora la verità del sogno mi parve indiscutibile: io ero condannato ad andare sempre a scuola mentre mio fratello aveva il permesso di restare a casa. Camminando a canto a Catina calcolavo la durata della tortura: fino a mezzodì! Mentre lui è a casa! E ricordavo anche che nei giorni precedenti dovevo essere stato turbato a scuola da minaccie e rampogne e che io avevo pensato anche allora: a lui non possono toccare. Era stata una visione di un’evidenza enorme. Catina che io avevo conosciuta piccola, m’era parsa grande, certamente perché io ero tanto piccolo. Vecchissima m’era sembrata anche allora, ma si sa che i giovanissimi vedono sempre vecchi gli anziani. E sulla via che io dovevo percorrere per andare a scuola, scorsi anche i colonnini strani che arginavano in quel tempo i marciapiedi della nostra città. Vero è che io nacqui abbastanza presto per vedere ancora da adulto quei colonnini nelle nostre vie centriche. Ma nella via che io con Catina quel giorno percorsi, non ci furono più non appena io uscii dall’infanzia.
La fede nell’autenticità di quelle immagini perdurò nel mio animo anche quando, presto, stimolata da quel sogno, la mia fredda memoria scoperse altri particolari di quell’epoca. Il principale: anche mio fratello invidiava me perché io andavo a scuola. Ero sicuro d’essermene avvisto, ma non subito ciò bastò ad infirmare la verità del sogno. Più tardi gli tolse ogni aspetto di verità: la gelosia in realtà c’era stata, ma nel sogno era stata spostata.

Il divano nello studio di Freud
Fra scrittura e memoria Svevo individua subito una frattura, tanto più quando la scrittura non è nella lingua madre: l’autore ricorda in triestino, traduce in italiano: già il tradurre è un tradire o meglio scegliere dalla memoria ciò che si è in grado di dire. Ora se l’intero suo testo è memoriale per ordine del dottor S. sarà pieno di rimozioni o volontarie bugie. Su quest’ultima espressione bisogna tuttavia sottolineare che, se bugia esiste, essa non nasce come consapevole menzogna, ma come trasfigurazione che la memoria opera nel presente. La memoria infatti viene alterata nel momento in cui viene rievocata, fondendosi in una realtà psichica, capace di nascondere gli impulsi psichici di volta in volta disturbanti. Questo può produrre delle vere e proprie “invenzioni” che, in quanto frutto di un processo mentale, diventano delle vere e proprie realtà.
A tale scopo rievoca un episodio infantile: Zeno e il fratello di un anno più piccolo; all’inizio dell’attività scolastica, accompagnato dalla fantesca, Zeno si reca a scuola, struggendosi dall’invidia, perché suo fratello sta, tranquillo a casa. La gelosia provata si deposita nell’inconscio e non si cancella sapendo che, passato un anno, anche lui andrà a scuola. Tale immagine permane, per meglio dire, permane il sentimento: possono cambiare alcuni dettagli di contorno, ma l’impressione psichica no, anche se, in età adulta viene a sapere che anche il fratello era geloso di lui, perché Zeno andava a scuola mentre lui doveva rimane rinchiuso a casa.
E’ la risposta di Svevo al problema della memoria posto, negli stessi anni, nella À la recherche du temps perdu (Alla ricerca del tempo perduto) di Marcel Proust. Per l’autore triestino passato e presente coesistono, come anche il tempo della rievocazione: si ci porta sempre dentro qualcosa di sé e si è oggi la fusione di passato e presente, si è cioè essere molteplici, dalle più sfacciate personalità.
L’ultima pagina del romanzo è forse quella più famosa:
LA VITA E’ INQUINATA ALLE RADICI
La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l’aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V’è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza… nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco!
Ma non è questo, non è questo soltanto.
Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c’era altra possibile vita fuori dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute.
Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati.
Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.
Questa pagina è preceduta dalla presa d’atto della guarigione di Zeno, o meglio della sua “creduta” guarigione. In fondo è proprio della psicoanalisi fingersi guarito per interrompere la terapia o per dichiarare incompetente il terapeuta stesso (resistenza).
A guarirlo è stata l’attività commerciale, che lo ha reso speculatore durante il periodo bellico e post bellico e lo ha fatto diventare un ricco borghese, come quelle figure contro cui da giovane si poneva, come il padre o il signor Malfenti. Ora è egli ha raggiunto la serenità, determinata dalla piena consapevolezza che non si può guarire dalla malattia, anzi è la stessa malattia a farlo vincente.
Capovolgendo la teoria schoperanhiana è il “malato”, proprio perché è inserito all’interno di una società completamente malata. Ora se il darwinismo affermava la capacità d’adattamento come quella che porta avanti la specie, soltanto chi, come Zeno, non ha certezze stabili, può mutare e quindi salvarsi. Come ha detto in un passo precedente, Augusta possiede una salute “malata”.
La società si è ammalata, da quando ha smesso di essere natura ed è diventata cultura: da quando cioè ha costruito il progresso e con esso le armi di distruzione.
Basterà quindi che uno, più malato degli altri, faccia deflagrare l’intero mondo e il seme della malattia si estinguerà, per ricrearsi “vergine”, senza alcuna malattia.

Johnny Dorelli nella parte di Zeno Cosini in uno sceneggiato televisivo del 1988