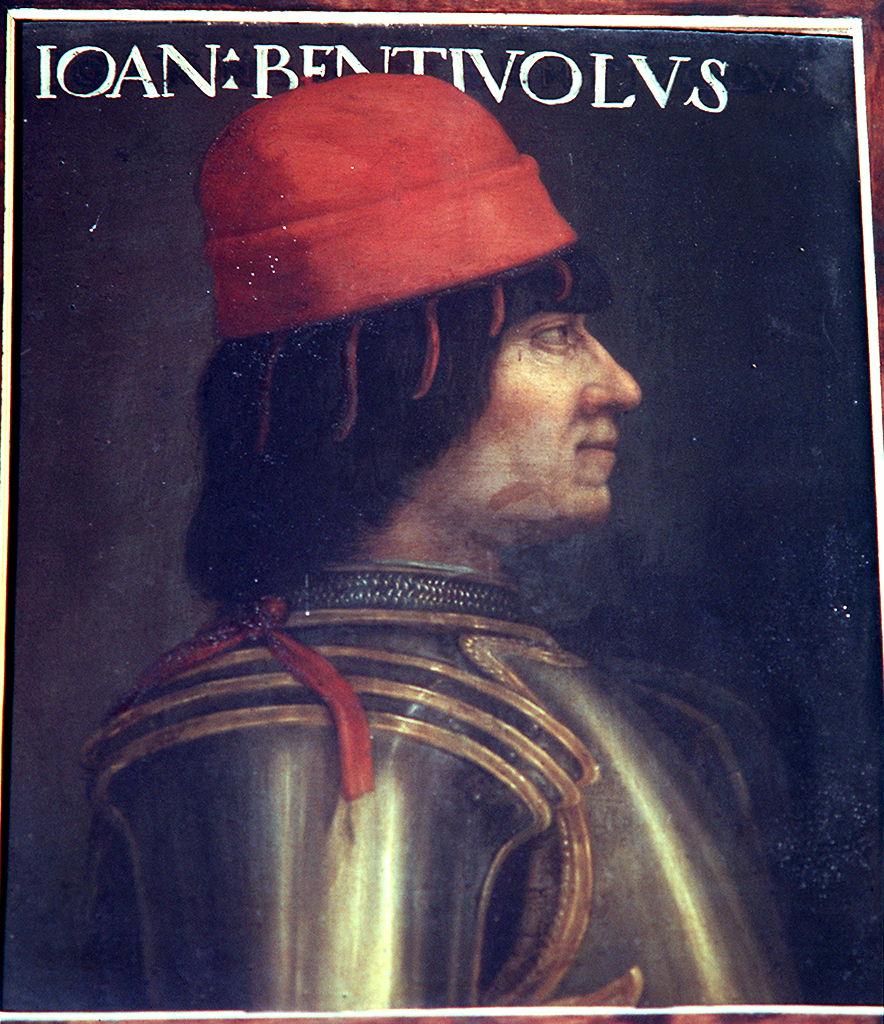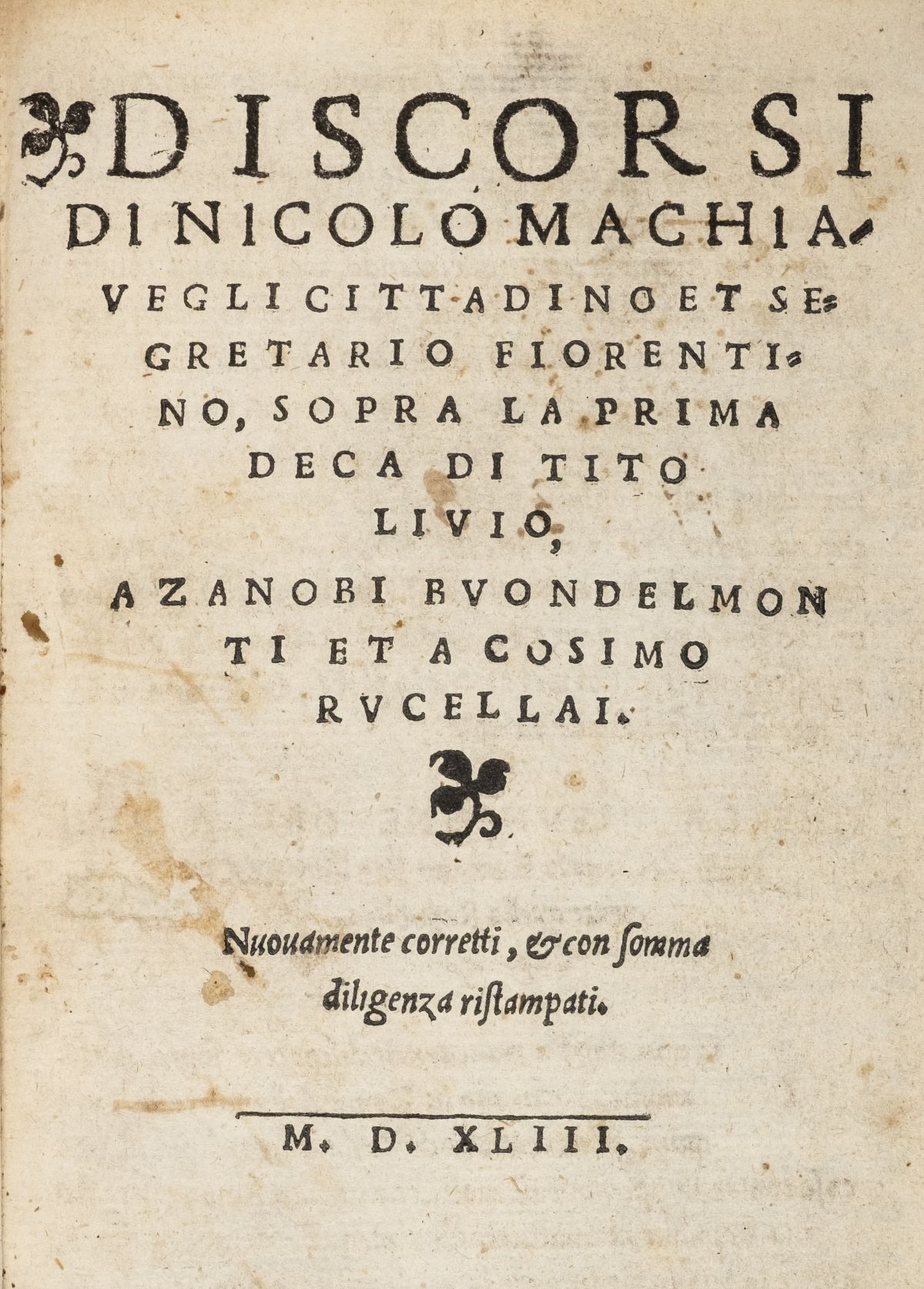Santi di Tito: Ritratto di Machiavelli (seconda metà XVI sec.)
Prima di affrontare il discorso sul grande intellettuale fiorentino, è necessario, proprio per il suo pensiero politico volto alla sua città e all’Italia intera, porre un accento particolare sulle vicende storico-politiche della capitale toscana:
Firenze tra la Repubblica e il Principato
Se storicamente ci occupiamo in modo particolare della città di Firenze è per due motivi:
- E’ proprio il principe della città italiana ad aver costituito il perno sul quale poggiava tutta la politica italiana per un cinquantennio circa: è logico che quindi fu essa a subire le maggiori conseguenze ed influenze della storia cinquecentesca e a sperimentare varie forme di governo;
- In questa città, proprio per ciò che si è detto, hanno operato i più grandi pensatori politici italiani che tanta influenza avranno per la filosofia e la letteratura europea.

Moretto da Brescia: Giacomo Savonarola
Dopo la morte di Lorenzo il Magnifico (1492), resse il governo di Firenze suo figlio Pietro che certo non aveva il carisma né le capacità politiche del padre. Quando Carlo VIII scese in Italia, l’accondiscendenza mostrata dal giovane duca, che ne accettò le esose condizioni, fece infuriare la popolazione che lo mandò via, ed è così che si instaurò a Firenze il governo repubblicano, ispirato dal frate Girolamo Savonarola, che, animato ad un’idea di libertà democratica concepita come libertà cristiana dal peccato, cercò di far convivere l’elemento religioso con l’elemento politico. I seguaci del frate (“Piagnoni”), con la loro esasperata censura verso tutto ciò che appariva “mondano”, si attirano le antipatie degli aristocratici e dei banchieri che, alleatisi con Alessandro VI, papa Borgia, stanco degli attacchi del domenicano e dopo averlo scomunicato, riuscirono a mandarlo al rogo nel 1498. Dopo lunghi quattro anni di conflitti tra le diverse forze sociali della città, il potere venne affidato a un gonfaloniere di giustizia Pier Soderini (1502) che rimarrà in carica fino al 1512, quando le truppe spagnole, dopo aver sconfitto Luigi XII, cui Soderini si era alleato, rimetteranno al potere la famiglia dei Medici. La situazione nei primi anni del ’500 per Firenze è assai turbolenta: la città vive il contrasto fra le grandi potenze (Francia e Spagna) interessate a contendersi il potere in un’Italia divisa e debole e con un papato, guidato da Alessandro VI e poi da Giulio II che intromettendosi tra i due contendenti, da una parte tenta di allargare il suo stato e d’imporre la sua voce, dall’altra esaspera una situazione già di per se stessa difficile. A tale scopo non è senza importanza, per la lettura che sulla sua figura farà Machiavelli, l’avventura del duca di Valentino, figlio di Alessandro VI, con il cui aiuto cercherà di creare un forte stato nell’Italia centrale. Le sorti della città di Firenze, che dopo 15 anni di guerra era riuscita a conquistare Pisa (1509), sono legate a Luigi XII, re di Francia, con cui è alleata e contro cui si contrappone la lega santa promossa da Giulio II con Venezia, Spagna, Inghilterra; battuto dalle soverchianti forze nemiche, difese dalle truppe “cittadine” organizzate da Machiavelli, Pier Soderini deve lasciare il posto al ritorno mediceo (1512).
Rodolfo Ghirlandaio: Pier Soderini
Sul soglio pontificio viene posto un Medici (Leone X), quando Carlo V, re di Spagna, viene eletto imperatore (1519); la lotta tra Francia e Spagna riprende vigore: il nuovo re francese, Francesco I, coalizza intorno a sé Venezia, Genova, Firenze, ed il nuovo papa Clemente VII (sempre della famiglia dei Medici), che rovescia la precedente alleanza; la “calata dei lanzichenecchi”, le truppe imperiali di Carlo V, provoca il “sacco di Roma” (1527): l’umiliazione papale, fa rinascere la “repubblica” fiorentina dalla vita assai effimera (tre anni). La pace di Cateau-Cambresis (1530) sancisce la vittoria imperiale; Firenze viene cinta d’assedio e quindi viene ripristinato il potere mediceo con il duca Alessandro De’ Medici, la cui politica, come quella dell’intera Italia, orbiterà ormai sotto l’influenza di quella spagnola.
Biografia
Niccolò Machiavelli nasce a Firenze nel 1469, da una famiglia borghese: il padre, pur essendo notaio, era di modeste origini, mentre la madre Barolomea de Nelli, era di profonda religiosità. Non sappiamo molto della sua giovinezza, se non che ricevette un’educazione umanistica, ma fortemente antispiritualistica: non per niente tra gli autori latini preferiti vi è Lucrezio, autore del De Rerum Natura, con cui porta l’epicureismo a Roma. Ha 25 anni quando assiste alla discesa di Carlo VIII e alla conseguente cacciata dei Medici dalla città. Dopo un po’ appare la sua prima testimonianza di una visione politica, che risale al 1498, quando in una lettera critica aspramente il frate Savonarola. Alla morte del frate, nel 1498, inizia la sua attività politica, sotto il governatorato di Pier Soderini; egli fu nominato segretario della seconda cancelleria (politica interna della città). Inizia un’intensa attività diplomatica che lo porterà a visitare la Francia (1500, 1504, 1510), con la quale Firenze ha stretto alleanza, i territori di Massimiliano d’Asburgo (1508) ed il duca di Valentino (1502). Di questi viaggi sono testimonianza i Ritratti di cose di Francia, Ritratti di cose di Magna nonché di un volumetto Del modo tenuto dal duca di Valentino nell’uccidere Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il Duca di Gravina Orsini in Senigallia. Al rientro dei Medici (1513), accusato per la sua attività filofrancese con Pier Soderini, sospettato di aver partecipato ad una congiura antimedicea, imprigionato per quindici giorni, (liberato per l’elezione di Leone X) viene esonerato da tutte le cariche e si rifugia all’Albergaccio, sua residenza in campagna, dove redige i suoi capolavori Il principe, Dialogo sopra la prima deca di Tito Livio e la commedia La Mandragola. Dal 1516 frequenta gli Orti Oricellari, i cui partecipanti sono d’orientamento repubblicano e nel 1519 ricomincia a interessarsi della politica fiorentina per incarico di Giuliano De’ Medici (futuro Clemente VII), per invito del quale scriverà le Istorie fiorentine.

Sebastiano del Piombo: Clemente VII
Una volta divenuto papa, quest’ultimo gli revocherà l’interdizione a ricoprire pubblici uffici e ne 1527, per l’appressarsi di Carlo V, gli viene affidato l’incarico di rinforzare le difese della città. Dopo il sacco di Roma, a Firenze viene ripristinata la repubblica, ma Machiavelli viene osservato con sospetto per l’aiuto dato al papa mediceo, così deluso, muore nel 1527.
Epistolario
L’importanza dell’esperienza culturale di Machiavelli è talmente vasta da influenzare l’intero pensiero filosofico e letterario. I critici per definire il suo modo di concepire la realtà politica e per stigmatizzarlo, utilizzarono addirittura dal suo nome un aggettivo, “machiavellismo”, ad indicare un atteggiamento incline ad ottenere un fine con qualsiasi mezzo. E’ evidente che tale visione, riferita all’intellettuale fiorentino è riduttiva, ma oggi ci si riferisce per indicare un atteggiamento politicamente spavaldo, certo oggi un po’ attenuato, ma non così tanto da non percepirne la sua resistenza ed importanza. Ma per capire il letterato, bisogna capire l’uomo. L’opera che si avvicina a tale compito è certamente l’Epistolario. Tale opera in realtà non esiste: nessun progetto da parte dell’autore di pubblicare lettere. Tuttavia la loro raccolta ci permette di cogliere l’aspetto più autentico di Machiavelli. Il gruppo di lettere più numeroso riguarda quelle indirizzate a Francesco Vettori, dopo la sua esclusione dall’azione politica. La più importante è quella del 10 dicembre 1513; a Francesco che chiedeva ragguagli circa il suo modo di vivere, così risponde Machiavelli:
LETTERA AL VETTORI
Magnifico oratori Florentino Francisco Vectori apud Summum Pontificem et benefactori suo. Romae
Magnifico ambasciatore. Tarde non furon mai grazie divine*. Dico questo, perché mi pareva haver perduta no, ma smarrita la grazia vostra, sendo stato voi assai tempo senza scrivermi; ed ero dubbio donde potessi nascere la cagione. E di tutte quelle mi venivono nella mente tenevo poco conto, salvo che di quella quando io dubitavo non vi havessi ritirato da scrivermi, perché vi fussi suto scritto che io non fussi buon massaio delle vostre lettere; e io sapevo che, da Filippo e Pagolo in fuora, altri per mio conto non le haveva viste. Hònne rihaùto per l’ultima vostra de’ 23 del passato, dove io resto contentissimo vedere quanto ordinatamente e quietamente voi esercitate cotesto ufizio publico; e io vi conforto a seguire così, perché chi lascia i sua comodi per li comodi d’altri, e’ perde e’ sua, e di quelli non li è saputo grado. E poiché la fortuna vuol fare ogni cosa, ella si vuole lasciarla fare, stare quieto e non le dare briga, e aspettar tempo che la lasci fare qualche cosa agl’huomini; e all’hora starà bene a voi durare più fatica, vegliar più le cose, e a me partirmi di villa e dire: eccomi. Non posso pertanto, volendo rendere pari grazie, dirvi in questa mia lettera altro che qual sia la vita mia; e se voi giudicate che sia a barattarla con la vostra, io sarò contento mutarla.
Io mi sto in villa; e poi che seguirono quelli miei ultimi casi, non sono stato, ad accozzarli tutti, venti dí a Firenze. Ho insino a qui uccellato a’ tordi di mia mano. Levavomi innanzi dí, impaniavo, andavone oltre con un fascio di gabbie addosso, che parevo el Geta quando e’ tornava dal porto con i libri di Amphitrione; pigliavo el meno dua, el più sei tordi. E cosí stetti tutto settembre. Di poi questo badalucco, ancoraché dispettoso e strano, è mancato con mio dispiacere: e quale la vita mia vi dirò. Io mi lievo la mattina con el sole, e vòmmene in un mio bosco che io fo tagliare, dove sto dua ore a rivedere l’opere del giorno passato, e a passar tempo con quegli tagliatori, che hanno sempre qualche sciagura alle mani o fra loro o co’ vicini. E circa questo bosco io vi harei a dire mille belle cose che mi sono intervenute, e con Frosino da Panzano e con altri che voleano di queste legne. E Frosino in spezie mandò per certe cataste senza dirmi nulla; e al pagamento, mi voleva rattenere dieci lire, che dice aveva havere da me quattro anni sono, che mi vinse a cricca in casa Antonio Guicciardini. Io cominciai a fare el diavolo, volevo accusare el vetturale, che vi era ito per esse, per ladro. Tandem Giovanni Machiavelli vi entrò di mezzo, e ci pose d’accordo. Batista Guicciardini, Filippo Ginori, Tommaso del Bene e certi altri cittadini, quando quella tramontana soffiava, ognuno me ne prese una catasta. Io promessi a tutti; e manda’ne una a Tommaso, la quale tornò a Firenze per metà, perché a rizzarla vi era lui, la moglie, la fante, i figlioli, che pareva el Gaburra quando el giovedí con quelli suoi garzoni bastona un bue. Dimodoché, veduto in chi era guadagno, ho detto agli altri che io non ho più legne; e tutti ne hanno fatto capo grosso, e in specie Batista, che connumera questa tra le altre sciagure di Prato.
Partitomi del bosco, io me ne vo ad una fonte, e di quivi in un mio uccellare. Ho un libro sotto, o Dante o Petrarca, o uno di questi poeti minori, come Tibullo, Ovidio e simili: leggo quelle loro amorose passioni, e quelli loro amori ricordomi de’ mia: gòdomi un pezzo in questo pensiero. Transferiscomi poi in sulla strada, nell’hosteria; parlo con quelli che passono, dimando delle nuove de’ paesi loro; intendo varie cose, e noto varii gusti e diverse fantasie d’huomini. Viene in questo mentre l’hora del desinare, dove con la mia brigata mi mangio di quelli cibi che questa povera villa e paululo patrimonio comporta. Mangiato che ho, ritorno nell’hosteria: quivi è l’hoste, per l’ordinario, un beccaio, un mugnaio, dua fornaciai. Con questi io m’ingaglioffo per tutto dí giuocando a cricca, a trich-trach, e poi dove nascono mille contese e infiniti dispetti di parole iniuriose; e il più delle volte si combatte un quattrino, e siamo sentiti non di manco gridare da San Casciano. Cosí, rinvolto in tra questi pidocchi, traggo el cervello di muffa, e sfogo questa malignità di questa mia sorta, sendo contento mi calpesti per questa via, per vedere se la se ne vergognassi.
Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in sull’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni; e quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento per quattro hore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro.
E perché Dante dice che non fa scienza sanza lo ritenere lo havere inteso – io ho notato quello di che per la loro conversazione ho fatto capitale, e composto uno opuscolo De principatibus; dove io mi profondo quanto io posso nelle cogitazioni di questo subietto, disputando che cosa è principato, di quale spezie sono, come e’ si acquistono, come e’ si mantengono, perché e’ si perdono. E se vi piacque mai alcuno mio ghiribizzo, questo non vi doverrebbe dispiacere; e a un principe, e massime a un principe nuovo, doverrebbe essere accetto: però io lo indirizzo alla Magnificentia di Giuliano. Filippo Casavecchia l’ha visto; vi potrà ragguagliare in parte e della cosa in sé e de’ ragionamenti ho hauto seco, ancora che tutta volta io l’ingrasso e ripulisco. Voi vorresti, magnifico ambasciatore, che io lasciassi questa vita, e venissi a godere con voi la vostra. Io lo farò in ogni modo; ma quello che mi tenta hora è certe mie faccende, che fra sei settimane l’harò fatte. Quello che mi fa star dubbio è, che sono costí quelli Soderini, e quali sarei forzato, venendo costí, visitarli e parlar loro. Dubiterei che alla tornata mia io non credessi scavalcare a casa, e scavalcassi nel Bargiello; perché, ancora che questo stato habbia grandissimi fondamenti e gran securità, tamen egli è nuovo, e per questo sospettoso; né manca di saccenti, che per parere, come Pagolo Bertini, metterebbono altri a scotto, e lascierebbono el pensiero a me. Pregovi mi solviate questa paura, e poi verrò in fra el tempo detto a trovarvi a ogni modo.
Io ho ragionato con Filippo di questo mio opuscolo, se gli era ben darlo o non lo dare; e, sendo ben darlo, se gli era bene che io lo portassi, o che io ve lo mandassi. Il non lo dare mi faceva dubitare che da Giuliano e’ non fussi, non che altro, letto; e che questo Ardinghelli si facessi onore di questa ultima mia fatica. El darlo mi faceva la necessità che mi caccia, perché io mi logoro, e lungo tempo non posso stare cosí che io non diventi per povertà contennendo. Appresso al desiderio harei che questi signori Medici mi cominciassino adoperare, se dovessino cominciare a farmi voltolare un sasso; perché, se poi io non me gli guadagnassi, io mi dorrei di me; e per questa cosa, quando la fussi letta, si vedrebbe che quindici anni, che io sono stato a studio all’arte dello stato, non gli ho né dormiti né giuocati; e doverrebbe ciascheduno haver caro servirsi di uno che alle spese di altri fussi pieno di esperienza. E della fede mia non si doverrebbe dubitare, perché, havendo sempre observato la fede, io non debbo imparare hora a romperla; e chi è stato fedele e buono quarantatré anni, che io ho, non debbe poter mutare natura; e della fede e bontà mia ne è testimonio la povertà mia. Desidererei adunque che voi ancora mi scrivessi quello che sopra questa materia vi paia. E a voi mi raccomando. Sis felix.
Die 10 Decembris 1513.
* Verso di Petrarca dai “Trionfi”
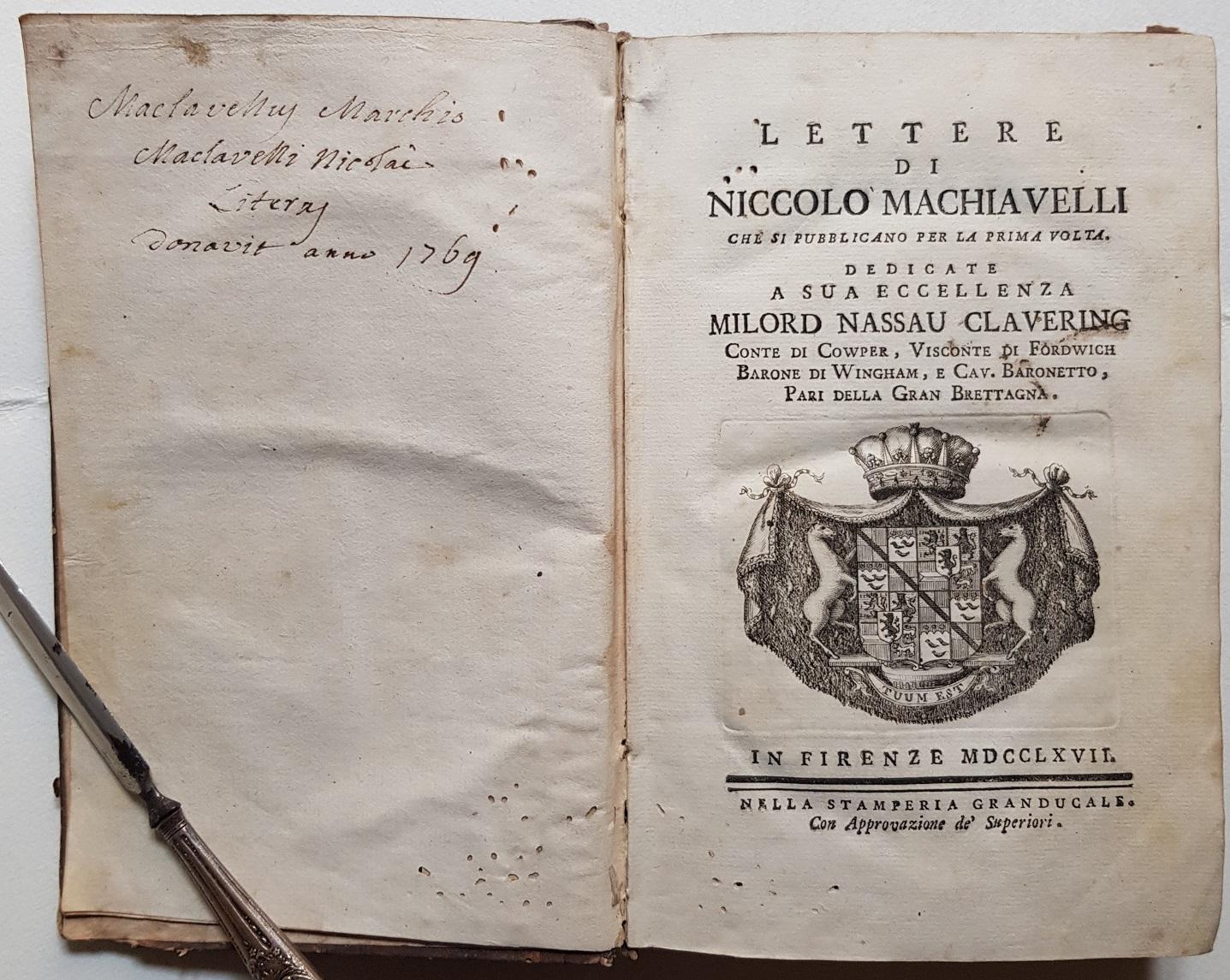
Edizione di alcune lettere di Machiavelli pubblicate in Firenze nel 1767
A Francesco Vettori, magnifico ambasciatore fiorentino presso il Sommo Pontefice, proprio benefattore. Roma
Le grazie ricevute da Dio, anche se arrivano tardi, sono sempre gradite. Dico questo perché mi sembrava di aver non perduto, ma smarrito la vostra benevolenza perché siete stato tanto tempo senza scrivermi e mi chiedevo quale potesse essere il motivo. E tra tutti quelli che mi venivano in mente, tenevo per buono solo quello che mi convinceva di più, e cioè che vi fosse stato scritto che io non ero stato un buon custode delle vostre lettere, ma in realtà io non le ho mostrate a nessuno, tranne che a Filippo e Pagolo.
Ho riavuto il piacere della vostra benevolenza con la lettera del giorno 23 (di Novembre) in cui ho letto che svolgete il vostro incarico (di ambasciatore) in modo tranquillo e pacifico e io vi invito a continuare in questo modo perché chi dimentica il proprio comodo per fare il comodo degli altri perde il proprio e non gli viene nemmeno detto grazie.
E siccome la Fortuna vuole fare i suoi comodi, è meglio lasciarla stare e non contrastarla, aspettando che essa permetta agli uomini di agire in qualche modo e allora voi dovrete lavorare di più, stare più attento e io sarò pronto a dirvi “Eccomi”.
Stando così le cose, non posso far altro, per rendervi il favore che mi avete fatto (raccontandomi della vostra vita attuale), che raccontarvi come trascorro le mie giornate e se voi pensate che la mia vita possa essere scambiata con la vostra, io sarò contento di farlo.
Io sto in paese, e, dopo esser stato accusato di aver partecipato ad una congiura contro i Medici, non sono stato a Firenze, se li dovessi contare tutti, più di venti giorni. Fino ad oggi sono andato a caccia di tordi, mi sono alzato all’alba, ho preparato le panie, e sono andato con un fascio di gabbie addosso, che sembravo il Geta quando porta i libri del suo padrone Anfitrione; prendevo almeno due o al massimo sei tordi. Così trascorsi il tempo per tutto Settembre; poi questo passatempo, sebbene dispettoso e strano alle mie inclinazioni, è terminato con grande dispiacere, e quale sia la mia vita ora vi dirò. Mi alzo con il sole e vado in un mio bosco che faccio tagliare, quindi sto due ore a rivedere i lavori del giorno precedente, e a parlare con i tagliatori che hanno sempre qualche problema tra loro o con i loro vicini. E riguardo questo bosco io avrei mille cose che mi sono accadute da dirvi e con Frosino da Panzano e con altri che volevano acquistare questa legna, e soprattutto Frosino che è venuto a prenderne quattro cataste senza chiedermi nulla, e quando doveva pagarmi, voleva trattenermi dieci lire, in quanto afferma che dovevo restituirgliele dato che le aveva vinte a carte a casa di Antonio Guicciardini. Cominciai a fare il diavolo a quattro, volevo accusare il vetturale che era venuto a prenderle per ladro, infine intervenne Giovanni Machiavelli e ci mise d’accordo. Batista Guicciardini, Filippo Ginori, Tommaso Del Bene, quando cominciò il freddo ognuno se ne prese una catasta, e ne mandai una anche a Tommaso, la quale arrivò a Firenze che sembrava la metà, perché a stringerla c’era lui, la moglie, il servo, che sembrava il Guburra quando il giovedì con tutti i suoi operai bastona un bue. Quindi, visto che il guadagno era poco, ho mandato a dire che non avevo più legna da vendere, e tutti se ne sono lamentati e soprattutto Battista che annovera questa tra le altre sciagure di Prato.
Quando mi allontano dal bosco, me ne vado ad una fonte e qui in un luogo riservato alla caccia d’uccelli, mi porto un libro, o Dante, o Petrarca, o uno di quei poeti elegiaci latini, Tibullo o Ovidio e simili: leggo le loro passioni e le loro storie d’amore, mi ricordo delle mie e godo per un attimo in questo pensiero. Mi trasferisco poi nella strada verso l’osteria, parlo con quelli che passano, domando notizie dei loro paesi, ascolto varie cose e annoto le diverse e straordinarie fantasie degli uomini. Nel mentre giunge l’ora di cena, dove con la mia famiglia mangio ciò che la mia povera fattoria e la piccola rendita permette. Dopo mangiato torno all’osteria. Qui, come al solito, c’è l’oste, il macellaio, un mugnaio e due fornai. Con loro io m’incanaglisco per tutto il tempo giocando a tric e trac, e nascono mille contese e per lo più si litiga per un soldo e le nostre urla si sentono fino a San Casciano. E così, rivoltandomi in mezzo a questi pidocchi tengo il cervello in esercizio e sfogo la malignità della mia sorte, contento che mi calpesti in questo modo, per vedere infine se riesco a vergognarmi.
Venuta la sera, mi ritiro in casa, ed entro nel mio studio, e sulla porta mi spoglio di quella veste quotidiana piena di fango e mi vesto con panni reali e adatti alle corti e rivestito con dignità entro nelle corti degli uomini antichi dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi nutro di quel cibo che solo è mio ed io sono nato per lui, dove non mi vergogno di parlare con loro, e quelli, per il loro alto concetto di humanitas mi rispondono e per quattro ore non provo noia, dimentico ogni affanno, non temo la povertà, non ho paura della morte. Mi immergo tutto in loro. E siccome Dante ha scritto che non vi è conoscenza senza annotare ciò che si è capito – ho fatto capitale delle loro conversazioni e ho scritto un piccolo libro De principatibus dove io mi profondo completamente in questo argomento, trattando di cosa è un principato, di quali specie essi siano, come si conquistano, come si mantengono, perché si perdono; e se avete trovato piacere per qualche mio scritto, questo dovrebbe risultarvi gradito, perciò lo indirizzo alla Magnificenza di Giuliano de’ Medici. Filippo Casavecchia l’ha letto; vi potrà pertanto ragguagliare in parte sul contenuto e sul soggetto stesso e dei ragionamenti intorno ad esso che ho avuto con lui, sebbene ancora lo continui a rivedere e a limare. Tu vorresti, magnifico ambasciatore, che io lasciassi questa vita e venissi a stare bene da voi. Tenterò di farlo, ma quello che mi trattiene ora sono alcuni impegni che sbrigherò entro sei settimane. Quello che mi lascia dubbioso è che lì, dove siete voi, vi sono i Soderini e mi sentirei in obbligo di andare a trovarli e dialogare con loro. Temo che, quando tornerò a Firenze, non attraverserò il cancello di casa mia, ma del carcere del Bargello, perché, sebbene questo Stato poggi su buone fondamenta e gran sicurezza, tuttavia è nuovo e per questo sospettoso, né vi mancano dei saccenti che per apparire, come Pagolo Bertini, metterebbero qualcuno in carcere, facendomi pagare il conto. Se voi mi scioglierete da questo timore, verrò certamente, come ho detto, a trovarvi.
Ho ragionato con Filippo di questo mio libretto, se era opportuno consegnarlo o meno e se dovesse essere dato, se era giusto che io lo consegnassi direttamente o lo facessi consegnare. Il non darlo personalmente mi fa dubitare sul fatto che Giuliano lo leggesse e che Ardinghelli (colui che lo dovrebbe consegnare) si facesse bello di questa mia fatica. Il darlo di persona mi spinge la necessità, perché io mi logoro, e che non diventi per povertà spregevole. Avrei inoltre il desiderio che questi signori Medici cominciassero ad adoperarmi, foss’anche dovessi rotolare un sasso, perché se non dovessi guadagnare quello per cui mi adopero, mi dorrei con me stesso, e per questo libretto, quando fosse letto, si vedrebbe che quindici anni in cui sono stato in politica non ho né dormito né giocato e dovrebbe ciascuno gradire di servirsi di uno che ha accumulato tanta esperienza nel regime precedente. E della mia fedeltà non si dovrebbe dubitare, perché l’ho sempre osservata e non devo imparare ora a romperla; chi è stato buono e fedele per quarantatré anni, non può mutare la sua natura, e della mia fedeltà e bontà ne è testimonianza la mia povertà. Desidererei dunque che voi mi scriveste le vostre impressioni su quanto vi ho detto. Mi raccomando a voi. Siate felice.
10 Dicembre1513

Particolare della casa di Machiavelli in San Casciano, oggi albergo e ristorante
Sin dalla prima lettura notiamo alcuni elementi d’estrema importanza per la comprensione del pensiero machiavelliano, partendo proprio dal primo paragrafo. In esso si colgono due aspetti, il primo riferito alla concezione pessimistica dell’uomo, il secondo alla fortuna: dice infatti Machiavelli chi lascia i sua comodi per li comodi d’altri, e’ perde e’ sua, e di quelli non li è saputo grado, lasciando intendere l’ingratitudine verso colui che dedica ogni suo sforzo per aiutare altri e non riceverne nemmeno gratitudine dove sembra riecheggiare il detto latino di Plauto (nell’Asinaria) ripreso dal filosofo Hobbes homo hominis lupus. O ancora il concetto di fortuna, centrale per la sua speculazione, in cui rivendica la sua imperscrutabilità ma allo stesso la capacità dell’uomo, laddove gli venga offerta l’occasione, per agire.
Nella descrizione della giornata invece, che occupa la seconda sequenza, il Machiavelli descrive le sue attività sia quotidiane che culturali: la mattina nel bosco a cacciare e poi perdersi tra le sue “questioni” economiche come venditore di legna. Sembrerebbe quasi sminuirsi, ma seppure lui, uomo che è stato a contatto con i più grandi protagonisti della storia europea, si perde in discussioni di poco conto, non può fare a meno di notare gli atteggiamenti umani, la cui conoscenza è fondamentale per la sua speculazione politica. Quindi pausa con la lettura di autori elegiaci e d’amore: ecco che la letteratura classica, sebbene per lui “minore”, serva a lui per capire e riflettere su se stesso, non diversamente da come farà con quella che Machiavelli considererà “maggiore”. Quindi il ritorno ad una quotidianità che comincia “nel cercare le fonti per elaborare il suo pensiero politico”, poi più degradata, dove all’homo economicus si sostuisce, oserei dire, l’istinto quasi animale, che non tollera la sopraffazione nemmeno se essa deriva da un gioco. Ma tale degradazione serve quasi a fare da contrasto col climax “narrativo dell’epistola”.

Statua di Machiavelli a Firenze
Tale è la terza sequenza in cui egli ci narra il suo rapporto con i grandi classici, gli storici soprattutto. E’ quasi un passo teatrale: l’uomo che si mette in abiti “rigorosi” e alti, come alti sono i personaggi con cui entra a colloquio, perché andando alla ricerca del comportamento umano, egli trova le risposte nelle grandi azioni che gli uomini del passato hanno compiuto, ma che lui vorrebbe fossero ancora “modelli” per gli uomini di oggi ed è per questo che, come diligente scolaro, ha potuto scrivere Il principe che dovrà dare a Giuliano de’ Medici.
Nell’ultima parte della lettera, quella di doverla consegnare personalmente o tramite emissario si misura tutta la capacità machiavellica di andare dietro la realtà effettuale delle cose e quindi, una volta presone atto, decidere sul da fare (così come dovrebbe fare un principe).
Ma ci accora l’ultima richiesta che esula dall’opportunità “politica” e che individua in Machiavelli una vera e propria passione per l’arte politica che egli ha individuato, non ne può fare a meno: la vera prigione o il vero esilio, per lui, è l’inattività.
Opere minori
Le opere minori possono individuarsi in ufficiali, quali legazioni e dispacci per il governo oppure in brevi scritti politici in cui il nostro individua per la Repubblica alcuni aspetti utili per la sue scelte governative. A tale produzione ci piace ricordare quelle prettamente operative come Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati (1503) o, più tarde le riflessioni sulle grandi potenze europee: Rapporto delle cose della Magna (1508) e Ritratto delle cose di Francia (1510), il cui studio permette a Machiavelli d’individuare nel paese transalpino, unito e forte, un modello positivo, nell’Alemagna, per il frazionamenti politico, uno negativo.

Altobello Melone: Presunto ritratto di Cesare Borgia
Tra queste ci piace ricordarne una: nell’opera principale, pubblicata nel 1513, il Machiavelli individua nel duca di Valentino un modello di un moderno principe, capace di andare oltre la morale al fine di costruirsi uno stato. Tale idea al pensatore fiorentino venne quando fu mandato dal governo a Senigallia per seguire gli accadimenti che dovevano portare alla riappacificazione tra coloro che si erano ribellati al suo dominio. Tale esperienza Machiavelli la traduce in un piccolo testo Del modo tenuto dal duca di Valentino nell’uccidere Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il Duca di Gravina Orsini in Senigallia, in cui descrive che, nel 1502, il duca Valentino Borgia, che ha costruito dal nulla uno stato molto potente, minaccia Bologna, governata da Giovanni Bentivoglio, con lo scopo di portarla sotto il suo dominio e renderla capitale del ducato di Romagna. Questa espansione, rapidissima e inarrestabile, preoccupa non solo gli avversari ma anche gli alleati. Così le potenti famiglie degli Orsini e dei Vitelli, che fino a quel momento avevano appoggiato il Valentino, organizzano un incontro nel castello della Magione, sul lago Trasimeno a cui partecipano il cardinale Giambattista Orsini, il capitano di ventura Vitellozzo Vitelli e i condottieri Olivierotto da Fermo, Paolo e Francesco, duca di Gavinana – tutti al soldo del Valentino – Giampaolo Baglioni tiranno di Perugia e Antonio da Venafro per conto della città di Siena. I congiurati stabiliscono di proteggere Bologna e di allearsi con i fiorentini, mandando in un luogo e nell’altro loro ambasciatori promettendo aiuto ai bolognesi spingendo i fiorentini ad unirsi per combattere il nemico comune. Alla congiura del Magione seguono numerose ribellioni: il Valentino sembra in pericolo, ma poi, con la rapidità che lo caratterizza, riesce ad avere la meglio sui rivoltosi. Riportato l’ordine, annuncia che si recherà a Senigallia per incontrare i congiurati e giungere a una pacificazione. Vitellozzo e i suoi compagni, protagonisti di un dramma ineluttabile di cui hanno il presentimento, vanno incontro al loro destino senza alcuna possibilità di difesa; il senso d’impotenza e d’isolamento che li circonda prepara l’esplodere della crudeltà e della violenza che culmina nella scena della loro uccisione:
IL DUCA DI VALENTINO: L’OMICIDIO COME LEGGE POLITICA
Vitellozzo, Pagolo e duca di Gravina in su muletti ne andorno incontro al duca, accompagnati da pochi cavagli; e Vitellozzo, disarmato, con una cappa foderata di verde, tutto afflitto come se fussi conscio della sua futura morte, dava di sé (conosciuta la virtù dello uomo e la passata sua fortuna) qualche ammirazione. E si dice che quando e’ si partì da le sua genti per venire a Sinigaglia e andare contro al duca, a li suoi capi raccomandò la sua casa e le fortune di quella, ed e nipoti ammunì che non della fortuna di casa loro, ma della virtù de’ loro padri e de’ loro zii si ricordassino. Arrivati adunque questi tre davanti al duca, e salutatolo umanamente, furono da quelli ricevuti con buono volto, e subito da quelli a chi era commesso fussino osservati, furno messi in mezzo. Ma veduto il Duca come Oliverotto vi mancava, il quale era rimaso con le sue genti a Sinigaglia, e attendeva innanzi alla piazza del suo alloggiamento sopra il fiume a tenerle nell’ordine, ed esercitarle in quello), accennò coll’occhio a Don Michele, al quale la cura di Oliverotto era data, che provvedesse in modo che Oliverotto non scampasse. Donde Don Michele cavalcò avanti, e giunto da Oliverotto li disse come e’ non era tempo da tenere le genti insieme fuora dello alloggiamento, perchè sarebbe tolto loro da quelli del Duca; e però lo confortava ad alloggiarle, e venisse seco ad incontrare il Duca. Ed avendo Oliverotto eseguito tale ordine, sopraggiunse il Duca, e veduto quello lo chiamò; al qual Oliverotto avendo fatto riverenza, si accompagnò con gli altri. Ed entrati in Sinigaglia, e scavalcati tutti a lo alloggiamento del duca ed entrati seco in una stanza secreta, furno dal duca fatti prigioni. El quale subito montò a cavallo, e comandò che fussino svaligiate le genti di Liverotto e degli Orsini. Quelle di Oliverotto furno messe a sacco, per essere propinque. Quelle degli Orsini e dei Vitegli sendo discosto e avendo presentito la ruina de’ loro padroni, ebbono tempo di mettersi insieme; e ricordatosi la virtù e disciplina di casa Vitellesca, strette insieme, contro alla voglia del paese e degli uomini inimici si salvorno. Ma e’ soldati del duca non sendo contenti del sacco della gente di Liverotto, cominciorno a saccheggiare Sinigaglia; e se non fussi che il duca con la morte di molti represse la insolenzia loro, l’arebbono saccheggiata tutta.
Ma venuta la notte, e fermi e tumulti, al duca parve di fare ammazzare Vitellozzo e Liverotto; e conduttogli in uno luogo insieme, gli fe’ strangolare. Dove non fu usato da alcuno di loro parole degne della loro passata vita: perché Vitellozzo pregò che si supplicassi al papa che gli dessi de’ suoi peccati indulgenzia plenaria; e Liverotto tutta la colpa delle iniurie fatte al duca, piangendo rivolgeva addosso a Vitellozzo. Pagolo e el duca di Gravina Orsini furno lasciati vivi per infino che il duca intese che a Roma el papa aveva preso el cardinale Orsino, l’arcivescovo di Firenze e messer Iacopo da santa Croce; dopo la quale nuova, a’ dì diciotto di gennaio, a Castel della Pieve furno ancora loro nel medesimo modo strangolati.
Vitellozzo Vitelli
Vitellozzo Vitelli, Paolo e Francesco Orsini, duca di Gravina su piccoli mezzi di trasporto andarono incontro al duca, accompagnati da cavalli; Vitellozzo disarmato, con un mantello foderato di verde, completamente assorto nella sua afflizione, consapevole che stava andando a morire, offriva di sé (saputo da tutti il suo valore e la sua trascorsa fortuna) qualche meraviglia (per lo stato in cui si era ridotto). Si dice che quando si allontanò dalla sua famiglia per andare dal duca, si accomiatò come fosse per l’ultima volta, raccomandando ai suoi uomini principali la casa ed il patrimonio e ammonì i suoi nipoti affinché ricordassero non la fortuna di quella casata, ma la virtù di essa per mezzo dei loro padri e zii. Arrivati davanti al duca, lo salutarono cortesemente e furono accolti da lui con un altrettanto volto cortese ed immediatamente furono consegnati a coloro ai quali era stato assegnato il compito di prenderli in custodia. Il duca notò che mancava Oliverotto da Fermo (che era rimasto con i suoi fanti a Senigallia ed era impegnato, davanti al suo alloggio sulla piazza sopra il fiume, a tenerli in ordine e a esercitarsi) diede un cenno con l’occhio a don Michele, che lo doveva prendere in consegna, affinché non scappasse. Don Michele a cavallo lo raggiunse e gli disse che non era il momento di tenere le truppe fuori dall’alloggiamento, perché lo stesso sarebbe stato occupato dalle truppe del duca, ma ne frattempo potevano rientrare, in quanto lui lo doveva seguire per incontrare il duca. Eseguito quanto gli veniva detto, sopraggiunse davanti al duca che lo chiamò e al quale rivolse una riverenza, quindi si unì agli altri. Entrati a Senigallia scesero dai cavalli ed entrarono nell’alloggiamento del duca ed entrati in una stanza segreta li fece prigionieri. Quindi il duca montò a cavallo ed ordinò affinché gli uomini di Oliverotto e degli Orsini fossero catturate. Quelli di Oliverotto furono presi e portati vicini; quelli di Vitellio e degli Orsini, essendo più lontani e sapendo che fine toccasse a loro padroni, si misero insieme e ricordandosi della virtù della casa di Vitellio, contro la volontà degli uomini del paese e dei loro nemici, riuscirono a salvarsi. Ma i soldati del duca, non contenti della cattura degli uomini di Oliverotto, cominciarono a saccheggiare Senigallia e se non fosse intervenuto il duca, che uccise i più insolenti tra gli abitanti della città, l’avrebbero saccheggiata tutta.
Arrivata la notte, cessati i tumulti, il duca risolse di uccidere Vitellozzo e Oliverotto e, portatili in un luogo, li fece strozzare. Egli non si curò di ascoltare parole da loro volte, degne della loro vita passata: Vitellozzo lo supplicò affinché ricevesse dal papa la remissione di tutti i suoi peccati, Oliverotto, invece, piangendo, dava la colpa a Vittellozzo per tutte le ingiurie che gli avevano rivolto. Paolo ne Francesco Orsini, duca di Gravina, furono lasciati vivi fino a quando Cesare Borgia venne a sapere che il papa aveva arrestato il cardinale Giambattista Orsini, Rinaldo Orsini, arcivescovo di Firenze e Iacopo di Santa Croce (partigiano degli Orsini): dopo questa notizia, il 18 gennaio, a Castel di Pieve furono anche loro strangolati.
Machiavelli racconta un qualcosa a cui aveva assistito personalmente: la distanza tra l’episodio e il momento di raccontarla permette al nostro di mantenere un atteggiamento quasi distaccato, da storico. Attraverso esso egli ci vuole mostrare l’agire profondamente politico del duca di Valentino, che esula da qualsiasi aspetto che non sia legato ad esso: mantenere, anche a costo dell’omicidio politico, lo stato contro le forze disgregatrici. Ma nonostante questo Machiavelli, pur con lo sguardo distaccato e impersonale dello storico mette in luce la sua grande capacità di drammaturgo che mette in scena una tragedia destinata a coinvolgere e scuotere il pubblico. Nel passo letto, Machiavelli esprime a pieno il suo gusto per la narrazione e la rappresentazione teatrale.
IL PRINCIPE
Il Principe viene composto nel 1513, quando Machiavelli sta all’Albergaccio, in una pausa della stesura dei Discorsi, opera di commento storico-politico su Livio. Tale opera, per stile e tempo di composizione (pochi mesi), sembra quasi indicarci l’impellenza con cui la scrisse, l’urgenza di sviluppare un discorso che, come dice nella lettera al Vettori, aveva maturato nel dialogo con i grandi del passato e non solo, la volontà, non certo venata da orgoglio, di collaborare per liberare l’Italia, come dirà nell’accorata preghiera dell’ultimo capitolo.
Quest’opera, infatti, segna un punto fondamentale nella storia del pensiero europeo: di contro agli specula principis in cui si trattava del dover esser di un regnante, egli disegna un ritratto, pur a tinte fosche, di come egli è e si deve comportare per l’alto compito che gli è affidato. Affinché ciò avvenga la politica dev’essere liberata dalla morale; pertanto essa “è”, in quanto autonoma e obbediente a leggi proprie, e non più un “dovrebbe essere”, in quanto vincolata alla religione e all’etica, ed è naturale, per questo, che acquisti lo statuto di scienza.
La scienza è tale se si basa su principi immutabili: si tratta di costruire l’assioma entro cui inserire le derivazioni razionali di un pensiero politico; tale assioma è nell’eternità ed immutabilità dell’uomo che governa e degli uomini che sono da lui governati. Tutti, in quanto uomini, sono naturalmente portati al loro male. Se si parte da ciò il resto viene da sé. Vediamone ora gli aspetti fondamentali.

Raffaello: Ritratto di Lorenzo de Medici
DEDICA A LORENZO DE’ MEDICI
Sogliono, el più delle volte, coloro che desiderano acquistar grazia appresso uno Principe, farsegli incontro con quelle cose che infra le loro abbino più care, o delle quali veghino lui più delettarsi; donde si vede molte volte essere loro presentati cavagli, arme, drappi d’oro, pietre preziose e simili ornamenti degni della grandeza di quelli. Desiderando io adunque, offerirmi alla vostra Magnificenzia con qualche testimone della servitù mia verso di quella, non ho trovato (intra la mia supellettile) cosa quale io abbia più cara o tanto existimi quanto la cognizione delle actioni degli uomini grandi, imparata da me con una lunga experienza delle cose moderne et una continua lectione delle antiche: le quali avendo io con gran diligenzia lungamente excogitate et examinate, et ora in uno piccolo volume ridotte, mando alla Magnificenzia Vostra.
E benché io iudichi questa opera indegna della presenzia di quella, tamen confido assai che per sua umanità gli debba essere accepta, considerato come da me non gli possa esser fatto magiore dono, che darle facultà ad potere in brevissimo tempo intendere tutto quello che io (in tanti anni e con tanti mia disagi e pericoli) ho cogniosciuto et inteso. La qual opera io non ho ornata né ripiena di clausule ample, o di parole ampullose e magnifiche, o di qualunque altro lenocinio o ornamento extrinseco, con li quali molti sogliono le loro cose descrivere et ornare; perché io ho voluto, o che veruna cosa la onori, o che solamente la varietà della materia e la gravità del subietto la facci grata. Né voglio sia imputata prosumptione se uno uomo di basso et infimo stato ardiscie discorrere e regolare e’ governi de’ principi. Perché, cosí come coloro che disegniano e paesi si pongano bassi nel piano a considerare la natura de’ monti e de’ luoghi alti, e per considerare quella de’ bassi si pongano alto sopra monti, similmente, ad cognoscere bene la natura de’ populi, bisogna essere principe, et a conoscere bene quella de’ principi, bisogna essere populare.
Coloro che desiderano ingraziarsi un Principe sono soliti andare loro incontro con quelle cose che fra le loro ritengono più care e quelle di cui vedono il Principe dilettarsi; per cui si vede che molte volte gli sono presentati cavalli, armi, tessuti dorati, pietre preziose e quelle cose che fungono da ornamento alla grandezza di quello. Desiderando dunque presentarmi alla Vostra Magnificenza con qualche testimonianza della mia devozione verso di essa, non ho trovato tra le mie cose qualcosa che io ritenga tanto cara o stimi talmente quanto la conoscenza delle azioni dei grandi uomini imparata da me con una lunga esperienza delle cose moderne e da uno studio assiduo delle antiche, le quali, avendo io per lungo tempo meditate ed esaminate, riportate in un piccolo libello, ora mando alla Vostra Magnificenza.
E benché io giudichi questa mia opera indegna al cospetto di quella, tuttavia confido molto che per la sua umanità gli risulti gradita, considerando come da me non possa essere fatto maggiore dono che offrirle la possibilità di potere in brevissimo tempo capire tutto ciò che io ho conosciuto e capito in tanti anni e con molti disagi e pericoli. La quale opera scrivendola io non ho ornato né riempito di periodi complessi o di parole ridondanti e magnifiche, o di qualche altra graziosità od ornamento estraneo all’argomento, con i quali molti sono soliti descrivere ed ornare; perché ho voluto o che nessuna cosa la onori o che solamente la varietà dell’argomento e l’importanza del soggetto gliela rendano gradita. Non voglio sia reputate presunzione che un uomo di basso ed umile stato abbia l’ardire di parlare e dettare le regole dei governi dei principi; perché così come coloro che debbono disegnare i paesi si pongono in pianura per esaminare l’altezza dei monti, e per esaminare la pianura si pongono in altitudine, allo stesso modo per conoscere bene la natura dei popoli bisogna essere un principe, e viceversa per conoscere quella dei principi bisogna essere uno del popolo.
Questo brano è importantissimo perché ci permette di cogliere alcuni aspetti essenziali che attengono al significato dell’opera:
- In primo luogo dobbiamo notare che essa non è più dedicata a Giuliano, fratello del papa, ma a Lorenzo, in quanto il primo era morto nel 1516 e il giovane Lorenzo faceva le veci di suo zio Giovanni, che era diventato papa col nome di Leone X;
- La rivendicazione dell’esperienza che, come abbiamo già visto nella lettera al Vettori, non si basa soltanto sull’osservazione dell’uomo, ma anche sull’imitazione dell’antico (concetto umanistico);
- La ricerca di una prosa aderente alle cose;
- La necessità della distanza per osservare ciò che si deve descrivere o commentare.
Ciò ci dice che Il Principe è un’opera assolutamente innovativa rispetto ad opere simili, il cui scopo era quella di cercare nel Medioevo un principe sottomesso ai valori religiosi, in età umanistica ai grandi classici. Machiavelli invece parte dalla realtà che, pur comparandola con le opere del passato, cerca attraverso il presente e la storia, leggi politiche. Ciò che lo distanzia è inoltre l’uso di una lingua priva di abbellimenti retorici, che per Machiavelli allontanano il lettore dall’importanza del dettato, per arrivare direttamente al concetto, in quanto il suo trattato non deve “relegarsi” a fatto letterario ma ad vero e proprio modus operandi.

L’Italia nel 1500
QUOT SINT GENERA PRINCIPATUUM ET QUIBUS MODIS ACQUIRANTUR Di quante ragioni siano e' principati e in che modo si acquistino (cap. I)
Tutti li stati, tutti e’ dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra li uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati. E’ principati sono o ereditarii, de’ quali el sangue del loro signore ne sia suto lungo tempo principe, o e’ sono nuovi. E’ nuovi, o sono nuovi tutti, come fu Milano a Francesco Sforza, o sono come membri aggiunti allo stato ereditario del principe che li acquista, come è el regno di Napoli al re di Spagna. Sono questi dominii cosí acquistati, o consueti a vivere sotto uno principe, o usi ad essere liberi; et acquistonsi, o con le armi d’altri o con le proprie, o per fortuna o per virtù.
Tutti gli stati, tutti i domini che hanno avuto sovranità sugli uomini sono stati o sono o repubbliche o principati. E i principati sono o ereditari, dei quali il sangue del loro signore sia stato da lungo tempo principe, o sono nuovi. I nuovi o sono nuovi del tutto, come è stata Milano di Francesco Sforza, o come membri aggiunti del principe che li conquista, come il regno di Napoli per il re di Spagna. Sono questi stati così conquistati o abituati a vivere sotto un principe o abituati ad essere liberi e si acquistano o con soldati mercenari o con propri soldati, o per mezzo di fortuna o per mezzo di virtù.
In questo testo Machiavelli procede in modo dilemmatico propagginato, cioè egli cita sempre due membri, poi partendo dal secondo di essi ne sviluppa altri due e così via. E’ un metodo “scientifico” in quanto si basa sulla propagginazione logica di dati realmente esistenti, infatti non è dato che gli stati siano repubbliche o principati in quanto “esistenti”, ma in quanto “sperimentati” e “verificati”. E’ questo, infatti, un dato “reale” e quindi inoppugnabile che gli stati si strutturano o in repubbliche o retti da un sovrano. Una volta stabilito questo è naturale che tutto il resto ne derivi.

Anonimo: Cesare Borgia detto Duca di Valentino
DE PRINCIPATIBUS NOVIS QUI ALIENIS ARMIS ET FORTUNA ACQUIRUNTUR I principati nuovi che si acquistano con le armi e la fortuna altrui (cap. VII)
Coloro e quali solamente per fortuna diventano di privati principi, con poca fatica diventano, ma con assai si mantengono: e non hanno alcuna difficultà tra via, perchè vi volano; ma tutte le difficultà nascono quando e’ sono posti. E questi tali sono quando è concesso ad alcuno uno stato o per danari o per grazia di chi lo concede: come intervenne a molti in Grecia nelle città di Ionia e di Ellesponto, dove furono fatti principi da Dario, acciò le tenessino per sua sicurtà e gloria; come erano ancora fatti ancora quelli imperatori che di privati, per corruzione de’ soldati, pervenivano allo imperio.
Questi stanno semplicemente in sulla volontà e fortuna di chi lo ha concesso loro, che sono dua cose volubilissime e instabili. E non sanno e non possano tenere quello grado: non sanno, perché, se non è omo di grande ingegno e virtù, non è ragionevole che, sendo vixuto sempre in privata fortuna, sappia comandare; non possono, perché non hanno forze che gli possino essere amiche e fedele. Dipoi gli stati che vengono subito, come tutte l’altre cose della natura che nascono e crescono presto, non possono avere le barbe e corrispondenzie loro in modo che il primo tempo adverso non le spenga; se già quelli tali (come è detto) che sì de repente sono diventati principi non sono di tanta virtù, che quello che la fortuna ha messo loro in grembo, e’ sappino subito prepararsi a conservarlo, e quelli fondamenti che gli altri hanno fatti avanti che diventino principi, gli faccino poi.
Io voglio a l’uno e l’altro di questi modi detti, circa il diventare principe per virtù o per fortuna, addurre dua exempli stati né dì della memoria nostra: e questi sono Francesco Sforza e Cesare Borgia. Francesco per li debiti mezi, e con una grande sua virtù, di privato diventò Duca di Milano; e quello che con mille affanni aveva acquistato, com poca fatica mantenne. Dall’altra parte Cesare Borgia, chiamato dal vulgo Duca Valentino, aquistò lo Stato con la fortuna del Padre e con quella lo perdé, non obstante che per lui si usassi ogni opera e facessinsi tutte quelle cose che per uno prudente e virtuoso uomo si doveva fare, per mettere le barbe sua in quelli stati che l’arme e fortuna di altri gli aveva concessi. Perché (come di sopra si disse) chi non fa e fondamenti prima, gli potrebbe con una grande virtù farli poi, ancora che si faccino con disagio dello architettore e pericolo dello edificio. Se adunque si considerrà tutti e progressi del duca, si vedrà quanto lui aversi fatti grandi fondamenti alla futura potenzia; li quali non iudico superfluo discorrere, perché io non saprei quali precetti mi dare migliori a uno principe nuovo, che lo exemplo delle actioni sue. E se gli ordini suoi non gli profittorno, non fu sua colpa, perché nacque da una extraordinaria ed extrema malignità di fortuna. Aveva Alexandro VI, nel volere fare grande il Duca suo figliuolo, assai difficultà presente e future. Prima, e’ non vedeva via di poterlo fare signore di alcuno stato che non fussi stato di chiesa; e vogendosi a tôrre quello della chiesa, sapeva che il Duca di Milano et ‘Viniziani non gliene consentirebbono, perché Faenza e Rimino erano di già sotto la protectione de’ Viniziani. Vedeva oltre a questo l’arme di Italia, e quelle in spezie di chi si fussi potuto servire, essere nelle mani di coloro che dovevano temere la grandeza del papa; e però non se ne poteva fidare, sendo tutte nelli Orsini e colomnesi e loro complici. Era adunque necessario si turbassero quelli ordini e disordinare gli Stati de Italia, per potersi insignorire sicuramente di parte di quelli; il che gli fu facile perché trovò e Veniziani che, mossi da altre cagioni, si erano volti ad fare ripassare i Franzesi in Italia; il che non solamente non contradisse, ma fe’ più facile con la resoluzione del matrimonio antico del Re Luigi.
Passò adunque il Re in Italia con lo aiuto de’ Veniziani e consenso di Alexandro; né prima fu in Milano, che il Papa ebbe da llui gente per la impresa di Romagna, la quale gli fu aconsentita per la reputazione del Re. Acquistata adunque il Duca la Romagna e sbattuti i colonnesi, volendo mantenere quella e procedere più avanti, lo impedivano dua cose: l’una le armi sua che non gli parevano fedele, l’altra, la volontà di Francia; cioè che l’arme orsine, delle quali si era valuto, gli mancassino sotto e non solamente gl’impedissino lo acquistare, ma gli togliessino lo acquistato; e che il re ancora non li facessi il simile. Delli Orsini ne ebbe uno riscontro quando, doppo la expugnazione di Faenza, asaltò Bologna: ché gli vidde andare freddi in quello assalto. E circa il re, conobbe lo animo suo quando, preso el Ducato di Urbino, assaltò la Toscana: dalla quale impresa il re lo fece desistere.
Onde che il duca deliberò di non dependere più dalle arme e fortuna d’altri. E la prima cosa, indebolì le parti orsine e colomnese in Roma: perché tutti gli aderenti loro che fussino gentili omini se gli guadagnò, faccendoli suoi gentili omini e dando loro grande provisioni; et onorògli, secondo le loro qualità, di condotte e di governi; in modo che im pochi mesi negli animi loro l’affectione delle parte si spense e tutta si volse nel duca. Doppo questo, aspettò la occasione di spegniere e capi Orsini, avendo dispersi quelli di casa Colonna: la quale gli venne bene e lui la usò meglio. Perché, advedutosi gli Orsini tardi che la grandeza del duca e della chiesa era la loro ruina, feciono una dieta alla Magione nel perugino; da quella nacque la ribellione di Urbino, gli tumulti di Romagna ed infiniti pericoli del duca, e quali tutti superò con l’aiuto delli Franzesi. E ritornatoli la reputazione, né si fidando di Francia, né de altre forze externe, per non le avere a cimentare si volse agl’inganni. E seppe tanto dissimulare l’animo suo, che gli Orsini, mediante il Signor Paulo si riconciliarono seco; con il quale il duca non mancò d’ogni ragione di offizio per assicurarlo, dandoli dinari, veste e cavalli; tanto che la simplicità loro gli condusse a Sinigaglia nella sua mane.
Spenti adunque questi capi e ridotti li partigiani loro sua amici, aveva il Duca gittati assai buoni fondamenti alla potenzia sua, avendo tutta la Romagna col Ducato di Urbino; parendoli maxime aversi acquista amica la Romagnia e guadagnatosi quelli popoli, per avere cominciato a gustare il bene essere loro. E perché questa parte è degna di notizia e da essere imitata da altri, non la voglio lassare indietro. Presa che ebbe il duca la Romagna e trovandola suta comandata da Signori impotenti, li quali più presto avevano spogliato e loro subditi, che corretti e dato loro materia di disunione non di unione, tanto che quella provincia era tutta piena di latrocinii, di brighe e di ogni altra ragione di insolenzia; iudicò fussi necessario, ad volerla ridurre pacifica ed ubidiente al braccio regio, dargli buono governo. E però vi prepose messer Ramirro de Orco, uomo crudele ed expedito, al quale dette plenissima potestà: costui im poco tempo la ridusse pacifica et unita, con grandissima reputazione.
Di poi iudicò il duca non essere necessaria sì excessiva autorità, perché dubitava non divenissi odiosa; e preposevi uno iudizio civile nel mezo della provincia, con uno presidente excellentissimo, dove ogni città vi aveva lo advocato suo. E perché cognosceva le rigorosità passate avergli generato qualche odio, per purgare li animi di quegli populi e guadagniarseli in tutto volse mostrare che, se crudeltà alcuna era seguita, non era causata da llui ma dall’acerba natura del ministro. E preso sopra questo occasione, lo fece a Cesena una mattina mettere in dua pezi in sulla piaza, con un pezo di legne et uno coltello sanguinoso accanto; la ferocità del quale spettaculo fece quegli popoli in uno tempo rimanere satisfatti e stupidi.
Ma torniamo donde noi partimmo. Dico, che trovandosi il duca assai potente et in parte assicurato de’ presenti periculi, per essersi armato a ssuo modo et avere in buona parte spente quelle arme che (vicine) lo potevano offendere, gli restava (volendo procedere collo acquisto) el respecto del Re di Francia; perché conosceva come dal Re, il quale tardi s’era acorto dello errore suo, non gli sarebbe sopportato. E cominciò per questo a cercare amicizie nuove e vacillare con Francia, nella venuta che li Franzesi facevano verso el Regno di Napoli contro alli Spagniuoli che assediavano Gaeta. E lo animo suo era assicurarsi di loro; il che già sare’ presto riuscito, se Alexandro viveva. E questi furno e governi sua, quanto alle cose presente.
Ma quanto alle future, lui aveva ad dubitare im prima che un nuovo successore alla chiesa non gli fussi amico e cercassi torgli quello che Alexandro li aveva dato. Di che pensò assicurarsi in quatro modi: prima, di spegniere tutti e sangui di quelli signori che lui aveva spogliati, per tôrre al Papa quella occasione; secondo, di guadagniarsi tutti e gentili omini di Roma (come è detto) per potere con quelli tenere il papa in freno; terzio, ridurre il Collegio più suo che poteva; quarto, aquistare tanto imperio avanti che il papa morissi, che potessi per se medesimo resistere a uno primo impeto.
Di queste quatro cose alla morte di Alexandro ne aveva condotte tre; la quarta aveva quasi per condotta: perché de’ signori spogliati ne ammazzò quanti ne poté aggiugniere e pochissimi si salvarono; i gentili omini romani si aveva guadagnati e nel Collegio aveva grandissima parte; e quanto al nuovo acquisto, aveva disegniato diventare Signore di Toscana, e possedeva di già Perugia e Piombino, e di Pisa aveva presa la protectione. E come non avessi avuto ad avere rispetto a Francia (che non gliene aveva ad avere più, per essere di già e Franzesi spogliati del Regno di Napoli dalli Spagniuoli, di qualità che ciascuno di loro era necessitato comperare l’amicizia sua), egli saltava in Pisa. Doppo questo Lucca e Siena cedeva subito, parte per invidia de’ Fiorentini, parte per paura: e Fiorentini non avevano rimedio. Il che se gli fussi riuscito (che gli riusciva l’anno medesimo che Alexandro morì), si acquistava tante forze e tanta reputazione che per se stesso si sarebbe retto, e non sare’ più dependuto dalla fortuna o forze di altri ma solo dalla potenzia e virtù sua.
Ma Alexandro morì doppo cinque anni che egli aveva incominciato a trarre fuora la spada: lasciollo con lo Stato di Romagnia solamente assolidato, con tutti li altri in aria, infra dua potentissimi exerciti inimici e malato ad morte. Et era nel duca tanta ferocità e tanta virtù e si bene conosceva come li omini si hanno a guadagnare o perdere, e tanto erano validi e fondamenti che in sì poco tempo si aveva fatti che, se non avessi avuto quelli exerciti addosso o lui fussi stato sano, arebbe retto ad ogni difficultà. E che e fondamenti sua fussino buoni, si vidde: ché la Romagnia lo aspettò più di uno mese; in Roma ancora che mezo vivo stette sicuro; e benché Baglioni, Vitelli et Orsini venissino in Roma, non ebbono seguito contro di lui; potè fare se non chi e’ volle papa, almeno che non fussi chi egli non voleva. Ma se nella morte di Alexandro fussi stato sano, ogni cosa gli era facile: e lui mi disse, negli dì che fu creato Julio II, che avea pensato a cciò che potessi nasciere morendo el padre et ad tutto aveva trovato rimedio; excepto che non pensò mai, in su la sua morte, di stare ancora lui per morire.
Racolte io adunque tutte le actioni del duca, non saprei riprenderlo; anzi mi pare, come io ho fatto, di preporlo imitabile a tutti coloro che per fortuna e con le arme di altri sono ascesi allo imperio. Perché lui, avendo l’animo grande e la sua intenzione alta, non si poteva governare altrimenti; e solo si oppose alli sua disegni la brevità della vita di Alexandro, e la sua malattia. Chi adunque iudica necessario nel suo principato nuovo assicurarsi delli inimici, guadagniarsi delli amici, vincere o per forza o per fraude, farsi amare e temere da’ populi, seguire e riverire da’ soldati, spegniere quelli che ti possono o debbono offendere, innovare con nuovi modi gli ordini antiqui, essere severo e grato, magnanimo e liberale, spegniere la milizia infedele, creare della nuova, mantenersi le amicizie degli re e de’ principi in modo che ti abbino a beneficare con grazia o offendere con respecto: non può trovare più freschi exempi, che le actioni di costui.
Solamente si può acusarlo nella creazione di Julio pontefice, nella quale il duca ebbe mala electione. Perché (come è detto) non potendo fare uno papa a suo modo, poteva tenere che uno non fussi papa; e non doveva mai consentire al papato di quelli cardinali, che lui avessi offesi o che, divenuti papa, avessino ad avere paura di lui: perché gli uomini offendono o per paura, o per odio. Quelli che lui aveva offeso erano infra gli altri Sancto Pietro ad Vincula, Colonna, San Giorgio, Ascanio; tutti li altri avevano (divenuti papi) ad temerlo, eccepto Roano e gli Spagniuoli: questi per cogniunzione et obligo, quello per potenzia, avendo coniunto seco el Regno di Francia. Pertanto el duca innanzi ad ogni cosa doveva creare papa uno spagniuolo; e non potendo, dovea consentire a Roano non a San Pietro ad Vincula. E chi crede che nelli personaggi grandi benefizii nuovi faccino dimenticare le iniurie vechie, s’inganna. Errò adunque el duca in questa electione e fu cagione dell’ultima ruina sua.

Anonimo: Rodrigo Borgia, papa Alessandro VI
Coloro che, affidandosi solamente alla fortuna, diventano da privati cittadini principi, lo diventano facilmente ma con molta difficoltà mantengono il loro stato; e non hanno alcuna opposizione nell’acquisizione del principato, ma molte una volta insediati. E questi principi lo diventano quando è concesso loro da qualcuno uno stato o dietro pagamento o perché lo riceve in dono da chi lo concede: come capitò a molti nelle città greche della Ionia e dell’Ellesponto, dove divennereo principi grazie a Dario affinché le governassero per garantirgli sicurezza e gloria; allo stesso modo erano eletti imperatori da cittadini privati dopo aver corrotto i soldati ottenendo così l’Impero.
Coloro che sono diventati principi in questo modo si appoggiano soltanto sulla volontà o la fortuna di chi ha concesso loro lo stato, che sono assolutamente volubili ed instabili. E non sanno ne possono mantenere quella posizione: non sanno, perché, se non vi è un uomo di grandissima capacità e virtù, non è pensabile che, avendo vissuto sempre da cittadino privato, sappia comandare; non possono, perché non possiedono armi proprie che siano loro obbedienti e fedeli. Inoltre gli stati che si sviluppano all’improvviso, come tutte le cose che crescono velocemente in natura, non possono avere radici e ramificazioni in modo che alla prima intemperie non appassiscano; a meno che gli stessi (come già detto) che improvvisamente sono diventati principi non possiedono tanta virtù che ciò che la fortuna ha procurato loro si apprestino da subito a mantenerlo, e le basi (degli stati) che gli altri hanno fatto prima di essere principi, facciano in seguito.
Voglio, riguardo ai due modi citati, cioè diventare principe per virtù o per fortuna, riportare due esempi tratti dalla contemporaneità e questi sono Francesco Sforza e Cesare Borgia. Francesco, con azioni opportune e con grande capacità politica, da cittadino privato divenne Duca di Milano e ciò che aveva acquistato con mille difficoltà, mantenne con poca fatica. L’altro, Cesare Borgia, chiamato Duca di Valentino, acquistò lo stato grazie alla potenza del padre e con la stessa lo perse; nonostante che, da parte sua, si facesse di tutto e si mettessero in opera tutte quelle azioni che un uomo saggio e virtuoso doveva fare, affinché si mettessero quelle radici in quegli stati che la forza e la fortuna di altri gli avevano concesso. Perché (come già detto) chi non pone fondamenta prima, potrebbe con grande capacità, farle in seguito, sebbene si facciano con difficoltà dell’architetto e pericolo di crollo dell’edificio. Se dunque si esamineranno tutti i comportamenti del duca, si vedrà che lui aveva messo solide fondamenta per la sua futura potenza, che giudico necessario analizzare, perché non saprei quali consigli più validi offrire ad un principe nuovo che l’esempio delle sue azioni. E se le azioni fatte non gli giovarono, non fu per colpa sua, perché derivarono da una eccezionale e grandissima avversità della sorte.
Alessandro VI aveva, nel voler rendere potente suo figlio molte difficoltà sia nell’immediato che nel futuro. per prima cosa non vedeva il modo di poterlo fare signore di alcuno stato che non fosse lo Stato della Chiesa e decidendosi a prendere (parte di) quello stesso, sapeva che il Duca di Milano e i Veneziani non glielo avrebbero consentito, perché Faenza e Rimini erano già sotto protezione veneziana. Vedeva inoltre le forze militari in Italia, soprattutto quelle di cui si sarebbe dovuto servire, essere nella mani di coloro che non desideravano che la potenza della chiesa si ingrandisse; e perciò non se ne poteva fidare, stando tutte nelle mani degli Orsini e dei Colonna e dei loro alleati. Era dunque necessario si mettesse in discussione quell’equilibrio politico e si mettessero in crisi gli stati italiani, per potersi impossessare di parte di quelli senza correre troppi rischi, cosa che gli fu piuttosto facile perché trovò i veneziani che, mossi da loro motivazioni (diverse da quelle di Alessandro) si erano decisi a richiamare i Francesi, il che non contraddisse i suoi piani, ma li rese più facili con lo scioglimento del matrimonio di re Luigi XII con l’antica sposa (Giovanna di Francia per prendere, in seconde nozze, Anna di Bretagna, vedova di Carlo VIII e discendente dei Visconti).
Venne dunque il re di Francia in Italia, con l’aiuto di Venezia e il consenso di Alessandro VI e non aveva ancora raggiunto Milano che il papa ricevette da lui soldati per la conquista della Romagna, che fu resa possibile grazie al prestigio del re. Il duca, presa dunque la Romagna e sconfitti i Colonna, volendola mantenere e continuare nella sua politica espansionista, era ostacolato da due cose, la prima che le sue forze militari non gli fossero fedeli, l’altra la proibizione della Francia; cioè che le armi degli Orsini, delle quali si era servito, gli venissero a mancare e non solamente gli impedissero d’allargare le sue conquiste, ma che gli togliessero anche quelle già fatte e che il re di Francia non facesse le stesse cose. Degli Orsini ebbe la prova quando, dopo Faenza, assaltò Bologna, che li vide non impegnarsi troppo in quell’attacco; riguardo il re di Francia capì le sue intenzioni quando, conquistato il ducato di Urbino, assaltò la Toscana, ma fu fermato per ordine del re.
E perciò il duca decise di non dipendere più dalle armi e dalla fortuna offerte da altri. Innanzi tutto indebolì i Colonna e gli Orsini a Roma facendo in modo di allontanare da loro e guadagnarli per sé tutti i loro partigiani in città, offrendo lauti stipendi e onorandoli affidando incarichi militari e politici, secondo le loro competenze di modo che, in pochi mesi, la partigianeria si spense e si rivolse verso il duca. In seguito aspettò l’occasione per uccidere i comandanti degli Orsini, dopo aver costretto alla fuga quelli dei Colonna, la quale occasione seppe sfruttare bene e utilizzare ancor meglio. Infatti, gli Orsini resisi conto tardi dell’accresciuta potenza del duca e della chiesa rappresentava la rovina per loro, indissero un’adunanza in Megione presso Perugia: da essa derivarono la ribellione di Urbino, la ribellione della Romagna ed altri innumerevoli pericoli per il duca, che superò grazie all’aiuto dei Francesi. Il duca, riacquistata la forza (che era stata in pericolo) non fidandosi completamente dei francesi né di altre forze esterne, per non metterle alla prova, decise di operare attraverso gli inganni. Seppe nascondere così bene le sue intenzioni che gli Orsini, grazie alla mediazione del signor Paolo Orsini, si riconciliarono con lui, e con Paolo il duca non mancò mai di ogni atto di cortesia per rassicurarlo, donandogli soldi, vesti e cavalli, tanto che la loro semplicità li portò a Senigallia a cadere nelle sue mani.
Uccisi dunque questi capi militari e fatti passare dalla sua parte i loro fautori, il duca aveva posto le basi per il suo potere, avendo sotto di sé tutta la Romagna ed il ducato di Urbino; sembrandogli soprattutto avere ottenuto il favore di tutta quanta la Romagna e di essersi guadagnato la fedeltà della popolazione per aver iniziato a sperimentare i vantaggi del suo governo. E perché questo fatto è degno di commento e di essere imitata, non la voglio trascurare. Il duca, presa la Romagna e trovandola governata da signori incapaci che avevano piuttosto spogliato che guidato i loro cittadini e dato loro motivo di disunione più che di unione, per il fatto che quella provincia era completamente piena di ruberie, rivalità e d’ogni altra prepotenza; il duca giudicò fosse necessario ridurla pacifica ed obbediente al suo sovrano e darle un buon governo. Perciò vi mise a capo Ramiro de Lorqua, uomo crudele e sbrigativo, a cui dette pienissima libertà d’azione; costui, in poco tempo, la riportò pacifica e obbediente.
In un secondo tempo il duca credette che non fosse più necessaria una così estrema autorità, perché pensava potesse diventare odiosa e pose a capo della Romagna una magistratura civile con sede nella regione con un presidente eccellentissimo, presso la quale magistratura ogni città della regione aveva il suo rappresentante. Poiché sapeva che la severità passata gli aveva procurato qualche risentimento, per liberare gli animi di quei popoli e guadagnare la loro fedeltà volle dare la dimostrazione che, se vi era stata qualche crudeltà, non dipendeva da lui, dal ministro preposto al governo, e preso a motivo l’odio dei suoi sudditi verso di lui, una mattina gli fece tagliare la testa su di un ceppo con una mannaia e un coltellaccio insanguinato, la ferocia di quello spettacolo fece in un attimo rimanere tutti quei popoli allo stesso tempo contenti e stupefatti.
Ma torniamo da dove siamo partiti: dico che il duca, trovandosi il duca in una posizione di forza ed essendosi assicurato dai pericoli immediati, per essersi procurato milizie proprie e per aver battuto quelle più prossime che potevano colpirlo, gli rimaneva, per allargare i suoi confini, il timore del re di Francia, perché sapeva come lo stesso re, il quale si era accorto troppo tardi del suo errore (nell’aver favorito il duca), non avrebbe mai concesso un allargamento della sua potenza. Per questo cominciò a cercare nuove alleanze e a tentennare nell’amicizia con i Francesi, in occasione della discesa di quest’ultimi verso il regno di Napoli contro gli Spagnoli che assediavano Gaeta. E il suo tentativo era quello di rendere innocui i Francesi, il che gli sarebbe riuscito se Alessandro VI non fosse morto. E queste furono le sue scelte politiche riguardo le cose presenti.
Ma quanto alle cose future, lui doveva temere per prima cosa che il nuovo pontefice non gli fosse amico e cercasse di togliergli quello che Alessandro VI gli aveva dato. Per cui pensò di neutralizzare questo rischio in quattro modi: primo, eliminare tutti i discendenti di quelli a cui aveva tolto lo stato, al fine di togliere al nuovo papa l’occasione di sfruttare le rivendicazioni dei signori e degli eredi spodestati; secondo, guadagnare a sé tutti i nobili di Roma (come è stato già detto) per potere, per mezzo loro, tenere a freno il papa; terzo, avere il maggior numero possibile di cardinali a lui favorevoli (per impedire l’elezione di un papa ostile); quarto, acquistare tanto potere prima che il papa suo padre morisse, da poter resistere con le proprie forze a un primo assalto. Di queste quattro cose alla morte di Alessandro ne aveva condotte tre, la quarta quasi realizzata: perché dei signori spodestati ammazzò tutti quelli che aveva potuto raggiungere e pochissimi tra loro scamparono; i nobili romani se li era fatti amici e nel collegio cardinalizio aveva un numero alto di prelati a lui favorevoli. Riguardo al nuovo territorio da conquistare, aveva progettato di diventare signore della Toscana e possedeva già Perugia e Piombino e aveva messo dsotto sua protezione Pisa. E non appena non avesse dovuto più temere i Francesi (e non doveva quasi averne più, avendo essi perso il regno di Napoli a favore degli Spagnoli in modo che sia la Francia sia la Spagna si trovavano nella necessità di comprare la sua amicizia), egli si sarebbe gettato su Pisa. Dopo questo Lucca e Siena si sarebbero immediatamente arrese, parte per rivalità dei Fiorentini, parte per paura; e i Fiorentini non avrebbero più avuto scampo. Il diventare duca di Toscana se gli fosse riuscito (che gli sarebbe riuscito l’anno stesso della morte di Alessandro) avrebbe acquisito tanta forza e tanto rispetto che si sarebbe sostenuto con le proprie forze e non sarebbe più dipeso dalla sorte e forze di altri, ma soltanto dalla sua potenza e capacità politica.
Ma Alessandro morì dopo cinque anni che il Valentino aveva iniziato le sue attività militari e lo lasciò con il solo stato di Romagna assicurato e con tutti gli altri non ancora assestati tra i due potentissimi nemici tra i Francesi e gli Spagnoli e gravemente ammalato. Eppure vi era nel duca tanta ferocia e tanta capacità e conosceva perfettamente come portare gli uomini dalla propria parte o annientarli, e tanto erano valide le basi che si era costruite che, se non avesse avuto eserciti minacciosi intorno o se non si fosse ammalato, avrebbe resistito a tutte le difficoltà. E che le fondamenta sua fossero valide, si vide con chiarezza, perché la Romagna lo aspettò per più di un mese; a Roma, benché gravemente malato, rimase in sicurezza e benché il governatore di Bologna, Baglioni, i Vitelli e gli Orsini fossero venuti a Roma, non trovarono aiuti contro di lui; se non riuscì a fare eleggere papa chi voleva lui, riuscì a impedire che fosse eletto chi non voleva. Ma se durante la morte di Alessandro fosse rimasto sano, ogni cosa gli sarebbe stata facile: lui mi disse, nei giorni in cui venne creato pontefice Giulio II, che aveva pensato a quello che sarebbe successo dopo la morte del padre e a tutto ciò che dopo la morte del padre potesse succedere aveva trovato rimedio; eccetto che non pensò mai, di fronte alla morte del padre, di stare anche lui per morire.
Ho riunite tutte le azioni del duca e non saprei criticarlo, anzi mi sembra (come ho fatto) di proporlo come modello per tutti coloro che per fortuna o per forza di altri sono arrivati al potere; perché lui avendo un animo magnanimo e un grande obiettivo, non poteva comportarsi diversamente e solamente si oppose ai suoi propositi la brevità della vita di Alessandro VI e la propria malattia. Chi dunque giudica necessario per il suo principato nuovo mettersi al sicuro dai nemici, guadagnarsi dagli amici; vincere per forza o per inganno; farsi amare o temere dai popoli; seguire e farsi rispettare dai soldati; uccidere quelli che ti possono o devono offendere; rinnovare le istituzioni vigenti prima dell’ascesa del principe; essere severo e ben accetto; di grande animo e generoso; eliminare la forza militare infedele, crearne una nuova; mantenere l’amicizia dei re e dei principi in modo che rechino benefici con riconoscenza o recare qualche danno con esitazione; non può trovare i più recenti esempi che le azioni di costui.
Solamente si può accusarlo della nomina di Giulio II come papa, nella quale il duca fece una cattiva scelta. Perché (come già detto) non potendo fare un papa a suo gradimento, poteva ottenere che non ne venisse eletto un altro; e non doveva permettere che venisse eletto papa uno di quei cardinali che lui avesse offeso o che, diventati papa, avesse motivo di aver paura di lui: perché gli uomini offendono per paura o per odio. Quelli che lui aveva offeso vi erano, fra gli altri, Giuliano della Rovere, cardinale di San Pietro in Vincoli, i cardinali Giovanni Colonna, Raffaello Riario, Ascanio Sforza; tutti gli altri, diventati papi, lo avrebbero dovuto temere, ad eccezione dei Roano e dei cardinali spagnoli, quest’ultimi per i legami di nazionalità e per obbligazione e quello di Roano per il suo potere, avendo l’appoggio di tutti i Francesi. Per cui il duca prima di tutto doveva creare papa uno spagnolo e, non potendo, doveva consentire a Roano, ma non a un Della Rovere. E chi crede che nei personaggi magnanimi i nuovi benefici facciano dimenticare le antiche ingiurie, si sbaglia. Sbagliò dunque il duca in questa scelta e ciò fu motivo della propria definitiva caduta.

John Collier: Un bicchiere di vino con Cesare Borgia (1914)
Questo lungo passo è da mettere in relazione con l’operetta Del modo che tenne el duca di Valentino per ammazzar Vitellozzo, Oliverotto da Fermo, il signor Paolo e il Duca di Gravina Orsini in Senigaglia in cui si descrive in modo dettagliato il modo di operare di Cesare Borgia. E’ proprio in quella occasione, a cui per ordine del governo fiorentino assistette personalmente, che poté misurare l’abilità del duca di Valentino, abilità ancora più apprezzabile in quanto costretta alla crudeltà. Nel passo precedente, tuttavia, quello che emerge è lo sguardo storico che, pur ammirato, osserva il momento e lo registra.
Ne Il Principe Machiavelli, dopo aver appena accennato alla “fortuna” di Francesco Sforza che, dopo esser stato a capo delle milizie di Milano impegnate nella guerra contro Venezia, rivolge le armi contro la propria città, ne abbatte il governo, e sposa la figlia del defunto Francesco Maria Visconti, diventando così “nuovo” signore della città Ambrosiana, incentra tutto il discorso su Cesare Borgia, la cui figura è inquadrata nella sua totalità. Infatti muore nel 1507 e lo scrittore fiorentino, nei cinque anni di distanza che lo separano dall’opera, può misurare l’intera sua grandezza politica, strutturando l’argomento in sei parti fondamentali:
- Parte dall’assioma scientifico: chi guadagna lo stato con le armi altrui o con la fortuna, lo raggiunge facilmente, ma difficilmente lo mantiene.
- conforta, con personalità contemporanee, l’assioma precedente nella figura di Francesco Sforza, che, ottenuto lo stato con difficoltà lo mantiene semplicemente e quello di Cesare Borgia che ottenuto facilmente dal padre, pur operando “politicamente” in modo virtuoso, per malignità della “fortuna” lo perde.
- Ripercorre la storia politica del duca a partire dalla politica nepotista di Adriano VI che lo condurrà in seguito alla piena conquista della Romagna e del ducato di Urbino.
- Mostra come un principe debba mantenere e rafforzare la sua posizione appena ottenuta anche con l’inganno: è l’episodio di Remirro de Orco (Ramiro de Lorqua) suo scudiero a cui viene ordinato per sedare gli scontenti e i facinorosi di usare la forza, quindi addossandogli tutta la responsabilità della violenza messa in atto, lo uccide, guadagnandosi la fama di pacificatore.
- Raggiunto l’apice del successo il Valentino comincia il suo declino per “malignità” della fortuna: gli muore il padre e lui si ammala: egli non riuscirà a gestire, nel pieno delle sue forze, le trame che porteranno all’elezione di un nuovo pontefice che non sia, nei suoi confronti, nemico.
- Valutazione finale sull’operato del figlio di Alessandro: egli mise in atto tutte le azioni gloriose ma, per una straordinaria cattiva sorte, non poté portarla a termine.
Se si considera il modello logico seguito dal Machiavelli nel disegnare la figura del Valentino due sono gli elementi che emergono:
- Lo sguardo di Machiavelli non è più storico ma politico: le azioni di Cesare Borgia vengono valutate alla luce del loro effetto politico e, a partire da esso, proposte come modello per il nuovo principe;
- La contraddizione tragica, e perciò poetica, di Cesare che si muove tra virtù e fortuna. Se nell’assioma iniziale, infatti, si afferma che chi raggiunge l’obiettivo politico grazie ad una concessione lo deve mantenere con estrema fatica e virtù, il duca di Valentino si mostra non solo capace, ma addirittura esemplare nel metterla in opera, ma tragicamente, la dea bendata gli volge le spalle.
Per Machiavelli dunque qual è il modo per non ruinare del tutto?

Sebastiano del Piombo: ritratto di Cesare Borgia
DE HIS REBUS QUIBUS HOMINES ET PRAESERTIM PRINCIPES LAUDANTUR AUT VITUPERANTUR Di quelle cose per le quali gli uomini e specialmente i principi sono lodati o vituperati (cap. XV)
Resta ora a vedere quali debbino essere e modi e governi di uno principe o con subditi o con li amici. E perché io so che molti di questo hanno scripto, dubito (scrivendone ancora io) non essere tenuto prosumptuoso, partendomi maxime nel disputare questa materia, dalli ordini delli altri. Ma, sendo l’intenzione mia stata scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare drieto alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa; e molti si sono immaginati republiche e principati che non si sono mai visti né conosciuti invero essere. Perché gli è tanto discosto da come si vive ad come si doverrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si doverrebbe fare, impara più tosto la ruina che la perservazione sua. Perché uno uomo che voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene rovini infra tanti che non sono buoni. Onde è necessario, volendosi uno principe mantenere, imparare a potere essere non buono, et usarlo e non usarlo secondo la necessità.
Lasciando adunque adietro le cose circa un Principe immaginate, e discorrendo quelle che son vere, dico, che tutti li uomini, quando se ne parla (e maxime e principi, per esser posti più alti) sono notati di alcuna di queste qualità che arrecano loro o biasimo, o laude. E questo è che alcuno è tenuto liberale, alcuno misero (usando uno termine toscano, perché avaro in nostra lingua è ancora colui che per rapina desidera d’avere, misero chiamiamo noi quello si astiene troppo dall’usare il suo); alcuno è tenuto donatore, alcuno rapace; alcuno crudele, alcuno pietoso; l’uno fedifrago, l’altro fedele; l’uno effeminato e pusillanime, l’altro feroce ed animoso; l’uno umano, l’altro superbo; l’uno lascivo, l’altro casto; l’uno intero, l’altro astuto; l’uno duro, l’altro facile; l’uno grave, l’altro legieri; l’uno religioso, l’altro incredulo, e simili. Et io so che ciascuno confesserà, che sarebbe laudabilissima cosa in uno principe trovarsi di tutte le sopraddette qualità, quelle che sono tenute buone. Ma perché non si possono avere tutte, né interamente observare, per le condizioni umane che non lo consentono; è necessario essere tanto prudente che sappi fugire la infamia di quelli vizii che gli torrebbano lo Stato; e da quegli che non gliene tolgano guardarsi, se gli è possibile, ma non possendo, vi si può con minor respecto lasciare andare. Et etiam non si curi d’incorrere nell’infamia di quelli vizii, sanza i quali possa difficilmente salvare lo stato. Perchè se si considera bene tutto, si troverà qualche cosa che parrà virtù, e seguendola sare’ la ruina sua; e qualcuna altra che parrà vizio, e seguendola ne nascie la sicurtà et il bene essere suo.
Dobbiamo ora considerare quale debba essere il modo di comportarsi di un principe verso i propri sudditi o gli amici. E siccome so che già molti hanno trattato questo argomento, dubito, scrivendone anche io, di sembrare presuntuoso, allontanandomi, soprattutto nel trattare questa materia, dal modo in cui l’hanno trattata gli altri. Ma avendo l’intenzione di scrivere una cosa utile a chi è in grado di capirla, mi è parso più giusto andare dietro la verità effettuale della realtà piuttosto che immaginarmela. Infatti molti si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti o non esistono affatto. Perché è tanto distante da come si dovrebbe vivere che colui il quale trascura ciò che si deve fare per ciò che si dovrebbe fare, impara piuttosto la sua rovina che la sua salvezza, perché un uomo che voglia apparire in tutte le cose buono, accade che rovini in mezzo a tanti altri che buoni non sono. Pertanto è necessario per un principe, volendo mantenere il proprio stato, imparare a poter essere non buono, e usare o non usare questa capacità, secondo la necessità.
Non prendendo dunque in considerazione le fantasticherie dette sui principi ed esaminando attentamente le verità di fatto, dico che tutti gli uomini (soprattutto i principi, perché posti più in vista degli altri) si distinguono per alcune qualità che arrecano loro il biasimo o la lode. Ciò significa che qualcuno è ritenuto generoso, qualcuno avaro (usando un termine toscano, perché in italiano avaro è colui che per avidità desidera la roba altrui, mentre misero definiamo noi colui che esagera nel non voler utilizzare i suoi beni); qualcuno generoso nel donare, qualcun’altro abile ad accaparrarsi le altrui cose; uno spietato, uno misericordioso; sleale, leale; debole e vile, bellicoso e coraggioso; benigno, presuntuoso; preda dei piaceri oppure casto; onesto e dissimulatore; severo, accondiscendente; serio o superficiale; religioso o scettico e altre caratteristiche simili. E so che tutti penseranno che sarebbe una cosa estremamente lodevole che si trovino, in uno stesso principe, tutte le qualità sopra elencate, ritenute buone. Ma poiché non è possibile possederle tutte, né metterle in pratica in ogni circostanza, perché i limiti umani non lo consentono, è necessario, per un principe essere tanto saggio da evitare quei difetti che potrebbero fargli perdere il potere e deve guardarsi anche da quelli che non glielo toglierebbero, se possibile, ma laddove non fosse possibile, può indulgervi con minor paura. Ma anche non si faccia scrupolo di guadagnarsi il biasimo per quei vizi senza i quali, difficilmente, potrebbe mantenere il potere. Perché se si prende in considerazione tutto (cioè la morale e l’azione politica), si troveranno qualità che sembrano virtù ma portano alla rovina del principe che le segue, e qualche altra virtù che sembra vizio che genererà il sicurezza per lo stato e benessere per il principe che l’ha seguita.
Questo capitolo rappresenta l’esplicitazione del pensiero di Machiavelli riguardo la politica. Ed è per questo che egli la indirizza a chi è in grado d’intenderla, cioè a chi è in grado di mettere in pratica la scienza della politica, di cui lui è il fondatore. Infatti egli mette in evidenza sin da subito la differenza tra quelli che un tempo erano gli specula principis dove regnava l’idea di un regno e di un principe reggente immaginato. Ora lui si basa sulla realtà e questa è effettuale, cioè “effettiva, positiva, basata su fatti (effetto per fatto è comune nel ‘500) è creazione del Machiavelli” (Luigi Russo). Allora ne consegue logicamente che egli non deve insegnare come si doverrebbe vivere ma come si deve vivere, più precisamente non come un principe dovrebbe governare, ma come deve governare.
Detto questo può quindi illustrare, in binomi oppositivi le qualità che ogni principe, in quanto uomo, possiede, ma deve altresì insegnare come tra questi, anche quelli più palesemente annoverabili tra i vizi, possano, laddove siano i soli a permettere la propria esistenza e quello dello stato, diventare virtù.

Chirone ed Achille: affresco del I sec. d. C.
QUOMODO FIDES A PRINCIPIBUS SIT SERVANDA
In che modo i principi debbano mantenere la parola data
(cap. XVIII)
Quanto sia laudabile in uno principe mantenere la fede, e vivere con integrità e non con astuzia, ciascuno lo intende. Nondimanco si vede per experienza, nelli nostri tempi, quelli principi avere fatto gran cose che della fede hanno tenuto poco conto, e che hanno saputo con l’astuzia aggirare e cervelli delli uomini et alla fine hanno superato quelli che si sono fondati in sulla lealtà.
Dovete adunque sapere come sono dua generazioni di combattere: l’uno con le leggie; l’altro, con la forza. Quel primo è propio dello uomo; quel secondo, delle bestie. Ma perché el primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo: pertanto a uno principe è necessario sapere bene usare la bestia e lo uomo. Questa parte è suta insegniata alli principi copertamente dalli antichi scriptori: li quali scrivono come Achille, e molti altri di quelli principi antichi, furono dati a nutrire ad Chirone centauro che sotto la sua disciplina li costudissi. Il che non vuol dire altro, avere per preceptore uno mezo bestia et mezo uomo, se non che bisogna a uno principe sapere usare l’una e l’altra natura; e l’una sanza l’altra non è durabile. Sendo adunque necessitato uno principe sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe et il lione; perché il lione non si defende da’ lacci, la golpe non si defende da’ lupi. Bisogna adunque essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a sbigottire e’ lupi: coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendano.
Non può per tanto uno signore prudente, né debbe observare la fede, quando tale observanzia gli torni contro e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. E se li uomini fussino tutti buoni, questo precepto non sarebbe buono; ma perché sono tristi e non la observarebbono a te, tu etiam non l’hai ad observare a loro: né mai a uno principe mancorno cagioni legittime di colorire la inobservanzia. Di questo se ne potre’ dare infiniti exempli moderni e monstrare quanta pace quante promisse sono state fatte irrite e vane per la infidelità de’ principi: e quello che ha saputo meglio usare la golpe, è meglio capitato. Ma è necessario questa natura saperla bene colorire, et essere gran simulatore e dissimulatore: e sono tanto semplici gli uomini, e tanto ubidiscono alle necessità presenti, che colui che inganna troverrà sempre chi si lascerà ingannare.
Io non voglio delli esempli freschi tacerne uno. Alessandro sexto non fece mai altro, non pensò mai ad altro che ad ingannare uomini: e sempre trovò subietto da poterlo fare. E non fu mai uomo che avessi magiore efficacia in asseverare e con magiori iuramenti affermassi una cosa, che l’observassi meno: nondimeno, sempre gli succederono gl’inganni ad votum, perché conosceva bene questa parte del mondo.
A uno principe, adunque, non è necessario avere in fatto tutte le soprascritte qualità, ma è bene necessario parere di averle. Anzi ardirò di dire questo, che avendole et observandole sempre, sono damnose, e parendo di averle, sono utili; come parere pietoso, fedele, umano, intero, relligioso, et essere; ma stare in modo edificato con lo l’animo che, bisognando non essere, tu possa e sappi mutare el contrario. Et hassi ad intendere questo: che uno principe (e maxime uno principe nuovo) non può observare tutte quelle cose per le quali gli uomini sono chiamati buoni, sendo spesso necessitato (per mantenere lo stato) operare contro alla fede, contro alla carità, contro alla umanità, contro alla religione. E però bisogna che elli abbia uno animo disposto a volgersi secondo che e venti della fortuna e le variazioni delle cose gli comandano; e (come di sopra dixi), non partirsi dal bene, potendo, ma sapere intrare nel male, necessitato. Debba adunque uno principe avere gran cura che non li esca mai di boca una cosa che non sia piena delle soprascripte cinque qualità: e paia, ad udirlo e vederlo, tutto pietà, tutto fede, tutto integrità, tutto umanità, tutto relligione. E non è cosa più necessaria ad parere di avere, che questa ultima qualità. E li uomini in universali iudicano piú alli ochi che alle mani: perché tocca a vedere a ogniuno, a sentire a pochi; ogniuno vede quello che tu pari, pochi sentono quello che tu se’; e quelli pochi non ardiscano opporsi alla oppinione di molti, che abbino la maestà dello stato che gli difenda. E nelle azioni di tutti li uomini e maxime de’ principi, dove non è iudizio a chi reclamare, si guarda al fine. Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo stato: e’ mezzi sempre fieno iudicati onorevoli e da ciascuno laudati. Perché el vulgo ne va preso con quello che pare e con lo evento della cosa: e nel mondo non è se non vulgo; e pochi ci hanno luogo quando gli assai hanno dove appoggiarsi. Alcuno principe de’ presenti tempi, quale non è bene nominare, non predica mai altro che pace e fede; e dell’una e dell’altra è inimicissimo; e l’una e l’altra, quando egli l’avessi observata, gli arebbe piú volte tolto o la reputazione e lo stato.

Un’immagine in cui l’autrice vuole rappresentare la forza e l’astuzia
Ognuno può capire quanto sia degno di lode, per un principe, mantenere la parola data e vivere con onestà e non con dissimulazione. Ciononostante si vede per esperienza diretta che nei nostri tempi i principi che hanno compiuto grandi imprese non si sono preoccupati di mantenere la parola data e che hanno saputo con furbizia confondere le idee della gente ed alla fine hanno avuto più potere di quelli che hanno basato il loro comportamento sulla sincerità.
Dunque, dovete sapere che esistono due modi di combattere (i propri nemici): : uno per mezzo delle leggi, l’altro per mezzo della forza: il primo è proprio dell’uomo, il secondo della bestia. Ma poiché il primo a volte non è sufficiente, è necessario ricorrere al secondo; pertanto un principe deve essere capace di servirsi (in modo politicamente efficace) sia delle qualità animali sia delle umane. Questo aspetto è stato insegnato ai principi dagli autori antichi sotto una veste mitologica: infatti essi scrivono come Achille ed altri principi antichi furono lasciati in custodia al centauro Chirone affinché li allevasse secondo le regole. L’avere come precettore un essere mezzo bestia e mezzo uomo non significa altro se non che un principe debba imparare ad usare entrambe le nature perché l’una senza l’altra non può durare. Poiché dunque necessario che il principe sappia usare bene l’indole della bestia, deve prendere ad esempio quella della volpe e del leone in quanto quest’ultimo non sa difendersi dagli lacci (inganni) mentre la volpe non sa difendersi dai lupi. Bisogna dunque essere astuto come una volpe per evitare gli inganni e forte come un leone per scacciare i lupi. Coloro che fondano il potere soltanto sulla forza non comprendono la natura della politica.
Pertanto un principe saggio non può e non deve mantenere la parola data quando tale osservanza gli risulti dannosa e quando sono venuti a mancare i motivi che lo indussero a promettere. Se gli uomini fossero tutti leali, questo consiglio non sarebbe valido; ma poiché sono cattivi e non manterrebbero la parola data a te, neppure tu devi mantenerla a loro, né mai ad un principe sono venute meno le ragioni per giustificare l’inosservanza della parola data. Di questo atteggiamento si possono trovare infiniti esempi nei nostri tempi e (si può) dimostrare quanti trattati di pace e quante promesse siano state rese inefficaci e vane per l’infedeltà dei principi e quel principe che ha saputo meglio agire alla maniera della volpe ha avuto maggior successo. Ma è necessario saper ben mascherare la qualità dell’astuzia ed essere un gran simulatore e dissimulatore e gli uomini sono tanto ingenui e costretti a piegarsi alle necessità contingenti, che colui che ordisce inganni troverà sempre chi si lascerà ingannare.
Voglio farvi un esempio contemporaneo. Alessandro VI non ha fatto mai altro e non ha pensato mai ad altro se non ad ingannare gli uomini e ha sempre trovato qualcuno che gli ha permesso di farlo. Non vi fu mai un altro uomo che avesse capacità di persuadere e che garantisse con maggiore fermezza una cosa alla quale non teneva fede: ciononostante gli inganni riuscirono sempre secondo il suo desiderio, perché conosceva bene questa parte della politica.
Non è dunque necessario che in realtà un principe possieda tutte le qualità che ho già detto* ma è assolutamente necessario che simuli di averle. Anzi, oserò dire questo: che il possederle e l’osservarle sempre è dannoso, mentre torna utile simulare di avere: come sembrare clemente, leale, umano, onesto e religioso, ma occorre stare con l’animo pronto, qualora sia necessario non esserlo e mutarti nel contrario. E devi capire questo: che un principe (e soprattutto un principe nuovo) non può avere tutte quelle qualità per le quali gli uomini sono ritenuti buoni, perché è spesso costretto, per mantenere il potere, ad agire in modo contrario alla lealtà, alla carità, all’umanità e alla religione. Perciò bisogna che il principe abbia un animo disposto a cambiare atteggiamento in base ai venti della fortuna e ai mutamenti delle circostanze; e (come ho detto prima*) non allontanarsi dal bene, potendo, ma anche sapere agire con malvagità quando è costretto. Quindi un principe deve stare attento a non farsi mai sfuggire dalla bocca un discorso che non sia improntato alle cinque qualità di cui ho parlato e deve parere, a vederlo e udirlo, tutto clemenza, lealtà, integrità, umanità e religione. E non c’è qualità che sia più necessario sembrare di avere che quest’ultima. Infatti gli uomini generalmente giudicano secondo l’apparenza più che secondo la concretezza, perché a tutti è concesso vedere, a pochi comprendere; ognuno vede ciò che appari, pochi percepiscono quello che sei e quei pochi non osano opporsi alla opinione dei molti che hanno dalla loro la grandezza e il prestigio del potere. Per giudicare le azioni di tutti gli uomini e soprattutto dei principi, per i quali non c’è tribunale a cui fare appello, si guarda al risultato finale. Agisca dunque un principe in modo tale da conquistare e mantenere il potere e i mezzi saranno giudicati leali e lodati da tutti. Perché la massa deve essere sempre attirata con le apparenze e con il successo finale: nel mondo non vi è che un’umanità passiva priva di giudizio critico e le poche o persone avvedute non hanno possibilità di farsi notare se la massa è appoggiata dall’autorità del potere. Un principe dei nostri tempi, che è bene non nominare**, non predica altro che pace e bene sebbene sia nemico di entrambe e l’una e l’altra (la pace e il bene) se l’avesse osservate gli avrebbero fatto togliere il prestigio ed il potere.
* cap. XV
** Ferdinando il Cattolico
Michel Sittow: Ritratto di Ferdinando il Cattolico
E’ un capitolo piuttosto controverso perché se è pur vero che nel precedente veniva conservata la possibilità da parte del principe di usare, secondo le circostanze, qualità positive o negative ma che, se lette in modo politico, perdevano il loro valore morale per acquisire quello dell’azione necessaria per la conservazione del potere e dello stato, qui Machiavelli va oltre, abbandona infatti il suo sistema dilemmatico e lascia soltanto un ramo sui cui lavorare che è quello della dissimulazione, da cui deriva a sua volta non lo scegliere quale delle due forme bestiali sia da preferire, ma come utilizzarle entrambi.
L’assioma da cui si parte è il seguente: è meglio usare l’astuzia che garantisce la salvezza dello stato piuttosto che la lealtà che significa il suo decadimento; da qui passa all’utilizzo del mito, quello di Chirone, il quale, come sottolinea il critico Ezio Raimondi, dà l’immagine di un sovrano giovane e forte di contro a quella “anziano” circondato da un alone religioso; dopo questo spiega qual è il modo in cui un principe debba utilizzare la forza del leone e l’astuzia della volpe, mostrando capacità di capire il momento opportuno che in politica si chiama duttilità.
Ma ciò che colpisce è il profondo pessimismo di Machiavelli, quale si evince nel momento in cui parla della massa: E li uomini in universali iudicano piú alli ochi che alle mani: perché tocca a vedere a ogniuno, a sentire a pochi; ogniuno vede quello che tu pari, pochi sentono quello che tu se’; e quelli pochi non ardiscano opporsi alla oppinione di molti, che abbino la maestà dello stato che gli difenda in cui riesce a sottolineare il conformismo nonché il rifugiarsi sotto l’ala protettrice del potente.

Raffaello Sanzio: Giulio II
QUANTUM FORTUNA IN REBUS HUMANIS POSSIT ET QUOMODO ILLI SIT OCCURRENDUM Quanto potere ha la fortuna nelle cose umane e in che modo ci si può opporre ad essa. (XXV)
E’ non mi è incognito come molti hanno avuto et hanno oppinione che le cose del mondo sieno in modo governate dalla fortuna e da Dio, che li uomini con la prudenzia loro non possino correggerle, anzi non vi abbino remedio alcuno; e per questo, potrebbano iudicare che non fussi da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare alla sorte. Questa oppinione è suta più creduta ne’ nostri tempi, per la variazione grande delle cose che si sono viste e veggonsi ogni dí, fuora d’ogni umana coniettura. Ad che pensando io qualche volta, mi sono in qualche parte inclinato nella oppenione loro. Nondimanco, perché el nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle actioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare l’altra metà (o presso) a noi. Et assomiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi, che, quando s’adirano, allagano e piani, rovinano li albori e li edifizii, lievono da questa parte terreno, pongono da quell’altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede all’impeto loro, sanza potervi in alcuna parte obstare. E benché sieno così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi quieti, non vi potessino fare provvedimenti, e con ripari e con argini, in modo che, crescendo poi, o andrebbono per uno canale, o l’impeto loro non sarebbe né sì licenzioso né sì dannoso. Similmente interviene della fortuna: la quale dimostra la sua potenzia dove non è ordinata virtù a resisterle: e quivi volta ’i sua impeti, dove ella sa che non sono fatti gli argini né ripari ad tenerla. E se voi considerrete la Italia, che è la sedia di queste variazioni e quella che ha dato loro il moto vedrete essere una campagna sanza argini e sanza alcuno riparo; ché, s’ella fussi riparata da conveniente virtù come è la Magna, la Spagna e la Francia, o questa piena non arebbe fatte le variazioni grande che la ha, o ella non ci sare’ venuta.
E questo voglio basti avere detto quanto allo avere detto allo opporsi alla fortuna, in universali.
Ma, restringendomi più a’ particulari, dico come si vede oggi questo principe felicitare e domani ruinare, sanza avergli veduto mutare natura o qualità alcuna: il che credo che nasca, prima, dalle cagioni che si sono lungamente per lo adrieto discorse, cioè che quel principe che s’appoggia tutto in sulla fortuna, rovina, come quella varia. Credo ancora che sia felice quello che riscontra il modo del procedere suo con la qualità de’ tempi; e similmente sia infelice quello che con il procedere suo si discordano e tempi. Perché si vede gli uomini, nelle cose che gli conducano al fine quale ciascuno ha innanzi (cioè glorie e ricchezze) procedervi variamente: l’uno con respetto, l’altro con impeto; l’uno per violenzia, l’altro con arte; l’uno per pazienzia, l’altro con il suo contrario: e ciascuno con questi diversi modi vi può pervenire. E vedesi ancora dua respettivi, l’uno pervenire al suo disegno, l’altro no; e similmente dua egualmente felicitare con dua diversi studii, sendo l’uno respettivo e l’altro impetuoso: il che non nasce da altro, se non dalla qualità de’ tempi, che si conformano o no col procedere loro. Di qui nasce quello ho detto: che dua, diversamente operando, sortiscano el medesimo effetto; e dua egualmente operando, l’uno si conduce al suo fine, e l’altro no. Da questo ancora depende la variazione del bene: perché, se uno che si governa con respetti e pazienzia, e tempi e le cose girono in modo che il governo suo sia buono, e’ viene felicitando; ma, se è tempi e le cose si mutano, rovina, perché non muta modo di procedere. Né si truova uomo sì prudente che si sappia accomodare a questo; sí perché non si può deviare da quello a che la natura lo inclina; sí etiam perché, avendo sempre uno prosperato camminando per una via, non si può persuadere partirsi da quella. E però lo uomo respettivo, quando elli è tempo di venire allo impeto, non lo sa fare; donde rovina: ché, se si mutassi di natura con li tempi e con le cose, non si muterebbe fortuna.
Papa Iulio II procedé in ogni sua cosa impetuosamente, e trovò tanto e tempi e le cose conforme a quello suo modo di procedere, che sempre sortì felice fine. Considerate la prima impresa che fe’ di Bologna, vivendo ancora Messer Giovanni Bentivogli. Viniziani non se ne contentavano, el Re di Spagna quel medesimo con Francia aveva ragionamenti di tale impresa: e lui nondimanco, con la sua ferocità ed impeto, si mosse personalmente ad quella expedizione; la qual mossa fece star sospesi e fermi Spagna e Viniziani; quegli per paura e quell’altro per il desiderio di ricuperare tutto il Regno di Napoli. E dall’altro canto si tirò dietro il Re di Francia: perché vedutolo quel re mosso e desiderando farselo amico per abbassare ‘Viniziani, iudicò non poterli negare gli exerciti sua senza iniuriarlo manifestamente.
Condusse adunque Iulio con la sua mossa impetuosa quello che mai altro Pontefice con tutta l’umana prudenza non avria condutto; perchè se egli aspettava di partirsi da Roma con le conclusione ferme, e tutte le cose ordinate, come qualunque altro Pontefice arebbe fatto, mai non gli riusciva. Perchè il Re di Francia arebbe avuto mille scuse, e gli altri gli arebbero messo mille paure. Io voglio lasciare stare le altre sue actioni, che tutte sono state simili, e tutte gli sono successe bene. E la brevità della vita non li ha lasciato sentire il contrario; perché se fussero sopravvenuti tempi che fosse bisogniato procedere con rispetti, ne seguiva la sua rovina; perché mai non arebbe deviato da quelli modi, a’ quali la natura lo inchinava.
Concludo, adunque, che, variando la fortuna, e stando li uomini ne’ loro modi ostinati, sono felici mentre concordano insieme, e, come discordano, infelici. Io iudico bene questo, che sia meglio essere impetuoso che respettivo; perché la fortuna è donna, et è necessario, volendola tenere sotto, batterla et urtarla. E si vede che la si lascia più vincere da questi, che da quelli che freddamente procedano. E però sempre, come donna, è amica de’ giovani, perché sono meno respettivi, più feroci e con più audacia la comandano.
Giovanni Bentivoglio, primo cittadino di Bologna
Non mi è sconosciuto come molti hanno creduto e credono tuttora che i fatti del mondo siano così governati o dalla fortuna (dal caso) o da Dio e che gli uomini con la loro capacità non possono interferire, anzi non possono cambiarli affatto, e per questo che sarebbe inopportuno dedicare tanta fatica nel cambiare i fatti del mondo, ma piuttosto lasciarsi trascinare dalla sorte. Questa opinione è stata maggiormente in auge in questi tempi, per i mutamenti continui che si vedono ogni giorno, fuori da ogni umana considerazione. Pensando a ciò, anch’io talvolta mi sono lasciato trascinare da questa opinione. Tuttavia affinché il nostro libero arbitrio non sia del tutto spento, ritengo sia vero che la fortuna governi la metà delle azioni umane, ma che anche lei ci lasci governare all’incirca l’altra metà. Io infatti la fortuna la raffiguro così: fiumi rovinosi che quando si gonfiano allagano i campi, distruggono gli alberi e le case, levano la terra da una parte per depositarla in un’altra; tutti fuggono davanti ad essi, tutti cedono al loro impeto senza potervi contrapporre. E sebbene avvenga ciò, nulla impedisce, però, che durante il bel tempo, non si possano mettere ripari ed argini, di modo che i fiumi impetuosi, potrebbero poi trovare dei canali dove scaricare la loro forza, senza essere così dannosi. Allo stesso modo accade per la fortuna, che mostra tutta la sua potenza laddove non esiste la virtù umana per contrastarla. E se questo pensiero lo applicate all’Italia, che è la sede di tutte le variazioni e da cui è partito il moto dei cambiamenti, la potete vedere come una campagna senza argini e senza riparo: perché se essa fosse stata riparata con sufficiente virtù, come in Germania, Spagna e Francia, avreste potuto vedere come questa piena non avrebbe avuto così grandi conseguenze o non avrebbe avuto luogo.
E questo sia sufficiente per quanto riguarda la fortuna in generale.
Ed ora, entrando ancor di più nel particolare, affermo che oggi si può vedere un principe ottenere buoni risultati e domani vederlo andare in rovina, senza che egli abbia mutato affatto la sua natura e le sue qualità; credo che ciò avvenga, in primo luogo, per le ragioni che si sono precedentemente affrontate, cioè che quel principe che basa la sua azione sulla sola fortuna, quando questa cambia, vada in rovina. Credo anche che sia felice quel principe le cui qualità si accordano con i tempi e vada incontro all’insuccesso quello le cui qualità non si accordano con i tempi. In quanto si vedono gli uomini andare verso i loro obiettivi, cioè la gloria e la ricchezza, in modo vario: chi con prudenza, chi con impeto, chi con violenza, chi con astuzia, chi con pazienza, chi con impazienza e tutti, con i diversi modi sovra citati può giungervi. E si vedano ancora due prudenti, uno giungere al suo obiettivo e l’altro no e ugualmente due ottenere lo stesso buon esito con diversi modi, uno con prudenza e l’altro con impeto, e tutto questo non nasce da altro se non dalla situazione del tempo che si accorda o no all’agire. Da qui nasce ciò che ho detto: che due agendo in modo completamente diverso ottengano il medesimo risultato; due agendo in maniera uguale giungono ad esiti differenti. Da ciò dipende la giusta azione del politico: se uno governa con prudenza e pazienza ed i tempi e le cose del mondo girano in modo che il suo modo di governare sia adatto, egli ottiene buoni esiti; ma se i tempi e le cose del mondo mutano egli andrà incontro a rovina se non muta il suo modo di governare. E non si trova un principe prudente che si sappia adattare a questo, perché difficilmente si può deviare da come la natura ci ha predisposto ed anche perché se uno ha ottenuto buoni risultati comportandosi in un certo modo, difficilmente potrà cambiare il suo modo di agire. E perciò l’uomo prudente quando è il momento di diventare impetuoso non lo sa essere e quindi va verso la sua rovina; perché se si fosse capaci di mutare la propria natura secondo le circostanze, la fortuna non l’avrebbe mai vinta.
Papa Giulio II procedette in ogni sua azione impetuosamente e trovò sempre le circostanze conformi al suo modo di agire, tanto che ebbe sempre successo. Considerate la prima conquista che fece di Bologna, mentre era ancora in vita Giovanni Bentivoglio. I Veneziani non la vedevano di buon occhio e anche il re di Spagna era contrario; Giulio II era in trattative con la Francia riguardo a tale impresa: e, nonostante ciò, con la sua audacia e il suo impeto, prese iniziativa di quella spedizione, partecipandovi personalmente. Tale iniziativa costrinse i Veneziani e la Spagna a rimanere neutrali. quelli (i Veneziani) per paura (di perdere i loro possedimenti nel regno di Napoli, se il papa si fosse alleato con la Spagna), l’altro (Ferdinando il Cattolico, re di Spagna) perché aspirava a ricostruire l’intero regno di Napoli. Dall’altra Giulio II indusse il re di Francia ad appoggiarlo militarmente; e questo re, vedendo che il papa aveva già avviato quella spedizione, ritenne di non potergli negare l’aiuto dei propri soldati senza recargli una chiara offesa.
Giulio II realizzò, con la sua veemente iniziativa, quello che nessun altro pontefice con tutta la cautela umana, avrebbe mai potuto fare: perché se avesse atteso per allontanarsi da Roma, il re di Francia avrebbe avuto mille scuse (per non aiutarlo) e gli altri avrebbero opposto mille paure. Non voglio parlare delle altre sue azioni, contotte tutte in modo simili e tutte concluse felicemente. E la brevità della vita non gli ha permesso di provare il contrario: perché se fosse giunto il momento in cui avrebbe dovuto adoperare la prudenza, avrebbe sicuramente fallito, né si sarebbe mai allontanatoda quel modo di agire al quale era incline per natura.
Concludo dunque che mutando la fortuna e rimanendo gli uomini fermi nel loro modo d’agire politico sono felici se il loro modo s’accorda e, non appena discorda, infelici. Io ritengo tuttavia che è meglio essere impetuosi che prudenti, perché la fortuna è femmina ed è necessario, volendola sottomettere, aggredirla e batterla e si capirà che lei si lascia vincere piuttosto dagli impetuosi che dai prudenti. E perciò sempre, come femmina, è amica dei giovani, perché sono meno prudenti, più arditi e la comandano con più audacia.
E’ questo un altro dei capitoli fondamentali de Il Principe. Infatti dopo aver affrontato la questione morale, scindendola definitivamente da quella politica, ora affronta uno dei temi centrali per la cultura cinquecentesca, quello della fortuna. Analizziamo il passo sopra riportato:
- Machiavelli fa riferimento all’opinione comune secondo cui, di fronte alla catastrofe italiana, bisogna far riferimento all’operato della “fortuna” o di Dio. Egli invece ribadisce il concetto che, se da una parte vi sono delle circostanze imprevedibili, dall’altra c’è sempre l’azione dell’uomo;
- Il paragone con il fiume in piena: proprio qui Machiavelli sottolinea l’importanza della “previsione” dell’azione politica. Bisogna cioè prevenire la fortuna, costruendo gli argini a tempo opportuno, cioè prendere le dovute misure prima che sia troppo tardi.
- L’uomo deve agire sempre contro o accompagnando la fortuna e l’uomo: i mezzi per farlo li possiede (ancora la concezione antropocentrica rinascimentale); può agire appunto con rispetto o con impeto a seconda della circostanza.
- Appare tuttavia un certo “pessimismo”: l’uomo difficilmente è in grado di cambiare la propria natura; gli stessi impetuosi possono andare in rovina se il loro modo d’agire non corrisponde alle necessità del momento;
- L’ultima metafora riguarda la donna: per Machiavelli la fortuna è femmina e bisogna sottometterla e per far questo bisogna essere giovani e forti: Machiavelli ha una concezione “vitalistica” dell’agire politico.
Il Principe si conclude con un’esortazione rivolta ai principi per liberare l’Italia. E’ il capitolo conclusivo dell’opera, nel quale Machiavelli, abbandonando la prosa scientifica, assume uno stile fortemente oratorio, giocato su figure retoriche che riprendono il periodare classico.
EXHORTATIO AD CAPESSENDAM ITALIAM IN LIBERTATEMQUE A BARBARIS VINDICANDAM Esortazione a prendere l'Italia e a liberarla dai barbari (XXVI)
Considerato adunque tutte le cose di sopra discorse, e pensando meco medesimo se al presente in Italia correvano tempi da onorare un principe nuovo, e se ci era materia che dessi occasione a uno prudente e virtuoso d’introdurvi forma, che facessi onore a lui e bene alla università delli uomini di quella: mi pare concorrino tante cose in benefizio di uno principe nuovo, che io non so qual mai tempo fussi più atto a questo. E se (come io dixi) era necessario, volendo vedere la virtù di Moysè, che il popul d’Istrael fussi schiavo in Egipto; et a conoscere la grandeza dello animo di Cyro, che ‘ Persi fussino oppressati da’ Medi, e la excellenzia di Theseo, che li Atheniesi fussino dispersi: così al presente, volendo conosciere la virtù di uno spirito italiano, era necessario che l’Italia si riducessi ne’ termini presenti e che la fussi più stiava che li Hebrei, più serva che ‘ Persi, più dispersa che gli Ateniesi; sanza capo, sanza ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa; et avessi sopportato d’ogni sorta rovine.
E benché infino a qui si sia mostro qualche spiraculo in qualcuno, da potere iudicare che fussi ordinato da Dio per sua redemptione; tamen si è visto come di poi, nel più alto corso delle actioni sua, è stato dalla fortuna reprobato. In modo che, rimasa come sanza vita, aspetta quale possa essere quello che sani le sua ferite e ponga fine a’ sachi di Lombardia, alle taglie del Reame e di Toscana, e la guarisca da quelle sue piaghe già per lungo tempo infistolite. Vedesi come la priega Iddio che li mandi qualcuno che la redima da queste crudeltà et insolenzie barbare. Vedesi ancora tutta pronta e disposta a seguire una bandiera, purché ci sia alcuno che la pigli. Né ci si vede, al presente, in quale lei possa più sperare che nella illustre casa vostra; la quale con la sua fortuna e virtù, favorita da Dio e dalla chiesa (della quale è ora principe), possa farsi capo di questa redemptione: il che non fia molto difficile, se vi recherete innanzi le actioni e vite de’ soprannominati. E benché quelli uomini sieno rari e maravigliosi, nondimeno furono uomini et ebbe ciascuno di loro minore occasione che la presente: perché la impresa loro non fu più iusta di questa, né più facile; né fu Dio più amico loro che a voi. Qui è iustizia grande: «iustum enim est bellum quibus necessarium et pia arma ubi nulla nisi spes est». Qui è disposizione grandissima: né può essere, dove è grande disposizione, grande difficultà; pure che quella pigli delli ordini di coloro che io vi ho proposto per mira. Oltre a di questo, qui si veggono extraordinarii senza exemplo, condutti da Dio: el mare si è aperto, una nube vi ha scorto il camino, la pietra ha versato acque, qui è piovuto la manna, ogni cosa è concorsa nella vostra grandeza. El rimanente dovete fare voi: Dio non vuole fare ogni cosa, per non ci tôrre el libero arbitrio e parte di quella gloria che tocca a noi. E non è maraviglia se alcuno de’ prenominati italiani non ha possuto fare quello che si può sperare facci la illustre casa vostra; e se, in tante revoluzioni di Italia et in tanti maneggi di guerra, e’ pare sempre che in Italia la virtù militare sia spenta: perché questo nascie che gli ordini antichi di quella non erono buoni e non ci è suto alcuno che abbia saputo trovare de’ nuovi. E veruna cosa fa tanto onore ad uno uomo che di nuovo surga, quanto fa le nuove leggie e li nuovi ordini trovati da lui: queste cose, quando sono ben fondate et abbino in loro grandeza, lo fanno reverendo e mirabile. Et in Italia non manca materia da introdurvi ogni forma: qui è virtù grande nelle membra, quando la non mancasse ne’ capi. Specchiatevi ne’ duelli e ne’ congressi de’ pochi, quanto gli Italiani sieno superiori con le forze, con la destreza, con lo ingegno; ma come si viene alli exerciti, non compariscano. E tutto procede dalla deboleza de’ capi: perché quegli che sanno non sono ubiditi et ad ciascuno pare sapere, non ci essendo insino a qui suto alcuno che si sia rilevato tanto (e per virtù e per fortuna) che li altri cedino. Di qui nascie che in tanto tempo, in tante guerre fatte nelli passati XX anni, quando gli è stato un esercito tutto italiano, sempre ha fatto mala pruova: di che è testimone prima el Taro, di poi Alexandria, Capua, Genova, Vailà, Bologna, Mestri.
Volendo adunque la illustre casa vostra seguitare quelli excellenti uomini che redimerno le provincie loro, è necessario innanzi a tutte le altre cose (come vero fondamento d’ogni impresa) provedersi d’arme proprie; perché non si può avere né più fidi, né più veri, né migliori soldati; e benché ciascuno di epsi sia buono, tutti insieme diventeranno migliori quando si vedessino comandare dal loro principe, e da quello onorare ed intrattenere. E’ necessario pertanto prepararsi ad queste arme per potersi con virtù italiana defendere dagli externi. E benché la fanteria svizera e spagniuola sia existimata terribile, nondimanco in ambedua è difetto, per il quale uno ordine terzo potrebbe non solamente opporsi loro, ma confidare di superargli. Perché gli Spagniuoli non possono sostenere e cavagli e li Svizeri hanno ad avere paura de’ fanti, quando gli riscontrino nel combattere obstinati come loro: donde si è veduto e vedrassi per experienzia li Spagniuoli non potere sostenere una cavalleria franzese e li Svizeri essere rovinati da una fanteria spagniuola. E benché di questo ultimo non se ne sia visto intera experienza; tamen se ne è veduto uno saggio nella giornata di Ravenna, quando le fanterie spagniuole si affrontorno con le battaglie tedesche (le quali servano el medesimo ordine che ‘ Svizeri): dove gli Spagniuoli, con l’agilità del corpo et aiuto delli loro brocchieri, erano entrati tra lle picche loro sotto e stavano sicuri ad offendergli, sanza che ‘ Tedeschi vi avessino remedio; e se non fussi la cavalleria che gli urtò, gli arebono consumati tutti. Puossi adunque, conosciuto il difetto dell’una e dell’altra di queste fanterie, ordinarne una di nuovo, la quale resista a’ cavalli e non abbia paura de’ fanti: il che lo farà la generazione delle arme e la variazione delli ordini. E queste sono di quelle cose che, di nuovo ordinate, danno reputazione e grandeza a uno principe nuovo.
Non si deve adunque lasciare passare questa occasione, acciò che la Italia vegga dopo tanto tempo apparire un suo redemptore. Né posso exprimere con quale amore egli fussi ricevuto in tutte quelle provincie che hanno patito per queste illuvioni externe, con qual sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime. Quali porte se li serrerebbono? Quali popoli gli negherebbano la obedienza? Quale invidia se li opporrebbe? Quale italiano gli negherebbe lo obsequio? Ad ogniuno puzza questo barbaro dominio. Pigli adunque la illustre casa vostra questo absunto con quello animo, e con quella speranza che si pigliano le imprese iuste, acciò che sotto la sua insegna, e questa patria ne sia nobilitata, e sotto i suoi auspizii si verifichi quel detto del Petrarca:
Virtù contro a furore
prenderà l’arme, e fia el combatter corto;
ché l’antico valore
nell’italici cor non è ancor morto.

William Dermoyen: Battaglia di Pavia tra Francesco I e Carlo V
Dopo aver considerato tutte le cose che ho trattato prima, e meditando tra me e me se oggi in Italia siano maturi i tempi per onorare un nuovo principe e se ci sono le condizioni necessarie per dare ad un uomo prudente e saggio l’occasione d’introdurre un ordinamento nuovo, tale che desse onore a lui e benefici alla maggioranza dei suoi abitanti, mi pare che tanti elementi concorrano a favore di un principe nuovo e non so quale altro periodo di tempo potrebbe essere più favorevole di questo. E se, come dissi, era necessario per vedere le grandi virtù di Mosè che il popolo fosse schiavo in Egitto, per conoscere la grandezza d’animo di Ciro, che i Persiani fossero oppressi dai Medi e l’eccellenza di Teseo che gli Ateniesi fossero dispersi; allo stesso modo ora, per riconoscere la virtù di un principe era necessario che l’Italia si riducesse nelle condizioni in cui si trova e che essa fosse più schiava degli Ebrei, più serva dei Persiani, più dispersa degli Ateniesi, senza principe, senza ordinamenti propri, sottomessa da armi straniere, depredata, impoverita, devastata da scorrerie di eserciti invasori e avesse sopportato ogni genere di sventure.
E benché in qualcuno si sia mostrato qualche barlume di virtù da pensare che fosse mandato Dio per il riscatto dell’Italia, tuttavia si è poi visto come, nel momento decisivo delle azioni, non sia stato favorito dalla fortuna. E così, quasi rimasta senza vita, l’Italia aspetta chi possa essere colui che sia in grado di sanare le sue ferite, ponga fine ai saccheggi della Lombardia, ai pesanti tributi del Regno di Napoli e della Toscana e guarisca in lei quelle piaghe ormai divenute croniche. Si vede bene come essa preghi Dio che le mandi qualcuno che la liberi da queste crudeltà e barbare insolenze. Si vede bene anche come essa sia tutta pronta a seguire una bandiera, purché ci sia uno che la stringa in pugno.
Nè si vede al presente in quale casata l’Italia possa sperare se non della Vostra Illustre Famiglia, che con la sua fortuna e la sua virtù, favorita da Dio e dalla Chiesa, di cui ora è a capo (Leone X, Giovanni di Lorenzo de’ Medici) possa mettersi a guidare questo riscatto. Il che non sarà molto difficile se terrete a mente le imprese e la vita dei personaggi sopra nominati: e benché quegli uomini siano stati eccezionali e meravigliosi, tuttavia furono uomini e ciascuno di loro ebbe un’occasione meno importante della presente, perché la loro impresa non fu più giusta e più facile della presente, né Dio fu con loro più amico che con voi. In questa impresa la giustizia è grande iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est*. In questa impresa ogni evento è favorevole, né ci possono essere grandi difficoltà dove tutto è favorevole, purché la Vostra Casata imiti le azioni di coloro che ho indicato come modelli. Oltre a ciò, in questa impresa si vedono prodigi straordinari voluti da Dio: il mare si è aperto, una nube vi ha indicato il cammino, da una pietra è scaturita l’acqua, qui la manna è caduta dal cielo: ogni evento ha contribuito alla vostra grandezza. Il resto dovete farlo voi. Dio non vuole fare ogni cosa, per non toglierci il libero arbitrio e quella parte di gloria che tocca a noi. Non c’è da meravigliarsi se nessuno dei già nominati italiani ha potuto fare quello che si può sperare che faccia la Vostra illustre Casa, e se in Italia in tanti rivolgimenti e in tante vicende belliche pare che per sempre sia spento il valore militare. Questo dipende dal fatto che i vecchi ordinamenti dell’Italia non erano più buoni, e non c’è stato nessuno che sia stato capace di trovarne di nuovi: niente dà tanta reputazione a un principe nuovo quanto possono darla le nuove leggi e i nuovi ordinamenti militari creati da lui. Queste cose, quando hanno solide basi e una loro grandiosità, lo rendono ammirevole e degno di rispetto: e in Italia non manca la materia per introdurvi i nuovi ordinamenti militari. Qui c’è il grande valore del popolo, qualora non mancasse nei capi. Esaminate quanto gli Italiani siano superiori per forza, per destrezza e per ingegno nei duelli e nei combattimenti fra pochi. Ma quando fanno parte degli eserciti, non fanno una buona figura. Tutto dipende dalla debolezza dei capi; perché quelli che sono bravi non sono obbediti e ognuno crede di saper comandare, non essendoci stato finora nessuno capace di distinguersi, sia per virtù che per fortuna tanto che gli altri si facciano da parte. Da ciò possiamo capire perché in tanto tempo, in tante guerre avutesi negli ultimi vent’anni, un esercito tutto italiano, quando c’è stato, ha sempre dato cattiva prova di sé. Ne sono testimoni prima la battaglia del Taro, poi quelle di Alessandria, Capua, Genova, Vailate-Agnadello, Bologna, Mestre.
Volendo dunque la illustre Casa Vostra imitare gli eccellenti uomini che liberarono le loro terre, è necessario innanzi tutto, come vero fondamento di ogni impresa, provvedersi di un proprio esercito; perché non si possono avere soldati né più fedeli, né più leali, né migliori. E quantunque ciascuno di essi sia valente, tutti insieme diventeranno migliori, quando si vedranno comandare dal loro principe e da lui essere onorati ed intrattenuti. È necessario, pertanto, preparare questo esercito per potere, col valore degli italiani, difendersi dai nemici esterni.
E benché le fanterie svizzera e spagnola siano considerate terribili, tuttavia in entrambe ci sono difetti, per cui un terzo tipo di esercito potrebbe non solamente opporsi ad esse, ma aver la fiducia di batterle. Gli Spagnoli, infatti, non sanno resistere all’assalto della cavalleria e gli Svizzeri debbono temere i fanti, quando ritrovano questi determinati a combattere come loro. Perciò si è visto, e si vedrà, che gli Spagnoli non hanno la forza di sostenere l’urto della cavalleria francese, e gli Svizzeri essere sconfitti dalla fanteria spagnola. E benché quest’ultimo caso non si sia visto del tutto nella realtà, tuttavia se ne è veduto un saggio nella battaglia di Ravenna, quando le fanterie spagnole affrontarono i battaglioni tedeschi che adottano lo stesso schieramento degli Svizzeri: gli Spagnoli, con l’agilità del corpo e l’uso dei loro brocchieri, erano penetrati sotto le picche nemiche e li colpivano stando al sicuro, senza che i Tedeschi vi avessero scampo; e se non fosse arrivata la cavalleria che li assaltò, li avrebbero uccisi tutti. Si può, dunque, conosciuto il difetto dell’una e dell’altra di queste fanterie, istituirne una di tipo nuovo, che resista ai cavalli e non abbia paura dei fanti, e questo risultato può essere raggiunto dal tipo di armi e dal nuovo tipo di schieramento sul campo di battaglia. E l’esercito è una di quelle cose che, con un nuovo modello di schieramento, dà prestigio e grandezza a un principe nuovo.
Non si deve dunque lasciar passare questa occasione affinché l’Italia, dopo tanto tempo, veda un suo redentore. Né posso esprimere con quale amore sarebbe accolto in tutte quelle regioni che hanno patito per queste invasioni straniere; con quale sete di vendetta, con quale fede ostinata, con quale devozione, con quali lacrime. Quali porte verrebbero chiuse davanti a lui? Quali popoli gli negherebbero la loro obbedienza? Quale rivalità gli si opporrebbe? Quale Italiano gli negherebbe il rispetto? A ognuno puzza questo barbaro dominio! Prenda dunque, l’illustre Casa Vostra, questo impegno, con quel coraggio e quella speranza con cui si prendono le imprese giuste, affinché sotto la sua insegna la patria sia nobilitata e sotto i suoi auspici si avveri quel detto del Petrarca: Il valore italiano combatterà contro la selvaggia furia // e la battaglia sarà breve, // perché l’antico valore // non si è ancora spento negli italiani.
*giusta infatti è la guerra per coloro i quali è necessaria, e pie le armi, quando non vi è speranza se non nelle armi (Tito Livio, Ab urbe condita, IX, 1)
L’ultimo capitolo de Il Principe è decisamente diverso dai precedenti: una teoria critica situa la Dedica e questa Exhortatio posteriori rispetto al resto dell’opera: a dirlo del primo è lo scambio di persona cui viene offerta l’opera (da Giuliano a Lorenzo) qui è lo stile e l’abbandono della prosa scientifica. Tale abbandono è presente a partire dal ritmo sostenuto, con riferimenti biblici e storici e frasi latine citate a memoria; dallo stile con metafore e accostamento di parole per asindeto che servono ad incalzare di più il discorso e ancora domande retoriche. Come diverso ed innalzato il discorso si fa nel momento in cui lo si conclude con le parole di Petrarca, poeta, retoricamente alto nella sua canzone politica All’Italia.
Nell’ultimo testo troviamo, tuttavia, alcuni concetti fondamentali che lo legano a quanto scritto precedentemente:
- l’azione nasce dalla realtà effettuale: oggi la realtà effettuale vede l’Italia sanza capo, sanza ordine, battuta, spogliata, lacera, corsa; et avessi (aver) sopportato d’ogni sorta rovine; tale realtà non può che spingere ad un risveglio (redemptione) che la ponga fuori dalla sottomissione politica e militare cui è costretta e questo lo può fare soltanto con la guida di un principe nuovo;
- la situazione (quindi la stessa realtà) aveva spinto qualcuno a cercare di prendere l’iniziativa e qui il riferimento è Cesare Borgia, abbandonato, poi, dalla fortuna per la morte del padre (Adriano VI); ora Lorenzo si trova nella condizione di avere un papa che lo può sostenere (Alessandro X) nel portare a compimento l’azione fallita per colpa della malignità della sorte.
- il discorso sull’esercito, che riprenderà in forma più organica ne l’Arte della guerra: per poter portare avanti un’azione politica con il supporto di quella militare è necessario avere delle “armi proprie”.

Il Principe edizione del 1769, commentato dallo storico francese Abraham Nicolas Amelot de la Houssaye
DISCORSI SOPRA LA PRIMA DECA DI TITO LIVIO
Se Il Principe è stato scritto di getto, mosso dall’urgenza della situazione politica italiana, ben diversa è la gestazione dei Discorsi, iniziati poco prima, ma nello stesso anno, interrotti e quindi ripresi nel biennio tra il ’15 e il ’17 nel clima degli Orti Oricellari (palazzo costruito dalla famiglia nobile dei Rucellai, nel quale sin dal ‘400 si riunivano intellettuali per discutere di arte e filosofia), i cui appartenenti guardavano a Machiavelli come un maestro, tra i quali appunto Zanobi Buondelmonti e Cosimo Rucellai, cui il pensatore fiorentino dedica l’opera. I Discorsi si presentano non unitari: si tratta infatti di un commento, pieno di divagazioni, sulla prima deca (i primi dieci libri) dell’opera dello storico romano Tito Livio. Vediamone un po’ la struttura:
- nel primo libro Machiavelli affronta il problema delle prime istituzioni della Roma repubblicana e della sua organizzazione e della religione. Egli rimpiange la religione pagana in quando essa permetteva al cittadino romano d’identificarsi nello stato romano; la religione romana era pertanto un instrumentum regni che faceva da collante all’intera comunità;
- il secondo libro è dedicato alla politica estera, alla guerra e alla milizia. E’ chiara qui la polemica machiavelliana verso le milizie mercenarie degli Stati italiani. Il cives romano difendeva la patria in quanto quest’ultima conteneva e prometteva appezzamenti di terreno da coltivare. Per il soldato, pagato al soldo, la guerra è solo un mezzo per guadagnare; perciò non difende strenuamente ciò che non gli appartiene; anzi l’unica cosa veramente sua, cioè la vita, cerca di salvarla con ogni mezzo, al di là del motivo per cui combatte;
- il terzo libro è più vario e si parla delle azioni di uomini eccezionali, che hanno reso grande Roma, sia delle trasformazioni degli Stati, come si evolvano e decadano. Qui si fanno chiari riferimenti alla “corruzione” di Firenze.
PROEMIO
Considerando adunque quanto onore si attribuisca all’antiquità, e come molte volte, lasciando andare infiniti altri esempli, un frammento d’una antiqua statua sia suto comperato gran prezzo, per averlo appresso di sé, onorarne la sua casa e poterlo fare imitare a coloro che di quella arte si dilettono; e come quegli dipoi con ogni industria si sforzono in tutte le loro opere rappresentarlo; e veggiendo, da l’altro canto, le virtuosissime operazioni che le storie ci mostrono, che sono state operate da regni e republiche antique, dai re, capitani, cittadini, latori di leggi, ed altri che si sono per la loro patria affaticati, essere più presto ammirate che imitate; anzi, in tanto da ciascuno in ogni minima cosa fuggite, che di quella antiqua virtù non ci è rimasto alcun segno; non posso fare che insieme non me ne maravigli e dolga. E tanto più, quanto io veggo nelle diferenzie che intra cittadini civilmente nascano, o nelle malattie nelle quali li uomini incorrono, essersi sempre ricorso a quelli iudizii o a quelli remedii che dagli antichi sono stati iudicati o ordinati: perché le leggi civili non sono altro che sentenze date dagli antiqui iureconsulti, le quali, ridutte in ordine, a’ presenti nostri iureconsulti iudicare insegnano. Né ancora la medicina è altro che esperienze fatte dagli antiqui medici, sopra le quali fondano e’ medici presenti e’ loro iudizii. Nondimanco, nello ordinare le republiche, nel mantenere li stati, nel governare e’ regni, nello ordinare la milizia ed amministrare la guerra, nel iudicare e’ sudditi, nello accrescere l’imperio, non si truova principe né republica che agli esempli delli antiqui ricorra. Il che credo che nasca non tanto da la debolezza nella quale la presente religione ha condotto el mondo, o da quel male che ha fatto a molte provincie e città cristiane uno ambizioso ozio, quanto dal non avere vera cognizione delle storie, per non trarne, leggendole, quel senso né gustare di loro quel sapore che le hanno in sé. Donde nasce che infiniti che le leggono, pigliono piacere di udire quella varietà degli accidenti che in esse si contengono, sanza pensare altrimenti di imitarle, iudicando la imitazione non solo difficile ma impossibile; come se il cielo, il sole, li elementi, li uomini, fussino variati di moto, di ordine e di potenza, da quello che gli erono antiquamente. Volendo, pertanto, trarre li uomini di questo errore, ho giudicato necessario scrivere, sopra tutti quelli libri di Tito Livio che dalla malignità de’ tempi non ci sono stati intercetti, quello che io, secondo le cognizione delle antique e moderne cose, iudicherò essere necessario per maggiore intelligenzia di essi, a ciò che coloro che leggeranno queste mia declarazioni, possino più facilmente trarne quella utilità per la quale si debbe cercare la cognizione delle istorie. E benché questa impresa sia difficile, nondimanco, aiutato da coloro che mi hanno, ad entrare sotto questo peso, confortato, credo portarlo in modo, che ad un altro resterà breve cammino a condurlo a loco destinato.
Edizione del 1543
Considerando quanta importanza venga attribuita all’antichità e come molte volte (tralasciando altri esempi) un frammento di un’antica statua sia stato acquistato ad un prezzo elevato per possederlo e per accrescere, con esso, l’onorabilità della propria casa, per farlo riprodurre dagli scultori, come coloro che si sforzano di rappresentarlo di nuovo con grande impegno e vedendo, con stupore, allo stesso modo le azioni virtuose che sono state compiute dai regni e dalle repubbliche antiche, dai re, dai capitani di eserciti, da legislatori e altre personalità che si sono impegnati per la loro patria con grande virtù che la storia ci mostra, essere più lodate che imitate; anzi evitate da ciascuno che non è rimasta traccia di quella antica virtù, non posso fare a meno di meravigliarmi e dolermi allo stesso tempo. E questo soprattutto (quando vedo) nelle controversie tra privati cittadini e nelle malattie degli uomini essersi rivolti sempre alle leggi e ai rimedi trovati dagli antichi. Perché le leggi civili non sono altro che quelle date dagli antichi legislatori che, messe in ordine, insegnano ancora a giudicare ai nostri avvocati e neppure la medicina non è altro se non quella proposta dai medici antichi sulla quale quelli moderno fondano le le loro diagnosi. Tuttavia nel dare un ordinamento ad uno stato repubblicano, nel conservare le istituzioni, nell’organizzare l’esercito e nel condurre guerre, nel giudicare i sudditi, nell’accrescere il potere non si trova né un principe, né una repubblica, né un capitano dell’esercito, né un privato cittadino che ricorra agli esempi degli antichi. Sono convinto che ciò derivi non dalla debolezza con cui la poca educazione ha condotto il mondo o da un costume ozioso che ha ridotto in questo stato molte provincie e città cristiane, quanto da non conoscere la storia, per non tirare fuori da essa, dopo averla letta, quel significato degli avvenimenti presenti in essa, né trovare quel piacere della verità che esse hanno in sé. Per cui i numerosissimi lettori delle storie provano gusto nel sentire la varietà degli episodi che esse contengono, senza pensare per niente ad imitarle, giudicando non solo difficile imitarle, ma addirittura impossibile: come se il cielo, il sole, gli altri elementi astrologici avessero cambiato il movimento, la forma e la loro potenza dalla loro antichità. Volendo dunque allontanare gli uomini da questo loro errore ho giudicato scrivere, considerati tutti quei libri che per sfortuna non ci sono stati tramandati, soprattutto quello che comparando i tempi antichi con i moderni risultino necessari per una maggiore comprensione per loro, affinché gli stessi possano trarne utilità per la quale è necessaria la conoscenza della storia. E benché sia un compito arduo, aiutato da coloro che in questo mi hanno aiutato e confortato, credo poterlo portare avanti in che qualcuno potrà percorrere il breve tratto che lo condurrà al fine a lui destinato.
Il Proemio ci illustra come il classicismo machiavelliano, ed in parte dell’intero Rinascimento, non si basi soltanto sull’imitazione estetica, ma, come nel pensiero dell’intellettuale fiorentino, diventi “militante”, capace cioè di dare linfa vitale all’asfittica e debole politica italiana.
Partendo dall’assunto che l’uomo, fisicamente, è ancora governato dai rimedi della medicina antica, giurisdizionalmente a quelli degli iura classici, non si capisce perché non debba esserlo riguardo il suo impegno politico che dovrebbe, necessariamente, osservare le grandi azioni dei grandi uomini del passato. Per questo l’opera non è soltanto un esercizio storiografico sull’opera liviana, ma un attento esame che deve insegnare l’agire politico contemporaneo.
Ci si potrebbe chiedere quale sia stata la spinta a continuare l’opera dopo il lavoro De principatibus: possiamo azzardare l’ipotesi secondo cui l’azione propugnata ne Il Principe, spieghi l’urgenza politica con cui un uomo (e quindi un personaggio autorevole) avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di liberare l’Italia dagli eserciti stranieri (spagnoli e francesi). I primi dieci libri di Livio, invece, gli offrono la possibilità di soffermarsi sull’insegnamento dell’autore latino della storia come “magistra vitae“, e quindi superare e in un certo modo di “cancellare” l’opera precedente ispirata a Cesare Borgia, personaggio, in seguito, caduto in disgrazia.
E se la storia si propugna come magistra vitae, alla sua stregua dovremo utilizzare la religio come importantissimo instrumentum regni:
I DANNI DELLA CHIESA IN ITALIA
Quelli príncipi o quelle repubbliche le quali si vogliono mantenere incorrotte, hanno sopra ogni altra cosa a mantenere incorrotte le cerimonie della loro religione, e tenerle sempre nella loro venerazione; perché nessuno maggiore indizio si puote avere della rovina d’una provincia, che vedere dispregiato il culto divino. Questo è facile a intendere, conosciuto che si è in su che sia fondata la religione dove l’uomo è nato; perché ogni religione ha il fondamento della vita sua in su qualche principale ordine suo. La vita della religione gentile era fondata sopra i responsi degli oracoli e sopra la sètta degli indovini e degli aruspici: tutte le altre loro cerimonie, sacrifici e riti, dependevano da queste; perché loro facilmente credevono che quello Iddio che ti poteva predire il tuo futuro bene o il tuo futuro male, te lo potessi ancora concedere. Di qui nascevano i templi, di qui i sacrifici, di qui le supplicazioni ed ogni altra cerimonia in venerarli: per che l’oracolo di Delo, il tempio di Giove Ammone ed altri celebri oracoli i quali riempivano il mondo di ammirazione e divozione. Come costoro cominciarono dipoi a parlare a modo de’ potenti, e che questa falsità si fu scoperta ne’ popoli, diventarono gli uomini increduli ed atti a perturbare ogni ordine buono. Debbono adunque i príncipi d’una republica o d’uno regno, i fondamenti della religione che loro tengono, mantenergli; e fatto questo, sarà loro facil cosa mantenere la loro repubblica religiosa, e per conseguente buona e unita. E debbono tutte le cose che nascono in favore di quella, come che le giudicassono false, favorirle e accrescerle; e tanto più lo debbono fare quanto più prudenti sono, e quanto più conoscitori delle cose naturali. E perché questo modo è stato osservato dagli uomini savi, ne è nato l’opinione dei miracoli che si celebrano nelle religioni eziandio false; perché i prudenti gli augumentano, da qualunque principio e’ si nascano, e l’autorità loro dà poi a quelli fede appresso a qualunque. Di questi miracoli ne fu a Roma assai, intra i quali fu che saccheggiando i soldati romani la città de’ Veienti, alcuni di loro entrarono nel tempio di Giunone, ed accostandosi alla immagine di quella e dicendole Vis venire Romam?, parve a alcuno vedere che la accennasse, a alcuno altro che la dicesse di sì. Perché sendo quegli uomini ripieni di religione (il che dimostra Tito Livio, perché nello entrare nel tempio vi entrarono sanza tumulto, tutti devoti e pieni di riverenza), parve loro udire quella risposta che alla domanda loro per avventura si avevano presupposta; la quale opinione e credulità da Cammillo e dagli altri prìncipi della città fu al tutto favorita ed accresciuta. La quale religione se ne’ prìncipi della repubblica cristiana si fusse mantenuta secondo che dal datore d’essa ne fu ordinato, sarebbero gli stati e le repubbliche cristiane più unite, piú felici assai che le non sono. Né si può fare altra maggiore coniettura della declinazione d’essa, quanto è vedere come quelli popoli che sono più propinqui alla Chiesa romana, capo della religione nostra, hanno meno religione. E chi considerasse i fondamenti suoi, e vedesse l’uso presente quanto è diverso da quelli, giudicherebbe essere propinquo sanza dubbio o la rovina o il fragello.
Suovetaurilia: rito che prevedeva l’uccisione di un maiale, di un montone e di un toro (Museo del Louvre)
Quei principati e quelle repubbliche che vogliono rimanere immuni dalla corruzione, devono sopra ogni cosa mantenere inalterati i riti della loro religione, e tenerli sempre in massima considerazione, perché non si può avere maggior segno dell’instabilità di una nazione che vedere disprezzato il culto divino. Questo è facile a capirsi nel momento in cui si conosce il fondamento della propria religione, proprio perché le religioni si muovono su fondamenti propri. La struttura della religione pagana si basava sui responsi degli oracoli e sulla casta degli indovini e degli auruspici: tutti i loro riti erano programmati da questi due, perché loro semplicemente credevano che quel dio che poteva predire un futuro, sia esso favorevole o sfavorevole te lo potesse anche concedere. Da questa credenza nacquero i templi, i sacrifici, le preghiere e tutte le altre cerimonie con cui venerarli: da qui l’oracolo di Apollo (Delo), il tempio di Giove Ammone (divinità egizia), ed altri celebri oracoli che riempivano il mondo di ammirazione e devozione. Appena loro iniziarono in seguito a parlare secondo gli interessi dei potenti, e questa falsità fu scoperta dalla gente, gli uomini diventarono non credenti e pronti a scardinare ogni ordine religioso e civile. Devono dunque i reggitori di una repubblica o di una monarchia mantenere saldi i principi della loro religione, e, fatto questo, sarà semplice per loro mantenere il loro stato religioso, e conseguentemente rispettoso e coeso. E devono altresì favorire ed accrescere tutte le cose che la riguardano, sebbene essi possano ritenerle false, e lo devono fare quanto più sono prudenti ed esperti della realtà naturale. E perché questo è stato osservato in tutti gli uomini saggi, ne è nata l’opinione che i miracoli siano veri anche nelle religioni “false”, perché i governanti accorti li incrementano da qualunque principio essi nascano, e la loro autorità fornisce a quelli credito ovunque. Di questi miracoli ce ne furono molti a Roma, tra i quali questo, che alcuni Romani, saccheggiando Veio, entrarono nel tempio di Giunone e avvicinandosi alla sua statua e dicendole Vuoi venire a Roma? sembrò che acconsentisse. Poiché quegli uomini erano fortemente religiosi (perché, come afferma Tito Livio, entrarono nel tempio silenziosi e con rispetto e pieni di devozione), sembrò loro ascoltare quella risposta che volevano essa dicesse, opinione e credulità che fu assolutamente accresciuta e aumentata da Furio Camillo e dagli altri generali. Se la religione cristiana si fosse mantenuta secondo le regole che lo stesso Cristo le aveva assegnato, sarebbero gli stati cristiani più uniti e molto più saldi di quanto siano adesso. Né si può fare maggiore deduzione di questa affermazione quanto vedere come quei popoli che sono vicini alla Chiesa Romana, la base della nostra religione, siano meno religiosi, e coloro che considerassero quanto i riti e gli atteggiamenti di questa religione siano molto diversi dai comportamenti di costoro, capirebbe subito esser vicino il tempo della loro rovina.
Sembra, leggendo questa pagina, che l’autore de Il principe non distingua poi tanto la riflessione sulla storia e la costruzione scientifica della politica. Ma per Machiavelli ciò non può essere, perché analizzando con attenzione i fatti di ieri e paragonandoli all’oggi, non si può non rendersi conto che la storia è la politica degli anni passati e la politica di oggi sarà, a sua volta, la storia di domani. Così si potrà ben comprendere quale insegnamento i “reggitori” di uno Stato devono apprendere dall’atteggiamento di Camillo, nell’usare un episodio religioso a fine politico: ma non dobbiamo dimenticare che la presa di Veio è un fatto storico anche per Tito Livio. E’ poi evidente, qui, il discorso di Machiavelli riguardo l’incidenza della Chiesa sulla disunione della penisola italiana, la sua feroce critica verso atteggiamenti amorali e non in linea con la profonda religiosità della gente, della sua vera e propria “indifferenza religiosa”: questi atteggiamenti non aiutano un popolo a trovare unità, anzi, creano fazioni, come è successo a Firenze con il Savonarola.
Si è discusso molto, a livello critico, sulla visione “repubblicana” di Machiavelli, soprattutto alla luce del pensiero politico emerso nelle pagine de Il Principe e nella valorizzazione della figura impetuosa e autoritaria di Cesare Borgia, che, nella sua mente, incarnava il perfetto principe. Eppure a ben guardare, il suo pensiero politico è più complesso, come ci mostra la riflessione sul popolo, in un capitolo, il 58°, che, al sui inizio, afferma che non vi è differenza “qualitativa” tra moltitudine e principe se ambedue non sono guidati, e nel contempo frenati, dalle leggi, quindi prosegue:
LA MOLTITUDINE
Conchiudo adunque, contro alla commune opinione; la quale dice come i popoli, quando sono principi, sono varii, mutabili ed ingrati; affermando che in loro non sono altrimenti questi peccati che siano ne’ principi particulari. Ed accusando alcuno i popoli ed i principi insieme, potrebbe dire il vero; ma traendone i principi, s’inganna: perché un popolo che comandi e sia bene ordinato, sarà stabile, prudente e grato non altrimenti che un principe, o meglio che un principe, eziandio stimato savio: e dall’altra parte, un principe, sciolto dalle leggi, sarà ingrato, vario ed imprudente più che un popolo. E che la variazione del procedere loro nasce non dalla natura diversa, perché in tutti è a un modo, e, se vi è vantaggio di bene, è nel popolo; ma dallo avere più o meno rispetto alle leggi, dentro alle quali l’uno e l’altro vive. E chi considererà il popolo romano, lo vedrà essere stato per quattrocento anni inimico del nome regio, ed amatore della gloria e del bene commune della sua patria; vedrà tanti esempli usati da lui, che testimoniano l’una cosa e l’altra. E se alcuno mi allegasse la ingratitudine ch’egli usò contra a Scipione, rispondo quello che di sopra lungamente si discorse in questa materia, dove si mostrò i popoli essere meno ingrati de’ principi. Ma quanto alla prudenzia ed alla stabilità, dico, come un popolo è più prudente, più stabile e di migliore giudizio che un principe. E non sanza cagione si assomiglia la voce d’un popolo a quella di Dio: perché si vede una opinione universale fare effetti maravigliosi ne’ pronostichi suoi; talché pare che per occulta virtù ei prevegga il suo male ed il suo bene. Quanto al giudicare le cose, si vede radissime volte, quando egli ode duo concionanti che tendino in diverse parti, quando ei sono di equale virtù, che non pigli la opinione migliore, e che non sia capace di quella verità che egli ode. E se nelle cose gagliarde, o che paiano utili, come di sopra si dice, egli erra; molte volte erra ancora un principe nelle sue proprie passioni, le quali sono molte più che quelle de’ popoli. Vedesi ancora, nelle sue elezioni ai magistrati, fare, di lunga, migliore elezione che un principe, né mai si persuaderà a un popolo, che sia bene tirare alle degnità uno uomo infame e di corrotti costumi: il che facilmente e per mille vie si persuade a un principe. Vedesi uno popolo cominciare ad avere in orrore una cosa, e molti secoli stare in quella opinione: il che non si vede in un principe. E dell’una e dell’altra di queste due cose voglio mi basti per testimone il popolo romano: il quale in tante centinaia d’anni, in tante elezioni di Consoli e di Tribuni, non fece quattro elezioni di che quello si avesse a pentire. Ed ebbe, come ho detto, tanto in odio il nome regio, che nessuno obligo di alcuno suo cittadino, che tentasse quel nome, poté fargli fuggire le debite pene. Vedesi, oltra di questo, le città, dove i popoli sono principi, fare in brevissimo tempo augumenti eccessivi, e molto maggiori che quelle che sempre sono state sotto uno principe: come fece Roma dopo la cacciata de’ re, ed Atene da poi che la si liberò da Pisistrato. Il che non può nascere da altro, se non che sono migliori governi quegli de’ popoli che quegli de’ principi. Né voglio che si opponga a questa mia opinione tutto quello che lo istorico nostro ne dice nel preallegato testo, ed in qualunque altro; perché, se si discorreranno tutti i disordini de’ popoli, tutti i disordini de’ principi, tutte le glorie de’ popoli e tutte quelle de’ principi, si vedrà il popolo di bontà e di gloria essere, di lunga, superiore. E se i principi sono superiori a’ popoli nello ordinare leggi, formare vite civili, ordinare statuti ed ordini nuovi; i popoli sono tanto superiori nel mantenere le cose ordinate, ch’egli aggiungono sanza dubbio alla gloria di coloro che l’ordinano.
Ed insomma, per conchiudere questa materia, dico come hanno durato assai gli stati de’ principi, hanno durato assai gli stati delle republiche, e l’uno e l’altro ha avuto bisogno d’essere regolato dalle leggi: perché un principe che può fare ciò ch’ei vuole, è pazzo; un popolo che può fare cio che vuole, non è savio. Se, adunque, si ragionerà d’un principe obligato alle leggi, e d’un popolo incatenato da quelle, si vedrà più virtù nel popolo che nel principe: se si ragionerà dell’uno e dell’altro sciolto, si vedrà meno errori nel popolo che nel principe e quelli minori, ed aranno maggiori rimedi. Però che a un popolo licenzioso e tumultuario, gli può da un uomo buono essere parlato, e facilmente può essere ridotto nella via buona: a un principe cattivo non è alcuno che possa parlare né vi è altro rimedio che il ferro. Da che si può fare coniettura della importanza della malattia dell’uno e dell’altro: ché se a curare la malattia del popolo bastan le parole, ed a quella del principe bisogna il ferro, non sarà mai alcuno che non giudichi, che, dove bisogna maggior cura, siano maggiori errori. Quando un popolo è bene sciolto, non si temano le pazzie che quello fa, né si ha paura del male presente, ma di quel che ne può nascere, potendo nascere, infra tanta confusione, uno tiranno. Ma ne’ principi cattivi interviene il contrario: che si teme il male presente, e nel futuro si spera; persuadendosi gli uomini che la sua cattiva vita possa fare surgere una libertà. Sì che vedete la differenza dell’uno e dell’altro, la quale è quanto, dalle cose che sono, a quelle che hanno a essere. Le crudeltà della moltitudine sono contro a chi ei temano che occupi il bene commune: quelle d’un principe sono contro a chi ei temano che occupi il bene proprio. Ma la opinione contro ai popoli nasce perché de’ popoli ciascuno dice male sanza paura e liberamente, ancora mentre che regnano: de’ principi si parla sempre con mille paure e mille rispetti. Né mi pare fuor di proposito, poiché questa materia mi vi tira, disputare, nel seguente capitolo, di quali confederazioni altri si possa più fidare; o di quelle fatte con una republica, o di quelle fatte con uno principe.
Cesare Maccari: Il cieco al Senato Romano (1880)
Dunque concludo contro l’opinione generale che dice che i popoli, quando sono alla guida di uno stato, sono volubili, incostanti ed ingrati, affermando che in loro vi sono gli stessi vizi di un reggitore singolare. Ora accusando un principe ed il popolo nello stesso tempo si potrebbe raggiungere la verità, ma sottraendo all’analisi un principe si incorre nell’errore, perché un popolo al potere e guidato da buone leggi, sarà stabile, prudente, gradito non diversamente di un principe o addirittura meglio di un principe, quand’anche fosse estremamente saggio. D’altra parte un principe non frenato da alcuna legge sarà incostante ed imprudente più di un popolo. Si è che la diversità tra loro non è nella diversità della loro natura, perché in tutti gli uomini è uguale e se vi è una superiorità di bene non è insito nel popolo, ma dall’avere, sia per esso che per il principe preso singolarmente, più o meno rispetto verso le leggi in cui l’uno e l’altro si trovano ad operare. E se si guarda con attenzione il popolo popolo romano, lo si vedrà essere stato per quattrocento anni nemico del nome di re ed amante della gloria e del bene comune per la sa patria e si accorgerà per i tanti esempi di ambedue i suoi atteggiamenti; e se qualcuno mi portasse ad esempio l’episodio di Scipione rispondo allo stesso modo in cui ho già parlato di tale argomento, dove ho mostrato che il popolo fu, nei suoi confronti, meno ingrato dei senatori. Ma quando parlo di prudenza e di stabilità affermo che il popolo è più prudente, più fermo e di maggiore lungimiranza rispetto ad un principe. Per questo si dice che la voce del popolo somiglia a quella di Dio, perché si vede un’opinione presa dalla moltitudine sortire meravigliosi effetti, tanto che sembra che, per un’arcana virtù, riesca ad intuire il suo male ed il suo bene. Quanto al giudicare qualsiasi opinione, si vede rarissimamente, quando si trova di fronte a due oratori, ambedue di eguale virtù, che il popolo non scelga quello migliore e che non sia in grado di capire la verità di ciò che ha ascoltato. E se nelle decisioni prese appassionatamente e che all’apparenza sono utili il popolo s’inganna, spesso s’inganna anche un principe nelle sue passioni, che sono molte di più di quelle del popolo. Si veda come nelle elezioni dei suoi magistrati il popolo farà di gran lunga una scelta migliore di un principe, né mai sarà possibile convincere un popolo che sia buona cosa eleggere a una carica pubblica un uomo infame e corrotto, cosa di cui più facilmente e per vie tortuose può essere convinto un principe. Si veda ancora una cosa essere in orrore al popolo e per molti secoli conservare tale opinione, cosa che non accade ad un principe. Di queste due ultime cose voglio che mi sia testimone il popolo romano, che in tante centinaia di anni, in tante elezioni di consoli e tribuni, non fece quattro elezioni di cui pentirsi, ed ebbe, come già detto, tanto in odio il nome di re che nessun cittadino romano che avesse tentato di conquistare il potere assoluto sfuggì alla debita punizione, per quanti meriti egli avesse. Si veda, oltre a questo, le città dove i popoli sono al governo fare in poco tempo allargamenti territoriali estremamente maggiori di quanti ne possa fare un principe, come fece Roma, dopo la cacciata dei re e Atene dopo che si liberò dal tiranno Pisistrato e questo deriva dal fatto che i governi retti dai popoli sono migliori di quelli retti da un principe. Nè voglio che si opponga a ciò tutto quello che Livio afferma nel brano di cui stiamo parlando o in ogni altra parte dell’opera, perché se si analizzeranno tutti i disordini e tutte le glorie dei popoli e dei principi , si vedrà il popolo di gran lunga essere migliore per bontà e gloria, e se i principi sono superiori ai popoli nel legiferare, organizzare la società civile, creare istituzioni ed emanare provvedimenti, i popoli sono tanto più in grado di conservare in vita per lungo tempo quello stato così ordinato da eguagliare senza dubbio la gloria dei primi ordinatori.
Insomma, in conclusione, affermo che come sono durati gli stati guidati da un principe allo stesso modo sono durati gli stati retti dal popolo ed ambedue hanno bisogno di essere guidati dalla legge, perché un principe che può fare ciò che vuole è pazzo, un popolo che non ha nessun freno non è saggio. Se si ragionerà di un principe obbligato ad esser sottomesso alla legge e di un popolo regolato secondo le leggi, si vedrà più virtù nel popolo che nel singolo reggitore; se si vedrà sia l’uno che l’altro sciolto dall’obbedienza della legge, si vedranno meno errori nel popolo che nel principe e di minore entità ed avranno più facile soluzione, perché un popolo senza licenza e ribelle può essere attraverso le parole di un uomo saggio essere riportato nella retta via; un principe malvagio non può essere corretto da nessuno e non c’è altra soluzione che il tirannicidio. Da ciò si può fare un esempio sui difetti dell’uno e dell’altro, perché se a porre rimedio a quello del popolo bastano le parole e a quella del principe occorre l’omicidio è naturale che dove occorre un rimedio più radicale i “mali” siano maggiori. Quando un popolo non è frenato, non si temono le pazzie che potrebbe fare, né si teme di quello che può al momento succedere, ma si teme quello che può nascere, potendo emergere, in tale confusione, la figura di un tiranno. Ma nei principi malvagi accade il contrario, perché si ha paura del presente e si spera nel futuro, convincendosi gli uomini che dalla sua cattiva vita possa nascere la libertà. Ora vedete la differenza tra l’uno e l’altro, la quale dimostra come le cose sono e come dovrebbero essere. Le violenze della moltitudine sono rivolte contro chi essa teme che voglia impossersi del bene comune, quelle di un principe sono rivolte contro chi teme voglia usurpargli il potere personale. Ma i giudizi negativi contro il popolo nasce perché nei governi repubblicani chiunque può parlare male senza paura e liberamente anche quando è a guida popolare; dei principi si parla sempre con mille paure e mille attenzioni. Nè mi sembra fuori argomento, poiché il discorso fatto fin qui me ne dà l’occasione, parlare nel prossimo capitolo di quali alleanze ci si possa più fidare, se quelle fatte con una repubblica o quelle fatte con un principe.
Sembra che questo passo neghi quanto dallo stesso è stato detto riguardo il principe: Machiavelli, infatti, nel brano proposto sottolinea che il popolo retto da giuste leggi sia da preferire al tiranno. Si ripete qui il profondo pessimismo machiavelliano: perché l’uomo ha bisogno di essere frenato, sia esso espressione di un gruppo o di se stesso, delle leggi? Perché l’uomo “naturalmente” non è in grado di uscire da quello stato di ferinità nel quale si trova da quando è nato: ecco l’importanza delle leggi.
Ma perché il passo è importante? Perché ci pone di fronte alla contraddizione machiavelliana di esaltazione del principe nel De principatibus e della moltitudine e quindi repubblica nei Dialoghi: illuminanti a tal proposito le parole di Luperini: “Si è a lungo discusso sulla relazione fra Il Principe e i Discorsi. Le base teoriche delle due opere sono le stesse; ma la prima pone il problema di fondare uno Stato nuovo (e ciò può avvenire solo a partire dalla “virtù” di un individuo, il principe), la seconda quello della durata e della continuazione dello Stato. Quando è un unico individuo a creare uno Stato nuovo, questo può assumere solo la forma del principato; ma perché poi lo Stato possa durare gli occorre l’appoggio del “popolo” e un equilibrio fra i poteri che solo la repubblica può garantire.” Ribadite con la stessa chiarezza da Grosser: “Machiavelli mostra di credere che un governo monarchico sia più efficace al momento della formazione o del riordinamento di uno stato, ma che poi sul lungo periodo, a garantirne cioè la durata, sia assai più efficace un governo popolare, purché limitato da buoni leggi”.
L’ARTE DELLA GUERRA
Composto tra il 1519 ed il 1521 è un trattato in forma dialogica in cui Machiavelli riprende alcuni concetti già espressi sia ne Il Principe che nei Discorsi: egli infatti sostiene la necessità di formare un esercito di cittadini, mostrando la sua contrarietà alle truppe mercenarie. Si sofferma, quindi, dopo aver sostenuto la superiorità della fanteria rispetto alla cavalleria, anche su aspetti maggiormente tecnici, come l’arruolamento dei soldati, quale fosse lo schieramento migliore e l’allineamento degli accampamenti.
E’ Fabrizio Colonna, che nel dialogo fa da portavoce alle idee di Machiavelli ad individuare nella viltà dei principi l’esito disastroso delle guerre in Italia:
L’INETTITUDINE DEI PRINCIPI ITALIANI
Ma torniamo agli Italiani, i quali, per non avere avuti i principi savi non hanno preso alcuno ordine buono, e per non avere avuto quella necessità che hanno avuta gli Spagnuoli non gli hanno per loro medesimi presi; tale che rimangono il vituperio del mondo. Ma i popoli non ne hanno colpa, ma sì bene i principi loro; i quali ne sono stati gastigati e della ignoranza loro ne hanno portate giuste pene, perdendo ignominiosamente lo stato e sanza alcuno essemplo virtuoso. Volete voi vedere se questo che io dico è vero? Considerate quante guerre sono state in Italia dalla passata del re Carlo ad oggi; e solendo le guerre fare uomini bellicosi e riputati, queste quanto più sono state grandi e fiere tanto più hanno fatto perdere di riputazione alle membra et a’ capi suoi. Questo conviene che nasca che gli ordini consueti non erano e non sono buoni; e degli ordini nuovi non ci è alcuno che abbia saputo pigliarne. Né crediate mai che si renda riputazione alle armi italiane se non per quella via che io ho dimostra, e mediante coloro che tengono stati grossi in Italia. Perché questa forma si può imprimere negli uomini semplici, rozi e proprii, non ne’ maligni, male custoditi e forestieri; né si troverrà mai alcuno buono scultore che creda fare una bella statua d’un pezzo di marmo male abbozzato, ma sì bene d’uno rozzo. Credevano i nostri principi italiani, prima ch’egli assaggiassero i colpi delle oltramontane guerre, che a uno principe bastasse sapere negli scrittoi pensare una acuta risposta, scrivere una bella lettera, mostrare ne’ detti e nelle parole arguzia e prontezza, sapere tessere una fraude, ornarsi di gemme e d’oro, dormire e mangiare con maggiore splendore che gli altri, tenere assai lascivie intorno, governarsi co’ subditi avaramente e superbamente marcirsi nello ocio, dare i gradi della milizia per grazia, disprezzare se alcuno avesse loro dimostro alcuna lodevole via, volere che le parole loro fussero responsi di oraculi ; né si accorgievano i meschini che si preparavano ad essere preda di qualunque gli assaltava. Di qui nacquero poi nel MCCCCLXXXXIIII i grandi spaventi, le sùbite fughe e le miracolose perdite; e così tre potentissimi stati che erano in Italia, sono stati più volte saccheggiati e guasti. Ma quello che è peggio, che quegli che ci restano stanno nel medesimo errore e vivono nel medesimo disordine. E non considerano che quegli che anticamente volevano tenere lo stato, facevano e facevano fare tutte quelle cose che da me si sono ragionate, e che il loro studio era preparare il corpo a’ disagi e lo animo a non temere i pericoli. Onde nasceva che Cesare, Alessandro e tutti quegli uomeni e principi eccellenti, erano i primi tra ’ combattitori, andavano armati a piè, e se pure perdevano lo stato, e’ volevano perdere la vita; talmente che vivevano e morivano virtuosamente. E se in loro o in parte di loro si poteva dannare troppa ambizione di regnare, mai non si troverrà che in loro si danni alcuna mollizia o alcuna cosa che faccia gli uomini delicati et imbelli. Le quali cose se da questi principi fussero lette e credute, sarebbe impossibile che loro non mutassero forma di vivere e le provincie loro non mutassero fortuna.
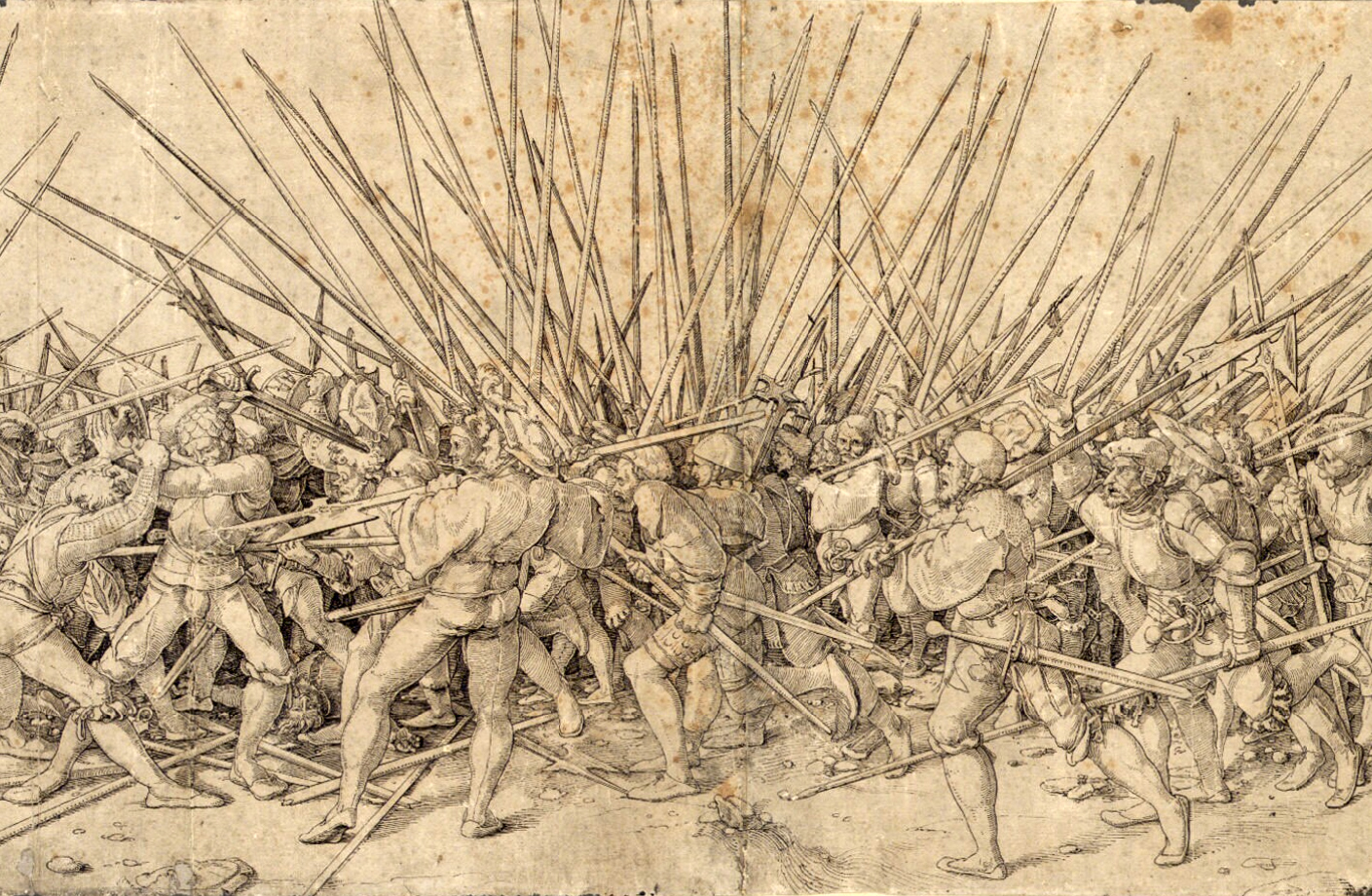 Lanzichenecchi
Lanzichenecchi
Ma torniamo a parlare degli Italiani i quali, non avendo avuto governanti saggi, non hanno adottato nessuno degli antichi ordini militari, e per non aver avuto la necessità degli Spagnoli, non lo hanno adottato per loro volontà, tanto da essere ormai vergogna del mondo. Ma la colpa non è dei popoli, ma dei loro principi, che ne sono stati castigati e hanno pagato giustamente, per la loro ignoranza, la pena, perdendo lo stato senza aver dato alcun esempio di valore. Volete voi vedere se questo che io dico è vero? Considerate quante guerre ci sono stare in Italia dalla discesa di Carlo VIII ad oggi, ed essendo le guerre atte a rendere gli uomini pronti a combattere e degni di reputazione, queste svolte in Italia, quanto più grandi e feroci tanto più hanno fatto perdere la reputazione ai popoli e ai loro governanti. Ciò dipende dal fatto che gli ordini militari tradizionali non erano né sono efficaci, e quelli nuovi non vi è stato alcun principe in grado di adottarli. Non crediate che gli eserciti italiani possano raggiungere una buona reputazione se non nel modo in cui vi ho esposto e per iniziativa di coloro che governano gli Stati più grandi. Perché questa capacità si può imprimere negli uomini semplici, rozzi e sudditi del proprio stato, non nei disonesti, difficili da gestire e forestieri; né mai si troverà un buono scultore che creda di fare una bella statua da un pezzo di marmo a cui si è già impressa una forma sbagliata, ma la farà bene su un pezzo di marmo grezzo. I nostri principi italiani credevano, prima che assaggiassero i colpi delle guerre degli eserciti transalpini, che ad un principe bastasse mostrare cultura nei gabinetti, pensare un’arguta risposta, scrivere una bella lettera, mostrare con le parole l’argomento e il modo di esprimerlo, saper ordire un inganno, riempirsi d’oro e di pietre preziose, dormire e mangiare con ricercatezza superiore agli altri, circondarsi di dissolutezze, rapportarsi ai sudditi con avidità e superbia, abbandonarsi all’ozio, concedere gradi militari come favori, mostrarsi sprezzanti se qualcuno dimostrasse loro miglioramenti nell’esercito, volere che gli altri ritenessero le loro parole come dette da oracoli, né di accorgevano i vigliacchi che si preparavano ad essere preda di chiunque li avesse assaliti. da qui nacquero nel 1494 le grandi paure, le immediate fughe, le inaspettate perdite, e così tre potentissimi stati italiani (Napoli, Milano e Venezia), sono stati più volte saccheggiati e rovinati. Ma ciò che è peggio, che i principi che sono ancora in Italia, continuano a commettere gli stessi sbagli e vivono nello stesso disordine. Non considerano che i governanti antichi che volevano mantenere lo stato, facevano tutte le cose sulle quali ho ragionato, e che la loro preoccupazione era quella di preparare il corpo alle privazioni e all’animo a non perdere il coraggio. Da ciò deriva che Cesare, Alessandro e tutti gli uomini e principi eccellenti, erano i migliori dei loro soldati, combattevano a piedi come i fanti, e se pure perdevano lo stato, sacrificavano per lui anche la loro vita tanto che vivevano e morivano in modo virtuoso. E se in loro o in alcuni di loro si poteva condannare l’eccessivo desiderio di potere, mai si troverà che in loro si condanni alcuna mollezza o altre cose che li rendano delicati e non adatti alla guerra. Le quali cose se da questi principi fossero lette e credute, sarebbe impossibile che loro non volessero mutare modo di vitae gli Starti non mutassero la loro situazione.
All’interno dell’opera ritroviamo lo stesso principio secondo cui bisogna avere delle truppe proprie, ovvero sia un esercito formato dai sudditi e cittadini, se si vuole conservare lo stato. Ma quello che colpisce lo scrittore fiorentino è l’inettitudine dei principi che dà vita ad una “sferzante quanto desolata ironia. In particolare colpisce l’accusa senza riserve nei confronti delle illusioni umanistiche, nelle quali si sono persi i prìncipi abili soltanto nella diplomazia e nella retorica, ma del tutto incapaci di assolvere i propri compiti politici e militari come pure di accorgersi che si preparavano ad essere preda di qualunque gli assaltava” (Barberi-Squarotti)
 Locandina del film tratto dalla Mandragola (1955)
Locandina del film tratto dalla Mandragola (1955)
LA MANDRAGOLA
La Mandragola è una commedia in cinque atti, scritta forse nel 1518, ed è considerata un vero e proprio capolavoro della commedia rinascimentale.
L’anziano Messer Nicia e la sua bella moglie Lucrezia sono delusi di non aver figli. Di ciò e della balordaggine di Nicia approfitta Callimaco, innamorato di Lucrezia. Con l’aiuto del mezzano Ligurio si fa passare per un famoso dottore e assicura a Nicia che Lucrezia avrà un bambino se berrà una pozione di mandragola, ma che è morte certa giacere con lei subito dopo; lo persuade poi che bisogna trovare un poveraccio che si presti all’opera quella notte. A convincere Lucrezia provvedono la sua sciocca madre Sostrata e il cinico fra Timoteo. Naturalmente è Callimaco travestito che quella notte sarà nel letto di Lucrezia la quale, conosciuta la leggerezza del marito, non esiterà a eleggere Callimaco suo signore.
La Mandragola s’inserisce in quella ripresa umanistico-rinascimentale del teatro comico latino, soprattutto di quella plautina. Infatti qui si riconosce l’adulescens (Callimaco), la donna di cui è innamorato (Lucrezia), il senex che è il proprietario – in questo caso il marito – (Nicia) ed il servus callidus (Ligurio). Eppure in Machiavelli la commedia è assolutamente “nuova” e non sembra così lontana dal suo trattato politico. Vediamo il perché, attraverso l’analisi dei personaggi:
Nicia rappresenta il vecchio sciocco, quello da “beffare”. Tuttavia in lui non vi è solamente l’aspetto dell’incapace, dello sprovveduto facile da circuire. Egli è “cattivo”, malvagio, avaro, sprezzante ogni morale (non gli importa nulla se quello che giacerà con Lucrezia dopo dovrà morire), probabilmente impotente. Incapace d’agire sembra rappresentare i fiorentini del tempo di Machiavelli che potevano vedere in lui, inconsciamente, se stessi, come nel brano seguente:
NICIA
(Atto II, scena III)
NICIA: Questo tuo è un gran valente uomo.
SIRO: Più che voi non dite.
NICIA: Il re di Francia ne de’ fare conto.
SIRO: Assai.
NICIA: E’ per questa cagione e’ debbe stare volentieri in Francia.
SIRO: Così credo.
NICIA: E fa molto bene. In questa terra non ci è se non cacastecchi, non ci s’apprezza virtù alcuna. S’egli stessi qua, non ci sarebbe uomo che lo guardassi in viso. Io ne so ragionare, che ho cacato le curatelle per imparare due hac: e se io avessi a vivere, io starei fresco, ti so dire!
SIRO: Guadagnate voi cento ducati?
NICIA: Non cento lire, non cento grossi, oh va’! E questo è, che chi non ha lo stato in questa terra, de’ nostri pari, non truova cane che gli abbai, e non siamo buoni ad altro che andare a’ mortori o alle ragunate d’un mogliazzo o a starci tutto dì in sulla panca del Proconsolo a donzellarci. Ma io ne li disgrazio, io non ho bisogno di persona; così stessi chi sta peggio di me. Non vorrei però che le fussino mia parole, che io arei di fatto qualche balzello o qualche porro di drieto che mi fare’ sudare.
NICIA: Il tuo padrone è proprio un gran uomo. SIRO: Più di quanto dite. NICIA: Il re di Francia lo deve tenere molto in considerazione. SIRO: Molto. NICIA: E’ per questo che egli deve stare molto in Francia. SIRO: Credo che sia così. NICIA: E fa bene. In questa terra non ci sono che spilorci e chi ha qualche virtù non ha possibilità di crescere. Se egli abitasse qui, nessuno lo guarderebbe in faccia. Ne so qualcosa io, che ho fatto una fatica cane ad imparare un po’ di latino; e se io dovessi qui guadagnare, starei fresco. Questi ti dico. SIRO: Voi guadagnate cento ducati l’anno? NICIA: Nemmeno cento lire e cento grossi (monete di minor valore del ducato), va là! Questo è: chi in questa terra non ha lo status dei suoi pari, non trova nessuno che gli dia considerazione. Non siamo capaci che andare ai funerali, alle feste dei matrimoni e tutto il giorno sulla panchina della via principale a non fare niente. Ma io non mi curo di loro, non ho bisogno di nessuno. Magari stesse così chi sta peggio di me. Non vorrei però che queste parole fossero riferite come mie, che io subirei qualche pagamento o grossa fregatura che mi farebbe penare.
Ligurio è il vero “princeps”: lui, una volta osservata la realtà effettuale (stupidità di Nicia, corruttibilità di fra Timoteo, scarsa virtù di Sostrata) decide l’inganno valutandone i pro e i contro; così se dapprima convince Nicia a portare Lucrezia ai bagni per far incontrare la stessa con Callimaco, dopo attenta valutazione ritiene tale piano poco fattibile riguardo l’obiettivo (Lucrezia potrebbe incontrare ai bagni qualcuno più ricco e più bello di Callimaco) e pertanto ordisce un secondo e più sicuro inganno. Rappresenta, nell’economia della commedia, la figura del servus callidus. Inoltre è l’unico il cui impegno avrà come ricompensa una sola e semplice cena e la compagnia amicale, che sembra organizzata più per soddisfazione che come vero e proprio guadagno.
Callimaco è l’adulescens del teatro comico classico. Tuttavia rispetto ai modelli plautini e terenziani Callimaco mostra un vitalismo che essi non possedevano. Egli è disposto a tutto pur di ottenere ciò che desidera, sapendo che il suo fine rappresenta la sua salvezza. La donna che vuole possedere non è né una liberta né una schiava da riscattare con denaro, ma una donna borghese, sposata, probabilmente insoddisfatta sessualmente, fatto cui Callimaco dove porre rimedio.
LIGURIO E CALLIMACO
(Atto I, scena III)
LIGURIO: Egli (Nicia) è uno uomo della qualità che tu sai, di poca prudenzia, di meno animo, e partesi mal volentieri da Firenze; pure, io ce l’ho riscaldato: e mi ha detto infine che farà ogni cosa; e credo che, quando e’ ti piaccia questo partito, che noi ve lo condurreno, ma io non so se noi ci fareno el bisogno nostro.
CALLIMACO: Perché?
LIGURIO: Che so io? Tu sai che a questi bagni va d’ogni qualità gente, e potrebbe venirvi uomo a chi madonna Lucrezia piacessi come a te, che fussi ricco più di te, che avessi più grazia di te: in modo che si porta pericolo di non durare questa fatica per altri, e che c’intervenga che la copia de’ concorrenti la faccino più dura, o che, dimesticandosi, la si volga ad un altro e non a te.
CALLIMACO: Io conosco che tu di’ el vero. Ma come ho a fare? Che partito ho a pigliare? Dove mi ho a volgere? A me bisogna tentare qualche cosa, sia grande, sia periculosa, sia dannosa, sia infame. Meglio è morire che vivere così. Se io potessi dormire la notte, se io potessi mangiare, se io potessi conversare, se io potessi pigliare piacere di cosa veruna, io sarei più paziente ad aspettare el tempo; ma qui non c’è rimedio; e, se io non sono tenuto in speranza da qualche partito, i’ mi morrò in ogni modo; e, veggendo d’avere a morire, non sono per temere cosa alcuna, ma per pigliare qualche partito bestiale, crudele, nefando.
LIGURIO: Non dire così, raffrena cotesto impeto dello animo.
CALLIMACO: Tu vedi bene che, per raffrenarlo, io mi pasco di simili pensieri. E però è necessario o che noi seguitiamo di mandare costui al bagno, o che noi entriano per qualche altra via, che mi pasca d’una speranza, se non vera, falsa almeno, per la quale io nutrisca un pensiero, che mitighi in parte tanti mia affanni.
LIGURIO: Tu hai ragione, ed io sono per farlo.
CALLIMACO: Io lo credo ancora che io sappia che e pari tuoi vivino di uccellare li uomini. Nondimanco, io non credo essere in quel numero, perché, quando tu el facessi ed io me ne avvedessi, cercherei valermene, e perderesti per ora l’uso della casa mia, e la speranza di avere quello che per lo avvenire t’ho promesso.
LIGURIO: Non dubitare della fede mia, ché, quando e’ non ci fussi l’utile che io sento e che io spero, e’ c’è che ’l tuo sangue si confà col mio, e desidero che tu adempia questo tuo desiderio presso a quanto tu. Ma lasciamo ir questo. El dottore mi ha commesso che io truovi un medico, e intenda a quale bagno sia bene andare. Io voglio che tu faccia a mio modo, e questo è che tu dica di avere studiato in medicina, e che abbi fatto a Parigi qualche sperienzia: lui è per crederlo facilmente per la semplicità sua, e per essere tu litterato e poterli dire qualche cosa in gramatica.
CALLIMACO: A che ci ha a servire cotesto?
LIGURIO: Serviracci a mandarlo a qual bagno noi vorreno, ed a pigliare qualche altro partito che io ho pensato, che sarà più corto, più certo, più riuscibile che ’l bagno.
CALLIMACO: Che di’ tu?
LIGURIO: Dico che, se tu arai animo e se tu confiderai in me, io ti do questa cosa fatta, innanzi che sia domani questa otta. E, quando e’ fussi uomo che non è, da ricercare se tu se’ o non se’ medico, la brevità del tempo, la cosa in sé farà o che non ne ragionerà o che non sarà a tempo a guastarci el disegno, quando bene e’ ne ragionassi.
CALLIMACO: Tu mi risusciti. Questa è troppa gran promessa, e pascimi di troppa gran speranza. Come farai?
LIGURIO: Tu el saprai, quando e’ fia tempo; per ora non occorre che io te lo dica, perché el tempo ci mancherà a fare, nonché dire. Tu, vanne in casa, e quivi m’aspetta, ed io andrò a trovare el dottore, e, se io lo conduco a te, andrai seguitando el mio parlare ed accomodandoti a quello.
CALLIMACO: Così farò, ancora che tu mi riempia d’una speranza, che io temo non se ne vadia in fumo.
LICURGO: Nicia è un uomo di cui sai la qualità, non avveduto, pauroso, e parte molto mal volentieri da Firenze. Eppure io l’ho convinto, e infine mi ha detto che farà di tutto per andarsene. Credo che quando noi decidessimo che lui vada, noi lo porteremo via. Ma non so se tutto questo sarà per noi conveniente. CALLIMACO: Perché? LIGURIO: Che ti posso dire? Sai che a questi bagni va una gran quantità di gente e che quindi potrebbe venirci un uomo che a madonna Lucrezia piaccia più di te, che fosse più ricco di te, che avesse più eleganza di te; tanto che noi portiamo avanti questo “pericoloso” progetto per favorire un altro, che intervenga l’abbondanza dei concorrenti che renda il nostro piano più difficile a realizzarsi, e che prendendo amicizia con altra gente lei si rivolga ad un altro e non a te. CALLIMACO: Riconosco che dici la verità. Ma che devo fare? Quale decisione prendere? Dove mi devo rivolgere? Per me è necessario provare qualche cosa, sia pure grande, pericolosa, dannosa o infame. Se io riuscissi a dormire, a mangiare, a parlare con gli amici, se potesse piacermi qualsiasi altra cosa, io sarei disposto ad aspettare con pazienza; ma qui non c’è possibilità di riuscita, e se io non avrò la possibilità di sperare con qualche azione, io morirò, e sapendo che devo morire, non devo avere paura di prendere qualsiasi decisione sia essa violenta, crudele, nefanda. LICURGO: Non dire così, calma questo tuo animo infuocato. CALLIMACO: Vedi bene che per calmarmi io mi nutro di questi pensieri. Dunque è necessario o che noi continuiamo affinché costui va-da ai bagni, o che noi prendiamo qualche altra azione con la quale io possa nutrirmi di una speranza che, se non vera, possa essere anche falsa, che alimenti un pensiero che plachi per un momento questa mia angoscia. LICURGO: Hai ragione e sto per farlo. CALLIMACO: Lo credo, sebbene sappia che la gente come te è nata per prendere in giro gli altri uomini. Tuttavia io credo di non essere tra costoro, perché se lo faresti e me ne accorgessi, mi vendicherei e non potresti più frequentare casa mia né avere quello che ti ho già promesso. LICURGO: Non mettere in dubbio la mia fedeltà e se non ci fosse l’utile che io invece sento e spero, è che il tuo sangue è simile al mio e voglio che il tuo desiderio vada a buon fine quanto te. Ma lasciamo andare queste chiacchiere. Il dottore mi ha affidato il compito di trovargli un medico affinché possa intendere a quale bagno gli convenga andare. Voglio che tu faccia a modo mio e cioè che tu dica di aver studiato medicina e di aver fatto qualche esperienza a Parigi. Lui ci crederà con facilità per il fatto che è stupido e per esser tu letterato e potergli dire qualcosa in latino. CALLIMACO: E questo a cosa ci servirà? LICURGO: Potrà servirci per mandarlo a quel bagno che noi vorremo oppure a pensare a qualche altro piano che ho in mente che sarà più breve, più sicuro, con migliore possibilità di successo dei bagni. CALLIMACO: Che dici? LICURGO: Dico che se tu sarai coraggioso e ti fiderai di me ti offro questo cosa come fatta prima della stessa ora di domani. E quando tu diventassi un uomo che non sei, tale da indagare se tu sei medico o no, la brevità del tempo, il fatto in sé, farà sì che egli non ci penserà o che non avrà il tempo per ripensarci, quando egli ci ragionerà un po’. CALLIMACO: Mi risusciti. Questa è una grande promessa e mi nutre di una grande speranza. Ma come farai? LICURGO: Lo saprai quando sarà il momento; per ora non è necessario che io ti sveli tutto, perché ci mancherà il tempo per fare se lo dedichiamo a dire. Tu vai a casa e aspettami, io andrò a trovare il dottore e se te lo porterò, seguirai il mio ragionamento e ti collegherai ad esso. CALLIMACO: Così farò, sebbene tu mi riempia di una speranza che temo possa andare in fumo.
Sostrata è la madre di Lucrezia. E’ presentata da Machiavelli come una donna dai costumi non irreprensibili. Anche lei avrà parte nell’inganno, con l’intento d’acquisire un nipote.

Locandina teatrale della Compagnia teatrale Il Castello per la rappresentazione a Perugia dell’opera di Machiavelli
SOSTRATA
(Atto III, scena I e scena X)
SOSTRATA: Io ho sempremai sentito dire che gli è ufizio d’un prudente pigliare de’ cattivi partiti el migliore: se, ad avere figliuoli, voi non avete altro rimedio che questo, si vuole pigliarlo, quando e’ non si gravi la coscienzia.
NICIA: Egli è così.
LIGURIO: Voi ve ne andrete a trovare la vostra figliuola, e messere ed io andreno a trovare fra’ Timoteo, suo confessoro, e narreregli el caso, acciò che non abbiate a dirlo voi: vedrete quello che vi dirà.
SOSTRATA: Così sarà fatto. La via vostra è di costà; ed io vo a trovare la Lucrezia, e la merrò a parlare al frate, in ogni modo.
(…)
SOSTRATA: Io credo che tu creda, figliuola mia, che io stimi l’onore ed el bene tuo quanto persona del mondo, e che io non ti consiglierei di cosa che non stessi bene. Io ti ho detto e ridicoti, che se fra’ Timoteo ti dice che non ti sia carico di conscienzia, che tu lo faccia sanza pensarvi.
LUCREZIA: Io ho sempremai dubitato che la voglia, che messer Nicia ha d’avere figliuoli, non ci facci fare qualche errore; e per questo, sempre che lui mi ha parlato di alcuna cosa, io ne sono stata in gelosia e sospesa, massime poi che m’intervenne quello che vi sapete, per andare a’ Servi. Ma di tutte le cose, che si son tentate, questa mi pare la più strana, di avere a sottomettere el corpo mio a questo vituperio, ad esser cagione che uno uomo muoia per vituperarmi: perché io non crederrei, se io fussi sola rimasa nel mondo e da me avessi a risurgere l’umana natura, che mi fussi simile partito concesso.
SOSTRATA: Io non ti so dire tante cose, figliuola mia. Tu parlerai al frate, vedrai quello che ti dirà, e farai quello che tu dipoi sarai consigliata da lui, da noi, da chi ti vuole bene.
LUCREZIA: Io sudo per la passione.
SOSTRATA: Io ho sempre sentito che un uomo giudizioso prenda tra tutti i cattivi partiti il meno cattivo: se, per avere figli, voi non avete che questo e si deve prendere, quando non vi pesi sulla coscienza. NICIA: E’ così. LIGURIO: Voi andate a trovare vostra figlia, che io e messer Nicia andiamo a trovare fra’ Timoteo, il suo confessore, che gli esporrà il fatto, senza che glielo diciate voi. Sentite cosa vi dirà. SOSTRATA: E così sarà fatto; la vostra via è di là. Io vado a trovare Lucrezia, e la condurrò a parlare col frate, ad ogni modo.
(…)
SOSTRATA: Io credo che tu sappia, figliola, che io stimi il tuo onore più di ogni altra persona al mondo e non ti consiglierei di compiere un’azione peccaminosa. Io ti dico e ti ripeto che se frate Timoteo dice che non c’è peccato, tu debba fare ciò che ti viene richiesto senza pensarci. LUCREZIA: Io ho sempre temuto che la voglia di messer Nicia di avere figli ci faccia compiere qualche sbaglio. E per questo, quando lui mi ha parlato di qualche cosa, io ne sono rimasta sempre sospettosa e preoccupata, soprattutto dopo essere andata al convento de’ Servi, (probabilmente quella di fra’ Timoteo, dove ho subito le inopportune attenzioni di un frate) come sapete. Ma di tutte le cose che si sono tentate (per farmi rimanere incinta) questa mi sembra la più strana, di sottomettere il mio corpo a questa vergogna, ed essere motivo per cui l’uomo dovrà morire dopo avermi svergognato, che io non crederei, fossi pure rimasta l’unica donna sulla terra dalla quale dover far nascere tutto il genere umano, mi sarebbe stato proposto. SOSTRATA: Io non so dire tante cose, figliola. Parlane al frate, vedi quello che ti consiglierà e poi ti comporterai secondo il suo consiglio, il nostro e di tutti quelli che ti vogliono bene. LUCREZIA: Tremo per paura.
Fra Timoteo: personaggio della Chiesa, ma la chiesa così come Machiavelli pensa sia al suo tempo. Egli è cinico, corrotto, dedito ai piaceri e ben si presta, in cambio di denaro, ad ordire l’inganno “immorale” contro l’immorale Nicia, come si vede in questo passo dove piega la logica cattolica ad azioni assolutamente antireligiose.
FRA TIMOTEO
(Atto III, scena XI)
TIMOTEO: Voi siate le ben venute! Io so quello che voi volete intendere da me, perché messer Nicia mi ha parlato. Veramente io son stato in su’ libri più di dua ore a studiare questo caso, e dopo molte esamine, io truovo di molte cose che e in particulare e in generale fanno per noi.
LUCREZIA: Parlate voi da vero o motteggiate?
TIMOTEO: Ah, madonna Lucrezia! son queste cose da motteggiare? Avetemi voi a conoscere ora?
LUCREZIA: Padre, no; ma questa mi pare la più strana cosa che mai si udissi.
TIMOTEO: Madonna, io ve lo credo, ma io non voglio che voi diciate più così. E’ sono molte cose che discosto paiano terribile, insopportabile, strane, e quando tu ti appressi loro, le riescono umane, sopportabili, dimestiche; e però si dice che sono maggiori li spaventi ch’e mali: e questa è una di quelle.
LUCREZIA: Dio el voglia!
TIMOTEO: Io voglio tornare a quello che io dicevo prima. Voi avete, quanto alla conscienzia, a pigliare questa generalità, che dove è un bene certo e un male incerto non si debbe mai lasciare quel bene per paura di quel male. Qui è un bene certo, che voi ingraviderete, acquisterete una anima a messer Domenedio: el male incerto è che colui che iacerà doppo la pozione con voi, si muoia: ma e’ si truova anche di quelli che non muoiono. Ma perché la cosa è dubia, però è bene che messer Nicia non corra quel periculo. Quanto allo atto, che sia peccato, questo è una favola, perché la volontà è quella che pecca, non el corpo; e la cagione del peccato è dispiacere al marito, e voi li compiacete; pigliarne piacere, e voi ne avete dispiacere. Oltra di questo, el fine si ha a riguardare in tutte le cose: el fine vostro si è riempiere una sedia in paradiso, contentare el marito vostro. Dice la Bibbia che le figliuole di Lotto, credendosi essere rimase sole nel mondo, usorno con el padre; e, perché la loro intenzione fu buona, non peccorno.
LUCREZIA: Che cosa mi persuadete voi?
SOSTRATA: Lasciati persuadere, figliuola mia. Non vedi tu che una donna che non ha figliuoli non ha casa? Muorsi el marito, resta com’una bestia, abandonata da ognuno.
TIMOTEO: Io vi giuro, madonna, per questo petto sacrato, che tanta conscienzia vi è ottemperare in questo caso al marito vostro, quanto vi è mangiare carne el mercoledì, che è un peccato che se ne va con l’acqua benedetta.
LUCREZIA: A che mi conducete voi, padre?
TIMOTEO: Conducovi a cose che voi sempre arete cagione di pregare Dio per me, e più vi satisfarà questo altro anno che ora.
SOSTRATA: Ella farà ciò che voi vorrete. Io la voglio mettere stasera al letto io. Di che hai tu paura, moccicona? E’ c’è cinquanta donne in questa terra che ne alzerebbono le mani al cielo.
LUCREZIA: Io sono contenta, ma non credo mai essere viva domattina.
TIMOTEO: Non dubitare, figliuola mia: io pregherrò Dio per te, io dirò l’orazione dell’agnol Raffaello che t’accompagni. Andate in buona ora, e preparatevi a questo misterio, ché si fa sera.
SOSTRATA: Rimanete in pace, padre.
LUCREZIA: Dio m’aiuti e la Nostra Donna, che io non capiti male!
TIMOTEO: Siate le benvenute! So cosa volete da me, perché ho già parlato con messer Nicia. A dire il vero io sono stato due giorni interi a studiare questo caso, e dopo molte verifiche ho trovato molti argomenti sia in particolare che in generale che ben si adattano al vostro caso. LUCREZIA: Dite veramente o scherzate? TIMOTEO: Ah, madonna Lucrezia! Sono queste cosa su cui scherzare? Mi conoscete solo da ora? LUCREZIA: No, padre. Ma questa è la cosa più strana che mai si è udita sinora. TIMOTEO: Madonna ve lo concedo. Ma io non voglio che voi diciate più così. Ci sono molte cose che, viste da lontano ci sembrano terribili, insopportabili, strane, e quando ci si avvicina risultano normali, sopportabili, quotidiane; per questo si dice che sono maggiori gli spaventi delle cose malvagie che li procurano: il vostro caso è uno di quelli. LUCREZIA: Dio lo voglia! TIMOTEO: Voglio riprendere da dove mi son fermato. Voi dovete, riguardo alla coscienza, prendere questa regola generale, che dove c’è un bene sicuro ed un male insicuro, non bisogna lasciare il primo per paura del secondo. Qui c’è un bene certo, ed è che voi rimarrete incinta e acquisterete un’anima a Dio; il male incerto è che colui che giacerà con voi, dopo debba morire; ma ci sono anche coloro che non muoiono. Tuttavia la cosa è incerta: per questo non è bene che messer Nicia corra il pericolo. Quanto all’atto, che questo costituisca peccato, è una bugia. E’ la volontà che pecca, non il corpo; e il motivo del peccato sta nel dispiacere al marito mentre voi lo compiacete; nel provare piacere, mentre voi ne provate dispiacere: Oltre a tutto questo bisogna osservare il fine di tutto questo: il vostro fine è quello di riempire una sedia in Paradiso e far contento vostro marito. Dice la Bibbia che le figlie di Lot, pensando d’essere sole al mondo, giacquero con padre e poiché la loro intenzione fu buona, non peccarono. LUCREZIA: Di che cosa mi state convincendo? SOSTRATA: Convinciti, figlia mia. Non vedi che una donna senza figli non ha una casa? Muore il marito e resta come un animale, abbandonata da tutti. TIMOTEO: Io vi giuro, per questo petto consacrato, che tanto peccato vi è nell’obbedire in questo caso a vostro marito, quanto mangiare la carne il mercoledì, peccato che se ne va bagnandosi con l’acqua benedetta. LUCREZIA: Dove mi portate, padre? TIMOTEO: Vi porto a cose che una volta fatte avrete sempre ragione di pregare Dio per me, e questo accadrà l’anno venturo più che questo. SOSTRATA: Lei farà ciò che vorrete. La metterò io a letto stanotte. Di cosa hai paura, bambinona? Ci sono perlomeno cinquanta donne qui in giro che al posto tuo alzerebbero le mani al cielo per ringraziare il Signore! LUCREZIA: Lo farò, ma non so se arriverò a domani viva nell’anima. TIMOTEO: Non dubitare, figlia mia. Pregherò Dio per te, farò un’invocazione all’angelo Raffaele, perché ti guidi. Andate ora e preparatevi a questo mistero, che si fa tardi.
Lucrezia giovane donna virtuosa, che non ama il marito, ma gli è fedele. Donna che non conosce le gioie dell’amore, vittima delle trame della madre e del frate, alla fine cede. E scoperta la felicità dell’amore, contro la dabbenaggine del marito, sceglie Callimaco come amante.
L’ULTIMA SCENA
(ATTO IV, scena VI)
TIMOTEO: Io vengo fuora perché Callimaco e Ligurio m’hanno detto che el dottore e le donne vengono alla chiesa.
NICIA: Bona dies, padre!
TIMOTEO: Voi siate le benvenute, e buon pro vi faccia, madonna, che Dio vi dia a fare un bello figliuolo maschio!
LUCREZIA: Dio el voglia!
TIMOTEO: E’ lo vorrà in ogni modo.
NICIA: Veggh’io in chiesa Ligurio e maestro Callimaco?
TIMOTEO: Messer sì.
NICIA: Accennateli.
TIMOTEO: Venite!
CALLIMACO: Dio vi salvi!
NICIA: Maestro, toccate la mano qui alla donna mia.
CALLIMACO: Volentieri.
NICIA: Lucrezia, costui è quello che sarà cagione che noi areno un bastone che sostenga la nostra vecchiezza.
LUCREZIA: Io l’ho molto caro, e vuolsi che sia nostro compare.
NICIA: Or benedetta sia tu! E voglio che lui e Ligurio venghino stamani a desinare con esso noi.
LUCREZIA: In ogni modo.
NICIA: E vo’ dare loro la chiave della camera terrena d’in sulla loggia, perché possino tornarsi quivi a lor commodità, ché non hanno donne in casa e stanno come bestie.
CALLIMACO: Io l’accetto, per usarla quando mi acaggia.
TIMOTEO: Io ho avere e danari per la limosina?
NICIA: Ben sapete come, domine, oggi vi si manderanno.
LIGURIO: Di Siro non è uomo che si ricordi?
NICIA: Chiegga, ciò che io ho è suo. Tu, Lucrezia, quanti grossi hai a dare al frate per entrare in santo?
LUCREZIA: Dategliene dieci.
NICIA: Affogaggine!
TIMOTEO: Voi, madonna Sostrata, avete, secondo mi pare, messo un tallo in sul vecchio.
SOSTRATA: Chi non sarebbe allegra?
TIMOTEO: Andianne tutti in chiesa, e quivi direno l’orazione ordinaria; dipoi doppo l’uficio ne andrete a desinare a vostra posta. Voi, aspettatori, non aspettate che noi usciàno più fuora: l’uficio è lungo, e io mi rimarrò in chiesa, e loro per l’uscio del fianco se ne andranno a casa. Valète!
TIMOTEO: Esco fuori perché Callimaco e Ligurio mi hanno detto che il dottore e le donne stanno venendo in chiesa. NICIA: Buon giorno, padre. TIMOTEO: Voi siate le benvenute, buon pro vi faccia!, signora, e che Dio vi doni un bel figlio maschio! LUCREZIA: Dio lo voglia. TIMOTEO: Certamente lo vorrà. NICIA: Vedo in chiesa Ligurio e il maestro Callimaco? TIMOTEO: Si signore. NICIA: Chiamateli. TIMOTEO: Venite. CALLIMACO: Dio vi salvi. NICIA: Maestro, prendete la mano di mia moglie. CALLIMACO: Volentieri. NICIA: Lucrezia, questo è colui che ci darà un bastone per la nostra vecchiaia. LUCREZIA: L’ho molto caro, e vorrei fosse nostro compare. NICIA: Benedetta sia tu. Voglio che lui e Ligurio vengano a mangiare da noi oggi. LUCREZIA: Certamente. NICIA: E voglio dar loro le chiavi di una camera al pianterreno sulla loggia, affinché possano tornare qui, a loro comodo, perché non hanno donne in casa e stanno come animali. L’accetto, per usarla quando mi capita. TIMOTEO: Devo avere denari per l’elemosina? NICIA: Già sapete, signore, che oggi li riceverete. LIGURIO: Di Siro non c’è nessuno che si ricordi? NICIA: Chieda, ciò che io ho è suo. Tu, Lucrezia, quanti denari hai da dare al frate per andare in Santo (espressione con la quale si indicava alle puerpere l’entrare in chiesa per il futuro battesimo del nascituro)? LUCREZIA: Dagliene dieci. NICIA: Accidenti! TIMOTEO: Voi, madonna Sostrata, sembrate ringiovanita! SOSTRATA: Chi non sarebbe felice oggi? TIMOTEO: Andiamo tutti in chiesa, e qui diremo la preghiera quotidiana. Poi dopo l’ufficio, andrete a casa vostra. Voi spettatori non aspettateci più fuori. L’ufficio è lungo ed io rimarrò dentro, mentre loro usciranno di lato e andranno a casa. State bene!

Costumi per la Mandragola
Da quanto abbiamo detto è chiaro che la Mandragola non è solo una parentesi piacevole di Machiavelli tra le opere politiche e storiche. Essa ci mostra il profondo pessimismo dello scrittore fiorentino sull’uomo. Quest’ultimo è mosso da un estirpabile egoismo (egoisti sono tutti i personaggi della commedia), ma al contempo Machiavelli riesce anche a disegnare l’ottimismo della volontà ed un vitalismo (elementi che deve possedere un principe) per ottenere un obiettivo. Per questo la commedia dello scrittore fiorentino è stata letta come la trasposizione letteraria del suo trattato politico.