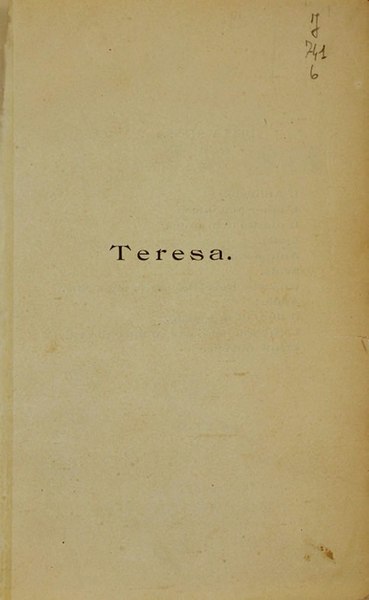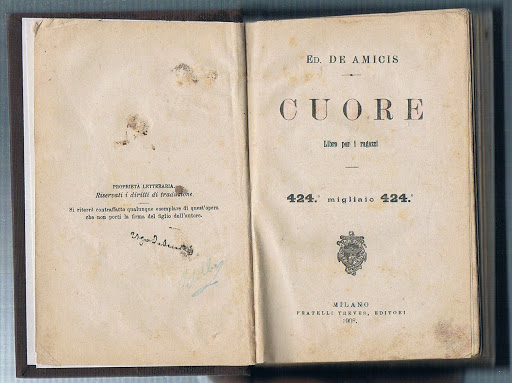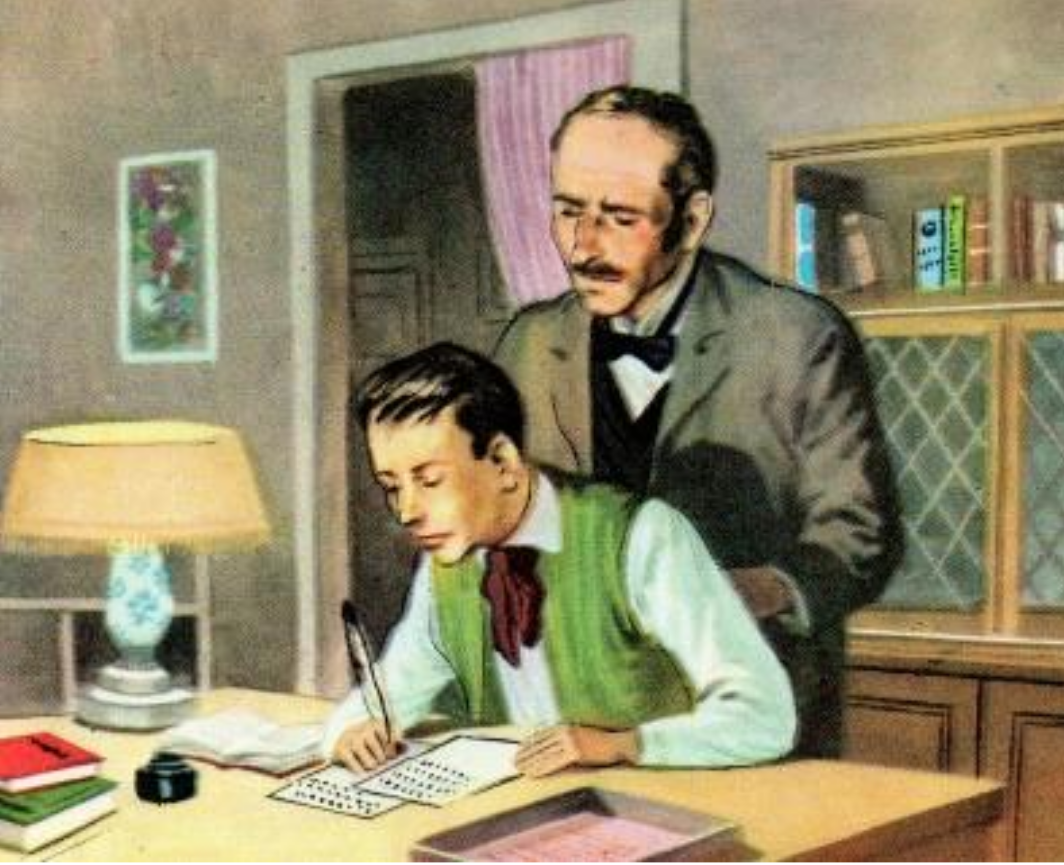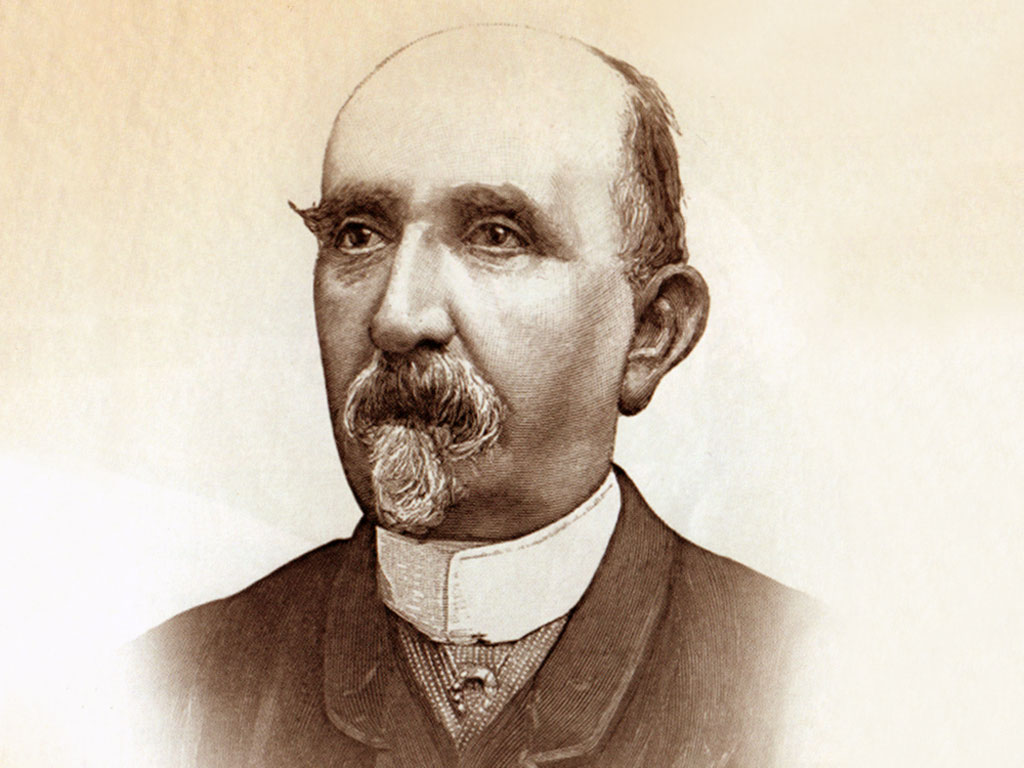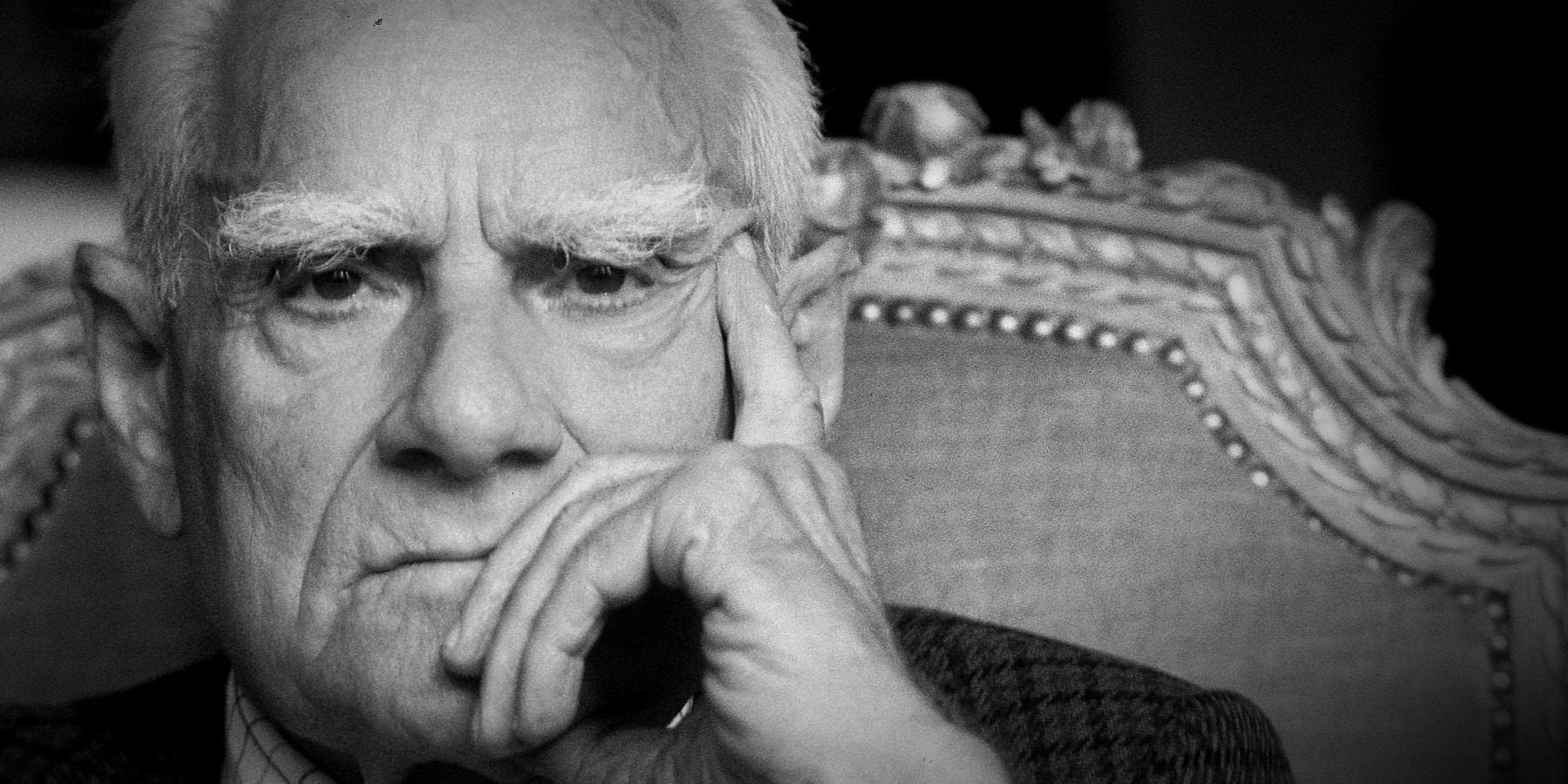
Alberto Pincherle Moravia nasce a Roma nel 1907 da una famiglia della medio-alta borghesia. Il padre era un famoso architetto, d’origini ebraiche, la madre Teresa Iginia De Marsanich era nata ad Ancona, sebbene la sua famiglia fosse originaria della Dalmazia. Fondamentali sono stati per il giovane Moravia gli intrecci familiari: Amelia Pincherle, sorella del padre, fu la madre dei fratelli Rosselli, emigrati in Francia e lì uccisi per mano dei fascisti.
All’età di nove anni si ammala di tubercolosi ossea: costretto a letto per tre anni a casa e due in un sanatorio a Cortina d’Ampezzo non può seguire uno percorso scolastico regolare (si fermerà alla licenza ginnasiale): ciononostante legge molto, tra cui i romanzieri russi e le opere teatrali di Goldoni, Molière e Shakespeare.
Comincia molto presto a scrivere ed alcuni suoi racconti trovano spazio nelle riviste letterarie dell’epoca, come Cortigiana stanca e Delitto al circolo del tennis, entrambi del ’27.
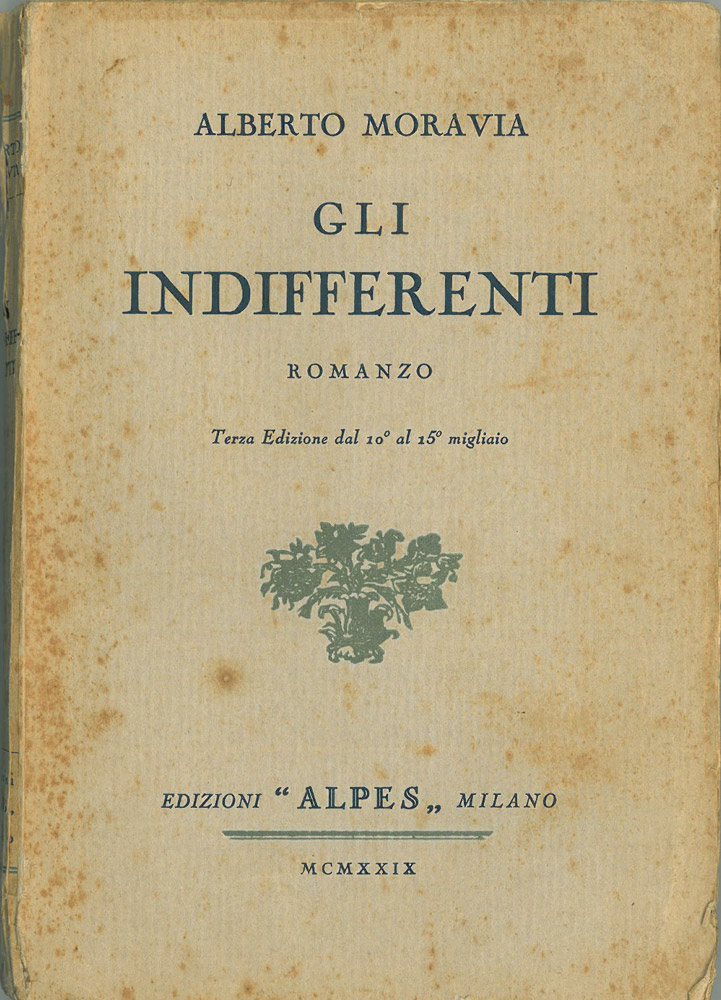
Nel frattempo, iniziato nel ’25, egli compone il romanzo Gli indifferenti, pubblicato a sue spese nel ’29 dalla casa editrice Alpes (diretta dal fratello di Benito Mussolini). L’opera avrà un successo immediato e inaspettato:
La relazione tra Leo Merumeci e la vedova Maria Grazia, coppia matura, è ormai stanca, e i due giovanissimi figli di lei, Carla e Michele, assistono con disagio, ma senza rivolte, alle manifestazioni di insofferenza di Leo e alle scenate della madre, gelosa di una vecchia fiamma dell’amante, Lisa. Leo rivolge le sue attenzioni a Carla e riesce a farla sua. Michele sente confusamente di dover intervenire: ma dentro di sé, nel profondo della sua indifferenza, non coglie motivi di autentica indignazione. Si ingegna, a freddo, di provocare Leo: arriva addirittura a tentare di ucciderlo, ma il tentativo naufraga, abbastanza ridicolmente. Allora Michele si rassegna: cede a Lisa che invaghitasi di lui, lo assilla con una corte insistente. Anche Mariagrazia si rassegna all’inevitabile e Carla sposerà Leo.
L’opera moraviana rappresenta un vero e proprio spartiacque per la narrativa degli anni ’20/’30. Era infatti l’età dei romanzi pirandelliani e sveviani e, soprattutto per quest’ultimo, la figura sia dell’inetto Emilio (di Senilità) sia dell’indifferente Michele dello scrittore romano, sembrano in qualche modo disegnare l’incapacità del personaggio novecentesco di rapportarsi in modo positivo alla realtà. Ma il tentativo moraviano va al di là “svecchiando” e “innovando” il genere romanzo su diversi piani:
- l’opera viene strutturata su un impianto formale tragico;
- unità di spazio (interni: casa di Mariagrazia e di Leo, quasi nulla gli esterni);
- unità di tempo: due giorni;
- cinque personaggi (Mariagrazia, Lisa, Leo, Michele e Carla);
- prevalenza dialogica.
- Viene recuperato uno stile “oggettivo” con narratore esterno che “osserva” e “registra”;
- Il linguaggio, assolutamente medio e neutro, si fa interprete di ciò che viene rappresentato con la completa mancanza d’intervento del narratore.
Ma se Gli indifferenti moraviani si muovono su un terreno che supera da una parte il frammentarismo e la prosa d’arte allora imperante (come d’altra parte lo stesso Pirandello e Svevo, che subiscono la stessa accusa, cioè quella di “scrivere male”) non bisogna dimenticare che getta uno sguardo impietoso verso la borghesia, dando della stessa una visione assolutamente “negativa” di contro alla esigenza del regime fascista, che voleva dare di sé un’immagine di efficienza e di ottimismo verso un futuro radioso e portatore di successi.
INCIPIT
Entrò Carla; aveva indossato un vestitino di lanetta marrone con la gonna così corta, che bastò quel movimento di chiudere l’uscio per fargliela salire di un buon palmo sopra le pieghe lente che le facevano le calze intorno alle gambe; ma ella non se ne accorse e si avanzò con precauzione guardando misteriosamente davanti a sé, dinoccolata e malsicura; una sola lampada era accesa e illuminava le ginocchia di Leo seduto sul divano; un’oscurità grigia avvolgeva il resto del salotto.
«Mamma sta vestendosi», ella disse avvicinandosi «e verrà giù tra poco».
«L’aspetteremo insieme», disse l’uomo curvandosi in avanti; «vieni qui Carla, mettiti qui». Ma Carla non accettò questa offerta; in piedi presso il tavolino della lampada, cogli occhi rivolti verso quel cerchio di luce del paralume nel quale i gingilli e gli altri oggetti, a differenza dei loro compagni morti e inconsistenti sparsi nell’ombra del salotto, rivelavano tutti i loro colori e la loro solidità, ella provava col dito la testa mobile di una porcellana cinese: un asino molto carico sul quale tra due cesti sedeva una specie di Budda campagnolo, un contadino grasso dal ventre avvolto in un kimono a fiorami; la testa andava in su e in giù, e Carla, dagli occhi bassi, dalle guance illuminate, dalle labbra strette, pareva tutta assorta in questa occupazione.
«Resti a cena con noi?» ella domandò alfine senza alzare la testa.
«Sicuro», rispose Leo accendendo una sigaretta; «forse non mi vuoi?». Curvo, seduto sul divano, egli osservava la fanciulla con una attenzione avida; gambe dai polpacci storti, ventre piatto, una piccola valle di ombra fra i grossi seni, braccia e spalle fragili, e quella testa rotonda così pesante sul collo sottile.
«Eh che bella bambina»; egli si ripete «che bella bambina». La libidine sopita per quel pomeriggio si ridestava, il sangue gli saliva alle guance, dal desiderio avrebbe voluto gridare.
Ella diede ancora un colpo alla testa dell’asino: «Ti sei accorto quanto fosse nervosa mamma oggi al tè? Tutti ci guardavano».
«Affari suoi» disse Leo; si protese e senza parer di nulla, sollevò un lembo di quella gonna: «Sai che hai delle belle gambe, Carla?» disse volgendole una faccia stupida ed eccitata sulla quale non riusciva ad aprirsi un falso sorriso di giovialità; ma Carla , non arrossì né rispose e con un colpo secco abbatté la veste: «Mamma è gelosa di te» disse guardandolo; «per questo ci fa a tutti la vita impossibile».
Leo fece un gesto che significava: «E che ci posso fare io?»; poi si rovesciò daccapo sul divano e accavalciò le gambe.
«Fai come me» disse freddamente; «appena vedo che il temporale sta per scoppiare, non parlo più… Poi passa e tutto è finito».
«Per te, finito» ella disse a voce bassa e fu come se quelle parole dell’uomo avessero ridestato in lei una rabbia antica e cieca; «per te… ma per noi… per me» proruppe con labbra tremanti e occhi dilatati dall’ira, puntandosi un dito sul petto; «per me che ci vivo insieme non è finito nulla…». Un istante di silenzio. «Se tu sapessi», ella continuò con quella voce bassa a cui il risentimento marcava le parole e prestava un singolare accento come straniero, «quanto tutto questo sia opprimente e miserabile e gretto, e quale vita sia assistere tutti i giorni, tutti i giorni…». Da quell’ombra, laggiù, che riempiva l’altra metà del salotto, l’onda morta del rancore si mosse, scivolò contro il petto di Carla, disparve, nera e senza schiuma; ella restò cogli occhi spalancati, senza respiro, resa muta da questo passaggio di odio.
Si guardarono: «Diavolo» pensava Leo un po’ stupito da tanta violenza, «la cosa è seria». Si curvò, tese l’astuccio: «Una sigaretta» propose con simpatia; Carla accettò, accese e tra una nuvola di fumo gli si avvicinò ancora di un passo.
«E così» egli domandò guardandola dal basso in alto «proprio non ne puoi più?». La vide annuire un poco impacciata dal tono confidenziale che assumeva il dialogo. «E allora», soggiunse «sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia».
«È quello che finirò per fare» ella disse con una certa teatrale decisione; ma le pareva di recitare una parte falsa e ridicola; così, era quello l’uomo a cui questo pendio di esasperazione l’andava insensibilmente portando? Lo guardò: né meglio né peggio degli altri, anzi meglio senza alcun dubbio, ma con in più una certa sua fatalità che aveva aspettato dieci anni che ella si sviluppasse e maturasse per insidiarla ora, in quella sera, in quel salotto oscuro.
«Cambia», gli ripetè; «vieni a stare con me».
Ella scosse la testa: «Sei pazzo…».
«Ma sì!» Leo si protese, l’afferrò per la gonna: «Daremo il benservito a tua madre, la manderemo al diavolo, e tu avrai tutto quel che vorrai, Carla…»; tirava la gonna, l’occhio eccitato gli andava da quella faccia spaventata ed esitante a quel po’ di gamba nuda che s’intravedeva là, sopra la calza. «Portarmela a casa»; pensava «possederla…». Il respiro gli mancava: «Tutto quel che vorrai… vestiti, molti vestiti, viaggi…; viaggeremo insieme…; è un vero peccato che una bella bambina come te sia così sacrificata…: vieni a stare con me Carla…».
«Ma tutto questo è impossibile», ella disse tentando inutilmente di liberare la veste da quelle mani; «c’è mamma… è impossibile».
«Le daremo il benservito…» ripete Leo afferrandola questa volta per la vita; «la manderemo a quel paese, è ora che la finisca…; e tu verrai a stare con me, è vero? Verrai a stare con me che sono il tuo solo vero amico, il solo che ti capisca e sappia quel che vuoi». La strinse più davvicino nonostante i suoi gesti spaventati; «Essere a casa mia» pensava, e queste rapide idee erano come lucidi lampi nella tempesta della sua libidine: «Le farei vedere allora che cosa vuole». Alzò gli occhi verso quella faccia smarrita e provò un desiderio, per rassicurarla, di dirle una tenerezza qualsiasi: «Carla, amor mio…».
Ella fece di nuovo il vano gesto di respingerlo, ma ancor più fiaccamente di prima, ché ora la vinceva una specie di volontà rassegnata; perché rifiutare Leo? Questa virtù l’avrebbe rigettata in braccio alla noia e al meschino disgusto delle abitudini; e le pareva inoltre, per un gusto fatalistico di simmetrie morali, che questa avventura quasi familiare fosse il solo epilogo che la sua vita meritasse; dopo, tutto sarebbe stato nuovo; la vita e lei stessa; guardava quella faccia dell’uomo, là, tesa verso la sua: «Finirla», pensava «rovinare tutto…» e le girava la testa come a chi si prepara a gettarsi a capofitto nel vuoto.
Ma invece supplicò: «Lasciami», e tentò di nuovo di svincolarsi; pensava vagamente prima di respingere Leo e poi di cedergli, non sapeva perché, forse per avere il tempo di considerare tutto il rischio che affrontava, forse per un resto di civetteria; si dibattè invano; la sua voce sommessa, ansiosa e sfiduciata ripeteva in fretta la preghiera mutile: «Restiamo buoni amici Leo, vuoi? Buoni amici come prima» ma la veste tirata le discopriva le gambe, e c’era in tutto il suo atteggiamento renitente e in quei gesti che faceva per coprirsi e per difendersi, e in quelle voci che le strappavano le strette libertine dell’uomo, una vergogna, un rossore, un disonore che nessuna liberazione avrebbe potuto più abolire.
«Amicissimi» ripeteva Leo quasi con gioia, e torceva in pugno quella vesticciola di lana; «amicissimi Carla…». Stringeva i denti, tutti i suoi sensi si esaltavano alla vicinanza di quel corpo desiderato: «Ti ho alfine» pensava torcendosi tutto sul divano per fare un posto alla fanciulla, e già stava per piegare quella testa, là, sopra la lampada, quando dal fondo oscuro del salotto un tintinnìo della porta a vetri l’avverti che qualcheduno entrava.
Era la madre; la trasformazione che questa presenza portò nell’atteggiamento di Leo fu sorprendente: subito, egli si rovesciò sullo schienale del divano, accavalciò le gambe e guardò la fanciulla con indifferenza; anzi spinse la finzione fino al punto di dire col tono importante di chi conclude un discorso incominciato: «Credimi Carla, non c’è altro da fare».
La madre si avvicinò; non aveva cambiato il vestito ma si era pettinata e abbondantemente incipriata e dipinta; si avanzò, là, dalla porta, con quel suo passo malsicuro; e nell’ombra la faccia immobile dai tratti indecisi e dai colori vivaci pareva una maschera stupida e patetica.
«Vi ho fatto molto aspettare?» domandò. «Di che cosa stavate parlando?».
Leo additò con un largo gesto Carla diritta in piedi nel mezzo del salotto: «Stavo appunto dicendo a sua figlia che questa sera non c’è altro da fare che restare in casa».
«Proprio nient’altro»; approvò la madre con sussiego e autorità sedendosi in una poltrona, in faccia all’amante; «al cinema siamo già state oggi e nei teatri danno tutte cose che abbiamo già sentite… Non mi sarebbe dispiaciuto di andare a vedere “Sei personaggi” della compagnia di Pirandello…: ma francamente come si fa?… è una serata popolare».
«E poi le assicuro che non perde nulla» osservò Leo.
«Ah, questo poi no» protestò mollemente la madre: «Pirandello ha delle belle cose…: come si chiamava quella sua commedia che abbiamo sentito poco tempo fa?… Aspetti… ah si, “La maschera e il volto”: mi ci sono tanto divertita».
«Mah, sarà…» disse Leo rovesciandosi sopra il divano; «però io mi ci sono sempre annoiato a morte». Mise i pollici nel taschino del panciotto e guardò prima la madre e poi Carla.
Dritta dietro la poltrona della madre, la fanciulla ricevette quell’occhiata inespressiva e pesante come un urto che fece crollare in pezzi il suo stupore di vetro; allora, per la prima volta, si accorse quanto vecchia, abituale e angosciosa fosse la scena che aveva davanti agli occhi: la madre e l’amante seduti in atteggiamento di conversazione uno in faccia all’altra; quell’ombra, quella lampada, quelle facce immobili stupide, e lei stessa affabilmente appoggiata al dorso della poltrona per ascoltare e per parlare. «La vita non cambia», pensò non vuol cambiare. Avrebbe voluto gridare; abbassò le due mani e se le torse, là, contro il ventre, così forte che i polsi le si indolenzirono.

Rod Steiger e Claudia Cardinale nelle parti di Leo e Carlo nel film Gli indifferenti di Francesco Maselli del 1964
L’incipit del romanzo svela sin dall’inizio la sua forza dirompente sia a livello stilistico che contenutistico; il tema è certamente l’eros e se l’eros era stato già raccontato, seppur in modo certamente diverso da D’Annunzio (in modo estetizzante) e Svevo (in modo psicoanalitico), Moravia lo borghesizza e ne fa una merce di scambio. Leo, uomo di mezza età, è attratto sessualmente da Carla, figlia della sua amante, ormai invecchiata ed avvizzita e non più desiderabile, e per conquistarla le promette “Tutto quel che vorrai… vestiti, molti vestiti, viaggi…; viaggeremo insieme…”; cioè mettendo in atto un vero e proprio compromesso. Le parole che caratterizzano Leo ne danno un ritratto moralmente mortificante e sono libidine, eccitazione, voglia di possesso (“Ti ho, alfine“).
Ma quello che colpisce è il non netto “rifiuto”: sembra quasi che Carla sappia già di finire tra le braccia di Leo, sebbene tale scelta sia solamente dettata dalla stanchezza e dalla voglia di cambiare, anche se completamente confusa.

Paulette Goddard: Maria Grazia
Certo la terza interprete della scena, Mariagrazia, riceve dall’autore un ritratto impietoso si era pettinata e abbondantemente incipriata e dipinta; si avanzò, là, dalla porta, con quel suo passo malsicuro; e nell’ombra la faccia immobile dai tratti indecisi e dai colori vivaci pareva una maschera stupida e patetica: la sua descrizione sembra che renda “fisicamente” il decadimento della borghesia romana, essendo virata verso “il brutto” non come straniamento, ma come sottolineatura della bassezza culturale (confonde un’opera di Pirandello con una di Chiarini) e morale.
Simile, ma rovesciato, il rapporto tra Michele e Lisa, anche quest’ultima di una certa età rispetto al giovane Michele.
 Tomas Milian: Michele
Tomas Milian: Michele
Lisa vuole confidare a Michele che la madre ha un amante (ma Michele lo sa già):
LISA E MICHELE
Vide Lisa alzarsi e sedersi al suo fianco. «Via» ella disse posando una mano goffa e consolatrice sulla sua testa; «via… fatti coraggio… capisco che ci debba dispiacere… si vive con la certezza che una persona meriti il nostro affetto, la nostra stima, e poi ad un certo punto tutto crolla intorno a noi… ma non importa… questo ti sarà di ammaestramento…»
Egli scosse la testa, mordendosi le labbra per non ridere; Lisa credette invece che il dolore lo soverchiasse: «Non tutto il male viene per nuocere» disse con voce patetica e melata, senza cessare di passare quella sua mano sui capelli del ragazzo; «questo ci riavvicinerà… vuoi che io diventi per te quella che era prima tua madre… di’? Vuoi che io diventi la tua amica, la tua confidente?…» Era sincera ma la voce era così flautata e falsa che Michele avrebbe voluto tappare la bocca con la mano; ma stette fermo, con la testa ostinatamente curva; giacché si vedeva, seduto accanto a quella donna, sul bordo del divano, con una faccia tra contrita e idiota… la scena gli pareva tanto ridicola che per non ridere non c’era che un mezzo: non muoversi.
Lisa diventò ancor più zelante: «Verrai a farmi delle visite… parleremo… ci sforzeremo di ricostruire, di riorganizzare una nuova esistenza».
Egli la guardò di sottecchi… rossa, sotto la frangia dei capelli biondi, rossa ed eccitata: «Ah, è così che cominci a organizzare» pensò; si ricordò di quel parente che doveva venire nel mattino… e perché non prendere seriamente tutta la faccenda e giovarsene?… Perché non continuare negli infingimenti?…
Alzò la testa: «È stato duro» profferì come chi è riuscito a dominare un gran dolore; «ma hai ragione… bisogna che mi faccia una nuova esistenza…»
«Certamente» approvò Lisa con fervore; dopo di che seguì un profondo silenzio; ambedue con scopi diversi, fingevano una trasognata e ispirata distrazione; stavano immobili, l’uno accanto all’altra, e guardavano in terra.
Un fruscìo; il braccio di Michele scivolò dietro la schiena della donna e le circondò la vita. «No» ella disse con voce chiara, senza muoversi o voltarsi, come se avesse risposto a una domanda interiore; Michele sorrise di malavoglia, né sentiva un certo turbamento invaderlo, e la attiro più strettamente; «No, no» ella ripeté in tono più debole, ma cedette e appoggiò quella sua testa sperduta sulla spalla del ragazzo; allora dopo un istante di sentimentale immobilità egli la prese per il mento e nonostante la falsa mutua protesta degli occhi, la baciò sulla bocca.

Shelley Winters e Tomas Milian
Qui, Moravia rovescia il protagonista con l’idea del possesso erotico, facendolo incarnare da una donna non certo più giovane: Lisa. L’autore dà vita così ad una triplice lettura: una di tipo psicanalitico (sia Carla che Michele, accettando il rapporto con persone più grandi loro, cercano rispettivamente un padre – Carla non lo ha realmente, ed una madre), sociale (il mondo dei giovani contro quello dei vecchi), stilistico (un chiasmo che vede da una parte Leo e Carla, dall’altra Michele e Lisa).
Ma quello che qui emerge è il concetto di falsità: Lisa che “inventa” l’arrivo di un ospite; Michele che si finge “stupito ed esterrefatto”, dopo che gli è stata rivelata la relazione tra Merumeci e la madre (fatto di cui lui era già consapevole). Ma soprattutto il suo gesto di abbracciare Lisa che finge ritrosia, per poi “starci”, è frutto di noia, più che di attrazione.

IL MOTIVO ECONOMICO E L’INDIFFERENZA DI MICHELE E CARLA
Per un istante non parlarono; Leo fumava con compunzione, la madre considerava con una mesta dignità le sue mani dalle unghie smaltate, Carla quasi carponi tentava di accendere la lampada nell’angolo e Michele guardava Leo; poi la lampada si accese, Carla sedette e Michele parlò: «Sono stato dall’amministratore di Leo e mi ha fatto un monte di chiacchiere… Il sugo della faccenda e poi questo: che a quel che pare tra una settimana scade l’ipoteca e perciò bisognerà andarsene e vendere la villa per pagare Merumeci…»
La madre spalancò gli occhi: «Quell’uomo non sa quel che dice… Ha agito di testa sua… l’ho sempre detto io che aveva qualche cosa contro di noi…».
Silenzio: «Quell’uomo ha detto la verità» disse alfine Leo senza alzare gli occhi.
Tutti lo guardarono. «Ma vediamo, Merumeci», supplicò la madre giungendo le mani; «non vorrà mica mandarci via così sui due piedi?… ci conceda una proroga…»
«Ne ho già concesse due», disse Leo «basta… tanto più che non servirebbe ad evitare la vendita…»
«Come a non evitare?» domandò la madre.
Leo alzò finalmente gli occhi e la guardò: «Mi spiego: a meno che non riusciate a mettere insieme ottocentomila lire, non vedo come potreste pagare se non vendendo la villa…»
La madre capì, una paura vasta le si aprì davanti agli occhi come una voragine; impallidì, guardò l’amante; ma Leo tutto assorto nella contemplazione del suo sigaro non la rassicurò: «Questo significa» disse Carla «che dovremo lasciare la villa e andare ad abitare in un appartamento di poche stanze?»
«Già», rispose Michele «proprio così».
Silenzio; la paura della madre ingigantiva; non aveva mai voluto sapere di poveri e neppure conoscerli di nome, non aveva mai voluto ammettere l’esistenza di gente dal lavoro faticoso e dalla vita squallida. «Vivono meglio di noi» aveva sempre detto; «noi abbiamo maggiore sensibilità e più grande intelligenza e perciò soffriamo più di loro…»; ed ora, ecco, improvvisamente, ella era costretta a mescolarsi, a ingrossare la turba dei miserabili; quello stesso senso di ripugnanza, di umiliazione, di paura che aveva provato passando un giorno in un’automobile assai bassa attraverso una folla minacciosa e lurida di scioperanti, l’opprimeva; non l’atterrivano i disagi e le privazioni a cui andava incontro, ma invece il bruciore, il pensiero di come l’avrebbero trattata, di quel che avrebbero detto le persone di sua conoscenza, tutta gente ricca, stimata ed elegante; ella si vedeva, ecco… povera, sola, con quei due figli, senza amicizie ché tutti l’avrebbero abbandonata, senza divertimenti, balli, lumi, feste, conversazioni: oscurità completa, ignuda oscurità.
Il suo pallore aumentava: “Bisognerebbe che gli parlassi da sola a solo”, pensava attaccandosi all’idea della seduzione; “senza Michele e senza Carla… allora capirebbe”.
Guardò l’amante. «Lei, Merumeci», propose vagamente «ci conceda ancora una proroga, e noi il denaro lo si troverà in qualche modo».
«In che modo?» Domandò l’uomo con un mezzo sorriso ironico.
«Le banche…» arrischiò la madre.
Leo rise: «Oh, le banche». Si chinò e fissò in volto l’amante: «Le banche» sillabò «non prestano denaro che contro sicure garanzie e ora poi con questa penuria di quattrini che c’è in giro non ne prestano affatto; ma mettiamo che ne prestassero… che specie di garanzia potrebbe lei dare, cara signora?»
«Il ragionamento non fa una grinza» osservò Michele; avrebbe voluto appassionarsi a questa loro questione vitale, protestare: “Vediamo” pensava “si tratta della nostra esistenza… potremmo da un momento all’altro non avere di che vivere materialmente” ma per quanti sforzi facesse questa rovina gli restava estranea; era come vedere qualcuno affogare, guardare e non muovere un dito.
Tutt’altra era invece la madre: «Lei ci dia questa proroga», ella disse con fierezza, ergendosi sul busto e staccando le parole; «e può star sicuro che alla data della scadenza lei avrà i suoi quattrini, non ne dubiti, fino all’ultimo centesimo».
Leo rise dolcemente chinando la testa: «Ne sono certo… ma allora a che serve la proroga?… Quei mezzi che lei adopererà tra un anno per ottenere denari perché non usarli ora e così pagarmi subito?»
Quella faccia china era così calma e sagace che la madre ne ebbe timore; da Leo i suoi occhi irresoluti passarono a Michele, poi a Carla: eccoli là i suoi due figli deboli che avrebbero provato le angustie della povertà; le venne un esaltato amor materno: «Senta Merumeci», incominciò con voce persuasiva «lei è un amico di famiglia, a lei posso dir tutto… Non si tratta di me, non è per me che chiedo questa proroga, io sarei anche pronta ad andare a vivere in una soffitta… ». Alzò gli occhi al cielo e: «Dio sa se penso a me… ma io ho Carla da maritare… ora lei conosce il mondo… il giorno stesso che io lasciassi la villa e andassi a vivere in qualche appartamentino, tutti ci volterebbero le spalle… la gente è fatta così… e allora me lo saluta lei il matrimonio di mia figlia?»
«Sua figlia» disse Leo con una falsa serietà, «ha una bellezza che troverà sempre pretendenti». Guardò Carla e le ammiccò; ma una rabbia trattenuta e profonda possedeva la fanciulla: «Chi vuoi che mi sposi» avrebbe voluto gridare alla madre «con questo uomo per casa e te in quelle condizioni?». L’offendeva, l’umiliana la disinvoltura con la quale la madre, che abitualmente non si curava affatto di lei, la tirava in ballo come un argomento favorevole ai suoi scopi; bisognava finirla, ella si sarebbe data a Leo, è così nessuno più l’avrebbe desiderata per moglie; guardò la madre negli occhi: «Non pensare a me, mamma» disse con fermezza; «io non c’entro né ci voglio entrare in tutto questo».
Fu in quel momento che è una risata agra, falsa da allegare i denti partì dall’angolo dove sedeva Michele; la madre si voltò: «Ma sai», egli le disse tentando con uno sforzo di dare alla sua voce indifferente un’intonazione sarcastica; «chi sarà il primo ad abbandonarci se lasciamo la villa? Indovina».
«Mah, non so».
«Leo» egli proruppe additando l’uomo, «il nostro Leo».
Leo ebbe un gesto di protesta. «Ah, Merumeci?» ripeté la madre incerta e impressionata guardando l’amante come se avesse voluto leggergli in faccia se fosse stato capace di un simile tradimento; poi ad un tratto, con occhi e sorriso infiammati di patetico sarcasmo: «Ma già… sicuro… e io stupida che non ci pensavo… sicuro Carla» soggiunse rivolgendosi alla figlia; «Michele ha ragione… il primo che fingerà di non averci mai conosciuto, dopo naturalmente che avrà intascato i quattrini, sarà Merumeci… non protesti» ella continuò con un sorriso ingiurioso; «non è colpa sua, tutti gli uomini sono così… potrei giurarlo, passerà da una di quelle sue amiche tanto simpatiche e tanto eleganti e appena mi vedrà… volterà la testa dall’altra parte… sicuro… caro lei… ci metterei la mano sul fuoco…». Tacque per un istante. «E già», concluse con amarezza e rassegnazione; «già… anche Cristo è stato tradito dai suoi migliori amici».
E’ il brano in cui la dinamica dei personaggi appare in tutta la sua evidenza:
- Michele, svelando il fine di Leo d’impossessarsi della villa di famiglia, osserva il tutto come non lo riguardi (Moravia usa la metafora dell’uomo che sta per affogare, senza riuscire ad intervenire per salvarlo);
- Carla “protesta” perché sente che la sua estraneità sta per essere infranta;
- Leo, l’unico che sa quello che vuole;
- Maria Grazia, ormai macchietta che, fingendo di preoccuparsi dei figli, paventa il suo abbassamento sociale.
Al solito Moravia inserisce tale scena all’interno di una situazione “topica” dell’intero romanzo, quello della cena; è forse il momento maggiormente teatrale in cui i rapporti si svelano nella loro integrità, mettendo in luce da una parte l’inazione dei personaggi giovanili, dall’altra l’egoismo dei personaggi maturi. E’ che dietro tale evidenza rappresentativa si erge il moralismo moraviano che non risparmia nessuno, come vedremo nel proseguo dell’azione. Infatti all’epiteto “mascalzone” che Michele rivolge a Leo (la massima forma di protesta), alle “pretese” di quest’ultimo di scuse, il giovane piegherà la testa, soprattutto per volere della madre, che temeva di perdere l’amante.
Il fatto che il giovane Moravia voglia riprendere l’idea di romanzo, come rappresentazione del reale di contro alle spinte “destrutturanti” dei rondisti e frammentisti, lo possiamo notare quando, in modo palese, cita l’inventore di tale genere letterario in Italia, Manzoni:
L’ADDIO DI CARLA
Addio strade, quartiere deserto percorso dalla pioggia come da un esercito, ville addormentate nei loro giardini umidi, lungo viali alberati, e parchi in tumulto; addio quartiere alto e ricco: immobile al suo posto a fianco di Leo, Carla guardava con istupore la pioggia violenta lacrimare sul parabrise e in questi fiotti intermittenti colar disciolte sul vetro tutte le luci della città, girandole e fanali. Le strade si seguivano alle strade; ella le vedeva piegare, confluire una nell’altra, girare laggiù oltre il cofano mobile dell’automobile; a intervalli, tra i sobbalzi della corsa, delle nere facciate si staccavano nella notte, passavano, e si dileguavano come fianchi di transatlantici in rotta, non senza difficoltà, attraverso i marosi; gruppi neri di persone, porte illuminate, lampioni, alberi, ogni cosa si affacciava per un istante nella corsa e poi scompariva inghiottita definitivamente dall’oscurità.
L’incipit del brano è decisamente manzoniano, ma poi lo piega descrivendo un notturno piovoso, con luci artificiali date dai fanali delle macchine, con gruppi di persone nere, e tutto che viene inghiottito nell’oscurità: sembra quasi una discesa di Carla verso il grigiore di una vita senza prospettive. Come avviene quando si dà a Leo:

Claudia Cardinale
LEO E CARLA
A poco a poco il suo corpo ardente riscaldava le lenzuola. Ad un tratto ebbe l’impressione che questo tepore avesse sciolto quel nodo di paura e di stupore che fino allora le aveva ingombrato l’anima; si sentì sola, provò una gran tenerezza, una pietà indulgente per se stessa, si sforzò di raccogliersi, di raggomitolarsi più che poteva, fino a toccare con le labbra le sue ginocchia rotonde. L’odore sano e sensuale che emanavano la commosse; le baciò più volte appassionatamente: “Povera… poverina” si ripeteva carezzandosi. Gli occhi gli si empirono di lacrime; avrebbe voluto piegar la testa sul suo petto fondo e piangervi come su quello di una madre; poi senza cessare di fissare con gli occhi attenti quella parete appena illuminata dalla lampada, ascoltò: i rumori che le arrivavano erano familiari e rivelavano irreparabilmente il luogo dove stava; la pioggia cadeva ancora; se ne udiva il fruscìo; qualcheduno camminava nel bagno; dell’acqua scorreva; se si muoveva, il letto mollemente sprofondava, con un suono sordo, e in un certo modo lontano; non sapeva se per qualche ricordo o per l’estrema cedevolezza delle piume. Non era il letto di casa sua, duro e stretto, né uno di quei letti stranieri nei quali ci si caccia dopo un lungo viaggio, e ci par subito di stare troppo in basso o troppo in alto, e ci si dorme senza soddisfazione; no, questo era un letto comodo, tenerissimo, pieno di attenzioni e premure; soltanto il corpo ne aveva paura, vi si rannicchiava tutto, vi tremava, e ogni tanto tendeva una mano a tastare lo spazio immenso e freddo che avanzava dietro, quella Siberia di tela, disabitata e ostile; era una sensazione sgradevole: come camminare per una strada buia sapendo di avere qualcuno alle spalle.
Se mai dovessimo ricercare le parole chiave e se cercassimo i campi semantici che rimandano ad una sfera positiva e quelli negativa, vedremo senza difficoltà che questi ultimi sarebbero di più. Carla, in questa focalizzazione interna, pur se ebbe l’impressione che questo tepore avesse sciolto quel nodo di paura e di stupore; alla fine “Povera… poverina” si ripeteva carezzandosi. Gli occhi gli si empirono di lacrime; avrebbe voluto piegar la testa sul suo petto fondo e piangervi come su quello di una madre; e se inoltre questo era un letto comodo, tenerissimo, pieno di attenzioni e premure; invece il corpo ne aveva paura, vi si rannicchiava tutto, vi tremava, e ogni tanto tendeva una mano a tastare lo spazio immenso e freddo che avanzava dietro, quella Siberia di tela, disabitata e ostile; era una sensazione sgradevole: come camminare per una strada buia sapendo di avere qualcuno alle spalle.

E’ la prima notte d’amore e Moravia è straordinario nel raccontarci le aspettative e le paure di Carla. Ma il lettore conosce già la ragazza, sa che per lei Leo potrebbe rappresentare un qualcosa che la farebbe uscire dalla “gabbia di falsità” in cui è rinchiusa, ma sa anche che Leo di quel mondo è uno dei maggiori rappresentanti: il suo tentativo di fuga è sin dall’inizio un fallimento ed è efficace il termine Siberia di tela con cui l’autore lo definisce.
“E SE IO L’UCCIDESSI?”
Non suonò; voleva entrare col respiro tranquillo ed era ansante; aspettò dritto, immobile, davanti quella porta chiusa, che l’ansito e i battiti del cuore si fossero calmati; ma non si calmavano; il cuore pulsava, saltava con fracasso nel suo petto, i polmoni gli si sollevavano contro volontà in un respiro doloroso. “O cuore, o respiro” pensò con un dispetto triste e nervoso, “anche voi vi mettete contro di me?” Premette con una mano il fianco, tentò di dominarsi; quanto tempo sarebbe stato necessario perché il suo corpo fosse stato pronto come la sua anima? Contò da uno a sessanta, ridicolmente, immobile contro quella porta silenziosa; Ricominciò… finalmente, stanco, s’interruppe e suonò.
Udì il campanello echeggiare nell’appartamento vuoto; silenzio; immobilità: “non è in casa” pensò con una gioia e un sollievo profondo. “Suonerò ancora una volta per iscrupolo… e poi me ne andrò” e già, apprestandosi a premere di nuovo il bottone, già immaginava di ridiscendere nella strada, andarsene per la città, libero, distrarsi; già dimenticava i suoi propositi di vendetta, quando dei passi pesanti risuonarono sul pavimento, di là dalla porta; poi questa si aprì e Leo apparve.
Indossava una veste da camera, aveva la testa arruffata e il petto nudo; squadrò dall’alto in basso il ragazzo.
«Tu qui» esclamò con faccia e voce assonnata senza invitarlo ad entrare; «e cosa vuoi?»
Si guardarono: “Cosa voglio?” avrebbe voluto gridare Michele; “lo sai bene, spudorato, cosa voglio”. Ma si trattenne:
«Nulla» disse in un soffio, ché ora il respiro di nuovo gli mancava; «soltanto parlarti.»
Leo alzo gli occhi; un’espressione impudente e stupida gli passò sul volto: «Oh bella, parlare? A me? A quest’ora?» disse con stupore esagerato; si teneva sempre nel bel mezzo della soglia: «E cosa vuoi dirmi?… Senti, senti caro» soggiunse cominciando a chiudere la porta, «non sarebbe meglio un altro giorno? Stavo dormendo, non ho la testa abbastanza chiara… per esempio domani».
La porta si chiudeva. “Non è vero che stavi dormendo” pensò Michele, e ad un tratto scaturì quest’idea: “Carla è di là… in camera sua”, e gli parve di vederla nuda, seduta sul bordo del letto, in atto di ascoltare ansiosamente questo dialogo tra l’amante e lo sconosciuto visitatore; diede una spinta alla porta ed entrò:
«No» disse con voce ferma e turbata, «no, oggi stesso ho da parlarti… ora».
Un’esitazione: «E sia» profferì l’altro come chi è al termine della sua pazienza; Michele entrò: “Carla è di là” pensava e un turbamento straordinario lo possedeva.
«Di’ la verità» profferì alfine con isforzo mentre quello chiudeva la porta, posandogli una mano sulla spalla; «di’ la verità, che ho turbato qualche dolce colloquio… c’è qualcheduno di là, non è vero?… eh, eh!… qualche bella ragazza…». Vide l’uomo voltarsi e schermirsi con un sorriso odioso di malcelata vanità: «Assolutamente nessuno… dormivo». Capì di aver colto nel segno.
Mise la mano in tasca e strinse la rivoltella; «Dormivo proprio” ripeté Leo senza voltarsi, precedendolo nell’anticamera; «dormivo tranquillamente e facevo sogni bellissimi».
«Ah! sì?»
«Sì… e tu sei venuto a destrami».
“No, colpirlo alle spalle no” pensò Michele; trasse di tasca la rivoltella e tenendo la mano contro il fianco la puntò nella direzione di Leo… appena questi si sarebbero voltato, avrebbe sparato.
Leo entrò per primo nel salotto, andò alla tavola, accese una sigaretta; avvolto nella veste da camera, come un lottatore, a gambe larghe, con la testa arruffata e tozza, china verso l’invisibile fiammifero, egli dava l’impressione di un uomo sicuro di sé e della sua vita; poi si voltò; allora, non senza odio, Michele alzò la mano e sparò.
Non ci fu né fumo né fracasso; alla vista della rivoltella Leo spaventatissimo si era gettato con una specie di muggito dietro una sedia: “S’è inceppata” pensò il ragazzo; vide Leo urlare: «Sei matto!» e alzare una sedia in aria mostrando tutto il corpo; si protese in avanti e sparò daccapo; nuovo rumore del grilletto. “E’ scarica”, comprese alfine atterrito, “e le palle l’ho in tasca io”. Fece un salto da parte, per evitare la seggiola di Leo, corse all’angolo opposto; la testa gli girava, aveva la gola secca, il cuore in tumulto: “Una palla”, pensò disperatamente, “soltanto una palla”. Frugò, arraffò con le dita febbrili alcuni proiettili, alzò la testa, tenendo, curvo, cole mani impazzate, di aprire il tamburo e cacciavi la carica; ma Leo scorse il suo gesto ed egli ricevette di sbieco un colpo di seggiola sulle mani e sulle ginocchia, così forte che la rivoltella cadde in terra; dal dolore chiuse gli occhi, poi una rabbia indicibile lo invase; si gettò su Leo tentando di stringerlo al collo; ma fu preso, scagliato prima a destra poi a sinistra, e alfine respinto con tanta violenza che dopo aver ciecamente urtato e rovesciato una sedia, cadde sul divano… L’altro gli fu subito sopra e lo prese per i polsi.
Silenzio; e si guardarono; rosso, ansante, costretto in malo modo dentro il divano, Michele fece uno sforzo per liberarsi; Leo gli rispose torcendogli i polsi; altro sforzo; altra torsione; alfine il dolore e la rabbia vinsero il ragazzo: gli parve oscuramente che la vita non fosse mai stata così aspra come in questo momento nel quale, così brutalmente oppresso, gli tornava un lamentoso desiderio di certe lontanissime carezze materne; gli occhi gli si empirono di lacrime; allentò i muscoli doloranti, si abbandonò. Per un istante l’uomo lo guardò: la veste da camera era aperta, il petto nudo e peloso gli si sollevava in un respiro che ogni tanto si sfogava per le narici frementi in una specie di soffio fermo: guardava, guardava e tutta la sua persona esprimeva un minaccioso furore a stento trattenuto.

Ma allora perché il romanzo ebbe un così vasto successo?
Perché soprattutto si muoveva su un binomio che poteva “solleticare” la curiosità del lettore: il binomio denaro e sesso. Leo infatti, pur nella sua grettezza, rappresenta la voglia del potere ottenuto attraverso l’accumulo di denaro e il possesso sessuale del corpo femminile: non è un caso se lui stesso si fa amante prima di Lisa, quindi di Maria Grazia e infine di sua figlia, Carla (cioè di tutte le figure femminili del romanzo), e come tutto questo sia frutto di un calcolo che gli permette di ottenere risultati positivi per tutti i suoi obiettivi: sia quello meramente sessuale (Lisa), che quello sessuale/economico (Maria Grazia e la sua villa) quindi, per paura che quest’ultima gli venga alienata da una vendita che lo terrebbe fuori gioco, Carla, figlia della padrona che, sposandola, gli permetterà di avere un’amante/sposa di circa metà dei suoi anni ed il possesso della villa.
Il successo non solo gli permette di affermarsi nell’ambiente letterario scrivendo racconti per 900 di Bontempelli e Pegaso di Ojetti. Ma inizia anche la sua collaborazione con articoli di viaggio su La Stampa, allora diretto da Curzio Malaparte. Soggiorna piuttosto a lungo a Parigi e a Londra, entrando in contatto con intellettuali quali Forgue e Valery.
In questo periodo i suoi rapporti con il Fascismo peggiorano. Incontra nel ’36 Elsa Morante, che sposerà nel 1941.

Il secondo romanzo di Moravia, pubblicato nel 1935, costò all’autore sei anni di lavoro, ma non ebbe alcun successo. Le ambizioni sbagliate, questo il titolo, venne ignorato per due ragioni: la prima, forse la meno incidente, è che, come già allora si disse, Moravia riscrisse Gli indifferenti moltiplicandone i protagonisti; l’altra, certamente più forte, è che venne dall’ “alto” l’obbligo, da parte del potere fascista, di non recensire né fare alcun riferimento all’opera del giovane autore.
I protagonisti sono Pietro e Andreina, due giovani animati da ambizioni tipicamente borghesi di notorietà e di ricchezza che si muovono nel mondo ovattato e futile della borghesia romana, testimoniata dalla vacuità civettuola della ricca Maria Luisa, dalla devozione calcolata del nobile Matteo, dall’inclinazione al chiacchiericcio di Sofia e, nonostante l’apparenza disinteressata, dal cinismo freddo e vendicativo di Stefano. Sebbene lo sguardo dell’autore scruti nell’animo di ogni personaggio, ricorrendo a un’unica tecnica per rivelarne intenti, pensieri e vissuti esistenziali, egli riserva un’attenzione particolare alle mosse e ai moventi della coppia suesposta: a differenza dei personaggi che gravitano attorno a essi, i quali non fanno che riproporre in maniera ricorsiva attitudini radicate senza possibilità di crescita o di mutamento, Pietro e Andreina agiscono in una trama volutamente macchinosa che procede grazie alla loro volontà di elevarsi dalla mediocrità in cui riversano: chi da un punto di vista economico, chi da un punto di vista spirituale.
Scrisse un critico dell’epoca: «Nel romanzo delle Ambizioni sbagliate abbiamo un esacerbato rincrudimento nel dirizzone ormai preso. Il Moravia non intende in nessun caso a piegarsi a un senso di più umana visione della vita. Fa quasi pensare a un ragazzo testardo, che un rimprovero per qualche birbonata, prende occasione d’impuntarsi e combinarne uno peggiore. Il branco d’attori, che nel primo romanzo erano chiamati “indifferenti”, ricompare qui sotto il nome di “ambiziosi” che falliscono. Ma, in fondo, sono gli stessi, per l’identità delle passioni e degli istinti che li portano ad agire. Lì si giocava su una trama piuttosto triangolare, qui invece la trama si allarga e raggiunge quasi l’aspetto di un labirinto». (D. Mondrone, Civiltà cattolica, 1938).
Non siamo completamente d’accordo con il critico cattolico; forse a rendere simili Michele e Pietro sono lo scontrarsi con una realtà sulla quale non riescono ad incidere; ma se il primo non può che sottolineare l’indifferenza verso ogni forma di realtà, il secondo cerca di cambiarla: il suo tentativo di educare Andreina (protagonista femminile) ricorda più il tentativo di Emilio Brentani verso Angiolina (in Senilità di Svevo) che uno dei cinque attori del primo romanzo moraviano. Se difetto c’è in quest’opera è che appare troppo “strutturata”, per meglio dire l’architettura romanzesca non appare nascosta come nel primo; infatti ogni personaggio, pur descritto con verità psicologica, sembra apparire per dar luce ad un meccanismo che preesiste alla narrazione stessa.
Ciò non toglie che la storia possieda una forza grazie alla capacità moraviana di descrivere i personaggi. Fra questi emerge quello di Andreina, potente figura femminile:
ANDREINA
Entrarono. Pietro si era appena disfatto del pastrano che la tenda del corridoio si sollevò e Cecilia apparve con le labbra atteggiate al suo solito sorriso lezioso. «Stasera abbiamo questo signore a cena», disse Andreina «e nel caso venisse o telefonasse il marchese Matteo rispondi pure che non sono in casa».
Passarono nel salotto. «Ecco, mi aspetti qui,» disse Andreina girando gli occhi intorno e togliendosi di testa il cappello. «Io vado a svestirmi. E poi si andrà subito a cena. Gli sorrise e passandosi una mano sui capelli scomposti uscì dalla stanza.
Senza fretta andrò dritta in fondo al corridoio alla sua camera, e, chiusa la porta, sedette sul letto. Per un poco, con le mani in grembo, come attonita, guardò davanti a sé. Si sentiva triste e torbidamente scoraggiata, l’aver sperato anche un solo istante al matrimonio con Matteo le ispirava adesso odio e disprezzo verso se stessa e nello stesso tempo non sapeva che ilarità amara e nervosa come per una pretesa insensata che non avrebbe potuto non sortire questi risultati. Alzò poi gli occhi, vide sul comodino il ritratto dell’amante, e per un momento le venne un rabbioso desiderio di sbatacchiarlo in terra. «Imbecille,» pensava, «che credi all’amore e non hai un soldo, imbecille miserabile e bugiardo.» Ma, comprendendo l’inutilità di questo atto violento, si trattenne e, chinandosi alquanto, girò con una mano il ritratto e prese a guardarlo fissamente, non sapeva neppure lei se con più odio o con più ripugnanza. Lo guardava attonita, con la bocca semiaperta e gli occhi sbarrati e vuoti come pensando ad altro; ad un tratto la mano le scivolò dal comodino sopra il letto, ed essa vi si lasciò cadere distesa, con la faccia contro il guanciale. Stette così per qualche minuto con gli occhi e la mente pieni di una oscurità nera e arida. Quel che veramente provasse non avrebbe saputo dirlo nemmeno lei, le pareva di soffrire in un modo anche più intollerabile del solito, forse perché cadute tutte le illusioni, svanite le speranze, venuti meno i desideri, mancavano appunto ragioni concrete e limitate di sofferenza. Agli impulsi dell’animo, alle tristezze e alle rabbie fra le quali si era fino allora dibattuta, pareva che si fosse sostituito per sempre un furioso e preciso senso di vuoto che accompagnava ogni suo pensiero e dovunque si rivolgesse faceva il deserto. «E’ segno,» pensava, «che ho toccato il fondo,» e ricordava, infatti, non senza una sorpresa impaurita, di non essere mai stata tanto disperata. Contro Matteo, Sofia, Maria Luisa e tutti gli altri provava un odio contorto e caparbio, privo di quelle giustificazioni che spira il senso offeso della giustizia, l’odio di chi senta di aver torto, e in fondo non desideri neppure di aver ragione. Le sembrava che questa gente avesse tutte le ragioni di disprezzarla e di calpestarla e nello stesso tempo essa non fosse meno giustificata a odiarli e a morderli. «Basta con le speranze,» pensava rabbiosamente, «basta con i buoni sentimenti: io non sono fatta per questo.» In verità, in tanto disastro, niente ormai l’attraeva all’infuori di una vendetta lenta e pericolosa, la quale, pur essendo rivolta contro gli altri, avrebbe dovuto colpire anche lei stessa. «Rovinarli… e insieme con loro rovinare anche me. E che non ci siano più speranze. E’ che tutto sia buio,» pensava in fretta muovendo le labbra come per una preghiera: e provava quello stesso senso d’angoscia e di tesa volontà che alcuni mesi addietro al mare l’aveva afferrata quando tuffandosi aveva sentito lo spessore dell’acqua opporsi ai suoi tentativi di toccare il fondo. Questa volta il fondo era quella specie di distruzione compiaciuta e vendicativa, per la quale sentiva un’attrazione forte e in un certo modo sensuale e capiva con un impaziente disappunto che non meno della grande altezza della gioia, l’estremo grado della tristezza distruttiva doveva essere oltremodo difficile a raggiungersi.

Fotogramma de Le ambizioni sbagliate, film Tv del 1983
Ritratto mirabile che disegna la protagonista come un demone dostoevskiano, mosso da una duplice forza: da una parte quella sociale (lei povera figlia di un professore ginnasiale, da cui l’amore di Matteo dovrebbe strapparla) dall’altra quella individuale che vuole e ambisce (appunto l’ambizione del titolo) far cadere nel gorgo infernale tutti coloro che le sono intorno nonché se stessa.
«E’ ovvio che Moravia stesso ne sia fiero: Andreina ha qualcosa del demone, ha l’“odio di chi si senta di aver torto, e in fondo non desideri neppure di aver ragione”. L’impianto dostoevskiano la fa essere inabile e vendicativa come gli altri: la rende, cioè, paritaria. Ma il suo demonio le dà anche il modo per sentire, con impressionante lucidità, il cortocircuito tra indigenza e caso, l’incrocio tra le contingenze e la vacuità. Moravia ce la presenta con una consapevolezza di miseria. La vediamo per un attimo sul letto: Una calza tesa e agganciata alla giarrettiera, sopra le trine molli della camicia, l’altra pendeva sul polpaccio lenta e arrotolata. Accanto c’è il mogano scuro, volgare e lucido dell’armadio; lo spazio si allunga in un imbuto, la banalità dell’ordinario frigge dentro una infelicità nera e senza speranza. (…) Eccola: gli occhi smorti e trasognati della donna parevano dire: «sono stanca di vivere», gli angoli delle sue labbra tremavano impercettibilmente, la luce vacillante delle candele prestava a tutta la faccia una fissità disperata e arida, ma bastava che Andreina stendesse un braccio per versarsi il vino, perché il suo grande corpo, come ridestato, palpitasse e fremesse, e il petto, malcontenuto dalla scarsa scollatura, si gonfiasse nudo e pieno di un respiro possente che pareva significare: «mi piace vivere, sono contente di vivere, sono giovane e voglio vivere” (Colasanti) e percepiamo la sua forza fatta di riscatto sociale, ma anche il suo abbandono, dovuto al desiderio frustrato, in cui s’infila per poi scomparire del tutto.
Dietro la sua “amoralità” come la definisce Pietro, non c’è niente che la possa salvare, ma come lei non si salva nessuno: Maria Grazia con la sua immobile arroganza, che l’accompagnerà per l’intero romanzo e che pagherà a caro prezzo; Pietro, che s’innamorerà perdutamente di lei, ma la perderà, perché non è stato in grado di “somigliarle” abbastanza; la sua fidanzata Sofia, pettegola e stupida, sorella del marchese Matteo, amante di Andreina, da cui la stessa è mantenuta; il malato Stefano, personaggio simile e nello stesso contrario ad Andreina, molle ma forte, pieno di anche lui di rabbia, rancore, ed anche passione calcolata; e poi tra gli altri l’adolescente Carlino, che viene iniziato ed usato dall’amore, e che non è in grado ancora di comprendere (l’unico in grado di suscitare un moto di tenerezza e simpatia).
Il libro, pubblicato da Mondadori, come già detto, non ebbe successo. Il clima intorno a lui si faceva piuttosto teso: controllo su ciò che scriveva, mancanza di libertà, soprattutto per un intellettuale come lui: per questo accettò l’invito di Prezzolini di recarsi negli Stati Uniti (dove tenne una conferenza sul romanzo italiano) e di proseguire il suo viaggio americano in Messico.
Tornato in Italia, nel 1937 pubblica L’imbroglio, testo che racchiude cinque romanzi brevi: La provinciale, L’avaro, L’architetto, L’imbroglio, La tempesta. Rifiutato da Mondadori, troverà accoglienza presso Bompiani, che da questa opera in poi sarà per sempre la sua casa editrice.
La provinciale, ambientata in una anonima città di provincia del centro Italia, narra la storia di Gemma Forese, ragazza di umili origini, che ogni estate la trascorre in una villa fuori città, ospite di un conte. Qui farà amicizia con le figlie del conte, ma attirerà l’attenzione del figlio maschio, Paolo, con il quale nascerà un vero e proprio rapporto d’amore che sarebbe sfociato in un matrimonio se non ci fosse stato l’intervento del conte. Tale intervento sarà motivato per la ragazza da un rifiuto d’ordine sociale, ma in realtà dal fatto che lui è il fratello di Gemma. Allora la ragazza accetta la proposta che un anonimo professore di fisica, pensionante della casa della mamma di Gemma, le aveva offerto. Interviene a questo punto del racconto una sedicente nobildonna bulgara, che dapprima incensa la delusione quindi la spinge a metterla in atto tradendo il marito e dandosi ad un amico. Questa donna metterà talmente soggezione a Gemma quasi a soffocarla, facendosi ospitare e diventando per la ragazza una specie di autorità; ma quando questa rimarrà incinta è come se prendesse consapevolezza di sé e si ribellerà, allontanandosi dalla città di provincia per andare a Roma dove il marito ha ottenuto una cattedra universitaria.
GEMMA
Gemma non era graziosa, anzi sfiorava la bruttezza, ma aveva quei lineamenti nobili e pronunziati che rivelavano un’origine non volgare; e a momenti sembrano comporsi in una specie di altera bellezza. Era alta, snella, ossuta, con lunghe e magre cosce eleganti, larga nel petto sfornito e nelle spalle: Il viso era smunto e pallido fuorché sugli zigomi sempre un po’ rossi; gli occhi grandi e lenti nel muoversi, con palpebre sporgenti che velavano la pupilla e davano agli sguardi un’aria di dignità squallida e sprezzante. Aveva il naso aquilino, la bocca grande e sdegnosa e, sotto capelli crespi, la carnagione delicata e malsana, ora diafana ora chiazzata di macchie di rossore. Certa peluria, che le adombrava le braccia e la nuca, faceva pensare ad un corpo villoso e infuocato pur nella sua sgraziata magrezza. Della madre aveva poco, salvo il naso che anche nelle Foresi era aquilino; del padre nulla, almeno a stare alle fotografie appese in casa dove appariva basso, tarchiato e bonario: era stato commerciante, era fallito e subito dopo era morto lasciando la moglie povera con la figlia ancora piccola. Comunque, così ossuta, pallida ed elegante, Gemma non aveva nulla di provinciale né di casalingo. Al contrario, veniva fatto di pensare, vedendola, a quelle donne anemiche e mondane, cittadine per vocazione, le quali passano le giornate distese languidamente sopra un divano e non escono che alla sera, vestite sempre di abiti da ricevimento, vere creature notturne, effimere e senza salute. Ma di tutte le apparenze, questa era certo la più ingannevole, perché Gemma non indossava mai altro che certi semplici vestiti scuri che cercava di stringere alla cintola per dare risalto alla snellezza del busto. E quanto alla vita, era la più monotona e morigerata che si potesse menare in quella pur tranquilla città di provincia.

Gina Lollobrigida: La provinciale
Il ritratto ci viene presentato anche sulla base di ciò che verremo a sapere in seguito: nata da un rapporto tra il conte e la signora Forese, Gemma nello stesso tempo, non può che avere aspetti popolari e nobiliari.
Potremmo definire la novella come una specie di “bildungsroman” al femminile: da una ragazza piena di sogni da rotocalchi e moglie borghese. Ma continua la lettura moraviana che sottolinea la distanza che separa il sogno e la realtà, in questo caso le aspettative nobiliari e una prospettiva di vita “non negativa”, ma possibile.
L’avaro, ci narra la storia di Tullio, avvocato, avaro economicamente, ma soprattutto negli affetti. Un giorno, per una questione legale conosce la coppia De Gasperis, che lo invitano a casa loro. La loro abitazione è estremamente modesta e Tullio ha il compito di tener compagnia alla signora Elena, moglie di De Gasperis, mentre quest’ultimo gioca a carte con altri tre uomini. A furia di parlarsi, fra i due nasce un sentimento, ma Tullio ha la netta sensazione (che si rivelerà veritiera) che sia gli altri giocatori che lui stesso siano gli strumenti “economici” per mantenere la coppia. Se ne renderà definitivamente conto quando dapprima sarà il signor De Gasperis a chiedergli soldi (che non darà), quindi Elena stessa che gli prospetta una vita insieme. Anche questa volta lui le negherà tale richiesta, ma andata via, Tullio si renderà conto, con dispiacere, della sua aridità sentimentale.
TULLIO
A differenza di molti avari che non possono fare a meno di dimostrare la loro passione in ogni loro attimo e finiscono così per incarnarla e diventarne l’immagine vivente, l’avarizia di Tullio si nascondeva sotto la maschera di interessi tutto diversi quando non opposti; e non si manifestava che quelle rare volte in cui, per fatalità inevitabili, egli si vedeva costretto ad allentare i cordoni della borsa. Già, nella persona, Tullio non aveva nulla della secchezza rapace e diffidente che di solito viene attribuita agli avari. Era di media statura, più grasso che magro, con quell’aspetto sensuale e bonario proprio a chi è abituato a vivere senza preoccupazioni e senza rinunzie. Nella condotta poi era addirittura il contrario giusto della figura tradizionale dell’avaro: cordiale, buon compagno, facile di modi, fluente nella parola, c’era in lui quell’abbondanza che fa pensare alla generosità; anche quando, come era il caso di Tullio, questa abbondanza sia soltanto di sentimenti e atti generici che non costano nulla. Si dice inoltre che gli avari, ossessionati dalla loro passione, non siano capaci di interessarsi ad altro che al denaro. Ora se bastasse una certa diffusa curiosità per le cose dell’arte e della cultura a provare che un uomo è generoso quest’uomo era proprio Tullio. Non soltanto la parola denaro non era mai stata sulle sue labbra, ma altre vi suonavano continuamente ben più nobili e disinteressate. Egli leggeva diligentemente tutti i libri nuovi degli scrittori più in vista, seguiva con assiduità i giornali e le riviste, non perdeva un solo spettacolo del cinema e del teatro. Qualche maligno avrebbe potuto insinuare che i libri riusciva sempre a farseli imprestare, che i giornali le riviste li trovava nel circolo della stampa di cui era membro e che abilmente sapeva sempre procurarsi i biglietti di favore per qualsiasi rappresentazione che lo interessasse. Ma tale malignità non avrebbe annullato il fatto che questa sua passione per le cose dello spirito esisteva e pareva davvero in lui sopraffare ogni altra. La sera poi, molto spesso, riuniva in casa sua certi amici, avvocati come lui, e con loro discuteva fino a tardi delle questioni politiche e culturali più attuali. E non basta: pur sotto la bonarietà e la cordialità più rilasciate, egli affermava di possedere uno di quei caratteri seri, puntuali e persino un po’ austeri che sentono fortemente gli scrupoli di coscienza e inclinano a crearsi dei problemi morali. Particolare questo che, se era vero, non si accordava con una passione come l’avarizia. La quale, notoriamente, mette con facilità a tacere la coscienza e non conosce altri problemi all’infuori di quello tutto pratico di campare la vita spendendo il meno possibile.
Tale era Tullio, o meglio tale era stato. Perché quella cordialità, quella liberalità, quegli interessi vasti e molteplici non erano ormai più che apparenza mentre un tempo erano state parti essenziali del suo carattere. Veramente, c’era stato un tempo, una diecina di anni addietro, quando Tullio aveva vent’anni, in cui si era appassionato all’arte teatrale fino al punto di domandarsi se non sarebbe stato preferibile smettere di fare l’avvocato e scrivere commedie. Un tempo nel quale i problemi morali l’avevano diviso, sia pure su fatti poco importanti, fino al punto di farlo riflettere sopra se stesso e la propria vita. Un tempo, finalmente, in cui aveva speso senza parsimonia per sé e per gli altri. Ma di quel tempo e del Tullio di allora non era rimasta che l’apparenza. La sostanza, le radici di quella prima e sola fioritura della sua vita, senza che egli se ne accorgesse, anno per anno, gliel’aveva rose l’avarizia.
Ci sono persone che afflitte da qualche vizio, prima lo combattono, poi, incapaci per debolezza di frenarsi, si illudono alla fine che passi inosservato e vi si abbandonano con frenesia. E avviene al contrario che mentre essi finiscono per non accorgersi quasi più di soggiacervi, agli altri il loro vizio appare così visibilmente da oscurare e sostituire ogni altro loro carattere. Non diversamente avvenne a Tullio per l’avarizia. In principio è verosimile che tentasse di contrastare questa passione, poi, non resistendo al dolcissimo e invincibile prurito del risparmio, arrischiò qualche minuscola tirchieria. Coloro che gli erano vicini se ne accorsero, ma pensando che si sarebbe emendato da sé, per non mortificarlo, preferirono non avvertirlo. Egli si illuse allora di averli ingannati e si buttò a grosse madornali spilorcerie. Le quali di nuovo e a maggior ragione non passarono inosservate; ma la gente, pensando che erano troppo grosse ormai per essere riparabili, tacque daccapo. Egli aveva in quel tempo circa venticinque anni; da allora non mise più alcun freno alla sua passione meritandosi così pienamente il nome di avaro che ben presto gli venne attribuito.
La figura dell’avaro è stata da sempre materia di commedie nell’età classica e di opere letterarie. Lo stesso Moravia se ne appropria disegnando la figura di un borghese la cui evoluzione “psicologica” non solo lo renderà “avaro” economicamente, ma avaro anche di sentimenti. A smuoverlo sarà un fatto esterno determinato da una donna, come spesso accade nella narrativa di Moravia. Ma la difficoltà a “vivere” ed il bisogno di chiudersi egoisticamente su stesso lo farà finire solo e la sua malinconia, metaforicamente illustrata, è come la forfora che piove in un pulviscolo di pellicole bianche, fino a velare la superficie scura e lucida della tavola.
L’architetto: Silvio Merighi è un giovane architetto, fresco vincitore di un concorso. Viene contattato per un lavoro da un certo Mancuso, che gli commissiona la costruzione di una villa dove andrà ad abitare con l’attuale fidanzata dopo il matrimonio. Quando il Merighi presenta il suo lavoro si trova di fronte sia il fidanzato che la suocera, che sembra sia la vera e propria finanziatrice dell’opera e come tale colei con la quale l’architetto deve misurarsi. Conosciuta la giovane futura sposa, proprio dalle sue parole, viene prospettato a Silvio la reale o supposta situazione: la madre è l’amante del fidanzato e affretta il matrimonio per tenerlo vicino. Intanto tra Silvio e la giovane Amelia scoppia una vera e propria passione, fatta di voluttà e sesso. Il rapporto tra Mancuso ed Amelia sembra entrare in crisi, ma basterà l’intervento della madre per rimettere le cose in ordine. Così anche Silvio, interrompendo la relazione, potrà riprendere il suo lavoro d’architetto, solo dopo essersi sposato con la sua antica ragazza e il ritorno della coppia Mancuso dal viaggio di nozze.
NON C’E’ DA FARE IL MORALISTA
Ci fu di nuovo silenzio. Ora Silvio avrebbe voluto saperne di più, arrivare a capire come avesse fatto la De Cherini a mutare a tal punto l’animo di sua figlia. Così le spiegazioni della madre come quelle dell’Amelia non lo convincevano completamente, ci doveva essere dell’altro. Ma che cosa? Di un fatto però era convinto: che non ci fosse da fare il moralista, da esprimere cioè il suo disappunto particolare con vedute e rimostranze generali. Di questo era sicuro. Difatti non era più virtuoso degli altri, si era divertito con l’Amelia senza pensare un solo momento a farne sua moglie. Proprio come il Mancuso il quale, però, alla fine la sposava e così, in tutta la faccenda, era quello che faceva migliore figura. No, egli concluse, una questione morale non era mai esistita, semmai un contrasto di forze. Ora in tale contrasto non c’era dubbio che la vittoria avesse arriso alla De Cherini.
Il “moralista” Moravia disegna un mondo dove regna l’egoismo: egli, narratore al di sopra dei personaggi, fa di Silvio, del voltafaccia di Amelia, del Mancuso stesso, degli egoisti il cui fine non può che essere una forma agli occhi degli altri “normale” e che consenta una “rispettabilità borghese”, scevra da qualsivoglia sentimentalismo, naturalmente in tale società, perdente.
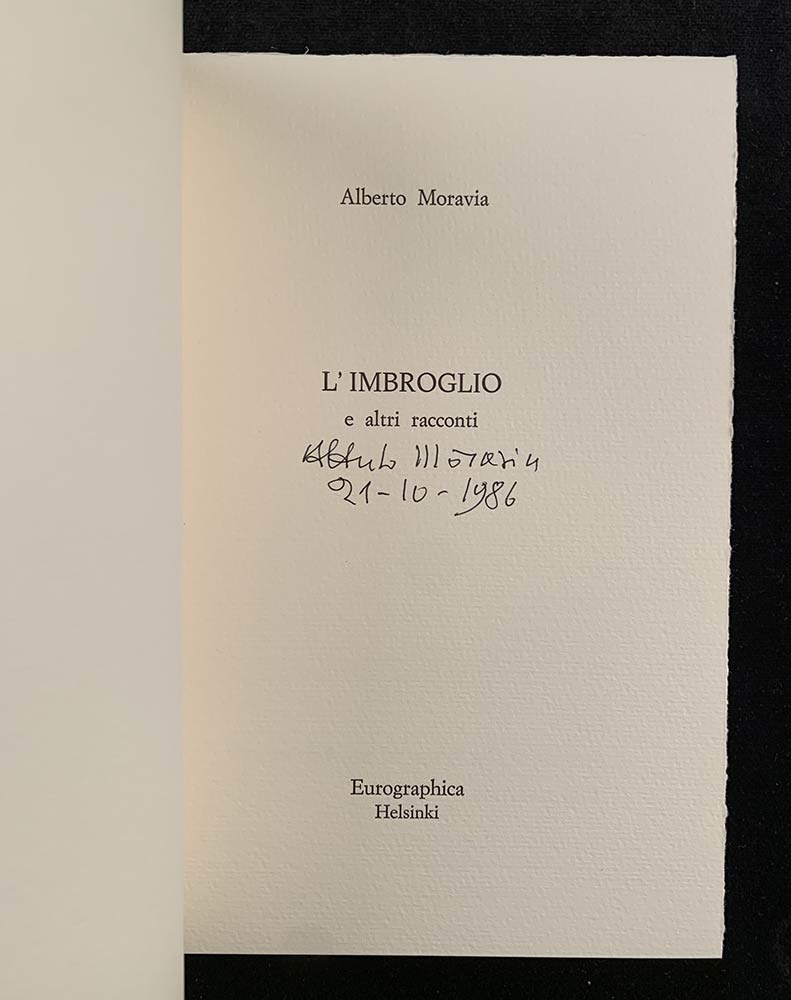
L’imbroglio: Gianmaria è un ragazzo estremamente timido, che vive a Roma in una pensione per studiare e diventare diplomatico. All’interno della pensione fa la conoscenza di una ragazza, Santina, accompagnata da quella che all’inizio fa passare per sua madre, la signora Cocanari e il suo compagno, sig. Negrini. Invaghitosi di Santina, il nostro viene a sapere dalla stessa di essere sfruttata dai due adulti e le chiede di prestarle dei denari per curare la vera madre e quindi non “vendersi” con la complicità dei due “protettori”; il nostro, precipitosamente, si presta di aiutarla e dapprima chiede i soldi ad uno zio, che lo mette alla porta, poi alla proprietaria dell’albergo che invece glieli offre. Dopo averglieli dati, viene a sapere che Santina, nottetempo, se ne andata sia con i soldi di Gianmaria che con quelli ed i gioielli dei suoi “protettori” fregando così sia l’ingenuità impulsiva di Gianmaria, sia chi le aveva insegnato ad essere disonesta. Ma l’amore lo trova egualmente: è quello della proprietaria dell’albergo, che aveva mostrato delle attenzioni su di lui che lo stesso non aveva saputo cogliere.
GIANMARIA
La timidezza di Gianmaria, dovuta all’età giovanile e all’esuberanza chimerica dell’immaginazione, era così profonda e, nello stesso tempo, accompagnata da una tanto rabbiosa volontà di disinvoltura e di franchezza, che, spesso, il risultato era una strana sfrontatezza insieme imprudente e inutile. Gli accadeva così, ossessionato com’era dal timore di parere timido, di precipitare azioni che avrebbero richiesto lunghi e cauti approcci; oppure di buttarsi ad occhi chiusi, quasi spaventato del proprio coraggio, in imprese ridicole o sterili o pericolose dalle quali ogni uomo sicuro di sé avrebbe rifuggito. Ancora, questa ostinata aspirazione a parere diverso da quello che era e a sforzare la propria natura lo portava ad agire senza necessità, secondo certi suoi calcoli astratti e rigidi coi quali si illudeva di crearci motivi e regole di condotta che in realtà gli mancavano affatto. E il tratto più curioso era che, una volta assunte queste parti insincere e puntigliose, come certi attori molto bravi, se ne investiva al punto di crederci; e di provare davvero quei sentimenti che in principio non aveva fatto che fingere.
(…)
La direttrice aveva fatto questo racconto con grande calma, ma guardando il ragazzo in una maniera singolare, insieme seria e inquisitoria. Poi tacque e lo fissò come chi aspetti qualche commento.
Gianmaria non sapeva davvero che dire. Sola cosa che avvertisse, piuttosto che delusione o dolore, era un gran gelo là dove la sera prima aveva provato per Santina tanti e così ardenti e generosi sentimenti. Tutto in una volta gli pareva di essere maturato, tutto in una volta la passione torbida e confusa per Santina era stata schiantata e spazzata via, lasciando dietro di sé nient’altro che vuoto e freddezza. Ora la sua avventura gli pareva chiara, leggibile e significativa in ogni particolare, ma oltre a questa lucida comprensione dei suoi errori non sapeva andare.
Come nel primo racconto anche qui si può parlare di bildungsroman, ed è lo stesso personaggio di Gianmaria a riconoscerlo: i due brani, tratti uno all’inizio e l’altro alla fine della storia, lo mostrano dapprima come un giovane timido ed inesperto della vita, l’altro come colui che, imparando attraverso l’errore è “maturato”, come dice lui stesso, pronto a vivere, che impara attraverso i sotterfugi e le scorciatoie disoneste altrui a scegliere l’amore non solo sessuale, come lo agogna per Santina, ma anche sentimentale, come quello per la direttrice dell’albergo (non dimentichiamo che è sempre il moralista Moravia a narrare).
La tempesta si svolge in un solo pomeriggio/sera: è una giornata uggiosa. Luca, giovane architetto, è ombroso e triste. Entra in un cinema per distrarsi con un film comico, ma cambia idea, esce e s’imbatte contro Marta, la sua ex fidanzata, che ha un bimbo da un altro uomo. Due anni prima, lei ha rifiutato di sposarlo, sotto l’influsso della sorella Nora, che preferiva vederla con un tale Meloni, ricco e disposto a mantenere entrambe. I due discutono animatamente, quindi vanno a casa di lei. Intanto si scatena la tempesta. Giungono alla casa di Marta che vive insieme alla sorella Nora; Luca nel salire le scale vede il campanello di un certo Bosso, altro riccone che non gli va a genio. Entrati, Luca cerca di riallacciare il legame passato, in quanto Meloni è in carcere per debiti. Marta, per ripagare i debiti dell’ex marito corre il rischio di rimanere povera, senza più nulla, se non un piccolo frutto del matrimonio. Mentre fuori imperversa la tempesta, arrivano prima Nora, poi Bosso, che cercano in tutti i modi di convincere Marta ad unirsi a Bosso, mentre la sorella avrà un provino in un varietà. Marta non riesce ad opporsi ai due, ma in seguito, avendo tutti bevuto champagne, Nora e Bosso si ubriacano. Allora Luca riesce a mandare Marta con il bimbo fuori dall’appartamento. Sorpreso da Nora e Bosso, usa la forza e si azzuffa con entrambi che, stupefatti, gli lasciano il margine necessario per raggiungere Marta. I due si allontanano in auto; il piccino è sereno e si addormenta cullato dalla corsa.
IL SIGNOR BOSSO
Rivedendolo, Luca si convinse subito che un uomo simile, anche se non ci fosse stata di mezzo la rivalità per Marta, egli non avrebbe potuto mai che odiarlo. Bosso aveva una grossa testa posata sopra un corpo mezzano e tozzo, una fronte calva ma di una calvizie incerta e come sudicia, che si perdeva sulla nuca in un folto strato di riccioli brizzolati, sopracciglia tenebrose, arruffate e dotate di una loro pensosa e scimmiesca mobilità, occhi piccoli, naso grosso e fiorito tra due guance sanguigne, bocca molto larga ma senza labbra, sottile come il taglio di un coltello, un po’ sporgente a modo di muso, anch’essa, come le sopracciglia, singolarmente mobile. In quel momento, poi, quello che c’era in lui di animalesco piuttosto che diminuito pareva accusato dal vestito da sera che indossava e nel quale, ritto, duro e impettito non pareva muoversi a suo agio. Dondolandosi un poco, muovendo con importanza, uno di qua l’altro di là, i piedi che aveva piccoli in maniera sorprendente e calzati di scarpe leggere e fini, mandando avanti non la pancia ma il petto anzi lo stomaco, lasciando immobilmente penzolare lungo i fianchi, fuor dei polsini duri, come branche inutili, le scure mani e i polsi villosi, si avvicinò in fretta a Nora e a Luca.
La tecnica moraviana di straniare un personaggio attraverso un’aggettivazione che viri verso il brutto, era stata già utilizzata in modo più episodico nel romanzo, ma nella narrazione breve esso appare in modo evidente. Così dietro la descrizione vi è sempre uno sguardo morale, che sottolinea il grottesco di certi modi non solo di vivere, ma anche di vestire (in questo caso maschile) della borghesia di quel periodo.
“Il romanzo breve si attaglia più di ogni altra forma al temperamento di Moravia, appunto perché romanzo di una crisi. Nella sua narrativa l’intreccio e il fatto sono dati in ogni caso da una serie di crisi, che mettono in moto figure di vittime passive e per se stessi inerti di un vizio o di una passione”. (Giacomo De Benedetti)

Intanto Moravia vive un momento difficile della sua vita: 1938, leggi antiebraiche (pur considerato ariano vive la sua situazione con angoscia e preoccupazione); 1941 morte del fratello Gastone e l’anno successivo morte del padre Carlo; nel ’41 inizia la tormentata vita coniugale con Elsa Morante, conosciuta nel ’37.
Nonostante tali difficoltà, Moravia nel 1940 dà alle stampe un’altra raccolta di racconti (la terza in ordine di tempo dopo La bella vita, che raccoglie i racconti pubblicati nei giornali tra il ’27 ed il ’32, pubblicata nel 1935 e L’imbroglio) che sembra confermare quanto detto da Debenedetti sulla sua capacità di raccogliere in un breve spazio narrativo le aporie della società contemporanea. Tale testo prende il titolo de I sogni del pigro, racconti, miti e allegorie. Quest’opera (che conoscerà altre due edizioni, una del ’44, con il titolo L’epidemia, con aggiunta di altri racconti, l’altra, nel ’56 con il titolo di Racconti surrealisti e satirici) sembra rispecchi uno sguardo che potremmo definire quasi “sperimentale”: si va infatti dal “realismo magico” di Bontempelli al surrealismo di Landolfi, senza tuttavia venir meno alle tematiche principali di Moravia stesso.
IL COCCODRILLO
La signora Curto, verso le cinque, si mise il cappello e uscì di casa per recarsi a far visita alla signora Longo. La signora Longo, moglie di un direttore di banca, abitava un appartamento al pianterreno di una palazzina vecchiotta ma signorile, in un quartiere un tempo elegante e ora decaduto. Per la signora Curto, il cui marito era un sottoposto del signor Longo, la visita rivestiva un’importanza particolare. In primo luogo ella era di una condizione molto inferiore a quella della signora Longo, abitando poche stanze moderne ma misere in uno dei tanti casamenti della periferia. In secondo luogo era la prima volta che la Longo, dopo quasi un anno che si conoscevano, si degnava di invitarla a casa sua. La signora Curto assomigliava molto ad una gallina tra affaccendata e misteriosa che stia raspando prima di deporre l’uovo: piccola, ancheggiante, con una faccia olivastra, due rotondi occhi neri di molto vicini l’uno all’altro, il naso a punta. La signora Longo era una grande donna bionda, maestosa, strabica, teatrale, pettoruta, dolciastra affettata, protettiva e dignitosa. La signora Curto aveva cinque figli piccoli, e non sapeva parlare d’altro. La signora Longo non aveva figli, ma in compenso andava alle rappresentazioni teatrali, proteggeva i musicisti, dipingeva acquarelli e recitava versi. La signora Curto vestiva preferibilmente di nero, portando ai piedi grandi scarpe simili a ciabatte, e in testa informi e complicati cappelli ornati di veli e di perline. La signora Longo si può dire che vestisse sempre da sera, in toni violacei o verdoni. Tutte queste differenze facevano sì che alla signora Curto, giunta da poco dalla provincia, la signora Longo apparisse come una specie di simbolo e di personificazione di tutte le eleganze cittadine; e il salotto di costei come un luogo più sacro di un tempio e più misterioso della grotta di un oracolo. Questa intimidita e amministrativa soggezione non impediva tuttavia alla signora Curto di avere il suo piano circa la visita che si accingeva a fare. Tale piano consisteva nella ferma risoluzione di osservare e per quanto le era possibile, stamparsi bene nella memoria tutto quello che la signora Longo facesse o dicesse, e tutti quegli oggetti che nella casa della signora Longo le sembrassero degni di nota. Abbiamo detto che la signora Curto era provinciale; aggiungeremo che i suoi natali erano stati umili e la sua educazione sommaria. Donde, in lei, una continua penosa incertezza circa quelle regole del vivere mondano che si rendono tanto necessarie per la moglie di un impiegato di banca il quale sia desideroso di far carriera. Si aveva da tendere la mano ad un uomo o da aspettare che venisse tesa? Soffiarsi il naso ritti o torcendosi da parte? Fumare o non fumare? Accavallare le gambe? Togliersi i guanti? Levarsi in piedi per ogni persona che arrivasse? Intingere i biscotti nel tè oppure mangiarli asciutti? E, in un senso più largo di eleganza e di completezza, come si serviva il tè? Con le paste o con i biscotti? Come se ammobiliava una casa? Che specie di tende si mettevano alle finestre del salotto? E a quelle della stanza da pranzo? Come doveva essere vestita la cameriera? Che vestito si portava alle cinque ricevendo le amiche? Eccetera, eccetera. La signora Curto sperava che durante quella visita l’ospite avrebbe dato con la sua presenza una muta risposta a tutte queste domande, sciolto per sempre tutte queste incertezze. Altra speranza della Curto, nell’animo della quale questa visita determinava lo scioglimento torrenziale di tutte le ambizioni finora congelate, era che la signora Longo avesse anche invitato quel giorno alcune delle sue amiche, di lei non meno eleganti e mondane. E’ vero che non era un venerdì, giorno in cui la Longo invariabilmente riceveva. Ma lo stesso, per fare onore alla Curto, ella poteva avere invitato alcune di quelle sue amiche così celebri nell’ambiente della banca: la signora Sgroi, per esempio, la signora Pedullo, la signora Boffe. Se queste signore, ciascuna delle quali, a sua volta, aveva il suo giorno di ricevimento, erano presenti, la Curto si sentiva quasi sicura di azzeccare almeno un paio di inviti. E così, di invito in invito… Ma quest’ultima speranza venne delusa. La Longo la ricevette in un salottino semibuio, pieno di armi, di tappeti appesi alle pareti e di mobiletti traforati che la signora Curto giudicò orientali. Il salotto in cui avevano luogo i famosi ricevimenti appariva invece chiuso e oscuro attraverso i doppi usci vetrati. Tutta vestita di rosso cupo, una rosa finta sull’ampia scollatura, la padrona di casa parve alla Curto gentile e anche protettiva, ma distante. Sedettero l’una di fronte all’altra, sull’orlo di un sofà, nella luce velata di una lampada anch’essa di foggia orientale; e subito incominciarono a chiacchierare. Tolta la delusione della mancata presenza delle amiche, la signora Longo non tradì le speranze della visitatrice. Pur sorbendo il tè e rispondendo alle cerimoniose e alquanto indifferenti domande della Longo sulla casa, i bambini, il marito, la villeggiatura e altrettali convenzionali argomenti, la Curto ebbe modo di fare molto osservazioni utili. La signora Longo accavallava le forti gambe sotto il vestito di velluto color ciliegia; non intingeva i biscotti bensì li mordeva sollevando alquanto le labbra; non si soffiava il naso (ma è vero che non pareva raffreddata); di tanto in tanto si assestava con la palma languidamente aperta, i biondi gonfi capelli pettinati in una foggia antiquata; chiedendo alla Curto se voleva il tè debole o forte, le posava con noncuranza la mano sulle ginocchia, gesto confidenziale e lusinghiero; parlava sottovoce staccando le sillabe e stringendo i denti; portando la tazza alle labbra sollevava leggermente il mignolo ornato di una larga pietra verde; per sputare il nocciolo di ciliegia contenuto in un cioccolatino si parava la bocca con la mano; con il tè offriva biscotti dolci e salati ma niente paste; aspirava continuamente da un lunghissimo bocchino rosso (forse per intonarlo con il colore del vestito) e ributtava il fumo dal naso. Usava, per dire posacenere, la parola evidentemente forestiera di sandrié… Quanto alla casa, oltre i suddetti mobiletti traforati che la visitatrice giudicò troppo esotici, e buoni appunto per una dama un po’ eccentrica qual era la Longo, la Curto notò che le tendine alle finestre erano rosse tutte pieghettate, giungendo fino a mezzo vetro, con due bacchette di ottone una sopra e l’altra sotto; che parimenti rosso era il damasco delle pareti; che c’erano dei portacenere assicurati con nastri sui bracciuoli delle poltrone; che una bambola vestita alla turchesca se ne stava seduta in fondo al sofà, sopra un mucchio di cuscini variopinti; che il tavolino del tè aveva le rotelle in modo da poterlo spingere dove si volesse e cento altre simili bazzecole. Ma la maggiore novità della visita e insieme la più discutibile parve alla Curto il fatto del coccodrillo. Si erano appena sedute che la bestia, spinto a musate l’uscio che dava nel corridoio, si fece avanti nel salottino. Sulle prime venne fatto alla Curto di mostrare alla padrona di casa l’animalaccio. Ma la Longo stava seduta proprio di fronte all’uscio e non poteva non aver visto il rettile; tanto più che in due passi barcollanti la bestia era giunta a sfiorare con il muso alzato il piede della Longo. Arguì dunque la Curto che il coccodrillo fosse di casa e sembrandole che non sarebbe stato educato far notare all’ospite una cosa che la stessa mostrava di voler ignorare, tacque e continuò a sorbire come se nulla fosse il suo tè. Intanto il coccodrillo, sempre con quel suo vacillante e faticoso incedere, girava dietro la Longo e si levava ritto alle sue spalle, poggiandosi sulla coda e sulle zampe posteriori. La Curto vide allora la signora Longo, con quello stesso gesto casuale e indifferente con il quale, pur discorrendo, ci si tira addosso i lembi di una pelliccia abbandonata sulla spalliera della poltrona, tendere indietro le due mani e aiutare il coccodrillo ad aderirle con la pancia al dorso, facendosi agganciare dalle quattro zampe gli omeri i fianchi. Tutto ciò fu seguito con quelle scosse nel corpo e quei gesti comodi e soddisfatti con i quali ci si assesta, appunto, qualche caldo e protettivo indumento sulle spalle. Quindi, evidentemente sicura che, così abbrancato, il coccodrillo non le sarebbe più caduto di dosso, la Longo si rivolse con bel garbo alla visitatrice chiedendole se desiderasse altro tè. Ora, la Curto si era certamente aspettata qualche stravaganza da una donna notoriamente eccentrica qual era la Longo; ma questa faccenda del coccodrillo superava di gran lunga ogni sua anticipazione. Per un momento, per così dire, ella rimase mentalmente a bocca aperta. Ma la domanda della Longo, destandola dal suo stupore, la fece vergognare di un atteggiamento tanto ingenuo e provinciale. Se la Longo, con l’aria di far cosa del tutto normale, si metteva addosso un coccodrillo vivo, perché mai ella doveva essere così rustica da meravigliarsene? Piena di rossore si chinò in avanti e rispose in fretta che desiderava certamente un’altra tazza di quell’ottimo tè. E, allo scopo di nascondere la propria confusione, aggiunse ancora qualche complimento sulla bevanda domandando alla Longo dove la trovasse se le era possibile procurarne anche a lei un pacchetto. Poi, per tutto il tempo che durò la visita, il coccodrillo non si mosse più, restandosene, come si è detto, ritto sulla massiccia coda, quattro zampe aggranfiate ai fianchi e alle spalle della signora Longo, la testa triangolare levata alta sulla testa di lei. La Longo si alzò un paio di volte per servire il tè, e il coccodrillo dietro, strana cosa a vedersi, anche perché era un esemplare molto grande che dalla punta del muso a quella della coda non misurava certo meno di tre metri; così che mentre con la testa sfiorava il soffitto, con la coda, dietro i calcagni della Longo, spazzava largamente il pavimento. Ma la Longo sempre maestosa girava per il salottino con l’animamalaccio aggrappato alla schiena seminuda senza dare a vedere alcuna fatica. Ormai la Curto pensava sempre più che questa del coccodrillo doveva essere una moda recentissima quanto bizzarra di cui ella, confinata nel suo casamento suburbano, non aveva avuto notizia; e, riflettendoci, le pareva che in questa novità ci fosse molto di buono: pur nella sua pesantezza, il coccodrillo così applicato, come si dice, donava, specie alle persone alte grandi come la Longo; inoltre proteggeva la schiena dai colpi d’aria, vantaggio non piccolo. Del resto, non si facevano forse le scarpe di coccodrillo? Dalle scarpe alla bestia viva e intiera non c’era che un passo. Sola difficoltà, semmai, il costo. Col prezzo corrente del coccodrillo pensò la Curto, non doveva essere stata piccola spesa per la Longo procurarsi un’esemplare di quelle dimensioni. E poi bisognava pensare al mantenimento della bestia, notoriamente assai vorace. La Curto si sorprese a sospirare pensando che lei, con il magro stipendio del marito, non avrebbe mai potuto permettersi nonché un coccodrillo, neppure una grossa lucertola. La Longo, avendo constatato la mancanza del limone, suonò il campanello per la cameriera; e l’ospite, in un ultimo impulso di scetticismo, aspettò non senza ansietà che la ragazza si affacciasse alla porta: voleva vedere come avrebbe preso questa faccenda del coccodrillo. Ma la cameriera, una robusta friulana a cui il succinto vestitino nero mal conteneva le membra sode e muscolose, aveva anch’essa il suo bravo coccodrillo aggrappato alla schiena; così che la Curto dovette arrendersi all’evidenza: certo era la moda più recente. Per altro non poté fare a meno di pensare che la Longo esagerava; c’era una vera e propria ostentazione di cattivo gusto nel permettere ad una domestica di portare gli stessi ornamenti dei padroni. Il coccodrillo della friulana era molto più piccolo di quello della Longo; così piccolo che, stando la donna di faccia, non si vedeva e si svelava soltanto quando voltava la schiena. Un coccodrillo appena più lungo di un ramarro di insolite dimensioni, seppure molto più largo e massiccio. Un coccodrillo bambino, si sarebbe detto. E si aggranfiava con una specie di tenerezza al dorso snello della ragazza, inserendo la coda scagliosa tra le natiche, e ficcandole il musetto appuntito sulla nuca sotto la crocchia dei capelli. Forse era un coccodrillo smesso, pensò la Curto, e la padrona dopo averlo portato per qualche tempo, se ne era stancata e l’aveva regalato alla cameriera. Ma le sue proporzioni simili a quelle del minuscolo e civettuolo grembialino avvitato ai fianchi vigorosi della friulana facevano piuttosto pensare che la Longo l’avesse comperato apposta per la cameriera. “Sprechi da gran signora” pensò la Curto non senza un invidioso dispetto. Uscita la cameriera, la Longo ne fece l’elogio. Ma la Curto volle farle capire come disapprovasse certe eccessive e dannose indulgenze del genere di quelle del coccodrillo; e rispose che bisognava stare molto attenti a non largheggiare troppo con le persone di servizio; altrimenti finiscono per montarsi la testa, e, quel che è peggio, non combinano più nulla. Specialmente coi regali, concluse la Curto, occorreva andare piano, molto piano. La Longo rispose che il suo sistema era di trattare le domestiche come se fossero state di famiglia. La Curto non sperava certo di essere mai in grado di comperarsi un coccodrillo, specie di quelle dimensioni. Cionondimeno volle osservarlo ben bene, per poterne poi parlare al marito e alle amiche. Il coccodrillo stava immobile, l’enorme testa triangolare rivolta al soffitto, quasi che avesse voluto, da quella sua boccaccia gengivosa, esalare un canto patetico. La sua gola bianca leggermente palpitante faceva da sfondo ai capelli della Longo di un biondo grigio, e non si poteva negare che l’effetto fosse piacevole. Fastidiosa invece doveva essere la pressione delle quattro zampe con le quali la bestia si abbrancava alle spalle e ai fianchi della Longo. Si vedevano benissimo gli unghioni cornei di quelle zampe affondarsi nel corpo molle e maturo della donna. Ne risultavano certe pieghe tirate del velluto rosso cupo del vestito, certi cuscinetti della carne troppo compressa di effetto poco grazioso. A parte le lividure, pensò la Curto, quale macello per i vestiti. Ma riflette che per decenni si erano portati i busti con le stecche di balena, strettissimi e malsani; valeva la pena, per seguire la moda, di sopportare qualche inconveniente. Di bell’effetto era invece la coda irta di scaglie cuspidate di un verde variegato e picchiettato di nero, massiccia e triangolare, languidamente appoggiata e trascicata in terra con movenze serpentine. Ma la bellezza della nuova moda si vedeva soprattutto quando la Longo si muoveva per il salotto. Con quel coccodrillo la cui schiena erta e corazzata le raddoppiava e più che raddoppiava lo spessore del corpo, la Longo faceva pensare ad un drago, ottenendo così, con grande semplicità, una linea molto moderna, e al tempo stesso ricca di imprevista e capricciosa fantasia. La Curto insospettita domandò alla Longo se fosse stata recentemente a Parigi, e, avutane risposta che ne era appena tornata, fu convinta che di là venisse questa straordinaria e in fondo abbastanza ardita novità. Bella forza, non poté fare a meno di pensare la Curto in un movimento di invidia, si sa che a Parigi ne inventano ogni giorno una nuova, bella forza in verità seguire la moda quando si ha la possibilità di fare appositamente il viaggio alla capitale francese. Un’altra curiosità che mordeva la Curto era di sapere come la Longo facesse quando usciva. Allo stesso modo di certi cappelli molto alti, il coccodrillo doveva essere di non piccolo impaccio negli autobus, nei tram e in genere in tutti gli ambenti angusti e affollati. E’ vero che la Longo aveva la macchina, e si sa che quando si possiede la macchina, ci si possono permettere molte cose che ai poveracci che vanno a piedi non sono consentite. Tuttavia, anche con la macchina, il coccodrillo restava una moda un po’ ingombrante. Per portare il coccodrillo bisognava stare o in piedi o seduti sopra uno sgabello senza spalliera in modo da permettere alla bestia di aggranfiare ben bene il corpo e di appoggiare a tutto suo agio la coda in terra. Ma in automobile? Si sedeva forse la Longo sul coccodrillo tirandosi la grossa coda tra le gambe? E il coccodrillo non soffocava? La Curto finì col dirsi che o la Longo non portava il coccodrillo che in casa, oppure, quando usciva, lo dava in consegna all’autista, riserbandosi di indossarlo tutte le volte che scendeva dall’automobile. Del resto, nessuno, pensò la Curto, si sognerebbe di andare in tram o al cinema vestito da gran sera, con diadema, scollatura e strascico. Evidentemente il coccodrillo non si portava che la notte, in occasioni straordinarie, all’opera o nei balli. Per quanto non si potesse negare che anche la mattina, ai giardini o al galoppatoio, un coccodrillo di dimensioni minori, simile a quello, per esempio, della cameriera, portato con disinvoltura sulla giacca di un completo color foglia morta, doveva riuscire una vera galanteria. Tutte queste cose la Curto le rimuginò senza però aprirsene alla Longo, ché non si sentiva ancora abbastanza intima per parlargliene. Ma si ripromise, ove fossero diventate amiche, di soddisfare completamente la sua curiosità. E chissà, forse la Longo, che pareva generosa, le avrebbe fatto ottenere a poco prezzo dal suo fornitore un coccodrillo magari di seconda mano. Il solo vero inconveniente della moda parve alla Curto il fatto che ogni tanto il coccodrillo, pur senza allentare la presa delle zampe, sbadigliava spalancando la smisurata bocca piena di denti e richiudendola di scatto, con un rumore secco assai sgradevole. Senza contare che ad ogni sbadiglio tutta la persona della Longo sobbalzava: un vero terremoto. Forse il coccodrillo aveva fame, pensò la Curto, o semplicemente si annoiava. L’inconveniente, del resto, non era molto grave. Bastava, infatti, mettere alla bestia una museruola simile a quella dei cani. E’ vero, però, che la bellezza del coccodrillo ne sarebbe stata assai menomata. Ormai quasi un’ora era passata; e la Curto, che si piccava di osservare le regole della buona creanza, si alzò per accomiatarsi. Avrebbe voluto domandare alla Longo qualche informazione sul coccodrillo, ma non ne ebbe il coraggio. Maestosamente, sempre tirandosi dietro l’enorme rettile la cui coda le trascicava alle calcagna per buon mezzo metro, la Longo la precedette nel corridoio che portava all’ingresso. La Curto, in questo passaggio, non resistette ad una tentazione molto scusabile, e, sporgendosi alquanto, tastò la schiena dell’animalaccio. Sperava di non farsene accorgere, ma inciampò in quella maledetta coda e cadde in avanti, con il naso tra le scaglie, rimanendo quasi soffocata dal puzzo acido e palustre che emanavano. «Attenzione», avvertì la Longo senza voltarsi, «non c’è molta luce in questo corridoio». Si salutarono nel vestibolo. La cameriera, con il suo coccodrillo aggrappato alla schiena, aprì la porta. Ma la Longa non disse alla Curto di tornare a vederla. E quella, andandosene, non poté fare a meno di attribuire questa freddezza alla povertà del proprio guardaroba. «Ma se mio marito riesce ad ottenere un avanzamento», pensò avviandosi a piedi alla fermata dell’autobus, «mi farò anch’io il mio bravo coccodrillo… e allora ce la vedremo, cara signora Longo…».

Questo racconto, scelto dal critico Contini per una antologia in lingua francese pubblicata nel ’46, intitolata Italie magique, “racconti surreali novecenteschi italiani” presenta un duplice carattere:
- Surrealista, intendendo con questo termine quel tipo di racconto in cui l’anormale viene descritto come fosse normale, senza alcuna forzatura né tematica, né linguistica: per meglio dire il lettore legge ciò che non può essere come fosse reale, quotidiano; (esempio principe di tale tecnica è La metamorfosi di Kafka)
- Satirico, risulta evidente che il “coccodrillo” rivesta qui il ruolo di un vero e proprio status symbol della classe alta (richiamata anche dal nome “Longo”) invidiato dalla bassa (significatamene nominata “Curto”). Non è un caso che tutto il racconto abbia una focalizzazione interna, che è quella della persona che aspira ad elevarsi socialmente, e certamente, visto il modo con cui ce la presenta Moravia, non è certo amata dallo scrittore romano.
Tuttavia sia il surrealismo che la stessa capacità satirica, senza che Moravia sia palesemente schierato a livello ideologico (d’altra parte non era possibile essere assolutamente contro), non nascondano il “moralismo” di fondo che caratterizza il modo attraverso cui lo scrittore romano guarda il mondo. Egli è sia contro il vuoto morale che caratterizza la borghesia, soprattutto quella del ventennio, (il coccodrillo come status symbol ne è un segno), ma anche contro le aspirazioni borghesi delle classi inferiori che rafforzano il potere delle prime e la subordinazione delle altre.

Appartenente a quest’opera vi è un’altro racconto lungo Cosma e i briganti, pubblicato dapprima sulla rivista Oggi, quindi sull’edizione de L’imbroglio e per ultimo, riportata meritoriamente e singolarmente alla luce dalla casa editrice Sellerio nel 1980. E’ un racconto che sembra riportarci al clima dell’Andreuccio di Boccaccio: si tratta di un giovane, Cosma, a cui il padre, noto giolleliere, affida dei preziosi al ragazzo da portare in città in cambio di merci.
COSMA
Quel gioielliere a nome Dragotis, uno dei maggiori nella capitale di quel piccolo stato dell’Europa orientale, ebbe una proposta assai vantaggiosa da tale Ataman sensale. Si trattava di recarsi in una città vicina per mostrare certe gioie di gran costo a persona arricchita che voleva ornarne la moglie. Parve al gioielliere che questa fosse una buona occasione per iniziare l’unico figlio, Cosma, alla pratica degli affari. Del resto Cosma si era già esercitato in transazioni di minor conto; e, seppure distratto e come reso disinteressato dai volubili umori dell’età giovanile, mostrava di essere sveglio e naturalmente dotato; anzi, talvolta, meravigliava il padre con la sua inaspettata accortezza. Il gioielliere disse al figlio che avrebbe dovuto recarsi in quella città insieme con il sensale, persona fidata. Gli avrebbe dato una borsa di cuoio con le gioie. Gli fornì tutti i chiarimenti sui prezzi e la qualità della merce. Del resto non si trattava che dei preliminari; dimostrare le gioie alla signora che, essendo incinta, non era in grado di affrontare il viaggio alla capitale; poi il padre sarebbe andato di persona a concludere la vendita. Cosma, sempre pronto ad accettare qualsiasi incombenza, accolse con piacere quest’incarico. Non che portasse molto amore al commercio paterno. Ma per lui, ancora svagato e curioso come sono spesso i giovani a venti anni, andare a mostrare questi gioielli era una avventura; allo stesso modo che cacciare il cinghiale selvatico nelle forre intorno la capitale o, la notte, arrischiarci nei locali più popolari. Egli era ancora nell’età felice delle scoperte, delle esplorazioni, degli esperimenti e delle incertezze. Questo senso di avventura, d’altronde, non gli avrebbe impedito di essere attento e scrupoloso, secondo le raccomandazioni paterne. Egli era come i bambini che pur fingendo azioni da adulti, sanno di giuocare; e tuttavia mettono nei giuochi più serietà e applicazione che i grandi nelle loro gravi faccende.
E’ chiaro, in questo incipit, il riferimento boccacciano: allo stesso modo con cui il padre del racconto dello scrittore fiorentino manda in figlio Andreuccio a Napoli per comprare cavalli e come il giovane ragazzo si lasci irretire dapprima da una giovane donna, quindi viva una serie di avventure, allo stesso modo Cosma durante il tragitto s’imbatte in alcune avventure: gli uomini che il padre gli aveva affidato per la sua sicurezza, lo tradiscono, ma vengono uccisi dai briganti, a capo dei quali vi è una giovane donna, Albina, con cui Cosma conoscerà l’amore. Sono entrambi chiaramente racconti di formazione e se Boccaccio lo inserisce in una Napoli reale, Moravia narra una storia che non ha né luogo né tempo precisi, il cui unico scopo è quello di divertire se stesso e il lettore, che per Boccaccio corrisponde a “dilettare”.
L’esperienza del surrealismo serve a Moravia per dar vita al suo terzo romanzo, La mascherata, pubblicato nel ’41, che venne direttamente sequestrato dall’autorità, rendendo esplicita la frattura tra lo scrittore romano ed il governo fascista. Esso trae ispirazione dalla sua permanenza messicana, pur essendo “chiaro” il riferimento ad ogni forma di dittatura (quindi anche quella fascista).
La mascherata è ambientato in un immaginario paese dell’America Latina sotto la dittatura di Tereso Arango, salito al potere dopo dieci anni di guerra civile. Il generale, dopo un primo periodo in cui, grazie a metodi brutali, pacifica il paese, vede la sua popolarità affermata; decide quindi la liquidazione del capo della polizia, Cinco, compagno feroce delle prime lotte. Allora Cinco, per non perdere l’incarico, decide di inscenare un falso attentato ai danni del generale, che, spaventato, avrebbe rinunciato a sostituirlo. Il Cinco sceglie come occasione per attuare il suo piano una festa in maschera alla quale Tereso avrebbe partecipato nei giorni successivi: allora decide di rivolgersi ad un agente provocatore, il Perro, per ultimare i preparativi della finta congiura. Il grande evento si sarebbe svolto nella villa di una ricca duchessa, la Gorina, che riesce ad assicurarsi la partecipazione della bella vedova Fausta, di cui Tereso è perdutamente innamorato. Le due donne intendono volgere a loro vantaggio la debolezza del generale per la marchesa Sánchez, disposta a diventare la sua amante per trarne dei benefici economici. Nel frattempo l’agente segreto del Cinco, alla vigilia della mascherata, si reca in una cittadina, dove incontra il Saverio. Il Perro tempo prima aveva individuato un certo numero di soggetti pericolosi per il potere di Tereso, potenziali rivoluzionari che teneva sotto controllo fingendosi il capo di un inesistente partito segreto che tramava ai danni della dittatura. Il Perro, in qualità di capo del partito, ordina a Saverio, un giovane estremista entusiasta di morire per la causa del proletariato, di inserirsi nella villa della Gorina travestito da cameriere per posizionare una bomba nella stanza da letto di Tereso; il piano del Perro e del Cinco sarebbe stato di sorprendere il Saverio in flagrante e di arrestarlo sotto gli occhi di Tereso, che avrebbe conferito loro gloria e ricchezza per aver sventato l’attentato. Nella vicenda si inserisce anche il fratellastro di Saverio, Sebastiano, un bel giovane, che, origliando una conversazione fra il Perro e il Saverio, viene a sapere che questi ultimi intendono far esplodere la villa della Gorina. Sebastiano allora decide di fingere di voler prendere parte all’azione rivoluzionaria al fine di salvare la vita a Fausta, della quale è anch’egli pazzamente innamorato, mentre per Fausta egli è solo uno dei suoi tanti amanti. Infatti, prima della festa, Sebastiano sorprende Fausta nel mezzo di un rapporto sessuale con un servo di nome Doroteo. Anche Tereso scopre del tradimento della donna, informato da un suo agente; per vendicarsi, decide di utilizzare il suo potere per costringere Fausta a maritarsi con Doroteo la sera stessa. Tuttavia succede un imprevisto: proprio nel momento in cui il Saverio sta mettendo l’ordigno esplosivo nella stanza da bagno adiacente alla camera di Tereso, Fausta entra nella stanza e sorprende il Saverio che, “agendo da vero rivoluzionario” strangola Fausta. Tereso, che ha udito un breve urlo della donna, accorre, sfonda la porta e spara al Saverio, e immediatamente annuncia che le nozze di Fausta con Doroteo sono annullate: al loro posto si sarebbe celebrato il funerale della donna. Il capo della polizia, Cinco, che aveva promesso a Tereso di occuparsi in modo discreto di questo attentato (di cui aveva parlato col generale, affermando di esserne venuto a conoscenza mediante delle indagini) è chiaramente rovinato. Il Perro quindi dà il colpo di grazia al Saverio sparandogli alla nuca, non avendo più interesse ad un grande processo.
Pur essendo un breve romanzo dalla non breve sinossi si percepisce come esso sia ricco di avvenimenti, come ammette lo stesso Moravia al suo editore Bompiani: “Caro Bompiani, tra quattro giorni ti mando il romanzo nuovo. S’intitola La cospirazione – se questo titolo non va, si potrebbe chiamare La mascherata. E’ lungo circa 150 pagine – ho fatto il conto e verrebbero circa 200 pagine stampate come quelle dei Sogni. Sebbene corto, nel romanzo c’è più materia che nelle Ambizioni sbagliate che sono lunghe 500 pagine”.

TERESO
Dopo quasi dieci anni di furiosa guerra civile, quella nazione di oltre oceano, decimata, rovinata, esausta, affidò le sue sorti al generale Tereso Arango.
Tereso, non meno valoroso che accorto, era il superstite e il vincitore di una mezza dozzina di generali che alla testa delle loro armate si erano contesi il potere per quei dieci lunghi anni di lotte intestine.
Tereso era di gusti semplici, militareschi, per non dire rozzi. La società molto brillante della sua capitale difficilmente avrebbe potuto dire di averlo mai avvicinato fuorché nelle feste patriottiche e durante le riviste militari. Tereso, a tutti i saloni, a tutti i ricevimenti aristocratici, preferiva le cene intime con gli antichi compagni d’arme, i combattenti dei galli, le corride, i teatri popolari, e, magari, qualche buon libro di storia o la musica facile di un’orchestrina di chitarre. Questa semplicità e ritrosia spiegano perché Tereso avesse per molti anni fermamente declinato gli inviti della duchessa Gorina, di gran lunga la più illustre, la più ricca, la più ospitale nobildonna del paese. Ma la Gorina aveva giurato a se stessa di trionfare della misantropia di Tereso; e vedendo che le adulazioni e le lusinghe non sortivano alcun effetto, decise di scoprire il punto debole del generale. Con tutta la sua virtù, Tereso era un uomo, e doveva pure averne uno. La Gorina, sotto il più esaltato e arcigno dei sussieghi, nascondeva una furbizia bonaria e penetrante. Non ci volle molto per scoprire che Tereso, così forte in guerra, si lasciava disarmare da un solo sguardo di donna che gli piacesse; e che, in particolare, in quel momento egli era innamorato di Fausta Sánchez, una vedova giovanissima, tra le più belle di quella società. La duchessa invitò Fausta a casa sua e si rinchiuse con lei per un paio d’ore nel suo gabinetto particolare. Il risultato di questa conversazione fu che qualche giorno dopo ad un ricevimento diplomatico, Tereso si vide ancora una volta invitato dalla Gorina.
Tereso odiava la Gorina in cui vedeva incarnati tutto l’orgoglio, l’ignoranza, la corruzione e la vanità dell’antica nobiltà del paese. Diede così la solita risposta; e cioè che gli doleva ma gli affari di stato gli impedivano assolutamente di prendersi svaghi del genere di quello che ella gli proponeva. La Gorina impassibile e sussiegosa lasciò cadere sbadatamente che questo suo rifiuto avrebbe certo costernato la marchesa Sánchez la quale aveva molto sperato di vederlo alla festa.
Tereso che da mesi dava inutilmente la caccia a Fausta, a quel nome sentì il proprio cuore, nonostante l’età e l’esperienza, mettersi a battere giovanilmente. «Ma chi vi dice», domandò imprudentemente, «che la mia presenza le sia gradita?»
«A chi non sarebbe gradita la presenza dell’Eccellenza Vostra?» rispose la Gorina con l’aria più che di adularlo, di fargli la lezione.
Tereso si morse le labbra e ribatté seccamente che se Fausta ardeva tanto di vederlo, non aveva che da venire al palazzo nelle ore di udienza e sarebbe stata subito ricevuta. La duchessa rispose esser vero che Fausta aveva perso il marito, ma aveva ancora un fratello; e come poteva credere Tereso che il fratello potesse permettere a Fausta di varcare quella soglia riuscita già fatale alla reputazione di tante donne? Troppo noto era il fascino che Tereso esercitava sulle donne perché il fratello di Fausta si mettesse a questi rischi. «Ho capito», pensò Teresio, «il prezzo di Fausta, per cominciare, è la mia partecipazione alla festa». Allora disse che era inteso, sarebbe venuto al ballo.

“Nel romanzo Tereso è il mandriano di un gregge vile, non un tenebroso criminale politico. Dagli scuotimenti sociali endemici di quelle terre lontane emerge come una figura tipica degli assestamenti periodici nella geologia politica latino-americana. Populista autentico, soldataccio di guarnigione, uno del volgo, Tereso vibra di emozione ogni volta che con sincerità evochi il popolo da cui è nato e a cui continua ad appartenere pur nella sua solitudine del vertice. Il popolo però non si vede, resta un coro lontano di demagogico sostegno, e tutto si svolge in una dimora ducale, non troppo diversa dalle ville moraviane dei quartieri alti, fra sudditi altolocati e infidi. Del resto l’uomo Tereso è ingenuo e la fragilità sentimentale ne rivela fatalmente la natura. Egli si innamora come un cameriere e mette a repentaglio la stessa dignità del suo potere per una sgualdrina matricolata. Non regge al confronto con una marchesa alla spudorata caccia di favori e piaceri. La lingua moraviana, educata all’indifferenza del puro rilievo da uno spietato realismo, non è quella dell’odio ma della desolata valutazione di una personalità autoritaria che incarna né più né meno valori e disvalori del gregge che ha ammansito, e che governa con paterno disprezzo. L’antifascismo moraviano non è infatti a senso unico, né declamatorio, né plateale, o formularmente virtuoso e consolatorio. Esso nasce non da una passione politica, da una partecipazione, ma da un distacco, da una solitudine, non da calore, ma da freddezza d’animo, da una voluta, cercata attenuazione di tensioni emotive, che sono poi la causa, per lo scrittore, degli inganni dell’ideologia, ma prevalentemente nasce da un ragionamento che rifiuta il potere che s’imponga con la violenza della retorica e del conformismo di massa e che sia subito dal consenso passivo dell’adesione irrazionale.” (Marino Biondi).
L’esperienza novellistica precedente il romanzo è piuttosto evidente nella creazione dei personaggi: ognuno sembra essere “maschera” di una tipologia (il dittatore che deve fare il dittatore”, Cisco che deve “tradire” per salvarsi, Saverio il tipo del rivoluzionario utopico e via dicendo) e tutti che finiscono proprio all’interno di una festa in maschera “una mascherata”, appunto, il cui titolo potrebbe alludere “pirandellianamente” all’idea dello scrittore siciliano secondo il quale tutti noi possediamo una maschera. Ma la componente satirica – che a volte scivola nel comico – non nasconde una velata allusione politica. Non è un caso che l’opera venne preventivamente sequestrata: se Tereso può alludere con il suo essere demagogo, vanesio nonché amante del bel sesso, al dittatore italiano, lo stesso possiamo dire dei suoi sottoposti, ognuno teso a tendere tranelli per il proprio tornaconto.
La mascherata, tuttavia, non ebbe il successo sperato, nemmeno dopo la caduta del fascismo: viene infatti considerata, a livello critico, un’opera minore, forse perché l’ideologia predomina sulla storia, oppure, forse meglio, per l’ambiguità dell’autore stesso verso il fascismo. Sappiamo che le bozze dell’opera vennero date a Galeazzo Ciano, che non si mostrò così contrario all’opera; le portò con sé per andare in Germania ad incontrare Hitler, ma di tale libercolo non si parlò più.
Nonostante ciò, Moravia non può più pubblicare niente col suo nome, né firmare sceneggiature cinematografiche che gli permettono di avere un qualche riscontro economico (usa lo pseudonimo Psico). Va via da Roma e nel 1941 Moravia è a Capri, insieme alla moglie Elsa Morante. Pubblica la raccolta di novelle L’amante infelice (che riprende, attorno a un nucleo di inediti risalenti al 1942, alcuni racconti già presenti in «La bella vita» del 1935 e brani scelti da «L’imbroglio»). Come nel caso di quest’ultimo libro e di La mascherata, anche L’amante infelice venne fermato dalle autorità fasciste poco dopo la sua pubblicazione. Nel frattempo Moravia lavora al romanzo Agostino, mentre la Morante è intenta al suo primo romanzo Menzogna e sortilegio, ambedue pubblicati nel ’43.
 Agostino, verrà pubblicato presso un editore minore, la “Documento” di Federico Valli, in sole 500 copie, in quanto il partito fascista porrà il veto perché giudicato “scabroso”. Tuttavia, come dice Moravia stesso nel 1986, rappresenta un “libro fondativo” in quanto l’autore afferma “di aver ritrovato la vena che poi mi ha assistito fino ad oggi”. Infatti l’opera (oltre ad essere ammirata sia da Saba che da Gadda) è il frutto di un momento di felicità creativa in quanto il romanzo preesiste nella mente dell’autore, senza alcuna costruzione in fieri. Moravia infatti descrive il giovane Agostino, cogliendone sì, i primi turbamenti sessuali dovuti al rapporto edipico con la madre e i primi scontri di classe con i ragazzi “proletari” sotto protezione del maturo omosessuale Saro (e non bisogna assolutamente ignorare quanto questi temi siano “rivoluzionari” nell’Italia fascista del ’43), ma sia Freud che Marx non soffocano, con le loro teorie, la vicenda di Agostino, ma lo fanno entrare nel mondo in cui Freud e Marx esistono; dice infatti Moravia che il racconto: “è anche la storia dell’incontro di Agostino con la cultura moderna che presuppone l’opera dei due grandi smascheratori, Marx e Freud”.
Agostino, verrà pubblicato presso un editore minore, la “Documento” di Federico Valli, in sole 500 copie, in quanto il partito fascista porrà il veto perché giudicato “scabroso”. Tuttavia, come dice Moravia stesso nel 1986, rappresenta un “libro fondativo” in quanto l’autore afferma “di aver ritrovato la vena che poi mi ha assistito fino ad oggi”. Infatti l’opera (oltre ad essere ammirata sia da Saba che da Gadda) è il frutto di un momento di felicità creativa in quanto il romanzo preesiste nella mente dell’autore, senza alcuna costruzione in fieri. Moravia infatti descrive il giovane Agostino, cogliendone sì, i primi turbamenti sessuali dovuti al rapporto edipico con la madre e i primi scontri di classe con i ragazzi “proletari” sotto protezione del maturo omosessuale Saro (e non bisogna assolutamente ignorare quanto questi temi siano “rivoluzionari” nell’Italia fascista del ’43), ma sia Freud che Marx non soffocano, con le loro teorie, la vicenda di Agostino, ma lo fanno entrare nel mondo in cui Freud e Marx esistono; dice infatti Moravia che il racconto: “è anche la storia dell’incontro di Agostino con la cultura moderna che presuppone l’opera dei due grandi smascheratori, Marx e Freud”.
L’opera venne ripubblicata nel ’45 e Agostino fu il primo romanzo italiano a ricevere nel dopoguerra il riconoscimento di un premio letterario autorevole, quello del “Corriere Lombardo”.
Agostino è un giovane tredicenne che trascorre l’estate in Versilia insieme alla madre vedova, ma ancora giovane e piacente. I due trascorrono insieme momenti felici, fino all’arrivo di Renzo, che si unisce ai tre, fino ad essere prescelto dalla madre, lasciando solo Agostino. Il giovane allora conosce Berto che gli fa conoscere altrettanti giovani, ma d’estrazione sociale diversa, inoltre viene a sapere che loro considerano sua madre una “poco di buono”. Agostino conosce anche Saro, un bagnino omosessuale, che ha una relazione con un ragazzo di colore, Homs, che fa parte del gruppo di ragazzi. Loro portano Agostino con loro e Saro tenta un approccio con lui, senza successo; ma non è il solo trauma del giovane, perché vede la madre baciarsi con Renzo. I ragazzi gli fanno conoscere l’esistenza dei postriboli, dove, per diventare grande, cerca d’entrare, ma viene respinto perché piccolo. Il romanzo termina con la richiesta di Agostino di tornare in città e di essere considerato dalla madre non più bambino ma uomo.
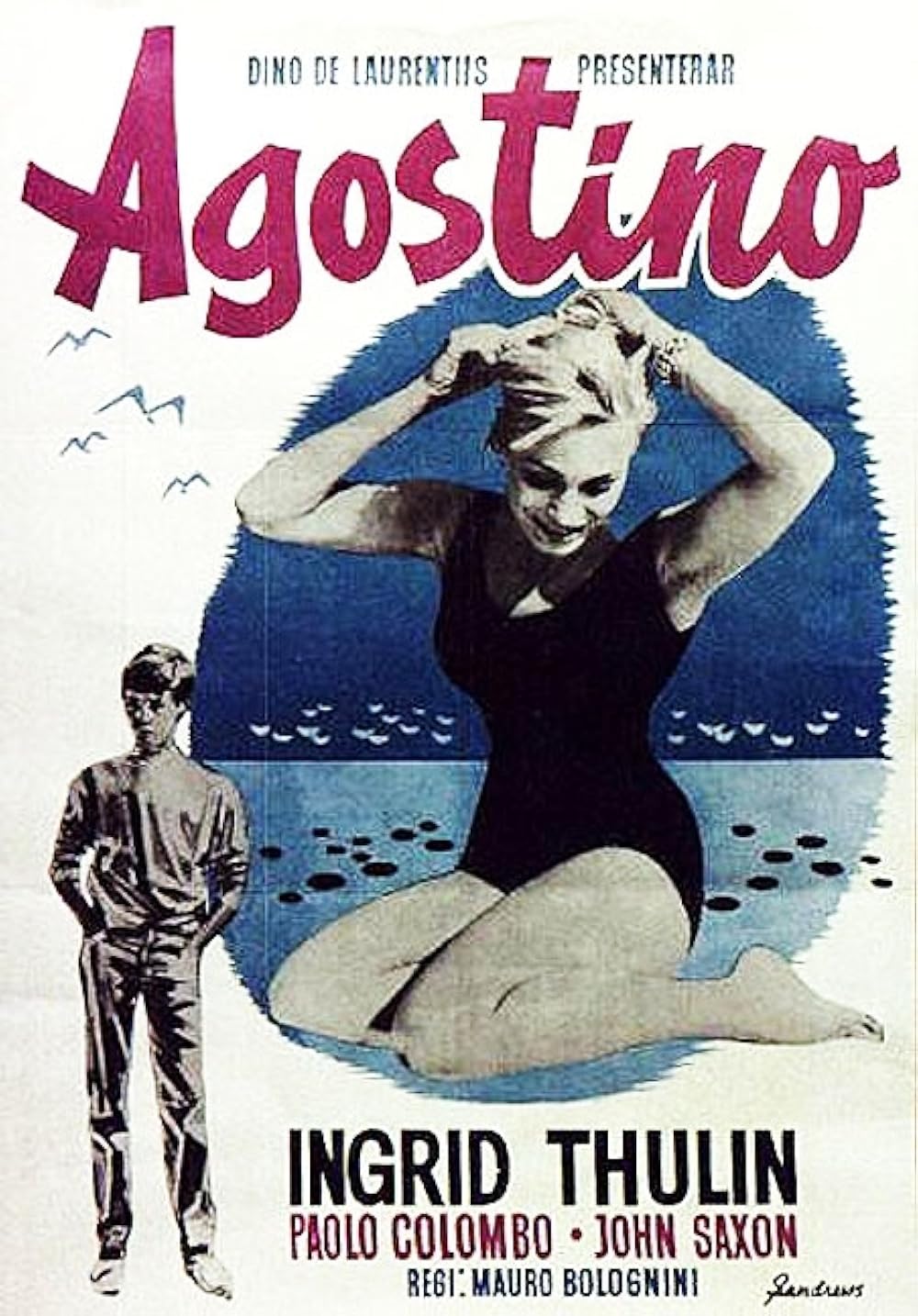
IL TRAMONTO DELL’INNOCENZA
La barca filò dritta verso la sponda, quindi il Saro diede un colpo di timone mettendola di traverso; e gettatosi sulla vela l’abbracciò, la ridusse e la calò. La barca si dondolò immobile nell’acqua bassa. Il Saro prese dal fondo della barca un ancorotto e lo lanciò in mare. «Si scende» disse. Scavalcò il bordo della barca e camminando nell’acqua andò incontro i ragazzi che lo aspettavano a riva.
Agostino vide i ragazzi affollarglisi intorno con una specie di applauso che il Saro accolse scuotendo il capo. Altro applauso più clamoroso salutò anche il suo arrivo; e per un momento si illuse che fosse di amichevole cordialità. Ma subito si accorse che si sbagliava. Tutti ridevano tra sarcastici e sprezzanti. Berto gridò: «E bravo il nostro Pisa a cui piacciono le gite in barca»; il Tortima gli fece un versaccio accostando la mano alla bocca; gli altri facevano eco. Persino Sandro, di solito così riservato, gli parve che lo guardasse con disprezzo. Quanto al negro, badava a saltellare intorno al Saro che camminava avanti a tutti incontro al fuoco che i ragazzi avevano acceso sulla spiaggia. Stupito, vagamente allarmato, Agostino andò con gli altri e a sedersi intorno al fuoco.
I ragazzi avevano fatto con la sabbia compressa e bagnata una specie di rozzo cunicolo, una dentro vi bruciavano pigne secche, aghi di pino e sterpaglia. Collocate di traverso sulla bocca del cunicolo, una decina di pannocchie di granoturco arrostivano lentamente. Presso il fuoco si vedeva sopra un giornale molto frutta e un grosso cocomero. «E bravo il nostro Pisa» riprese Berto come si furono seduti «tu e Homs ormai siete compagni… avvicinatevi uno all’altro… siete come dire?, fratelli… lui è moro, tu sei bianco, ma la differenza è poca… a tutti e due vi piace andare in barca…»
Il negro sorrideva soddisfatto. Il Saro accovacciato badava a rigirare le pannocchie sul fuoco. Gli altri sghignazzavano. Berto spinse la derisione fino a dare uno spintone ad Agostino buttandolo contro il negro, in modo che per un momento essi furono addossati l’uno all’altro, l’uno ridacchiante nella sua bassezza e come lusingato, l’altro incomprensivo e pieno di ripugnanza «Ma io non vi capisco» disse a un tratto Agostino «sono andato in barca… che male c’è»?»
«Ah, che male c’è… è andato in barca che male c’è» ripeterono molte voci ironiche. Alcune si tenevano la pancia dal gran ridere.
«Eh già, che male c’è» ripeté Berto rifacendogli il verso, «non c’è nessun male… anzi Homs pensa che sia proprio un bene… non è vero Homs?»
Il negro assentì giubilante. Ora ad Agostino cominciava ad albeggiare seppure in maniera confusa, la verità; ché non poteva fare a meno di stabilire un nesso tra quelle beffe e lo strano contegno del Saro durante la gita. «Non so che cosa volete dire» dichiarò «io in questa gita in barca non ho fatto nulla di male… Saro mi ha fatto recitare delle poesie… ecco tutto.»
«Ah… ah… le poesie» si sentì gridare da ogni parte.
«Non è vero Saro che ho detto la verità» gridò Agostino rosso in viso.
Il Saro non disse né sì né no; contentandosi di sorridere e sogguardandolo, si sarebbe detto, con curiosità. I ragazzi si scambiarono questo contegno in apparenza indifferente e in realtà traditore e vanitoso, per una smentita ad Agostino. «Si capisce» si udiva ripetere da molte voci, «va a chiedere all’oste se il vino è buono… non è vero Saro? bella questa… ah, Pisa, Pisa…»
Il negro, soprattutto, vendicativo, pareva godersela. Agostino gli si rivoltò e gli domandò bruscamente tremando per la collera: «Che hai da ridere?»
«Io, nulla,» disse quello scostandosi.
«E non vi litigate… Saro penserà lui a mettervi d’accordo» disse Berto. Ma già i ragazzi, come se la cosa a cui alludevano fosse pacifica e non meritasse più neppure di essere discussa, parlavano d’altro. Raccontavano come si fossero insinuati in un campo e vi avessero rubato il graturco e la frutta; come avessero veduto il contadino venirgli incontro furioso, armato di fucile; come fossero scappati e il contadino avesse sparato una fucilata di sale senza tuttavia colpire nessuno. Le pannocchie intanto erano pronte, rosolate e abbrustolite sul fuoco quasi spento. Il Saro le tolse dal fornello e con il solito paterno compiacimento, le distribuì a ciascuno. Agostino approfittò di un momento che tutti erano intenti mangiare, e con una capriola si fece presso a Sandro che un po’ in disparte sgranocchiava il suo granturco.
«Io non capisco» incominciò. L’altro gli lanciò uno sguardo d’intelligenza e Agostino comprese che non aveva bisogno di dire altro. «E’ venuto il moro in tramvai» pronunziò Sandro lentamente «e ha detto che tu e il Saro siete andati in barca.»
«Ebbene, che male c’è?»
«Io non c’entro» rispose Sandro gli occhi rivolti a terra, «sono affari vostri… di te e del moro… ma il Saro» egli non finì la frase e guardò Agostino.
«E allora?»
«Beh… io col Saro solo non ci andrei in barca»
«Ma perché?»
Sandro si guardò intorno e poi abbassando la voce diede ad Agostino la spiegazione che questi presentiva senza rendersene conto. «Ah» fece Agostino. E senza potere dire di più tornò al gruppo.
Accovacciato in mezzo ai ragazzi, con quella sua testa bonaria e fredda declinata verso la spalla, il Saro pareva proprio un buon papà tra i suoi figliuoli. Ma Agostino ora non poteva guardarlo senza un odio fondo, più forte ancora di quello che provava contro il negro. Ciò che soprattutto gli rendeva odioso il Saro era quella reticenza di fronte alle sue proteste; come a lasciare intendere che le cose di cui lo accusavano i ragazzi erano realmente avvenute. D’altra parte non poteva fare a meno di avvertire non sapeva che distanza di disprezzo e di divisione tra lui e compagni; quella stessa distanza che, ora se ne accorgeva, frapponevano tra loro e il negro; soltanto che il negro, invece di esserne come lui umiliato e offeso, pareva in qualche modo goderne. Più di una volta tentò di attaccare il discorso sull’argomento che gli bruciava, ma sempre incontrò sia la conzonatura sia una noncuranza ingiuriosa.
(…)
Dalla spiaggia erano passati alla boscaglia bassa dei pini giovani; poi varcarono un sentiero sabbioso ed entrarono nel canneto. Le canne erano folte, molte portavano in cima a bianchi pennacchi, i ragazzi apparivano e scomparivano tra quelle lunghe e verdi lance, sdrucciolando sulla melletta e smuovendo le canne con un fruscio arido delle rigide foglie fibrose. Trovarono alla fine un punto dove il canneto si allargava intorno un po’ di proda melmosa; come apparvero, grossi ranocchi saltarono da ogni parte dentro l’acqua compatta e vitrea; e qui, l’uno contro l’altro, sotto gli occhi del Saro che seduto a ridosso delle carni sopra un sasso pareva assorto a fumare ma in realtà li spiava tra le palpebre socchiuse, presero a spogliarsi. Agostino si vergognava, ma timoroso di nuove beffe cominciò anche lui a slacciarsi i pantaloni, procurando di mettervi molta lentezza e sogguardando gli altri. I ragazzi invece parevano gioiosi di mettersi nudi e si strappavano i panni urtandosi e interpellandosi scherzosamente. Erano, contro lo sfondo delle canne verdi, tutti bianchi, di una bianchezza squallida e villosa, dall’inguine fino alla pancia; e questa bianchezza rilevava nei loro corpi quel non so che di storto, di sgraziato e di eccessivamente muscoloso che è proprio della gente che fatica manualmente. Soltanto Sandro, biondo all’inguine come in capo, grazioso e proporzionato, forse perché aveva la pelle egualmente abbronzata per tutto il corpo, non pareva neppure nudo; e per lo meno non nudo in quella laida maniera di piscina popolare. I ragazzi preparandosi a tuffarsi, facevano cento lazzi osceni, scosciandosi, dandosi delle spinte, toccandosi, con un’impudenza è una sfrenata promiscuità che stupiva Agostino affatto nuovo a questo genere di cose. Era anche lui nudo, i piedi nudi neri lordi di melletta fredda, ma volentieri si sarebbe nascosto dietro quelle canne, non fosse altro per sfuggire agli sguardi che il Saro, accovacciato e immobile, in tutto simile a un’enorme batrace abitatore del canneto, avventava su di lui gli occhi socchiusi. Soltanto, come al solito, la sua ripugnanza non era più forte della torbida attrattiva che lo legava alla banda; e mescolata con essa indissolubilmente, non gli permetteva di capire quanto piacere si nascondesse in realtà in fondo a quel ribrezzo. I ragazzi si confrontavano a vicenda, vantando la loro virilità e la loro prestanza. Il Tortima, che era il più vanitoso al tempo stesso, così nerboruto è sbilanciato, il più plebeo e squallido, si esaltò al punto di gridare ad Agostino: «e se mi presentassi un bel mattino tua madre… così nudo… lei che direbbe? ci verrebbe con me?»
«No» disse Agostino.
«E io invece dico che ci verrebbe subito» disse il Tortima, «mi darebbe un’occhiata… tanto per valutarmi… e poi direbbe: “su Tortima, andiamo”».
Tanta goffaggine fece ridere tutti. E al grido di “su Tortima, andiamo” si slanciarono l’uno dopo l’altro nel fiume, buttandosi a capofitto proprio come quei ranocchi che il loro arrivo poco prima aveva disturbato.
La proda era circondata d’ogni parte dalle alte canne, in modo che si vedeva non più che un tratto del fiume. Ma come furono nel mezzo della corrente, apparve loro il fiumicello intero che con un modo insensibile della compatta e scura acqua di canale andava a sfociare poco più giù, tra i sabbioni. A monte il fiume si inoltrava tra due file di bassi e gonfi cespugli argentei che si spandevano sull’acqua specchiante certe loro vaghe ombre; fino ad un piccolo ponte di ferro dietro il quale le canne, i pini, i pioppi, folti e premuti gli uni contro gli altri, chiudevano il passaggio. Una casa rossa, mezzo nascosta tra gli alberi, pareva sorvegliare questo ponte.
Per un momento Agostino, nuotando in quell’acqua fredda e possente che pareva voler portar via le gambe, si sentì felice; e dimenticò ogni cruccio e ogni torto. (…)
Ma era meno forte ed esperto degli altri; e stancantosi ben presto, si lasciò andare secondo la corrente verso la foce. Presto i ragazzi con le loro grida e i loro schiamazzi gli furono alle spalle; i canneti si diradarono, l’acqua si fece limpida e incolore scoprendo il fondo sabbioso tutto percorso da fluttuanti increspature grigie. Finalmente, passata una pozza più profonda, specie di occhio verde della corrente diafana, egli mise i piedi nella sabbia e, lottando contro la forza dell’acqua, uscì sulla proda. Il fiumicello confluiva nel mare arricciandosi e formando come una groppa d’acqua. Perdendo la sua compattezza, la corrente si allargava a ventaglio, si assottigliava, non più che un velo liquido sui sabbioni lisci. Il mare risaliva il fiume con leggere onde orlate di spuma. Pozze dimenticate dalla corrente riflettevano qua e là il cielo brillante nella sabbia intatta e gonfia d’acqua. Tutto nudo, Agostino passeggiò per un poco su quelle sabbie tenere e specchianti, godendo a imprimervi con forza i piedi e a vedere l’acqua subito fiorire e allargare l’orme. Ora provava un vago, disperato desiderio di varcare il fiume e allontanarsi lungo litorale, lasciando alle sue spalle i ragazzi, il Saro, la madre e tutta la vecchia vita. Chissà che forse, camminando sempre dritto davanti a sé, lungo il mare, sulla rena bianca e soffice, non sarebbe arrivato in un paese dove tutte quelle brutte cose non esistevano. In un paese dove sarebbe stato accolto come voleva il cuore, e dove gli fosse stato possibile dimenticare tutto quanto aveva appreso, per poi riapprenderlo senza vergogna né offesa, nella maniera dolce e naturale che pur doveva esserci e che oscuramente avrebbe voluto. Guardava alla caligine che sull’orizzonte avvolgeva i termini del mare, della spiaggia e della boscaglia e si sentiva attratto da quella immensità come dalla sola cosa che avrebbe potuto liberarlo dalla presente servitù. Le grida dei ragazzi che si avviavano attraverso la spiaggia verso la barca, lo destarono da queste dolenti fantasie. Uno di loro agitava i suoi vestiti, Berto gridava: «Pisa… si parte». Si scosse e camminando lungo il mare raggiunse la banda.
Tutti i ragazzi si erano affollati nell’acqua bassa; il Saro badava ad avvertirli paternamente che la barca era troppo piccola per contenerli tutti; ma si vedeva che faceva per celia. Come infuriati, i ragazzi si gettarono gridando sulla barca, venti mani afferrarono i bordi e in un batter d’occhio la barca si trovò riempita di quei corpi gesticolanti. Alcuni si distesero sul fondo; altri si ammonticchiarono a poppa, intorno al timone; altri a prua; altri ancora sui sedili; alcuni infine si sedettero sui bordi lasciando penzolare le gambe nell’acqua. La barca era veramente troppo piccola per tanta gente e l’acqua arrivava fino quasi ai bordi.
«Allora, ci siamo tutti» disse il Saro pieno di buon umore. Ritto in piedi, sciolse la vela e la barca scivolò al largo. I ragazzi salutarono con un applauso questa partenza.
Ma Agostino non condivideva il loro buon umore. Spiava un’occasione favorevole per discolparsi e ottenere giustizia della calunnia che lo opprimeva. Approfittò di un momento che i ragazzi discutevano tra loro, per avvicinarsi al negro che se ne stava tutto solo, inerpicato a prua, e pareva, così nero, quasi una polena di nuovo genere; e stringendogli forte il braccio gli domandò: «di un po’… che cosa sei andato a dire poco fa di me?»
Il momento era mal scelto, ma Agostino non aveva potuto prima di allora avvicinare il negro, perché costui, consapevole del suo odio, durante tutto il tempo che erano stati a terra aveva fatto in modo di star lontano da lui. «Ho detto la verità» disse Holmes senza guardarlo.
«E cioè?»
Il negro ebbe una frase che spaventò Agostino: «non mi stringere, io ho detto soltanto la verità… ma se tu continuerai a metter su Saro contro di me, io andrò a raccontare ogni cosa a tua madre… sta attento Pisa».
«Che?» esclamò Agostino intuendo l’abisso che gli spalancava sotto i piedi, «cosa dici?… sei pazzo?… io… io». Balbettava incapace di seguire con le parole quello che l’immaginazione ad un tratto, come per un lurido strappo, gli mostrava. Ma non ebbe il tempo di continuare. Sulla barca era scoppiata una grande sghignazzata.
«Eccoli lì tutti e due, uno accanto all’altro» ripeteva Berto ridendo, «eccoli lì, bisognerebbe avere una macchina fotografica e fotografarli insieme, Homs e Pisa… restate, cari, restate insieme». Il viso bruciante di rossore, Agostino si voltò e vide che tutti ridevano. Lo stesso Saro sorrideva sotto i baffi, gli occhi socchiusi nel fumo del sigaro. Ritraendosi come dal contatto di un rettile, Agostino si staccò dal nero, si prese le ginocchia fra le braccia e guardò il mare con occhi pieni di lagrime.
Era ormai il tramonto, rosso e nebuloso all’orizzonte, sopra al mare violetto e percorso di luci vetrine e aguzze. La barca, nel vento che si era levato impetuoso, se ne andava come poteva, con tutti quei ragazzi a bordo che la facevano pericolosamente inclinare sopra un fianco (…) Agostino ora sentiva una pesantezza, un senso di oppressione e di chiuso dolore che il mare fresco e ventilato e l’incendio magnifico del tramonto sulle acque violette gli rendevano più amaro e insoffribile. Gli pareva sommamente ingiusto che in quel mare, sotto quel cielo, corresse una barca come la loro, così colmo di cattiveria, di crudeltà e di perfida corruzione. Quella barca traboccante di ragazzi in tutto simile a scimmie gesticolanti e oscene, con quel Saro beato e gonfio al timone, gli pareva tra il mare e il cielo, una vita triste e incredibile. A momenti si augurava che affondasse; e pensava che sarebbe morto volentieri tanto si sentiva anche lui infetto di quella impurità e come bacato (…). Si rendeva oscuramente conto di essere entrato, con quella funesta giornata, in una età di difficoltà e di miserie, ma non riusciva a immaginare quando ne sarebbe uscito.

Potremo definire questo estratto come estremamente significativo, grazie anche alla focalizzazione interna, della presa di coscienza di un mondo adulto e del “diventare” adulto di Agostino; dividiamo il brano in parti:
- all’inizio Agostino (chiamato dalla “banda” Pisa, dalla città di origine del ragazzo) si rende conto dell’esclusione sociale e culturale dei ragazzi della banda (il popolo) e della loro visione del mondo “smaliziata, violenta e impulsiva”;
- all’ingiusta accusa che i ragazzi gli muovono, egli non riesce ad opporsi e giudica i loro atteggiamenti come “animaleschi” paragonandoli alle ranocchie che avevano attirato, precedentemente la sua attenzione;
- la sua cultura borghese l’allontana, ma gli fa provare anche un terribile senso di colpa, quando Holms lo minaccia di rilevare tutto a sua madre, a cui oppone, appunto, un impacciato balbettio;
- Agostino si libera di ogni costrizione soltanto a contatto con la natura, quando fa il bagno; solo allora si sente libero, sotto il sole cocente e la trasparenza delle acque, ma questa sensazione fa a pugni con il suo tormento interiore, determinato soprattutto da un senso di repulsione/attrazione che prova verso la “banda”;
- presa di coscienza oscura e incerta del suo passaggio dall’incanto dell’infanzia al disincanto dell’adolescenza.
Intanto, sul piano politico, dopo lo sbarco anglo-americano in Sicilia, i due, Moravia e Morante, per non essere arrestati dai fascisti, tentano di raggiungere Napoli, ma sono costretti a fermarsi a Fondi (comune a sud del Lazio), dove vivono insieme a contadini e ad altri rifugiati (periodo fondamentale per l’spirazione di due grandi opere, il moraviano La ciociara e La Storia della Morante del 1974) .
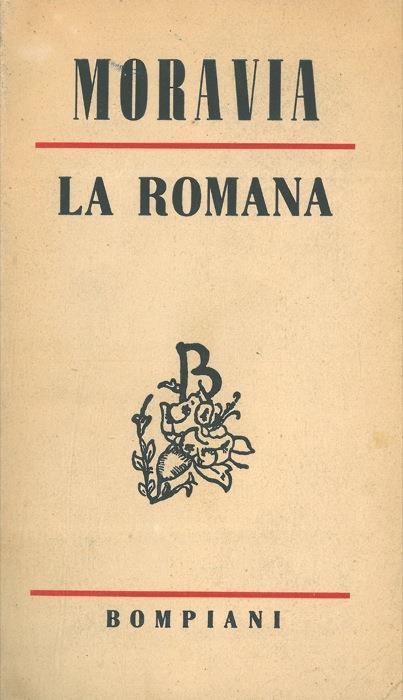
Del 1947 è La romana, romanzo che lo riconcilia con il pubblico, grazie anche al film omonimo di Luigi Zampa del 1954. Il clima cambiato dopo la liberazione e la conseguente cultura neorealista che s’impone in quegli anni (soprattutto a livello cinematografico) gli permettono di riflettere sull’elemento “popolare” (già visto, in parte in Agostino); infatti il romanzo è condotto con la voce narrante di Adriana ed il mondo è visto attraverso i suoi occhi, mentre lotta tra le sue semplici aspirazioni e quelle di sua madre che vuole per lei una vita facile e agiata, da ottenere grazie alla sua bellezza.
Il romanzo si svolge ai tempi dell’Italia fascista, ma la politica rimane nel sottofondo. La protagonista e voce narrante è Adriana, una ragazza ventenne, popolana ma di grande bellezza, che vive con la madre vedova, donna completamente disincantata da una vita di stenti, che vuole per la figlia una vita felice fatta di agi e ricchezze. Affinché Adriana possa sfruttare la sua bellezza la spinge a posare nuda per alcuni pittori, come primo passo per una scalata sociale; la ragazza entra così in contatto con un mondo mediocre ed ipocrita. Adriana, invece, ha altri sogni: vorrebbe sposarsi e vivere in tranquillità in una bella casetta, nulla di più. Ad alimentare questi desideri è Gino, un autista mal visto dalla madre di Adriana proprio per il suo lavoro. La protagonista scopre con Gino l’amore, sia sentimentale sia carnale, ma il personaggio si rivela ben presto un ipocrita essendosi finto celibe. Nel frattempo Gisella, (come lei modella) la invita a farsi mantenere (come fa lei) da gente ricca e facoltosa. Adriana comincerà quindi a frequentare uomini in cambio di denaro, oltre a dedicarsi a qualche piccolo furto. Conoscerà Astarita, un funzionario fascista che prima seduce, con la complicità della corrotta Gisella, Adriana e poi ne fa la propria accompagnatrice, (sarà lui a svelarle la situazione matrimoniale di Gino). Avviatasi sulla strada della prostituzione e riallacciati i rapporti con Gino, compie un furto nella casa dei padroni dell’amante, su sua istigazione. La restituzione della refurtiva (che aveva portato all’incriminazione di una cameriera innocente) diventa per Gino l’occasione di far soldi con il ricettattore Sonzogno, che di lì a poco, eliminato Gino, diventa il nuovo e violento amante della donna. Nel mentre, entra in scena Mino, un giovane studente antifascista. Adriana, incinta di Sonzogno, ricercato dalla polizia e dallo stesso Astarita, fa credere a Mino (cui si affeziona, e di cui rispetta gli ideali, benché le sembrino irreali ed improduttivi) che il nascituro sia suo. Incarcerato per motivi politici, Mino svela però i nomi dei compagni cospiratori; Adriana, su intercessione di Astarita, lo fa rilasciare, ma il rimorso spinge il giovane al suicidio. Sonzogno, in fuga, uccide Astarita ma poi cade in uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine: Adriana, rimasta sola in attesa del figlio che Mino, in una lettera, ha legalmente riconosciuto, può forse sperare in un futuro migliore, con l’aiuto della famiglia di Mino.
Questo romanzo inaugura una seconda fase della narrativa moraviana che si concluderà nel 1957 con un’altra memorabile figura femminile in La ciociara. Eppure, pur in questa nuova fase, Adriana non è così diversa sia dal disilluso Michele de Gli indifferenti che dall’adolescente Agostino del romanzo omonimo: anche per lei si tratta di una presa di coscienza di un mondo “altro”, quindi di una specie di “crescita” che la spinge ad accettare un mondo fatto di “sesso e di potere”. Per questo potremo dire che Moravia usi il topos della scalata sociale attraverso la prostituzione come i romanzi sette/ottocenteschi di De Defoe (Moll Flanders) e Zola (Nanà) – per non parlare del contemporaneo Il petalo cremisi e bianco di Michel Faber, scrittore olandese di lingua inglese.
IL PITTORE E LA MODELLA
A sedici anni ero una vera bellezza. Avevo il viso di un ovale perfetto, stretto alle tempie e un po’ largo in basso, gli occhi lunghi, grandi e dolci, il naso dritto in una sola linea con la fronte, la bocca grande, con le labbra belle, rosse e carnose e, se ridevo, mostravo denti regolari e molto bianchi. La mamma diceva che sembravo una madonna. Io mi accorsi che rassomigliavo a un’attrice del cinema in voga in quei tempi, e presi a pettinarmi come lei. La mamma diceva che, se il mio viso era bello, il mio corpo era cento volte più bello; un corpo come il mio, diceva, non si trovava in tutta Roma. Allora non mi curavo del mio corpo, mi pareva che la bellezza fosse tutta nel viso, ma oggi posso dire che la mamma aveva ragione. Avevo le gambe dritte e forti, i fianchi tondi, il dorso lungo, stretto alla vita e largo alle spalle. Avevo il ventre, come l’ho sempre avuto, un po’ forte, con l’ombelico che quasi non si vedeva tanto era sprofondato nella carne; ma la mamma diceva che questa era una bellezza di più, perché il ventre deve essere prominente e non piatto come si usa oggi. Anche il petto l’avevo forte ma sodo e alto, che stava su senza bisogno di reggipetto: anche del mio petto quando mi lamentavo che fosse troppo forte, la mamma diceva che era una vera bellezza, e che il petto delle donne, oggidì, non valeva nulla. Nuda, come mi fu fatto notare più tardi, ero grande e piena, formata come una statua, ma vestita parevo invece una ragazzina minuta e nessuno avrebbe potuto pensare che fossi fatta a quel modo. Ciò dipendeva, come disse il pittore per il quale incominciai a posare, dalla proporzione delle parti.
Fu la mamma che mi trovò quel pittore: prima di sposarsi e di fare la camiciaia, era stata modella; un pittore le aveva dato da fare delle camicie e lei, ricordandosi del suo antico mestiere, gli aveva proposto di farmi posare. La prima volta che mi recai dal pittore, la mamma volle accompagnarmi, sebbene protestassi che potevo benissimo andarci da sola. Provavo vergogna, non tanto di avere a spogliarmi di fronte ad un uomo per la prima volta in vita mia, quanto delle cose che prevedevo la mamma avrebbe detto per invogliare il pittore a farmi lavorare. E infatti, dopo avermi aiutata a sfilare le vesti per il capo e avermi fatta mettere tutta nuda in piedi nel mezzo dello studio, la mamma accalorata incominciò a dire al pittore: «Ma guardi che petto… che fianchi… guardi che gambe… dove li trova lei un petto, delle gambe, dei fianchi come questi?». Pur dicendo queste cose, ella mi toccava, proprio come si fa con le bestie per invogliare i compratori al mercato. Il pittore rideva, io mi vergognavo e, siccome si era d’inverno, avevo molto freddo. Ma capivo che non c’era alcuna malizia nella mamma e che lei era fiera della mia bellezza perché mi aveva messo al mondo e, se ero bella, lo dovevo a lei. Anche il pittore pareva comprendere questi sentimenti della mamma e rideva senza malignità, in maniera affettuosa, così che mi sentii subito rinfrancata e, vincendo la mia timidezza, mi avvicinai in punta di piedi alla stufa per riscaldarmi. Quel pittore poteva avere quarant’anni ed era un uomo grasso, dall’aspetto allegro e pacifico. Mi sentivo guardata da lui senza desiderio, come un oggetto, e questo mi rassicurava. Più tardi, quando mi conobbe meglio, mi trattò sempre con gentilezza e con rispetto, non più come un oggetto ma come una persona. Io provai subito molta simpatia per lui e forse avrei potuto anche innamorarmi di lui, per gratitudine, soltanto perché era così gentile e così affettuoso con me. Ma lui non mi diede mai confidenza, trattandomi da pittore e non da uomo; e i nostri rapporti, per tutto il tempo che posai per lui, restarono corretti e distanti, come il primo giorno.
Quando la mamma ebbe finito di lodarmi, il pittore, senza dir parola, andò a certi suoi scartafacci ammucchiati sopra una seggiola e, dopo aver di sfogliati, tirò fuori una stampa a colori e la mostrò alla mamma dicendo a fior di labbra: «Ecco tua figlia». Mi mossi anch’io dalla stufa per guardare la stampa. Rappresentava una donna nuda, distesa sopa un letto coperto di ricche stoffe. Dietro il letto c’era una cortina di velluto e, sospesi per aria, tra le pieghe della cortina, due putti con le ali, simili a due angioletti. La donna effettivamente mi somigliava; soltanto, sebbene fosse nuda, da quelle stoffe e anche da certi anelli che aveva sulla dita, si capiva che doveva essere stata una regina o qualche altro personaggio importante, mentre io non ero che una ragazza del popolo. La mamma dapprima non capì e guardò sconcertata la stampa. Poi, tutto ad un tratto, parve afferrare la somiglianza ed esclamò trafelata: «Proprio così… è lei… vede se avevo ragione… e chi è questa?»

Gina Lollobrigida (La romana nel film di Zampa) con i quattro attori del film che interpretano rispettivamente Gino, Astarita, Mino e Sonzogno
L’intento di Moravia è di “creare la figura di una donna piena di contraddizioni e di errori e, ciò nonostante, capace per forza ingenua di vitalità e slancio di affetto di superare queste contraddizioni e rimediare a questi errori, e giungere ad una chiaroveggenza e ad un equilibrio che ai più intelligenti e ai più dotati spesso sono negati”. Ma quello che può lasciare il lettore perpelesso è la non perfetta aderenza tra i pensieri e la “bassa cultura” di Adriana. Infatti sin dall’incipit emerge la sua semplicità, ma in altri passi la sua consapevolezza sembra oltrepassi tale ingenuità, lasciando scoperto il pensiero autorale.
Di tale incongruenza se ne accorge anche la critica: “(…) ne La romana, si potrebbe parlare di una contaminazione tra neorealismo ed esistenzialismo negativo, dove l’esistenzialismo potrebbe entrare in funzione di uno specchio deformante di fronte al dato realistico della scottante materia su cui è costruita la trama (…). Più che altrove risulta chiaro, in questa creatura primitiva che, nonostante la sua dichiarata professione, ragioni a tratti come un filosofo esistenzialista largamente dotato di introspezione psicologica, il singolare processo di sovrapposizione e di identificazione in virtù del quale l’autore stesso si sostituisce, consapevolmente, pare, alla sua protagonista, alterandone in senso artisticamente negativo, la schietta fisionomia popolana”. (Ines Scaramucci). Inoltre ciò che si rimprovera all’autore è che il lungo romanzo sembri la sovrapposizione di più romanzi brevi, in ognuno dei quali Adriana racconta le sue storie d’amore con ogni uomo con cui si è relazionata (Gino, Astarita, Sonzogno, Mino); inoltre la critica ha sottolineato un eccessivo ricorso al “romanzesco” – si veda il finale – piuttosto che la capacità di renderci un personaggio “vivo”. Ciò non gli toglie tuttavia la sua grande attenzione verso il mondo femminile, che sa descrivere sempre mostrando la sua abilità nel coglierne anche le più piccole sfumature.
Dopo La Romana, in successione annuale, dà alle stampe due brevi romanzi sui quali aveva lavorato sin dai tempi di Capri, La disubbidienza, stampato nel ’48 e L’amore coniugale nel ’49.
Ne La disubbidienza il giovane protagonista è Luca, di quindici anni, (poco più grande rispetto ad Agostino, che ne ha tredici) di cui si racconta la difficoltà della crescita e il tortuoso cammino dell’adolescenza. Nato in un’agiata famiglia borghese, affettuosa ma incapace di comprendere le reali esigenze del ragazzo, Luca vive con sgomento il desiderio di ribellione che lo porta a gesti incomprensibili per i genitori ma anche per sé: inizia a disfarsi di giocattoli e di oggetti a lui cari; si disinteressa della scuola che prima era sempre stata al primo posto. A tali forme di ribellione, si aggiunge poi l’intenzione di scoprire l’erotismo, e Luca sceglie la governante di casa, non più giovanissima, non particolarmente avvenente, ma così attraente per gli occhi ingenui del ragazzo. Tra ripugnanza e curiosità, Luca accetta le attenzioni della donna, che tuttavia si ammala presto. E’ questa l’occasione perché Luca inizi a pensare alla morte e al sentimento del distacco… Una caduta in una depressione giovanile, quindi, forse insanabile, se al suo capezzale non fossero giunte le cure di un’infermiera amorevole, generosa, ora materna ora quasi seducente. Sarà con lei che Luca riuscirà a scoprire l’amore fisico, superando quel senso di disgusto iniziale, e sentendosi finalmente un uomo.

Luca è senza dubbio il fratello maggiore di Agostino, se infatti quest’ultimo è ancora un bambino che attraversa una fase che lo condurrà all’adolescenza (scoperta disincantata della realtà), il primo è un ragazzo nella piena temperie adolescenziale che si “opporrà” (disubbiderà) al mondo. Afferma Manacorda: “Come Agostino, è la storia di un’iniziazione liberatrice, anche se ne sono spostati i termini, ché là si trattava dell’affrancamento da un ovattata tenerezza materna con tutte le sue implicazioni psicologiche ed economiche, qui del superamento di un complesso di inferiorità fisica. Questa condizione del protagonista determina una decisione di «sciopero» nei confronti della vita, con un’inconscia ma sintomatica applicazione della tecnica della lotta sociale alla individuale lotta per la vita. Luca, il protagonista, si astiene dalla vita, ma non per stoica saggezza sibbene per una sua incapacità ad inserirvi, a comunicare, che ha un’iniziale motivazione fisiologica cui la successiva coscienza della ripugnanza della società della quale dovrebbe entrare a far parte finisce per conferire una giustificazione sul piano non più soltanto naturale ma storico”.
IL RIFIUTO DELL’IDEOLOGIA BORGESE
Egli avrebbe sotterrato il denaro nel luogo stesso dove un tempo aveva pensato che avesse giaciuto l’assassinato; e seppellendoli il denaro, in un certo senso vi avrebbe sepolto anche se stesso; o, almeno, quella parte di se stesso che era attaccata al denaro. Vagamente, inoltre, a questi propositi più seri, si mescolavano ricordi di tesori sepolti in circostanze avventurose, echi di letture della sua prima adolescenza.
Era lo Scarabeo d’oro di Poe che soprattutto aveva in mente. Ma come una specie di alibi, rivolto a togliere ogni tragicità al sacrificio, e tenerlo nei limiti del gioco. Oltre al denaro, aveva portato seco una boccetta di vetro azzurro dentro la quale aveva chiuso una carta con la spiegazione del luogo dove avrebbe sotterrato il suo piccolo tesoro. Ignaro di criptogrammi, Luca si era accontentato di scrivere la spiegazione in gergo scolastico, aggiungendo una effe ad ogni sillaba. Questa boccetta, come nella novella, l’avrebbe nascosta nel cavo di uno degli elci che circondavano il piazzale.
Attraversò un grande prato quadrato guardando davanti a sé. In fondo al prato, il bosco d’elci si agitava di qua e di là con i suoi tronchi neri come una folla in preda al panico la quale ondeggi prima di fuggire. (…) Entrò nel bosco godendo a camminare sull’erto strato di foglie morte. Nel silenzio del sottobosco udì un fischio sottile di uccello; e poi, volgendosi, vide l’uccello stesso, grosso e nero, saltellare in terra e quindi levarsi a volo e nascondersi tra le foglie. Notò pure che, avviandosi per il bosco, provava una sensazione di libertà; e pensò che era bello agire, sia pure per distruggere la propria vita; e che agire era proprio questo: compiere atti secondo idee e non per necessità.
Nel piazzale non c’era nessuno. Egli vi si aggirò un momento pensando al tempo in cui aveva avuto la certezza del morto sepolto, e gli parve di ritrovare intatta l’aria romita e un po’ sinistra che durante l’infanzia l’aveva sedotto. Ecco il muro decorativo, con le nicchie vuote, le lapidi spezzate, le cornici sgretolate. Ecco i finestroni coi sedili e le grosse inferriate. Egli si arrampicò fino a una di quelle finestre e guardò dall’altra parte, nel giardino zoologico. C’era il fogliame fitto di una siepe di lauri, ma tra le foglie, gli parve di intravvedere le penne verdi e dorate di un grosso uccello esotico. Un ruggito lontano lo fece trasalire: le belve come allora, come sempre, avevano fame. Scese dalla finestra e si avvicinò al luogo designato. C’era tuttora lo stesso elce vetusto, sventrato in una grande apertura nera, con il ramo principale proteso verso il piazzale e appoggiato ad un sostegno di mattoni come il braccio di uno zoppo sopra una stampella. Sotto l’elce, c’era il morto. Tutto ad un tratto gli tornò il senso crudele e patetico di esservi stato sepolto lui, assassinato senza pietà.
Si inginocchiò sotto l’albero con un temperino prese a scavare una buca. Sotto il fogliame morto, la terra era fradicia e leggera, tutta piena di frantumi marciti di corteccia. Egli smuoveva la terra e poi con la mano la toglieva e la metteva da parte, in un piccolo mucchio. Terminata la buca, tolse lentamente di tasca i biglietti da banca e prese a lacerarli uno dopo l’altro, lasciando cadere i pezzi in fondo alla buca. Scoprì di provare per quel denaro un odio profondo; come si odia qualcuno che ci ha dominato e contro cui ci si è ribellati. Anche l’idea che il denaro fosse tenuto in tanta considerazione dai genitori e che lui, senza saperlo, per tanti anni, avesse pregato davanti a un forziere pieno di quel denaro, contribuiva al suo risentimento. Lacerando quei biglietti, sentiva di vendicare le sue preghiere, di compiere una riparazione. Ma anche il denaro era sacro; seppure in una maniera tutta diversa dall’immagine sacra che gliel’aveva nascosto mentre pregava. Era sacro per quelle effigi regali e quei simboli che ne garantivano il valore; ed era sacro perché avrebbe potuto essere felicità per tante persone. Per il povero, per esempio, che ogni mattina quando andava a scuola gli tendeva la mano all’angolo della strada. Ma darlo ad un povero sarebbe stato in fondo rispettarlo, confermarne il valore. E invece Luca voleva veramente distruggerlo, non soltanto nel proprio desiderio ma anche nella realtà. Idolo odiato, come sentiva, non ci voleva meno di quella lacerazione profanatoria, per sconsacrarlo definitivamente.
Quando ebbe finito di stracciare i biglietti, mescolò i pezzi e poi, tratta di tasca una busta piena di monete di argento, la ficcò in fondo alla buca sopra i biglietti. Compiva questi gesti con un senso di rigore grave e consapevole, seppure mescolato di mortale tristezza. Gli tornò in mente il morto assassinato e sepolto e di nuovo l’assalì quella strana pietà per se stesso. Intanto riempiva di terra la buca. Finito che ebbe, pareggiò il suolo e ricoprì ogni cosa con il tappeto delle foglie morte.
Si levò spolverandoli le ginocchia bagnate e sporche di terra e allora si ricordò della boccetta di vetro turchino e della novella di Poe. Ma questa volta gli mancò il coraggio di eseguire quella parte del piano. Provava una tristezza funebre e ammaliata e capiva che, dopo tutto, non era stato un gioco. Lui non era il corsaro sanguinario e insensibile alla fine di una vita di avventure e di libertà; quel piazzale non era il litorale deserto di una terra selvatica; infine nessuno avrebbe mai scoperto con gioia il suo povero tesoro di biglietti stracciati e di monetine d’argento. La mediocrità di se stesso, del luogo e del tesoro gli parve ad un tratto la prova migliore della serietà strenua di quanto andava facendo e dell’impossibilità di illudersi attribuendogli il valore di un gioco. Trasse di tasca la boccetta, l’aprì, tolse il cartiglio, e lo stracciò in pezzi minuti. La boccetta la schiacciò sotto il tacco. Allontanandosi, gli parve di aver agito come un pazzo. Tuttavia doveva esserci un senso in questa pazzia soltanto lui non era ancora in grado di scoprirlo.

Scena de “La disubbidienza” di Aldo Lado (1981)
Qui il protagonista, che già precedentemente aveva dato prova di volersi liberare di tutte quelle “qualità borghesi” che, come fossero nuovi totem della classe al potere, lo portano a “disubbidire” loro, porta alle estreme conseguenze questo atto: cancellare, sminuzzando e seppellendo il denaro, sminuzza e seppellisce il dio in cui credono i suoi genitori (nascondono i soldi dietro un’icona religiosa, cui Luca rivolgeva le sue preghiere) e quindi “cancella” le figure genitoriali e cancellandole, rende se stesso, che di quella classe fa parte, un morto. L’azione che in questo passo compie è infatti estremamente ritualizzata e il terreno dove sotterra il denaro viene immaginato come il terreno su cui verrà seppellito un morto che Luca identifica come se stesso.
L’amore coniugale e altri racconti, pubblicato, com’è stato già detto nel ’49, può certamente definirsi un metaromanzo:
La storia è ambientata in una villa in Toscana, negli anni Trenta del secolo scorso. L’io narrante, Silvio Baldeschi, scrittore maturo e agiato, coltiva ambizioni letterarie, la moglie, Leda (nell’intimità Dina), è un’anima più semplice disinteressata al mondo della letteratura e dell’arte; nonostante questo il marito si fida molto del suo giudizio critico. Tutte le sere i due fanno l’amore in modo appassionato, ma ciò sembra togliere all’uomo la forza creativa necessaria per scrivere: convinto che le difficoltà che incontra davanti al foglio bianco derivino dalle fatiche del sesso, che lo svuotano completamente di energie, egli lo comunica alla moglie, quindi si concede un periodo di castità, per trovare le energie per scrivere. La moglie accoglie la proposta di Silvio con convinzione e lo incoraggia a perseguire la carriera di scrittore. Silvio si fa redere giornalmente dal barbiere del borgo in cui è situata la villa. Antonio. Il barbiere è un uomo pingue, piuttosto comune, dai lineamenti grossolani, che ha una famiglia con cinque figli a carico, ma in paese ha fama di essere un donnaiolo, un libertino, un erotomane. Leda confessa al marito di essere stata molestata dall’uomo e gli chiede di licenziarlo. Al principio non può credere che la moglie possa cedere al desiderio di quell’uomo rozzo, ma lei chiede di licenziarlo perché le confessa di essere stata molestata. Silvio tergiversa, quello che conta è aver trovato l’energia letteraria. Termina il romanzo, da lui intitolato L’amore coniugale, ma non lo soddisfa. Un giorno vede il barbiere e la moglie abbandonarsi sul fieno, non prova gelosia, ma solo insoddisfazione. In lui prevale il sentimento di sconfitta sia come marito che come scrittore.
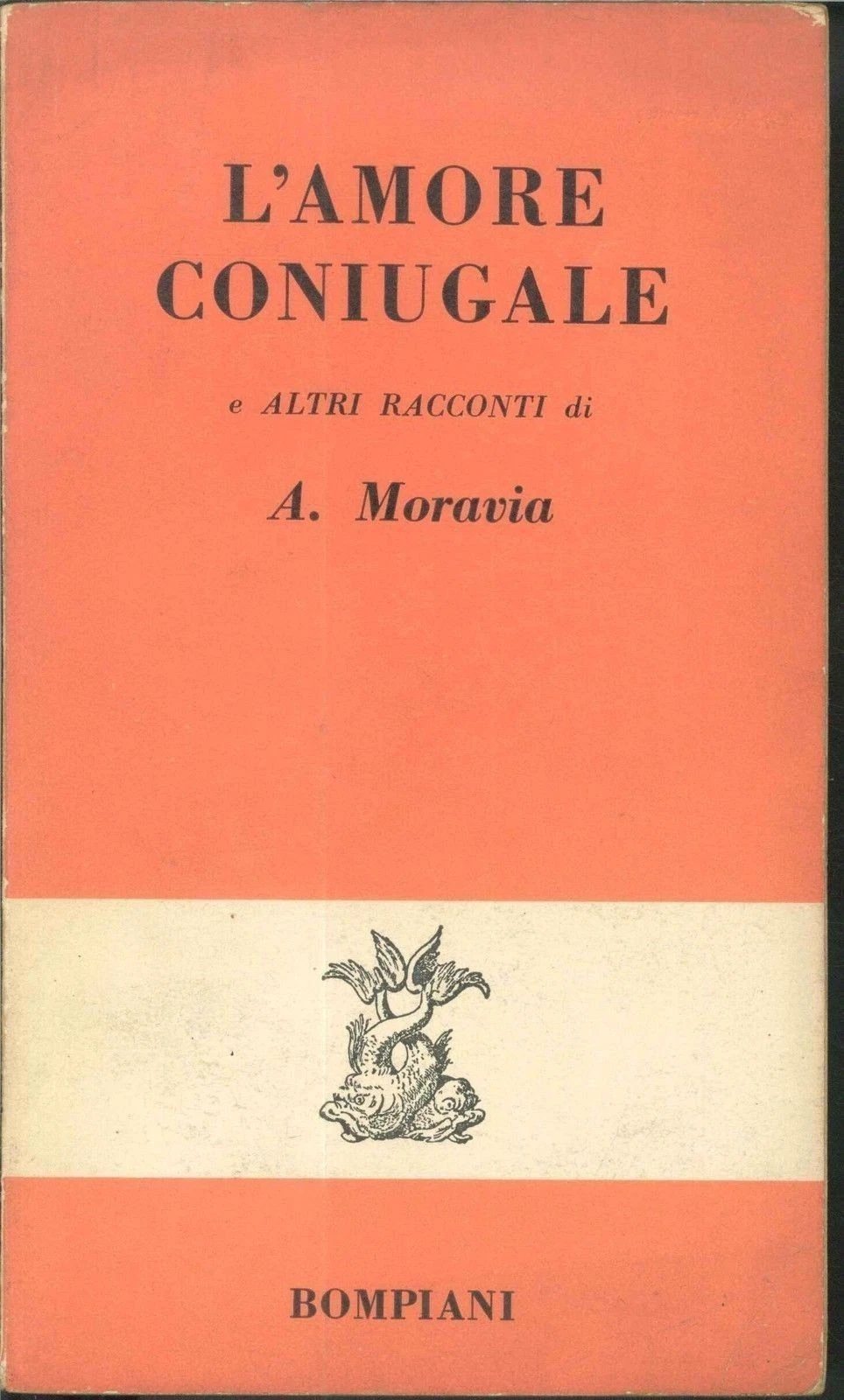
La vicenda, che ripercorre un po’ il topos della donna che “impedisce”, grazie alla sua potenza erotica, la possibilità creatrice dell’uomo (lo abbiamo letto nel primo Verga e in D’Annunzio) acquista qui un valore freudiano:
AMORE E CREAZIONE ARTISTICA
C’è nell’opera di Poe una novella che torna acconcia per descrivere la condizione del mio animo in quel tempo: è quella in cui è descritta l’avventura di un pescatore attirato con il proprio battello nelle spire di un vortice marino. Egli gira con la barca tutt’intorno le pareti del baratro e insieme con lui, sopra, accanto e sotto, girano innumerevoli relitti di precedenti naufragi. Egli sa che girando si avvicina sempre più al fondo del vortice dove l’aspetta la morte, e sa quale sia l’origine di quei relitti. Ebbene la mia vita poteva paragonarsi ad un costante vortice. Io ero preso nelle spire di un nero imbuto e sopra, sotto e accanto a me vedevo girare con me tutte le cose che amavo. Quelle cose di cui, secondo gli altri, vivevo e che invece vedevo travolte con me nello stesso strano naufragio. Io sentivo di girare in cerchio con quanto di bello e di buono è stato creato al mondo e non cessavo un sol momento di vedere il fondo nero dell’imbuto che prometteva a me e a tutti gli altri relitti una fine inevitabile. C’erano momenti in cui il vortice sembrava restringersi, appianarsi, girare più lentamente e restituirmi alla superficie calma della vita quotidiana; c’erano altri momenti, invece, in cui i giri si facevano più rapidi e più profondi e io allora scendevo girando sempre più in basso e con me scendevano tutte le opere e le ragioni umane e io quasi desideravo di essere inghiottito definitivamente. In gioventù queste crisi erano frequenti e posso dire che non c’è stato giorno, tra i venti e i trent’anni, in cui io non abbia accarezzato l’idea del suicidio. Nnaturalmente io non volevo nella realtà uccidermi (altrimenti mi sarei ucciso davvero), ma questa ossessione del suicidio era purtuttavia il colore dominante del mio passaggio interiore.
Ai rimedi pensai più volte; e ben presto mi resi conto che soltanto due cose avrebbero potuto salvarmi: l’amore di una donna e la creazione artistica. Sembrerà un po’ ridicolo che io nomini due cose così importanti in maniera tanto sbrigativa, come se si trattasse di due comuni medicine da acquistarsi in qualsiasi farmacia; ma questa sommaria definizione non rivela se non la grande chiarezza a cui, verso i trentacinque anni, ero giunto circa i problemi della mia vita. All’amore mi pareva di aver diritto come tutti gli altri uomini di questa terra; e alla creazione artistica ero convinto di essere portato per natura dai miei gusti e anche da un talento che nei momenti migliori mi illudevo di possedere.
Ora avvenne invece che io non oltrapassassi mai le due o tre prime pagine di qualsiasi composizione; e con le donne non raggiungessi mai quel sentimento profondo che convince noi stessi e gli altri. Ciò che mi nuoveva di più negli approcci sentimentali e creativi era proprio quella facilità dell’entusiasmo altrettanto pronto ad accendersi quanto rapido a cadere. Quante volte a un bacio strappato da labbra ritrose, a due o tre pagine scritte di furia, mi parve di aver trovato quel che cercavo. Ma poi, con la donna, scivolavo subito in un sentimentalismo verboso che finiva per allontanarla da me; e sulla pagina mi perdevo in sofismi, oppure in una abbondanza di parole cui mi induceva, in mancanza di seria ispirazione, una momentanea facilità. Avevo il primo impeto buono che ingannava me e gli altri, a cui poi subentrava non so che fiacchezza fredda e generica. E io mi accorgevo che in realtà non avevo tanto amato e scritto quanto voluto amare e scrivere. Talvolta trovavo anche la donna che per tornaconto e per compassione sarebbe stata disposta a lasciarsi ingannare e a ingannarmi; tal’altra la pagina sembrava resistere e invitarmi a proseguire. Ma ho questo di buono almeno: una coscienza diffidente che mi ferma a tempo sulla strada dell’illusione. Strappavo le pagine e con un protesto cessavo di frequentare la donna. Così, in questi tentativi passò la giovinezza.
Il rapporto di coppia, la crisi del matrimonio borghese, il difficile rapporto uomo-donna, il tradimento e il fallimento esistenziale sono gli altri fondamentali temi affrontati da Moravia in questo piccolo romanzo, dove lo scrittore romano mette in luce una grande capacità di introspezione psicologica. Con la rinuncia momentanea al sesso, in favore della creazione artistica, Moravia ci introduce al tema freudiano e dunque psicoanalitico della sublimazione. In Moravia, infatti, il sesso è usato come la chiave per comprendere la realtà. La donna ha un’esistenza più naturale dell’uomo, animata dall’istinto, un’innocenza che talvolta si muta in “crudeltà”, “determinazione fredda e brutale, senza scrupoli di delicatezza”, assenza di “semplice buon gusto”. E in queste caratteristiche la donna manifesta il suo fascino e il suo mistero. Le idee di Moravia sulla donna sono note. Nell’Intervista sullo scrittore scomodo (a cura di Nello Ajello) pubblicata da Laterza nel 1978 affermò: “Per un romanziere, la donna è interessante in quanto selvaggia, o almeno per metà selvaggia, cioè non totalmente integrata nella società. Lasciamo stare le ragioni storiche che hanno prodotto questo suo mezzo apartheid: sono d’altronde piuttosto evidenti. Questo carattere semi-indomito, semi-selvaggio rende la donna, già di per sé, un personaggio drammatico.”
Interessanti sono anche le pagine, contenute all’interno del racconto, in cui l’autore ci suggerisce il metodo per analizzare e recensire correttamente un testo letterario.

Nel 1952 la casa editrice decide di raccogliere tutti i racconti di Moravia in un unico testo, in due volumi. L’opera ricevette il Premio Strega, suscitando il risentimento di Gadda nei confronti dello scrittore romano. Lo stesso ci dice che il premio gli venne dato non perché la sua opera fosse migliore di quella di Gadda (arrivato secondo con Quer pasticciaccio brutto di via Merulana) , ma come “protesta” contro l’autorità ecclesiastica che aveva messo all’indice la sua opera, sottolineando l’incongruità di tale istituto censorio. Tra i racconti c’è uno in particolare che mette in luce il dibattito culturale che puntualizza la posizione degli intellettuali nel dopoguerra verso il popolo, quello che efficacemente può essere sintetizzato dal titolo di un famoso saggio di Alberto Asor Rosa Scrittori e popolo (1965):
ANDARE VERSO IL POPOLO
La macchina si fermò ed essi discesero. La strada in quel punto passava davanti ad una gola angusta formata dalla confluenza di due mediocri montagne incolte e sassose. Dall’altra parte la pianura allagata si stendeva a perdita d’occhio con larghi specchi d’acqua grigia e gelata alternati a ciuffi di cespugli e gruppi di alberi fronzuti. Qualche rovina di casa emergeva dalle acque, melanconicamente specchiandosi i muri sgretolati e le finestre piene di cielo. Allagata era pure la gola montuosa; ma in fondo, laddove le due montagne si congiungevano, un fumo azzurro si levava a mezza costa e stagnava per l’aria. A prima vista si pensava al braciere di un carbonaio; poi guardandolo meglio, si distingueva una capanna incappucciata dal basso tetto di paglia annerita. Era il tramonto, una nuvolaglia fredda e oscura ricopriva il cielo. L’aria era immobile e come intirizzita. Tra l’inondazione e la gola montuosa, il nastro di asfalto nero della strada descriveva un esse che pareva il guizzo di un rettile che cercasse con ogni forza di fuggire.
«Bisogna andare fino a quella capanna lassù», disse il giovane indicando il fumo azzurro sul pendio, «lì potranno darci un secchio e dell’acqua.»
La ragazza fece una smorfia di scontento. Aveva una faccia tonda, con una bocca capricciosa, un piccolo naso aquilino, e occhi grandi e inespressivi, a fior di testa. Alta, il cappotto a grandi scacchi scozzesi le modellava morbidamente i contorni dei fianchi opulenti e del petto florido. Era senza cappello e i capelli lunghi e bruni le si arricciavano tutt’intorno la fronte e le guance come una graziosa criniera. «Non puoi prendere l’acqua con qualche altro mezzo senza andare lassù?» domandò imbronciata.
«Con quale mezzo?» domandò il compagno. Non aveva più di vent’anni, ma nei grossi tratti del viso magro, nei forti baffi neri, nella voce nasale, dimostrava già qualche cosa di petulantemente virile. Anche lui era vestito alla moda sportiva, a scacchi, con la giacca a vento di cuoio, i pantaloni sbuffanti, e i calzettoni e un basco calcato sugli occhi.
«Arrangiati,» e la rispose stringendosi nelle spalle.
«Come? con le mani?» Egli domandò ironicamente. Ella non disse nulla, si guardava intorno e pareva malcontenta. «Io lo so,» disse ad un tratto, «queste fermate si rassomigliano tutte… Per un motivo o per un’altro andiamo alla casa del contadino… Ma poi, a mezza strada, cerchi sempre di baciarmi».
Il compagno scosse la testa, ma pareva lusingato dall’accusa.
«Su, Ornella,» disse con serietà finta e sforzata, «ti giuro che questa volta andiamo veramente per prendere l’acqua… del resto,» guardando un grosso cronometro d’oro che teneva al polso, «non abbiamo tanto tempo da perdere se vogliamo essere in città per l’ora di cena… deciditi… se vuoi, puoi aspettarmi qui.»
«Sì, tutta sola,» ella proferì in tono riottoso, «e poi passano le macchine dei militari e mi danno fastidio come stamattina… e tu intanto fai le tue inchieste sui contadini… chiacchieri con loro e ti dimentichi della mia esistenza.»
«Ma insomma,» la perpessità del giovane suonava falsa perché agli pareva oltremodo sicuro di se stesso, «se non vuoi aspettare perchè temi che i militari di diano fastidio… no vuoi venire con me perché temi che ti baci… si può sapere cosa vuoi?»
«Vengo,» ella si decise improvvisamente con una scontrosa civetteria, «se mi prometti di star buono.»
«Te lo giuro.»
«Allora andiamo.»
Egli chiuse lo sportello della macchina e si avviò per il sentiero che portava alla capanna. La ragazza lo seguì, camminando malferma sui sassi.
«Io mi domando,» disse il giovane precedendola, «di che cosa possano vivere i contadini che abitano questa capanna. Coltivazione non ce n’è, né qui né per molto spazio intorno. La pianura è allagata. Mah, mistero.»«Vivranno di rendita,» rispose la ragazza aggrappandosi con le unghie alla manica del giovane per non cadere.
«Ti ho già detto tante volte, Ornella,» egli la rimproverò, «che non mi piace la tua mancanza sensibilità di fronte alle sofferenze della povera gente… che diamine… sembra che tu lo faccia apposta.»
«Quel che m’importa,» ella disse fingendo di non aver udito, «è che tu non ti fermi come al solito a fare le tue eterne domande ai contadini… non posso soffrire i contadini.»
«Invece bisogna parlarci,» rispose il giovane, «a parlarci si vengono a sapere una quantità di cose interessanti.»
«Interessanti per te.»
«Ma non lo sai,» egli disse leggermente e quasi ironicamente, «che bisogna andare verso il popolo?»
Adesso erano a mezza via tra la capanna e la strada maestra. Si vedeva distintamente il fumo azzurro uscire non già da un comignolo ma dai fianchi gonfi del basso tetto di paglia. Il sentiero correva a mezza costa. Cinquante metri più giù l’acqua che allagava la gola non rifletteva il cielo bensì lasciava intravvedere, in una trasparenza gelata, l’erba avara, di un verde opaco, che tappezzava il suolo. «Che brutto posto,» disse la ragazza rabbrividendo e guardandosi intorno.
Dalla cima di uno dei monti, si levò un grande uccello nero, e cominciò a scendere ad ali spiegate e immobili, in lenti giri, verso il fondo della gola. «Che importa,» disse il compagno goffamente, «ci siamo noi.» In così dire, si voltò, passò un braccio intorno alla vita della ragazza e l’attirò a sé.
«Ecco… e tu mi avevi giurato che non l’avresti fatto,» ella gridò. Il giovane sorrise e tentò di baciarla. Ella gli mise la palma della mano aperta sulla faccia, cercando di respingerlo. In questo gesto sconvolgeva il bel viso in una smorfia di accanimento e di ripugnanza. Ma gesto e smorfia parevano più che altro civetterie, ripulse convenzionali. Il giovane, nonostante quella mano puntata sulla faccia, avvicinava sempre più le proprie labbra alle sue. Ella cambiò gesto e, con piccoli pugni, presi a tempestargli di colpi la faccia. Ma anche i colpi erano deboli e senza convinzione. Più che veramente ritrosa e sdegnata, ella pareva fingere sdegno e ritrosia. E infatti, dopo un momento, cessò di colpirlo e si lasciò baciare di buona grazia, chiudendo gli occhi e cingendolo il collo con un braccio. «Questi orribili baffi,» disse subito, come si separarono.
«Questo orribile rossetto,» egli rispose in tono vanitoso, asciugandosi la bocca e guardando le macchie di rossetto che restavano sul fazzoletto.
Ripresero a camminare verso la capanna. Ora avevano percorso tre quarti del sentiero e la strada maestra appariva quasi remota, con la macchina piccola e scura ferma presso il fossato, nella luce bassa del tramonto temporalesco. Di lassù si vedeva anche maggiore estensione di pianura allagata. E altri cespugli, altri gruppi di alberi, altre rovine di case che si specchiavano tristemente nelle acque grigie e immobili.
Il giovane la precedeva dondolandosi sui fianchi, con una vanità così visibile che ella, ad un tratto, si irritò fortemente. «Meriteresti che io tornassi indietro,» disse fermandosi e battendo i piedi in terra
«Provaci.»
«E’ quello che faccio.»
Ella si voltò e prese a camminare, incespicando, in direzione della strada maestra. Il giovane la raggiunse, la prese per un braccio e guardandola con attenzione sufficiente e ironica: «Ornella, è mai possibile che tu debba sempre fare i capricci?»
«E tu perché mi hai baciata,» ella domandò già arresa.
Ormai erano giunti alla capanna, una base circolare di pietre murate a secco e un tetto di paglia scura, conico che giungeva fin quasi a terra. La porta, piccola e bassa, schiacciata da un architrave formato da una pietra più grossa delle altre, faceva pensare piuttosto ad una stalla per animali che ad un’abitazione umana. Un albero completamente morto e secco, col tronco denudato di corteccia e rami ridotti a spuntoni forcuti, si inclinava verso la capanna. Infilate per i manichi in quegli spuntoni, pendevano due o tre marmitte annerite, qualche tazza e una pignatta di terracotta. Un’ascia da boscaiolo era appesa per il ferro in un’inforcatura dell’albero. In cima al ramo più alto si scorgeva un grande teschio di animale infilato per l’orbita in uno stecco coi denti lunghi e bianchi alzati verso il cielo tetro. Altro ossame, costole, vertebre, tibie, teschi, fiancheggiava sparso dovunque sullo spiazzo davanti la capanna. Nel mezzo del quale un cerchio nero di tizzoni spenti e due o tre ceppi d’albero disposti come sedili suggerivano l’idea di gente radunata intorno un fuoco.
«E ora,» domandò la ragazza girandosi e guardandosi intorno con ripugnanza, «cosa facciamo?»
«Bussiamo e ci facciamo ricevere dal padrone di casa,» rispose il compagno con soddisfazione. Egli andò all’uscio della capanna e bussò col pugno.
Quasi subito la porta si dischiuse, tentennò e si aprì del tutto. Ma nessuno comparve. «Ehi,» gridò il giovane con petulanza, chinandosi spingendo lo sguardo nell’interno della capanna, «ehi, di casa, c’è nessuno?»

«Vieni, vieni, vieni pure avanti signorino,» rispose una voce stridula, smagliata, allegra.
«Su entriamo,» disse il giovane. «Entrare lì dentro?» ella domandò con ribrezzo. «Quante storie, entriamo,» egli ripeté prendendola per un braccio. La fanciulla ubbidì e chinando il capo e le spalle entrò nella capanna. Dopo di lei entrò il compagno.
Per un momento stettero ritti, le spalle alla porta. Un fuoco vivace ardeva in terra, sotto un tripode di ferro sormontato da una grossa pentola nera. Tutt’intorno la pentola, la ragazza, piena di impaccio e di ripugnanza, vide varie facce che il fuoco illuminava inegualmente. Erano facce di ragazzi, ma gonfie, rudi, con gli occhi piccoli e i capelli arruffati, pesanti, come ingrommati. Tra i suoi figli che le stavano aggrappati addosso e guardavano in silenzio i visitatori, la madre si sporgeva a girare con le due mani in un lungo mestolo nella pentola; e come la fanciulla ebbe rivolto gli occhi verso di lei, rabbrividì pensosamente.
Aveva una testa da far pensare a quelle bambole di stoffa e di segatura che per l’uso e gli strapazzi si anneriscono e si sformano senza tuttavia rompersi. Sul viso gonfio e piatto gli occhi piccoli, straordinariamente scintillanti, si perdevano in un mare di grinze sottili. Dalla gran bocca ridente spuntava un solo dente lungo e giallo. I capelli le stavano ritti tutt’intorno la testa, come tanti spilli intorno un puntaspilli. C’era una certa bonarietà in quel viso; ma corretta da una inquietante ed ilare eccitazione. E i bagliori rossi del fuoco, illuminandola a tratti secondo i movimenti delle fiamme, le davano un aspetto di apparizione, come di strega affaccendata intorno alla sua caldaia. «Buonasera, buonasera,» ella ripeté con voce strillante.
«Siete voi la padrona di casa?» domandò il giovane. Anche lui era sconcertato dall’aspetto della donna, ma non voleva mostrarlo.
«I tedeschi ci hanno distrutto la casa, ci hanno allagato il podere, ci hanno portato via le bestie, ci hanno rubato la roba… questa era la stalla delle capre, signorino», gridò la donna con impetuosa allegria.
«E ora come fate?» domandò il giovane. La fanciulla, riconoscendo l’inizio di uno di quei suoi interminabili interrogatori, ebbe una smorfia di noia e gli diede col gomito un colpo sul braccio. Ma lui fece un gesto col capo come per dire: “lasciami in pace.” La fanciulla levò gli occhi al cielo e sospirò. «Come facciamo,» continuava intanto la donna, «non sappiamo come fare… mio marito ha la malaria e non può lavorare… i miei figli non hanno vestiti, non hanno scarpe, vanno in giro nudi,» ed indicò gli stracci bucati, i piedi nudi e neri dei figli, «abbiamo finito proprio ieri la farina… guarda;» si alzò, andò in un angolo della capanna e ne tornò con un secchio vuoto che scosse per aria sprigionando una nuvola di bianca polvere. «E’ proprio finita,» ripeté soddisfatta buttando via il sacco. E poi, sporgendo la faccia ridente verso la fanciulla, con una esplosione più forte di quella sua ingiustificata allegria: «Come faremo?… moriremo di fame.»
«Morirete di fame,» ripeté il giovane ormai del tutto assorbito dal dialogo, «ma vediamo… non potete andare al paese più vicino e farvi dare la roba della tessera?»
«Il paese vicino l’hanno distrutto le bombe,» gridò la donna con fervore, «le bombe l’hanno distrutto… e la roba della tessera non c’è, ci sono soltanto le tessere… la roba è per chi paga… e noi non abbiamo quattrini, signorino.»
Queste informazioni fornite con tanto entusiasmo sembravano destare nel giovane uno scomodo malessere; visibilmente, egli avrebbe preferito che non fossero vere. «Eppure i vostri figli non hanno l’aspetto patito e neppure voi,» egli osservò. Effettivamente, la donna sembrava corpulenta, della maniera sformata, appunto, delle bambole di stoffa e di segatura. E i ragazzi erano tutte e quattro pasciuti, seppure in un loro modo torvo.
«Non siamo patiti perché i miei figli trovano la roba,» gridò la donna con rinnovata allegria.
«E in che modo?»
«Rubano, signorino,» gridò la donna con lo stesso entusiasmo con il quale prima aveva strillato: “Muoiono di fame.”
«Andiamo via,» mormorò la ragazza spaurita. Ma il giovane non le diede retta, sebbene fosse anche lui sconcertato. «E che rubano» domandò cercando di dare alla sua voce un’intonazione di normale curiosità.
«Eh, signorino, quello che possono… quello che c’è… adesso sulla montagna ci sono molte bestie… rubano i capretti e gli agnelli… vanno di notte e rubano i capretti e gli agnelli.» «Ma i pastori» domandò il giovane «non se ne accorgono?»
«I pastori no, che non se ne accorgono… se ne accorgono dopo, signorino… loro le bestie le chiudono, ma i miei figli vanno di notte, aprono le porte delle stalle e si pigliano gli agnelli e i capretti.»
«Vi arresteranno,» disse il giovane con improvvisa severità.
«E come fanno ad arrestarci? Non ci sono più carabinieri,» l’entusiasmo della donna pareva al colmo «e poi le guardie hanno fame anche loro,» soggiunse strillando come se il giovane fosse stato sordo, «tutti hanno fame oggi, signorino, tutti.»
«Ma rubare è brutto, è un delitto,» egli insistette con ostinazione.
«Rubare è brutto,» gridò la donna quasi affettuosamente, «ma morire di fame è più brutto ancora, signorino.»
«Ma smettila, smettila una buona volta, e andiamo via,» disse la ragazza. Aveva parlato quasi ad alta voce e la donna l’udì. «Non ti piace la capanna, eh signorina,» gridò «ma siamo in campagna… compatire e perdonare bisogna… perdonare e compatire.»
«La signorina ha fretta perché dobbiamo tornare a casa,» disse il giovane.
«La signorina è bella,» gridò la donna con entusiasmo, «la signorina è ben vestita… non ti trovi bene, eh, qui dentro, signorina.»
Finalmente il giovane si decise a porre un termine al dialogo: «Siamo venuti» disse, «per chiedervi se potete prestarci un recipiente e indicarci un pozzo dove prendere l’acqua.»
«Un secchio d’acqua,» gridò la donna, «ma subito, l’acqua non costa niente…» si levò andò in fondo alla capanna e ne tornò con un secchio. «Bisogna andare a prenderla di fuori,» soggiunse sempre gridando, «là fuori al pozzo… è lontano il pozzo… ma c’è mio marito al pozzo… ti aiuterà mio marito.» Ella si affacciò alla porta e facendo una voce lunga e lamentosa gridò: «Ohi, Alfredo.» Una voce d’uomo non meno lamentosa rispose da lontano: «Ohi Leonia.» Poi ricadde il silenzio.
«Va’ signorino,» disse la donna porgendo il secchio al giovane, «va’ pure… mio marito ti aspetta accanto al pozzo… prendi il sentiero dietro la capanna… però è meglio che la signorina aspetti qui…» soggiunse in fretta, «è brutto il sentiero… la signorina si scalderà accanto al fuoco.»
Il giovane che aveva già messo il capo fuori dalla porta, si raddrizzò e guardo la ragazza. «In fondo è meglio che mi aspetti qui,» disse, «vado e torno.» La fanciulla avrebbe voluto protestare ma non ebbe il tempo. «Siediti qui,» disse la donna spolverando con zelo un banco davanti al fuoco.
Il giovane intanto era uscito. La ragazza non osò rincorrerlo, e con un gesto schifiltoso sedette cautamente sull’angolo del banco. Subito la donna andò a chiudere la porta. La capanna ripiombò nel buio, salvo che intorno al tripode sotto il quale, in un bagliore circoscritto, il fuoco ormai agonizzava.
«Scaldati signorina,» disse la donna. Andò in fondo alla capanna e prese a frugare. Addossati gli uni contro gli altri, in un solo mucchio di Cenci, i quattro ragazzi fissavano in silenzio sulla fanciulla gli occhi intenti. Ella aprì la borsa, ne trasse delle sigarette, ne accese una con l’accendino quindi ripose astuccio accendino nella borsa e accavallò le gambe.
La donna tornò dal fondo della capanna con una bracciata di sterpi e un’accetta. Posò l’accetta sul banco e cacciò gli sterpi sotto la pentola, tra le braci. Quindi si gettò carponi in terra, la guancia contro il suolo fangoso, e prese a soffiare. Le fiamme corsero per gli sterpi, divamparono, avvolsero con rosse lingue i fianchi neri della pentola. Faville rosse salirono crepitando nell’oscurità della capanna.
«Ecco un bel fuoco acceso,» gridò la donna festosa, «ti piace il fuoco eh, signorina… è caldo… ripara dal freddo… dammi la tua borsa signorina.» Queste ultime parole furono pronunciate senza modificare la solita intonazione allegra e entusiasta. La ragazza la guardo, il viso le si sbiancò, le labbra le tremarono: «La borsa… perché?»
«Ma te l’avevo detto signorina,» gridò la donna in tono accorato e affettuoso rimprovero, quasi supplichevolmente, «te l’avevo detto… noi rubiamo… e se no come faremmo?» Ella si sporse, prese la borsa dalle ginocchia della ragazza, l’aprì e scosse in terra tutto quanto conteneva. Caddero il portasigarette, l’accendino, il tubo del rossetto, il portacipria e altri simili oggetti. Uno dei ragazzi, forse attirato da quel luccichio di cose metalliche e preziose, allungò una mano. La madre lo percosse sulla testa con un colpo bizzarro, tra il pugno e lo schiaffo: «Giù le mani.» Quindi rivolta alla fanciulla: «E’ tutto oro, signorina, è tutto oro?»
«Mario, Mario,» gridò ad un tratto la ragazza, balzando in piedi. Ma la donna fu più lesta e afferrata l’accetta andò a mettersi tra lei e la porta. «Signorina, perché lo chiami?… è con mio marito al pozzo.» La guardò un momento in tralice, con quei suoi occhi brillanti. «Ha il fucile mio marito» soggiunse con gioia.
La ragazza non disse nulla. Guardava alla donna, poi portò una mano alla bocca e se la morse.
«Siediti, signorina,» continuò quella, «ma togliti prima il paltò… anche il paltò mi serve. E fece il gesto di mettere la mano sul cappotto della ragazza.
«No, me lo tolgo da me,» disse la fanciulla con voce alta e astratta. Disfece i grossi bottoni dalle asole, si sfibbiò la cintura, fece per sfilare le maniche. «Aspetta signorina,» gridò la donna slanciandosi, «aspetta ti aiuto.» Nonostante i gesti disperatamente schivi della ragazza, ella l’aiutò a togliersi il cappotto e se lo buttò sopra un braccio. Ee ora togliti le scarpe signorina… anche le scarpe.»
«Ma io,» disse la fanciulla bianca in viso e le labbra tremanti, come farò poi a camminare?»
«Camminerai benissimo… i miei figli camminano tutti a piedi nudi… poi quando vai a casa, te le rifai le scarpe.»
La fanciulla era rimasta in un leggero vestito avana, con i polsini e il bavero di lino bianco. Sedette sulla panca e accennò chinandosi a slacciare le scarpe. Erano scarpe sportive, gialle, con la suola di gomma. «No, signorina,» gridò la donna, «no, te le tolgo io le scarpe.»
Si gettò in ginocchio per terra, prese in grembo il piede della ragazza e muovendo con delicatezza le dita tozze tra i lacci, aprì la scarpa e la sfilò dal piede, mettendola da parte. Tolse anche l’altra scarpa nella stessa maniera, ma questa volta non poté fare a meno di esaminarla alla luce delle fiamme. «Che bel piede hai,» riprese poi accarezzando il piede piccolo e raccolto della ragazza, «che bel piede piccolo piccolo… e le calze di seta,» soggiunge levando il viso in atteggiamento di preghiera, le calze di seta, signorina, non vuoi darmele?»
«Prendete, prendete tutto,» gridò la fanciulla e scoppiò in un pianto impaurito, nervoso, singhiozzando dentro il braccio levato.
«Piangi, signorina piangi, anch’io, quando i tedeschi mi presero gli ori, piansi e poi mi sentii meglio.»
«Prendetele… prendetele,» ella ripeté. Senza stornare il braccio dagli occhi e continuando a singhiozzare, ella andò con l’altra mano al bordo del vestito, lo rovesciò sopra il ginocchio, stese in fuori la bella gamba tonda calzata di seta e con le dita risalì lungo la coscia a slacciare i cappi delle giarrettiere. La donna inginocchiata, la guardava estatica, le mani sollevate e aperte come a significare che non voleva toccarla, che la lasciava fare da sé. Slacciata la calza della gamba sinistra, la fanciulla la tirò giù fino al ginocchio, quindi si girò sull’altro fianco, stese fuori l’altra gamba, si slacciò anche la seconda calza e l’abbassò sullo stinco. Finalmente si coprì il volto con le due mani, e stette immobile, in un atteggiamento desolato, la veste rivoltata sulle ginocchia, le gambe distese e come offerte.
«Grazie, signorina, grazie,» ripeté con gratitudine la donna. Ella arrotolò la calza sulla gamba della piangente come avrebbe potuto fare un’esperta cameriera, la ricondusse sul piede e poi, passando una mano sotto il calcagno, la tolse del tutto. Ripeté lo stesso procedimento per l’altra calza e si alzò in piedi. «Me le metterò io le calze, e anche le scarpe metterò io,» gridò come se avesse creduto di consolare la ragazza rivelandole la destinazione degli oggetti rubati. «Ma col paltò,» soggiunse sedendosi ed esaminando la stoffa, «col paltò ci farò i calzoni ai ragazzi… ci verranno due paia di calzoni,» gridò soddisfatta. «E forse anche la giacchettina per Natalino,» concluse.
La fanciulla non disse nulla. Singhiozzava, le lunghe gambe bianche stese verso il fuoco. La donna che aveva finito di esaminare il soprabito, lo ripiegò con cura e lo posò sulla panca. Arrotolò quindi le calze le mise dentro le scarpe che dispose in terra sotto il soprabito. Alfine si voltò di nuovo verso la ragazza e domandò in tono festoso: «Non hai altro signorina?… non hai anelli, non hai collane, non hai braccialetti? Io, quando mi sono sposata, avevo anelli, avevo collane, avevo braccialetti… e i tedeschi si sono presi tutto… tutto si sono presi i tedeschi, signorina.»
«Non ho più nulla,» ella rispose tra i singhiozzi.
La donna disse, come parlando a se stessa: «Hai un bel vestito… ma quello non te lo prendo… noialtre donne non sta bene che ci facciamo vedere mezze nude, nevvero signorina? Il vestito te lo lascio, signorina.» Chinandosi in avanti scoperchiò la pentola e prese a girare con forza il mestolo tra il fumo della vivanda. I ragazzi che fino allora erano rimasti immobili, tesero le facce verso quel fumo. «Vuoi mangiare?» gridò la donna. «Vuoi mangiare con noi?… E’ capretto… roba di campagna, si sa…»
«No, non voglio mangiare,» disse la ragazza. Ella si tolse il braccio dal viso, tiro giù la veste e si voltò da una parte, quasi mostrando la schiena alla donna. I piedi nudi cercava di non appoggiarli in terra; ma già aveva i calcagni neri di fango.
La donna disse ai figli, in tono giubilante: «La signorina non vuol mangiare.» Quindi con un forchettone di stagno pescò nella pentola un primo pezzo di carne e lo tese ad uno dei ragazzi che subito l’afferrò e l’addento. La donna distribuì altri tre pezzi, uno per figlio, ne prese uno per sé, e incominciò a divorarlo con accanimento, ungendosi tutta la faccia con l’intingolo. «Non vuoi mangiare?… proprio non vuoi?» insistette, il boccone tra i denti, voltandosi verso la fanciulla.
Questa non si mosse, non parlò. La porta si aprì e il giovane senza basco, bianco e spaurito in viso, affacciò la testa nella capanna. «Ornella,» disse.
La fanciulla si levò in fretta e uscì dalla capanna. Ormai era quasi buio; nell’ombra, dietro il giovane, ella intravide una figura d’uomo, ritta, con un viso lungo e scuro di barba, gli occhi intenti, la mano sulla cinghia del fucile. Ella guardò il compagno: era anche lui a piedi nudi, in mutande e maniche di camicia.
«E’ buio,» gridò la donna, «ma Alfredo vi accompagnerà… tieni, Alfredo.» Sbucò ad un tratto dalla capanna porgendo al marito un mazzo di cannucce infiammate. La luce rossa saltò ai visi e tutto intorno fu notte affatto.
In silenzio l’uomo si mosse, precedendo i due derubati, quella specie di face nella mano.
«Addio signorina, addio» giunse la voce della donna.
La ragazza taceva, stringendosi al fianco del compagno. Anche lui taceva. Reggeva il secchio pieno d’acqua e camminava a testa china, posando con difficoltà i piedi tra i sassi e il fango. Accanto ai suoi, i piedi piccoli e contratti della fanciulla, parevano eseguire una specie di danza. La luce davanti a loro lasciava nel buio l’uomo e sembrava che avanzasse da sola nella notte.
Gelati e assorti ad evitare i ciottoli aguzzi e il grosso fango, non si accorsero di essere giunti al termine del sentiero se non quando al suolo rupestre successe il liscio asfalto. Il giovane andò alla macchina, svitò il tappo del radiatore e prese a versare l’acqua. La ragazza aprì lo sportello e si gettò sul sedile.
Il giovane vuotò il secchio e lo rese all’uomo. Costui disse tranquillamente: «Buonanotte,» e scomparve nel buio.
Il giovane entrò nella macchina, chiuse lo sportello e accese il motore. «Mi hanno rubato tutto, tutto, tutto» ella disse stringendosi a lui con una voce che lo spavento rendeva vacua e riflessiva.
«Ed io allora?» egli rispose indicando il piede nudo con il quale premeva il pedale. La macchina partì, imboccò un lungo rettifilo e prese a correre nella notte, preceduta, sul nastro nero dell’asfalto, dall’alone bianco della luce dei fanali.
Il testo è significativo: scritto nel 1944 e pubblicato su rivista, venne infine inserito nel testi I racconti (ripubblicato in seguito con il titolo Racconti 1927 _ 1951) che vinsero il Premio Strega nel ’52.
Non è la prima volta che Moravia ci presenta personaggi popolari, li abbiamo già incontrati in Agostino. Ma sia in questo romanzo che in questo racconto essi sono disegnati in modo fortemente anti idillico, stravolti nel primo da una esclusione di tipo economico, qui da un motivo bellico. L’azione, infatti, s’immagina nel periodo della guerra di Liberazione, in cui due borghesi si rivolgono ad una contadina per chiedere dell’acqua per il radiatore della macchina, ma vengono derubati di tutto quello che possiedono. La forza del racconto sta nella presentazione borghese: i due giovani “recitano” la vuota commedia sentimentale del bacio prima rifiutato e poi accolto, quindi succede l’invito ad “andare verso il popolo” del giovane. Anche qui viene a mancare l’azione: la donna ed i figli si preparano a mangiare, mentre spogliano la povera ragazza. E’ evidente che l’intento moraviano è quello di mostrarci la borghesia che si affaccia verso il popolo senza avere una grammatica che le permetta di capire la sua condizione; non può che opporle un sistema fatto di giustizia “borghese” che le è completamente impermeabile. Insomma, sembra dirci l’autore romano, la borghesia intellettuale che prova a rappresentare le esigenze della classe popolare, non ne possiede per nulla gli strumenti.
Nel 1951 Moravia dà alle stampe uno dei suoi romanzi più controversi, ma da cui è stato tratto uno dei film più belli degli anni Settanta; sto parlando de Il conformista.

L’ottavo romanzo sembra nascere da un’esigenza che potremo definire biografica: sappiamo che lo scrittore romano era nipote di Amelia Rossella e i suoi figli, Carlo e Nello, fondatori di Giustizia e Libertà, furono barbaramente uccisi da sicari filofascisti e ritrovati in un bosco vicino a Parigi (episodio ripreso nel romanzo). Scrive infatti Moravia alla zia: “tra le tante testimonianze che ho ricevuto, la tua è quella che mi ha fatto più piacere. Tu hai mostrato di capire il senso del libro e il suo intento […]. Soprattutto mi fa molto piacere che tu abbia apprezzato la pagina sui due, nel bosco. Io ho scritto quella pagina per i tuoi figli, soltanto quella pagina e lì ho espresso il profondo sentimento che aveva destato in me la vostra tragedia” e aggiunge “il romanzo l’ho scritto per spiegare a me stesso e agli altri perché possano avvenire tali tragedie e in che modo. Sarebbe stato facile fare come tanti: mettere da una parte i cattivi e dall’altra i buoni” ma “la mia intenzione era più alta: volevo scrivere un libro che equivalesse a una tragedia e nelle tragedie non ci sono né cattivi né buoni, ma solo personaggi dai diversi destini.”
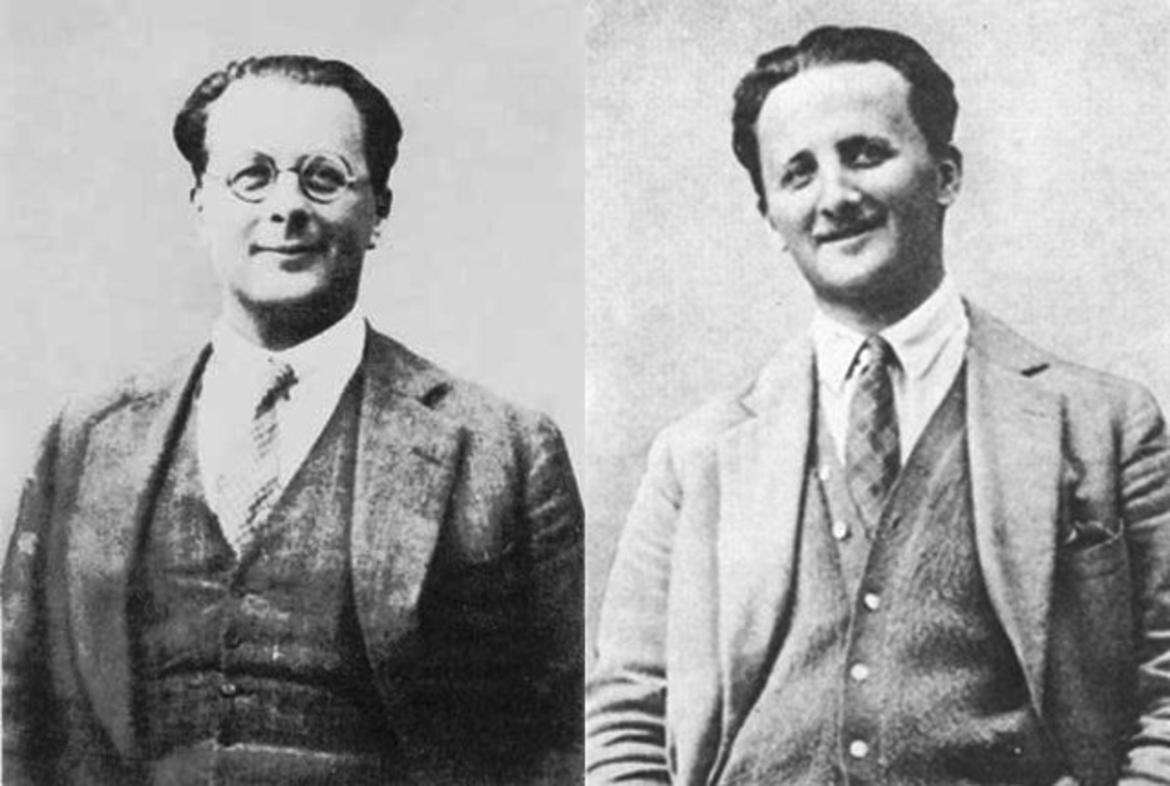
Carlo e Nello Rosselli
La struttura del libro è di tipo tragico, come si vede nell’articolazione del racconto: un prologo (tre capitoli), una parte prima (quattro capitoli), una parte seconda (undici capitoli) e l’epilogo (tre capitoli). D’altra parte la vita di Marcello è narrata come fosse già determinata da un destino tragico: non per niente Moravia ce la racconta tutta sin dall’infanzia.
Marcello Clerici, protagonista del romanzo, sin da ragazzo percepisce quel senso di anormalità e inadeguatezza dalla quale cercherà per tutta la vita di liberarsi. In questo periodo viene avvicinato da un uomo, Lino, che con la falsa promessa di regalargli una rivoltella lo avvicina, cercando di approfittarsi di lui, ma Marcello trova la forza di liberarsi dalla sua presa e a far fuoco con l’arma che le era capitata tra le mani e fugge, convinto di averlo ucciso. Nella parte centrale del romanzo, Marcello, diventato grande, è costretto a fare i conti con il trauma vissuto nell’infanzia e che vive con intenso disagio l’anormalità. Infatti cerca di omologarsi al modo di vivere corrente: si comporta comunemente, secondo l’etica piccolo borghese e accoglie convintamente il fascismo. È in questa fase che a Marcello, impiegato statale presso i servizi segreti, viene affidata la missione di rintracciare a Parigi il suo ex professore dell’università, adesso impegnato come militante antifascista all’estero. Egli accetta, e il caso vuole che la missione coincida con il periodo del suo matrimonio, così che il viaggio di nozze viene scelto come copertura per la missione. Giunto a Parigi, Marcello rintraccia il professore il quale, ricevuta la chiamata del suo ex alunno, lo invita a casa. Marcello e Giulia, sua moglie, vi si recano e qui non solo emerge che il professore e sua moglie sanno tutto di Marcello e dei suoi scopi, ma si crea anche un curioso triangolo: Marcello infatti resta folgorato dalla bellezza della moglie del professore e crede anche di essersene innamorato, ma questa si scopre subito avere inclinazioni omosessuali, ed essersi invaghita disperatamente di Giulia. Comunque la sera stessa del primo incontro le due coppie si rivedono, e durante la cena Marcello segnala al collega chi è il professore e lo informa che questi il giorno dopo sarebbe partito per la propria casa in Savoia. A Parigi sarebbero dovuti rimanere Marcello, Giulia e la moglie del professore che parte con il marito e Marcello e Giulia fanno ritorno in Italia. Qui dopo alcuni giorni vengono a sapere dell’uccisione dei due sulla strada per la Savoia e Marcello scopre da Orlando che prima che fosse compiuto l’omicidio era stato inoltrato l’annullamento della missione che però non era arrivato in tempo agli esecutori. Alla fine del romanzo Marcello osserva dalla finestra la città in festa per la Liberazione. Marcello e Giulia sono preoccupati per il loro passato; decidono di fuggire, ma quella sera egli decide di recarsi nel centro della città a osservare il giubilo di coloro che festeggiano. Si ritrovano quindi a Villa Borghese e qui Marcello incontra, ormai impiegato come guardiano notturno, Lino, che non era morto. Scacciato Lino i due vanno via e tornano a casa. Il giorno successivo Marcello, Giulia e la figlioletta partono per villeggiare con i nonni a Tagliacozzo, da dove poi progettano di fuggire per l’estero, possibilmente per un paese lontano. Sulla strada, mentre Marcello guida, l’auto in corsa viene raggiunta da un aereo che, nel fare fuoco sulla zona, la colpisce. Marcello, ferito, viene ribaltato fuori e prima di morire ha solo il tempo di accorgersi che non c’è vita neanche dentro l’auto perché anche moglie e figlia vengono ferite mortalmente.
Il brano fa parte della prima parte, quella riguardante l’infanzia e l’adolescenza di Marcello:
LA RIVOLTELLA
Egli doveva a tutti i costi ottenere che Lino mantenesse la promessa e gli desse la rivoltella, pensò Marcello più tardi affrettandosi per le strade, verso il viale dei platani. Marcello si rendeva conto che Lino gli avrebbe dato l’arma soltanto che egli avesse voluto e, pur camminando, si domandò quale contegno avrebbe dovuto tenere per raggiungere più sicuramente il suo scopo. Pur non penetrando il vero motivo delle smanie di Lino, con istintiva civetteria quasi femminile intuiva che il modo più spiccio per entrare in possesso della rivoltella era quello suggeritogli il sabato avanti da Lino stesso: non curarsi di Lino, disprezzarne le offerte, respingerne le suppliche, rendersi, insomma, prezioso; finalmente non accettare di salire nella sua macchina se non quando fosse ben sicuro che la rivoltella era sua. Perché, poi, Lino tenesse tanto a lui, e lui fosse in grado di fare questa specie di ricatto, Marcello non avrebbe saputo dirlo. Lo stesso istinto che gli suggeriva di ricattare Lino, gli lasciava intravvedere, dietro i suoi rapporti con l’autista, l’ombra di un affetto insolito, di una qualità imbarazzante quanto misteriosa. Ma la rivoltella era in cima a tutti i suoi pensieri; né, d’altra parte, avrebbe potuto affermare che quell’affetto e la parte quasi femminile che gli toccava di recitare gli riuscissero veramente spiacevoli. La solo cosa che avrebbe voluto evitare, come pensò affacciandosi tutto sudato per il gran correre, sul viale dei platani, era che Lino lo prendesse per la vita, come aveva fatto nel corridoio della villa, la prima volta che si erano veduti.
Come sabato, la giornata era tempestosa e rannuvolata, percorsa da un vento caldo che pareva ricco di foglie rapinate un po’ dappertutto al suo turbolento passaggio: foglie morte, cartacce, piume, lanugine, fuscelli, polvere. Sul viale il vento aveva investito proprio in quel momento un mucchio di foglie secche sollevandole in gran numero molto in su, tra i rami denudati dei platani. Egli si distrasse a guardare le foglie che volteggiavano per l’aria, sullo sfondo del cielo tetro, in tutto simili a miriadi di gialle mani dalle dita bene aperte, e poi, abbassando gli occhi, vide tra tutte quelle mani d’oro mulinanti nel vento, la lunga forma nera e lucida dell’automobile ferma presso il marciapiede. Il cuore prese a battergli più in fretta, non avrebbe saputo dire perché; tuttavia, fedele al suo piano, non affrettò il passo e tirò avanti, incontro alla macchina. Trascorse senza fretta accanto al finestrino e subito, come ad un segnale lo sportello si aprì e Lino, senza berretto, sporse la testa fuori dicendo: «Marcello, vuoi salire?»
Non potè fare a meno di meravigliarsi di questo invito così serio, dopo i giuramenti del primo incontro. Così Lino si conosceva bene, pensò; ed era persino comico vederlo fare una cosa che aveva preveduto lui stesso di fare nonostante ogni volontà contraria. Egli proseguì come se non non avesse udito e si accorse, con oscura soddisfazione, che la macchina si era mossa e gli veniva dietro. Il marciapiede, molto ampio, era deserto a perdita d’occhio tra le fabbriche regolari e piene di finestre e i grossi tronchi inclinati dei platani. La macchina lo seguiva al passo, con un ronzio sommesso che suonava carezzevole all’orecchio; dopo una ventina di metri, l’oltrepassò, si fermò a qualche distanza; poi lo sportello si aprì di nuovo. Egli passò senza voltarsi e udì di nuovo la voce struggente che supplicava: «Marcello, sali… ti prego… dimentica quello che ti ho detto ieri… Marcello mi senti?» Marcello non poté fare a meno di dirsi che quella voce era un po’ ripugnante: che aveva Lino da lamentarsi in quel modo? Era una fortuna che nessuno passasse per il viale, altrimenti egli si sarebbe vergognato. Tuttavia, non volle scoraggiare del tutto l’uomo e, pur oltrepassando la macchina, si voltò a metà a guardare indietro, come per invitarlo ad insistere. Si accorse di lanciare un’occhiata quasi lusinghiera, e, tutto d’un tratto, provò, inconfondibile, lo stesso sentimento di umiliazione non spiacevole, di finzione non innaturale che, due giorni prima, per un momento gli aveva ispirato la gonnella legatagli alla vita dai compagni. Quasi che, in fondo, non gli fosse dispiaciuto, anzi fosse portato per natura a recitare la parte della donna sdegnosa e civetta. Intanto la macchina si era mossa di nuovo dietro di lui. Marcello si domandò se fosse giunto il momento di cedere e decise, dopo riflessione, che il momento non era ancora giunto. La macchina gli passò accanto senza fermarsi, soltanto rallentando. Egli udì la voce dell’uomo che lo chiamava: «Marcello…» quindi, subito dopo, il rombo improvviso della macchina che si allontanava.
Improvvisamente temette che Lino si fosse spazientito e se ne andasse; lo invase una gran paura di avere a presentarsi, il giorno dopo, a mani vuote a scuola; e prese a correre gridando: «Lino… Lino, fermati Lino.» Ma il vento si portava via le parole, disperdendo le per aria insieme con le foglie morte, in un turbinio angoscioso e sonoro; la macchina rimpiccioliva a vista d’occhio; evidentemente Lino non aveva udito e se ne andava; e lui non avrebbe avuto la rivoltella; e Turchi, una volta di più l’avrebbe canzonato. Poi egli respirò e riprese a camminare con passo quasi normale, rassicurato: la macchina era corsa avanti non per sfuggirlo ma per aspettarlo ad una traversa; adesso, infatti, si era fermata, sbarrando il marciapiede per tutta la sua larghezza.
Gli venne una specie di rancore contro Lino per aver provocato lui quell’umiliante batticuore; e decise in cuor suo con subitaneo impulso di crudeltà, di farglielo scontare con una ben calcolata durezza. Intanto, senza fretta, era giunto alla traversa. La macchina era lì, lunga, nera, luccicante con tutti i suoi vecchi ottoni e la sua carrozzeria antiquata. Marcello accennò a girarle intorno: subito lo sportello s’apri e Lino si affacciò.
«Marcello», disse con una decisione disperata, «dimentica quanto ti ho detto sabato… hai fatto fin troppo il tuo dovere… vieni, su, Marcello.»
Marcello si era fermato presso il cofano. Tornò un passo indietro e disse con freddezza, senza guardare l’uomo: «Non ci vengo… ma non perché sabato mi hai detto di non venirci… perché proprio non mi va.»
«E perché non ti va?»
«Perché sì… perché dovrei salire?»
«Per farmi piacere…»
«Ma io non ho voglia di farti piacere.»
«Perché? Ti sono antipatico?»
«Sì» disse Marcello abbassando gli occhi e giocando con la maniglia dello sportello. Si rendeva conto di fare un viso crucciato, restio, ostile e non capiva più se lo facesse per commedia o sinceramente. Era certo una commedia quella che stava recitando con Lino; ma se era una commedia, perché provava un sentimento così forte e così complicato, mischiato di vanità, di ripugnanza, di umiliazione, di crudeltà e di dispetto? Udì Lino ridere piano, affettuosamente poi domandare: «E perché ti sono antipatico?». Questa volta alzò gli occhi e guardò in viso l’uomo. Era vero, Lino gli era antipatico, pensò ma non si era mai domandato perché. Guardò il viso, quasi ascetico nella sua magrezza severa, e allora comprese perché non aveva simpatia per Lino: perché, come pensò, era un viso doppio, in cui la frode trovava addirittura un’espressione fisica. Gli sembrò, guardandolo, di ravvisare questa frode soprattutto nella bocca: sottile, secca, sdegnosa, casta a prima vista; ma poi, se un sorriso ne disserrava e rovesciava le labbra, lustra sulla erta e infuocata mucosa di non sapeva che vogliosa acquolina. Esitò guardando Lino che sorridendo aspettava la sua risposta, e poi disse sinceramente: «Mi sei antipatico perché hai la bocca bagnata.»
Il sorriso di Lino scomparve, egli si rabbuiò: «Che sciocchezze inventi adesso?… e poi subito riprendendosi, con disinvoltura scherzosa: «Allora signor Marcello… vuol salire nella sua macchina?»
«Salgo» disse Marcello decidendosi finalmente «soltanto un patto.»
«Quale?»
«Che mi dai veramente la rivoltella.»
«Intesi… vieni, su.»
«No, devi darmela adesso, subito,» insistette Marcello ostinato.
Ma non ce l’ho qui, Marcello», disse l’uomo con sincerità, «è rimasta sabato in camera mia… adesso andiamo a casa e la prendiamo.»
«Allora non vengo,» si decise Marcello in una maniera inaspettata anche lui, «arrivederci.»
Mosse un passo come per andarsene; e questa volta Lino perse la pazienza. «Ma vieni, non fare il bambino,» esclamò. Sporgendosi, afferrò Marcello per un braccio e lo attirò sul sedile accanto a lui. «Adesso andiamo subito a casa,» soggiunse, «e ti prometto che avrai la rivoltella…» Marcello, contento, in fondo, di essere stato costretto con la violenza a salire nella macchina, non protestò, limitandosi ad atteggiare il viso a un broncio puerile. Lino, alacremente, chiuse lo sportello, accese il motore; e la macchina partì.
Per un lungo momento non parlarono. Lino non pareva loquace, forse, come pensò Marcello, era troppo contento per parlare; quanto a lui, non aveva nulla da dire: adesso Lino gli avrebbe dato la rivoltella e poi egli sarebbe tornato a casa e il giorno dopo avrebbe portato la rivoltella a scuola e l’avrebbe mostrata a Turchi. Più in là di queste semplici e piacevoli previsioni il suo pensiero non andava. Solo timore era che Lino volesse in qualche modo frodarlo. In tal caso, come pensò, avrebbe inventato qualche malizia per spingere Lino alla disperazione e costringerlo a mantenere la promessa.
Fermo, il pacco dei libri sulle ginocchia, egli guardò sfilare i grandi platani e i casamenti fino in fondo al viale. Come la macchina attaccò la salita, Lino quasi a conclusione di una lunga riflessione domandò: «Ma chi ti ha insegnato a essere così civetta, Marcello?»
Marcello, non ben sicuro del significato della parola, esitò prima di rispondere. L’uomo parve accorgersi della sua innocente ignoranza e soggiunse: «Voglio dire così furbo.»
«Perché?» domandò Marcello.
«Così.»
«Sei tu il furbo,» disse Marcello, «che mi prometti la rivoltella e non non me la dai mai.»
Lino rise e con una mano andò a battere sul ginocchio nudo, con voce esultante: «Lo sai, Marcello, che sono tanto contento che tu sia venuto oggi… quando penso che l’altro giorno ti pregai di non darmi retta e di non venire, mi rendo conto quanto si possa essere sciocchi qualche volta… davvero sciocchi… ma per fortuna tu hai avuto più buon senso di me, Marcello.»
Marcello non disse nulla. Non capiva troppo bene quello che gli diceva Lino e, d’altra parte, quella mano posata sul ginocchio gli dava fastidio. Aveva cercato più volte di smuovere il ginocchio ma la mano non era stata tolta. Per fortuna, ad una svolta ecco una macchina venire incontro. Marcello finse di spaventarsi, esclamò: «Attento, quella macchina ci viene addosso,» e questa volta Lino ritirò la mano per girare il volante. Marcello respirò.
Ecco la strada di campagna, tra le mura di cinta e le siepi; ecco il portale con il cancello dipinto di verde; ecco il viale di accesso, fiancheggiato di piccoli cipressi spennacchiati e, in fondo, il luccichio dei vetri della veranda. Marcello notò che, come l’altra volta, il vento tormentava i cipressi, sotto uno scuro cielo temporalesco. La macchina si fermò, Lino balzò a terra e aiutò Marcello a discendere, avviandosi, poi, con lui, verso il porticato.
Questa volta Lino non lo precedeva ma lo teneva per un braccio, forte, quasi avesse temuto che egli volesse scappare. Marcello avrebbe voluto dirgli di allentare quella stretta ma non fece in tempo. Come volando, tenendolo quasi sollevato da terra per il braccio, Lino gli fece attraversare la sala di soggiorno e lo spinse dentro il corridoio. Qui, in una maniera inaspettata, la afferrò al collo, duramente, dicendo: «Stupido che sei… stupido… perché non volevi venire?»
La voce non era più scherzosa ma roca e rotta seppure meccanicamente tenera. Marcello stupito fece per levare gli occhi e guardare in faccia a Lino; ma, nello stesso tempo, ricevette una spinta violenta. Come si getta lontano un gatto o un cane dopo averlo afferrato per la collottola, Lino l’aveva lanciato dentro la camera. Poi Marcello lo vide e girare la chiave nella serratura, intascarla e voltarsi verso di lui con un’espressione mischiata di gioia e di rabbioso trionfo. Egli gridò forte: «Adesso basta… farai quello che vorrò io… basta Marcello, tiranno, piccola carogna, basta… fila dritto, ubbidisci e non una parola di più.»
Pronunziava queste parole di comando, di disprezzo e di dominio con una gioia selvaggia, quasi con voluttà; e Marcello, per quanto confuso, non poté fare a meno di avvertire che erano parole senza senso, piuttosto strofe di un canto trionfale, che espressione di un pensiero e di una volontà consapevoli. Spaventato, attonito, vide Lino andare e venire per la cameretta, a gran passi, togliendosi il berretto dal capo e gettandolo sul davanzale; facendo una palla di una camicia appesa su una seggiola e chiudendola in un cassetto; spianando la coperta spiegazzata e compiendo insomma, altrettanto gesti pratici con una furia piena di oscuro significato. Poi lo vide, sempre gridando all’aria con le sue incoerenti frasi di prepotenza e di imperio, avvicinarsi alla parete, sopra il capezzale, staccarne il crocifisso, andare all’armadio e gettarlo in fondo al cassetto con ostentata brutalità; e comprese che, con quel gesto, in qualche modo, Lino voleva dare a vedere di aver messo da parte gli ultimi scrupoli. Come a confermarlo in questo timore, Lino trasse dal cassetto dal comodino la rivoltella tanto desiderata e mostrandogliela gridò: «La vedi… ebbene non l’avrai mai… dovrai fare quello che voglio io senza regali, senza rivoltelle… per amore o per forza.»
Così era vero, pensò Marcello, Lino voleva frodarlo, come aveva tenuto. Sentì di diventare bianco in viso per l’ira; e disse: «Dammi la rivoltella o me ne vado.»
«Niente, niente… o per amore o per forza.»
Lino brandiva tuttora la rivoltella in una mano; con l’altra afferrò Marcello per un braccio e lo scagliò nel letto. Marcello cadde a sedere, con tanta violenza che sbatté la testa contro il muro. Subito Lino, passando improvvisamente dalla violenza alla dolcezza e dal comando alla supplica, gli si inginocchiò davanti. Gli circondava le gambe con un braccio e posava l’altra mano, che stringeva tuttora l’arma, sulla coperta del letto. Gemeva e invocava Marcello per nome; quindi, sempre gemendo, gli cinse con ambedue le braccia le ginocchia. La rivoltella adesso era sul letto, abbandonata, nera sulla coperta bianca. Marcello guardò Lino inginocchiato che ora alzava verso di lui il viso supplichevole, bagnato di lacrime e infiammato di desiderio e ora lo abbassava a strofinarglielo contro le gambe come fanno col muso certi cani devoti; poi impugnò la rivoltella e, con una spinta forte, si levò in piedi. Subito Lino, forse pensando che egli volesse secondare il suo amplesso, aprì le braccia e lo lascio andare. Marcello fece un passo nel mezzo della stanza e poi si voltò.
Più tardi, pensando a quanto era accaduto, Marcello doveva ricordare che il solo contatto del calcio freddo dell’arma aveva destato nel suo animo una tentazione spietata e sanguinaria; ma in quel momento non avvertiva che un forte dolore alla testa, laddove l’aveva sbattuta contro la parete; e al tempo stesso un’irritazione, una ripugnanza acuta verso Lino. Questi era rimasto in ginocchio presso il letto; ma come vide Marcello fare un passo indietro e puntare la rivoltella, si girò alquanto, pur senza alzarsi; e spalancando le braccia, con un gesto teatrale, gridò istrionescamente: «Spara, Marcello… ammazzami… sì, ammazzami come un cane.» Sembrò a Marcello di non averlo mai odiato come adesso, per quel suo miscuglio ripugnante di sensualità e di austerità, di pentimento e di libidine; e, insieme atterrito e consapevole, quasi parendogli di dover compiacere la richiesta dell’uomo, premette il grilletto. Il colpo echeggiò di schianto nella piccola camera; e lui vide Lino cadere di fianco e poi rialzarsi, mostrandogli la schiena e aggrappandosi con le sue mani al bordo del letto. Lino si tirò su pian piano, cadde di fianco sul letto e rimase immobile. Marcello gli si avvicinò, posò la rivoltella sul capezzale, chiamo a bassa voce «Lino», e poi senza aspettare risposta, andò alla porta. Ma era chiusa e la chiave, come ricordò, Lino l’aveva tolta dalla toppa e messa in tasca. Esitò, gli ripugnava di frugare nelle tasche del morto; quindi gli occhi gli caddero sulla finestra e rammentò che era a pianterreno. Scavalcando la finestra girò in fretta il capo gettando un lungo sguardo circospetto e pieno di paura allo spiazzo e all’automobile ferma davanti al porticato: capiva che se qualcuno fosse passato in quel momento, l’avrebbe visto a cavalcioni sopra il davanzale; e tuttavia non c’era altro da fare. Ma non c’era nessuno, e, al di là dei radi alberi che circondavano lo spiazzo, anche la campagna brulla e collinosa appariva deserta perdita d’occhio. Egli discese dal davanzale, prese il pacco dei libri dal sedile della macchina e si incamminò senza fretta verso il cancello. Nella sua coscienza, come in uno specchio, si rifletteva tutto il tempo, mentre camminava, l’immagine di se stesso, ragazzo in pantaloni corti, i libri sotto il braccio, nel viale fiancheggiato di cipressi, figura incomprensibile e piena di sbigottito presagio.

Jean-Louis Trintignant: Marcello Clerici in “Il conformista” film di Bernardo Bertolucci
Lo splendido binomio con cui Moravia chiude il brano, induce il lettore ad interrogarsi su quale “presagio” Marcello s’interrogasse. Sappiamo quanto fosse un bambino difficile, affetto da comportamenti “sadici” verso gli animali (torture alle lucertole e l’uccisione di un gatto) e come tali comportamenti provocassero in lui una forma di quasi cancellazione della sua “diversità” verso una omologazione che lo rendesse indistinto verso gli altri. Tale “diversità” si accentua nella sua repressa omosessualità, ma riconosciuta dai compagni di classe, che gli infilano una gonnellina a forza – episodio che lo porterà a conoscere Lino che, come si è visto, tenterà di approfittarsi di lui. La sicurezza di averlo ammazzato, di essere un assassino, comporterà in lui la voglia di “annullarsi” in un grigiore comune che lo porterà a fidanzarsi con una ragazza abbastanza formosa da diventare una buona madre, comprarsi un appartamento abbastanza elegante con mobili altrettanto di buon gusto (chiaramente tutto rateizzato) posto in mezzo ad altri appartamenti uguali dove tutti fanno le stesse cose: lavorare, mangiare, dormire e dalle radio sentire la voce del padre di tutti loro, colui che guida per il meglio il popolo: Mussolini. Entrerà quindi in un sistema oliato, diventando un funzionario statale. Sarà proprio questo lavoro a dar lui l’occasione di pagare il fio del giovanile omicidio, uccidendo non come atto singolo, quindi “impulsivo”, ma come atto pubblico, cioè per la patria: trovare a Parigi un intellettuale antifascista (suo professore universitario), indicarlo a dei sicari e quindi ammazzarlo.

Che il comportamento di Lino sia determinato da una famiglia con un vecchio padre, spesso iroso ed in ultimo uscito fuori di senno, ed una madre assente, spiega soltanto in parte la psicologia di Marcello, ma è lo stesso autore che ci induce a sottolineare la diversità tra una donna, bovaristicamente disegnata, e suo figlio, così grigiamente rappresentato, con questo splendido ritratto:
LA MADRE DI MARCELLO
Udì un rumore di motore nel giardino, verso l’ingresso, e subito si alzò, con un movimento brusco che fece fuggire la lucertola. Senza fretta, uscì dalla Pergola e si avviò verso l’ingresso. Una vecchia automobile nera stava ferma nel viale, a breve distanza dal cancello ancora spalancato. L’autista, vestito di una livrea bianca e passamani turchini, stava chiudendo il cancello ma, come vide Marcello, si fermò sollevando il berretto. «Alberi», disse Marcello con la sua voce più quieta, «oggi andiamo alla clinica, è inutile che rimettete la macchina nel garage.» «Sì, signor Marcello,» rispose l’autista. Marcello gli lanciò un’occhiata di sbieco. Alberi era un giovane dalla carnagione olivastra e dagli occhi neri come il carbone, con la sclerotica di una bianchezza lucida di porcellana. Aveva tratti molto regolari, denti candidi e serrati, capelli neri accuratamente impomatati. Non alto, dava, però, un senso di grande proporzione forse per via delle mani e dei piedi molto piccoli. Aveva l’età di Marcello ma sembrava più vecchio, a causa, forse, della mollezza orientale che si insinuava in ogni suo tratto e pareva destinata, col tempo, a diventare pinguedine. Marcello lo guardò ancora una volta, mentre chiudeva il cancello, con profonda avversione; quindi si avviò verso la villa. Aprì la porta-finestra ed entrò nel salotto, quasi al buio. Subito lo colpì il tanfo che ammorbava l’aria, ancora leggero in confronto a quello delle altre stanze in cui i dieci pechinesi di sua madre si aggiravano liberamente, ma tanto più notevole qui dove non penetravano quasi mai. Aprendo la finestra, un po’ di luce entrò nella sala ed egli vide per un momento i mobili coperti di foderine grigie, i tappeti arrotolati e appoggiati ritti negli angoli, il pianoforte imbacuccato in lenzuoli appuntati con spilli. Traversò il salotto e la sala da pranzo, passò nel vestibolo, si avviò su per la scala. A mezza rampa, sul marmo di un gradino (il tappeto, troppo logoro, da tempo era scomparso e non era stato mai rinnovato), c’era un escremento di cane ed egli ci girò intorno per non calpestarlo. Giunto sul ballatoio, andò alla porta della camera materna e l’aprì. Non fece neppure a tempo a disserrarla completamente che, come un fiotto a lungo contenuto il quale trabocchi improvviso, tutti e dieci i pechinesi gli si gettarono tra le gambe con qualche abbaiamento per il ballatoio e la scala. Incerto e annoiato, li guardò correre via, graziosi con le loro code a pennacchio e i loro musi scontenti e quasi gatteschi. Poi, dalla camera immersa nella penombra, gli giunse la voce di sua madre: «Sei tu, Marcello?» «Sì, mamma, sono io… ma questi cani?» «Lasciali andare… poveri santi… Sono stati chiusi tutta la mattina… lasciali pure andare.» Marcello aggrottò le sopracciglia in segno di malumore ed entrò. L’aria nella camera gli parve subito irrespirabile: le finestre chiuse avevano conservato dalla notte, mischiati, i diversi odori del sonno, dei cani e dei profumi; il calore del sole che ardeva dietro le imposte, pareva già farli fermentare e inacidire. Rigido, guardingo, quasi avesse temuto, muovendosi, di sporcarsi o di impregnarsi di quegli odori andò al letto e sedette sulla sponda, le mani sulle ginocchia. Adesso, pian piano, abituandosi gli occhi alla penombra, poteva vedere la camera intera. Sotto la finestra, nel chiarore diffuso dalle lunghe tende ingiallite e impure che gli parevano fatte dello stesso floscio tessuto di molti panni intimi sparsi per la stanza, stavano allineati numerosi piatti di alluminio con il cibo dei cani. Il pavimento era sparso di scarpette e di calze; presso l’uscio del bagno in un angolo quasi buio, si intravedeva una vestaglia rosa rimasta su una seggiola, come era stata gettata la sera avanti, mezza in terra e con una manica penzolante. Dalla camera, il suo occhio freddo e pieno di ripugnanza passò al letto sul quale giaceva sua madre. Al solito, ella non aveva pensato a ricoprirsi al suo ingresso ed era seminuda. Distesa, le braccia alzate e le mani riunite dietro la testa, contro la spalliera materassata di seta azzurra lisa e annerita, ella lo guardava fissamente, in silenzio. Sotto la massa di capelli sparsi in due gonfie ali brune, il viso appariva fine e smunto, quasi triangolare, divorato dagli occhi che l’ombra ingrandiva e incupiva in maniera mortuaria. Ella indossava una trasparente sottoveste verdolina che le giungeva appena al sommo delle cosce; e, una volta di più, lo fece pensare piuttosto che alla donna matura che era, ad una bambina invecchiata e insecchita. Il petto scarnito mostrava sullo sterno come una rastrelliera di ossicini aguzzi; attraverso il velo, le mammelle riassorbite si rivelavano con due macchie scure e tonde, senza alcun rilievo. Ma soprattutto le cosce destavano insieme ripugnanza e pietà in Marcello: madre e sfornite erano proprio quelle di una bambina di dodici anni che non abbia ancora forme donnesche. L’età della madre si vedeva in certe smagliature macerate della pelle e nel colore: una bianchezza gelida, nervosa, maculata di misteriose chiazze quali bluastre e quali livide. “Botte,” egli pensò, “o morsi di Alberi.” Ma sotto il ginocchio, le gambe apparivano perfette, con un piccolissimo piede dalle dita raccolte. Marcello avrebbe preferito non mostrare a sua madre il proprio malumore; ma anche questa volta non seppe trattenersi: «Ti ho pur detto tante volte di non ricevermi così, mezza nuda,» disse con dispetto, senza guardarla. Ella rispose, insofferente ma senza rancore: «Uh, che figlio ha austero mi ritrovo,» tirandosi sul corpo un lembo della coperta. La voce era rauca e anche questo dispiaceva a Marcello. Ricordava, durante l’infanzia, di averla udita dolce e limpida come un canto: quella raucedine era un effetto dell’alcol e degli strapazzi. Egli disse dopo un momento: «Allora, oggi andiamo alla clinica.» «Andiamoci pure,» disse la madre tirandosi su e cercando qualche cosa dietro la spalliera del letto, «sebbene io mi senta tanto male e a lui, poveretto, la nostra visita non faccia assolutamente né caldo né freddo.» «E’ pur sempre tuo marito e mio padre,» Disse Marcello prendendosi la testa fra le mani e guardando in basso. «Sì, certamente lo è,» ella disse. Adesso aveva trovato la peretta della luce e la premette. Sul comodino si illuminò fiocamente una lampada che, come parve a Marcello, era involtata in una camicia femminile. «Sebbene,» ella continuò levandosi dal letto e mettendo i piedi in terra, «ti dico la verità, qualche volta mi augurerei che morisse… tanto lui non se ne accorgerebbe neppure… e io non spenderei più i soldi per la clinica… ne ho così pochi… pensa,» soggiunse in tono improvvisamente lamentoso, «pensa che dovrò forse smettere l’automobile.» «Be’, che male c’è?» «C’é molto di male» ella disse con un risentimento e un’impudenza puerili, «così, con la macchina, ho un pretesto per tenere Alberi e per vederlo quando mi pare… dopo, questo pretesto non l’avrò più.» «Mamma, non parlarmi dei tuoi amanti,» disse Marcello con calma, ficcando le unghie di una mano nelle palme dell’altra. «I miei amanti… è il solo che abbia… se tu mi parli della gallina della tua fidanzata, ho ben io il diritto di parlare bene di lui, povero caro, che è tanto più simpatico e più intelligente di lei.» Stranamente, questi insulti alla fidanzata da parte della madre che non poteva soffrire Giulia, non offendevano Marcello. “Sì, e vero,” pensò, “può anche darsi che sembri una gallina… ma mi piace che sia così.» Disse in tono raddolcito: «Allora, vuoi vestirti?… Se vogliamo andare alla clinica, è tempo di muoversi.» «Ma sì, subito.» Leggera, quasi un’ombra, ella attraversò in punta di piedi la camera, raccolse al passaggio, dalla seggiola, la vestaglia rosa e, pur gettandosela sulle spalle, aprì l’uscio del bagno e scomparve.

Yvonne Sansonne: La mamma di Marcello nel film
L’ennesimo ritratto femminile, disegnato con brevi tratti eppure così preciso; ma se dovessimo dare a Marcello e al suo omologante grigiore il segno di una metafora sul fascismo, il ritratto della madre potremmo metaforicamente interpretarlo come simbolo del periodo giolittiano o della belle époque, estremamente libero, intellettualisticamente un po’ snob, ma nel frattempo corrotto e degradato (si pensi allo scandalo della Banca di Roma), a cui il fascismo – oltre a diversi motivi di tipo economico e sociale – rispose con una volontà di un riscatto valoriale, in cui tale valore era rappresentato nell’identificarsi nello Stato e quindi nella cancellazione dell’individuo come persona singola.
EPILOGO
Discesero dalla macchina e, braccio sotto braccio, si avviarono verso i giardini che si trovavano dietro il museo. Il parco era deserto, gli avvenimenti politici l’avevano spopolato perfino delle coppie di innamorati. Nella penombra, si vedevano biancheggiare sullo sfondo silvestre e oscuro degli alberi, le statue di marmo dai gesti elegiaci o eroici. Camminarono fino alla fontana e per un momento indugiarono in silenzio, a guardarne l’acqua nera e immobile. Adesso Giulia stringeva la mano al marito, inserendo fortemente, come in un minimo abbraccio, le sue dita tra le dita di lui. Ripresero a camminare, imboccarono un viale molto buio, in un bosco di querce. Dopo qualche passo, Giulia si fermò improvvisamente, e, voltandosi, cinse il collo a Marcello con un braccio e lo baciò sulla bocca. Stettero così, abbracciati, baciandosi, un lungo momento, ritti nel mezzo del viale. Poi si separarono e Giulia sussurrò, prendendo il marito per mano e tirandolo verso il bosco: «Vieni, facciamo l’amore qui… in terra.»
«Ma no,» non poté fare a meno di esclamare Marcello, «qui?…»
«Sì, qui», ella disse, «perché no… Vieni, ho bisogno di farlo per sentirmi rassicurata».
«Rassicurata di che?»
«Tutti pensano alla guerra, alla politica, agli aereoplani… e invece si potrebbe essere così felici… vieni… lo farei anche in mezzo ad una delle loro piazze,» ella soggiunse con subitanea esasperazione, «se non altro per dimostrare che io almeno sono capace di pensare ad altro… vieni.»
Ella pareva esaltata, adesso, e lo precedeva nell’ombra fitta, tra i tronchi degli alberi.«Vedi che bella camera da letto», la udì mormorare, «presto non avremo più casa… ma questa è una camera da letto che non potranno portarci via… vi potremo dormire e amare tutte le volte che vorremo.» D’improvviso ella scomparve dai suoi occhi, come entrando dentro terra. Marcello la cercò e poi la intravvide, in quella oscurità, distesa ai piedi di un albero, in terra, un braccio sotto la testa a far da guanciale, l’altro alzato verso di lui, silenziosamente, in atto di invitarlo a stendersi al suo fianco. Egli ubbidì e, appena si fu disteso, Giulia gli si avviticchiò strettamente, con le gambe e con le braccia, baciandolo con forza cieca ed ottusa per tutto il viso, come cercando sulla fronte e sulle guance altre bocche attraverso le quali penetrare in lui. Ma quasi subito il suo abbraccio si allentò, e Marcello la vide levarsi a metà sopra di lui, guardando nel buio: «qualcuno sta venendo,» ella disse. Marcello si levò anche lui a sedere e guardò. Tra gli alberi, ancora lontana, si vedeva la luce di una lampadina tascabile avanzare oscillando, preceduta in terra da un debole chiarore circolare. Non si sentiva un sol rumore, il fogliame morto che ricopriva il terreno soffocava i passi dello sconosciuto. La lampadina avanzava nella loro direzione e Giulia, ad un tratto, si ricompose e si levò a sedere, prendendosi le ginocchia tra le braccia. Seduti fianco a fianco, contro l’albero, guardarono la luce avvicinarsi: «Sarà una guardia,» mormorò Giulia. Adesso la lampadina proiettava il suo raggio in terra a poca distanza da loro, poi si alzò e il raggio li investì in pieno. Abbagliati, guardarono a loro volta alla figura maschile, non più che un’ombra, dal cui pugno scaturiva quella luce bianca. La luce, pensò Marcello, doveva abbassarsi, una volta che la guardia li avesse bene bene guardati in faccia. E invece, no, ecco la luce prolungare lo sguardo, in un silenzio che gli parve pieno di meraviglia e di riflessione. «Ma si può sapere che cosa volete?» domandò allora con voce risentita. «Non voglio nulla, Marcello,» rispose subito una voce dolce. Nello stesso tempo la luce si abbassò e prese di nuovo a muoversi, allontanandosi da loro. «Ma chi è?» Mormorò Giulia, «sembra che ti conosca…» Marcello stava fermo, senza respiro, profondamente turbato. Poi disse alla moglie: «Scusami, un momento… vengo subito.» Di un balzo fu in piedi e rincorse lo sconosciuto. Lo raggiunse sul limite del bosco, presso il piedistallo di una di quelle statue di marmo bianco. Poco distante c’era un fanale, e, come l’uomo, al rumore dei suoi passi si voltò, lo riconobbe subito, sebbene fossero trascorsi tanti anni, dal viso glabro e ascetico sotto i capelli tagliati a spazzola. Allora, l’aveva veduto chiuso nella tunica di autista; anche adesso indossava una divisa nera, abbottonata fino al collo, con pantaloni sbuffanti e gambali di cuoio nero. Teneva il berretto sotto il braccio e stringeva in mano la lampadina tascabile. Disse subito sorridendo: «Chi non muore si rivede.» La frase parve a Marcello fin troppo adatta alle circostanze, sebbene in maniera scherzosa e, forse, inconsapevole. Disse, ansimando per il turbamento e per la corsa: «Ma io credevo di… di averti ucciso.» «Io, invece, speravo che tu l’avessi saputo Marcello, che mi avevano salvato,» rispose Lino tranquillamente, «un giornale, è vero, annunziò che ero morto ma perché ci fu un equivoco… morì un’altro all’ospedale, nel letto accanto al mio… e così tu mi credevi morto… allora ho detto bene: chi non muore si rivede.»Ora, più che del ritrovamento di Lino, Marcello provava orrore del tono discorsivo, familiare, eppure funebre che si era stabilito subito tra di loro. Disse con dolore: «ma dall’averti creduto morto sono venute tante conseguenze. E tu invece non eri morto.» «Anche per me, Marcello, vennero tante conseguenze,» disse Lino guardandolo con una specie di compassione, «pensai che fosse un avvertimento e mi sposai… poi mia moglie morì,» soggiunse più lentamente, «tutto è ricominciato come prima… adesso faccio la guardia notturna… questi giardini sono pieni di bei ragazzi come te.» Disse queste parole con una sfrontatezza placida e dolce, senz’ombra, però, di lusinga. Marcello notò per la prima volta che i suoi capelli erano quasi grigi e che il viso era un po’ ingrassato. «E tu ti sei sposato… quella era la tua moglie, nevvero?»Improvvisamente, Marcello non poté più sopportare quel chiacchiericcio sommesso e squallido. Disse, afferrando l’uomo per le spalle e scuotendolo: «Mi parli come se nulla fosse successo… ma ti rendi conto che hai distrutto la mia vita?» Lino rispose, senza tentare di svincolarsi: «Perché mi dici questo, Marcello? Sei sposato, magari hai anche figli, hai l’aria di essere agiato, di che ti lamenti? Sarebbe stato peggio se tu mi avessi ucciso davvero.»«Ma io,» non poté fare a meno di esclamare Marcello, «io quando ti ho conosciuto ero innocente… e dopo non lo sono più stato, mai più.» Vide Lino guardarlo con stupore: «Ma tutti, Marcello, siamo stati innocenti… non sono forse stato innocente anch’io? E tutti la perdiamo la nostra innocenza, in un modo o nell’altro… è la normalità.» Egli si liberò a fatica dalla stretta già allentata di Marcello e soggiunse in tono di complicità: «guarda, ecco tua moglie, sarà bene che ci lasciamo.»
Immagine iconica del film “Il conformista” di Bernardo Bertolucci
“Perdere l’innocenza è la normalità”, dice Lino a Marcello, sottolineando che a farlo sono tutti. Ma Marcello l’ha persa credendo d’uccidere un uomo, ma questo uomo non è morto ed è lì, che gli rinfaccia l’inanità del suo gesto. Tutto il vivere di Marcello, quindi, è diventato inutile ed egli, normale tra i normali, quando la normalità diventa altro, non riesce a riciclarsi: all’autore (ma oserei dire allo stesso personaggio) non resta che sparire, uscire dalla storia insieme a coloro con cui l’aveva costruita: la consapevolezza del vuoto non può che essere la morte.
Il romanzo ebbe critiche feroci: Gioanola, critico psicoanalista, così lo liquida: «Dopo l’incontro con Freud e Marx, Moravia scrive i suoi libri peggiori, condotti come temi svolti su un argomento prestabilito, La disubbidienza e Il conformista, (quest’ultimo basato) sull’equazione risibile tra deviazioni sessuali spiattellatte in tutta la casistica e “conformismo” politico sotto specie nera di fascismo: Freud e Marx accoppiati a fornire ragioni esplicative per un teorema assurdo, il tutto in un intrigo con esecuzioni capitali e morti… che resuscitano»; non diverso il giudizio di Manacorda, critico marxista: «Sia pure per via negativa il romanzo serviva però ad illuminare la personalità di Moravia. Nessuno in Italia era stato quanto lui capace di penetrare nei più intimi recessi il marcio della società borghese che si era appunto incarnato nella realtà fascista; ma la sua analisi era stata condotta sempre al livello delle strutture – sesso e denaro – con una tendenza piuttosto a sprofondare nell’angoscia dell’esistenza che non a levarsi alla critica razionale delle istituzioni. I suoi personaggi sono sempre uomini, non mai cittadini, e quando vogliono comparire in tale veste risultano forzati e distorti. Il conformismo, insomma, è come l’indifferenza o la disubbidienza, la noia, il disprezzo o l’attenzione, tutti atteggiamenti propri di un’universale condizione umana, quasi un segno metafisico; i fatti dell’individuo da evento di cronaca tendono perciò a farsi emblema di un carisma naturale, ad uscire con loro ultimo senso dai parametri della storia per entrare nell’indeterminato dell’esistenza. Per questo il conformismo, che avrebbe dovuto esplicitamente alludere al rapporto fra stato e cittadino in un periodo ben individuato della nostra storia, scade a svolgimento di un caso patologico, la ricerca di mimetizzazione di un pervertito entro l’elefantiaco complesso burocratico-politico del suo Stato. Problema e soluzione del tutto paralleli a quelli della disubbidienza, anche se per Luca la patologia sessuale si risolveva, anziché nella partecipazione, nell’astensione.
Il fatto concreto, recente, ancora bruciante nel paese restava invece appena un episodio e uno strumento di una storia tutta individuale per quanto riguarda il protagonista e tutta universale per quanto riguarda le perenni possibilità dell’uomo. Il conformista proprio perché aveva portato al limite questa insufficienza della dialettica moraviana tentandone invano l’integrazione di un impegno tipico, rappresentò per ciò stesso lo scacco maggiore di Moravia, il tentativo non riuscito di entrare con i suoi personaggi non soltanto nel corpo sociale dell’Occidente borghese, ma in quello specificamente politico dell’Italia fascista, dove il conformismo era stato ben altro che medicina per invertiti, tesi inaccettabile e insufficiente anche se intesa in un suo valore di simbolo-limite.»
Eppure, al di là dell’incomprensione critica, il tema che appariva nel risvolto di copertina della prima edizione de Il conformista, cioè quello per cui “in tutti i tempi entrare a far parte di una società o comunità, condividerne i miti e le ideologie, ottenerne l’assistenza, comportarono sempre un prezzo molto alto sia di rinunzia alla libertà di pensiero e di azione, sia, addirittura, di complicità criminale. Questo romanzo vuole essere la storia del prezzo pagato da un conformista moderno per ottenere di appartenere ad una società inesistente.” doveva a tal punto affascinare lo scrittore romano che ne fa l’argomento anche del romanzo che stava elaborando contemporaneamente che tuttavia non verrà concluso e apparirà nelle diverse redazioni solo postumo: I due amici. Tuttavia la condivisione ideologica, questa volta, è quella del PCI degli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale. In una intervista del ’53 Moravia, parlando del nuovo lavoro, afferma: “La storia di alcuni ragazzi comunisti e delle loro vicende amorose in rapporto all’ideologia politica: volevo cioè rappresentare la misura in cui incide sulla vita sentimentale un partito che non lascia all’uomo residui d’individualità”

I tre frammenti recuperati nel Fondo Moravia tra carte e manoscritti dell’autore narrano l’amicizia fra Maurizio, cinico e dongiovanni, e Sergio, antifascista incapace di agire e pieno di rancore inespresso nei confronti dell’amico più fortunato, raccontata in tre momenti diversi, da tre voci diverse. Dal litigio a causa di una vedova, Emilia, che entrambi amano e che spinge Sergio a rompere i rapporti con Maurizio, agli scontri per la diversa posizione sociale, che ispira Sergio, comunista, dalle continue rivendicazioni di classe, ai compromessi ed in ultimo ai tradimenti e alle sfide nel contendersi Nella, una ragazza di umili origini, arrivata a Roma per trovare lavoro e amata prima da Sergio poi da Maurizio.
Ciò che rende simile questo “abbozzo” di narrazione a Il conformista è che se Marcello non trova la sua autenticità perchè immolata nell’altare del conformismo fascista, Sergio è annebbiato dall’ideologia comunista ed immola per essa l’amore cedendo la donna di cui è innamorato al suo rivale.
Il romanzo sul quale comunque aveva già intinto la penna durante la composizione sia de Il conformista che de I due amici e nel quale troviamo anche alcuni elementi che dovevano far parte dell’opera non portata a termine, è Il disprezzo, pubblicato nel 1954 e dal quale, anche questa volta, venne tratto un importantissimo film con la regia di Jean Luc Godard e dal titolo Le mépris:
Riccardo Molteni è un giovane intellettuale innamorato perdutamente di sua moglie Emilia. Quando per accontentarla decide di comprare casa, si vede costretto ad accettare il lavoro di sceneggiatore. Battista, produttore cinematografico di successo, lo assume per una prima sceneggiatura, poi gli affida una sceneggiatura più importante, si tratta di “rivitalizzare” il genere “peplum” affrontando l’Odissea omerica, che il regista Rheingold vuole affrontare in modo psicoanalitico, mentre il produttore vuole scene “popolari” per attrarre il grande pubblico. Riccardo, pur essendo fedele ad Emilia, si accorge che lei invece si sta raffreddando nei suoi confronti, finché lei infine ammette di disprezzarlo. Quando con Emilia viene invitato a Capri alla villa di Battista per lavorare sulla sceneggiatura con il regista tedesco, Riccardo vede Battista baciare Emilia. Ciò lo spinge a decidere di abbandonare il progetto di lavoro e fare ritorno a Roma. Il mattino, al risveglio, trova un messaggio da parte della moglie che lo avverte che lei è già partita con Battista. Mentre Riccardo passa il resto della giornata a Capri, i due fuggitivi hanno un incidente d’auto nel quale Emilia perde la vita.
Anche per questo romanzo qualche critico fa risalire l’ispirazione ad un fatto reale, la fine del rapporto di Alberto Moravia con Elsa Morante. Non è un caso che le liti burrascose tra i due avvennero nell’isola di Capri, ospiti nella casa di Curzio Malaparte, dove anche si ambienta parte del romanzo che il narratore romano sembra abbia scritto proprio durante il suo soggiorno campano. Tuttavia è bene sottilineare che Elsa, intellettuale, non è Emila (dattilografa), mentre più stringente sembra il rapporto tra Riccardo e Alberto: anche il primo è un intellettuale, ma anche, per necessità, uno scrittore per il cinema, sebbene la sua grande ambizione sia scrivere per il teatro; anche Moravia scrive sceneggiature, anche se sottolinea non spinto da necessità (anche se il cinema gli offre buoni introiti), ma un narratore di storie come lui non può prescindere dal mezzo che nel Novecento diventa il modo più idoneo e “popolare” di narrare storie.

Nel romanzo Battista offre a Riccardo il destro per girare un film sull’Odissea di Omero; sappiamo come il produttore voglia fare della mitologia omerica un nuovo film in costume che si richiami a quelli di gran successo biblici, mentre Rehinolg ne vuol dare una lettura psicoanalitica, lettura che Molteni non può accettare (dirà che tradirà lo spirito omerico) ma che richiama troppo le tensioni tra lui ed Emilia (quest’ultima letta, secondo il regista, troppo aderente all’Emilia che lui sta perdendo)
TI DISPREZZO
Si possono immaginare le cose più spiacevoli e immaginarle con la sicurezza che sono vere. Ma la conferma di queste supposizioni o meglio di queste certezze giungerà sempre in attesa e dolorosa, come se non si avesse immaginato nulla. In fondo io avevo sempre saputo che Emilia non mi amava più. Ma sentirmelo dire da lei mi fece lo stesso un effetto agghiacciante. Ella non mi amava più: queste parole, tante volte pensate, assumevano, pronunziate dalla sua bocca, un significato tutto nuovo. Erano un fatto, non una supposizione per quanto mischiata di certezza. Avevano un peso, una dimensione che nella mia mente non avevano mai avuto. Non ricordo bene come dicessi questa dichiarazione. Probabilmente trasalii come chi si mette sotto una doccia gelata sapendo che è gelata, e tuttavia, ricevendola, tradisce lo stesso, come se non l’avesse mai saputo. Poi cercai di riprendermi, dimostrarmi in qualche modo ragionevole e obiettivo. Dissi più dolcemente che potei: «vieni qui… siediti e spiegami perché non mi ami più».
Ella ubbidì e sedette di nuovo, questa volta sul divano. Rispose un po’ irritata: «Non c’è nulla da spiegare… non ti amo più e questo è proprio tutto quello che ho da dire.»
Io mi rendevo conto che più cercavo di mostrarmi ragionevole e più la spina di quel dolore ineffabile mi si affondava nella carne. Risposi, la faccia contorta da un sorriso sforzato: «Ammetterai almeno che mi devi una spiegazione… anche quando si licenzia la serva, le si spiega il perché.»
«Io non ti amo più, non ho altro da dire.»
«Ma perché?… Tu mi amavi, no?»
«Sì, ti ho amato… molto… ma ora non ti amo più.»
«Mi hai amato molto?»
«Sì, molto, ma ora è finito.»
«Ma perché? Ci sarà un perché.»
«Ci sarà, forse… ma non lo so dire… so soltanto che non ti amo più»
«Non ripeterlo così spesso», esclamai quasi mio malgrado, alzando un poco la voce.
«Sei tu che me lo fai ripetere… Non vuoi convincerti e allora te lo ripeto.»
«Ora ne sono convinto.»
Seguì il silenzio. Emilia adesso aveva acceso una sigaretta e fumava guardando in basso. Io stavo chino, la testa tra le mani. Dissi alla fine: «Se te lo dico io, il motivo, tu lo riconoscerai?»
«Ma io stessa non lo so.»
«Ma se te lo dico, potrai riconoscerlo.»
«Va bene, su… dillo.»
«Non parlarmi in questo modo», avrei voluto gridare, ferito dal suo tono sbrigativo e indifferente. Ma mi trattenni e, cercando di mantenere quel mio tono ragionevole, incominciai: «Ricordi quella ragazza che qualche mese fa veniva in casa nostra a battere a macchina una sceneggiatura… quella dattilografa… tu ci sorprendesti mentre ci baciavamo… fu una debolezza stupida da parte mia… ma non ci fu che quel bacio, il primo e l’ultimo, te lo giuro… poi non l’ho mai più rivista… ora, di’ la verità, non è stato forse quel bacio a distaccarti da me?… di’ la verità… non è stato a partire da quel bacio che tu hai cominciato a non amarmi di più?»
Mentre parlavo, la guardavo con attenzione. Ella ebbe un primo movimento quasi di sorpresa e di conseguente diniego: come se la mia supposizione le fosse sembrata del tutto assurda. Poi, come vidi chiaramente, un’improvvisa riflessione le fece cambiare espressione. Rispose lentamente: «Beh, mettiamo che sia stato quel bacio… ora che lo sai, ti sembra di star meglio?»
Fui subito sicurissimo che non era stato il bacio, come ella adesso pretendeva di farmi credere. Era chiaro: in un primo momento Emilia era stata addirittura sorpresa dalla mia supposizione, tanto era lontana dalla verità; poi, un calcolo improvviso gliel’aveva fatta accettare. Non potevi fare a meno di pensare che il motivo del suo disamore dovesse essere molto più grave di quel bacio senza conseguenze. Un motivo, probabilmente, che ella non voleva rivelarmi per un superstite riguardo verso di me. Emilia non era cattiva, come sapevo, e non amava offendere nessuno. Evidentemente il vero motivo era offensivo.
Dissi con dolcezza: «Non è vero, non è stato il bacio.»
Ella si meravigliò: «Perché?… Se ti ho detto di sì.»
«No, non è stato il bacio… è stata un’altra cosa.»
«Non so cosa vuoi dire.»
«Lo sai benissimo.»
«No, non lo so, parola d’onore.»
«E io ti dico che lo sai.»
Ella si spazientì, in una sua maniera quasi materna: «Ma perché vuoi sapere tante cose? Ecco come sei… perché vuoi frugare… che te ne importa?»
«Perché preferisco la verità, qualunque essa sia, alla menzogna… Oltre a tutto, se non mi dici la verità, posso immaginare chissà che cosa… qualche cosa di molto brutto.»
Ella mi guardò un momento, in silenzio, in una maniera singolare: «Che te ne importa», riprese poi, «hai la coscienza tranquilla, no?»
«Io, sì, certo.»
«E allora che può importarti del resto?»
Insistetti: «Dunque è vero… dunque è qualcosa di molto brutto.»
«Non ho detto questo… ho detto soltanto che se tu hai la coscienza tranquilla, tutto il resto non deve importarti.»
«Io ho la coscienza tranquilla, è vero… ma questo non vuol dire nulla… qualche volta anche la coscienza inganna.»
«La tua no, non è vero?», ella disse con un’ironia lievissima che non mi sfuggì tuttavia, e mi parve anche più offensiva della sua indifferenza.»
«Anche la mia.»
«Beh, devo andare», e ella disse improvvisamente, «hai altro da dirmi?»
«No, non te ne andrai prima di avermi detto la verità.»
«Te l’ho già detta la verità: non ti amo più.»
Che effetto mi facevano quelle quattro parole. Diventai pallido e la supplicai dolorosamente: «Ti ho già pregato di non dirmelo più… mi fa troppo male.»
«Sei tu che mi costringi a ripeterlo… a me, certo, non fa alcun piacere dirlo.»
«Perché vuoi che io creda che tu non mi ami più a causa di quel bacio?» proseguii seguendo il filo della mia riflessione, «un bacio è una cosa da nulla… quella ragazza era uno sciocca qualsiasi e non l’ho mai più rivista… tu queste cose le sai e le comprendi… no, la verità è che tu non mi ami più» adesso più che parlare compitavo le parole cercando di esprimere la mia difficile e oscura intuizione, «perché qualcosa è successo… qualche cosa che ha cambiato il tuo sentimento verso di me… anzi, forse, qualche cosa che ha cambiato prima di tutto l’idea che tu ti facevi di me poi, conseguentemente, anche il sentimento.»
Ella disse, con sincero tono di sorpresa e quasi di lode: «Bisogna riconoscere che sei intelligente.»
«Dunque è vero.»
«Non ho detto che è vero… ho detto soltanto che sei intelligente.»
Io cercavo e sentivo che la verità mi stava, come si dice, sulla punta della lingua. Insistetti: «Insomma, tu prima che avvenisse una certa cosa, pensavi bene di me… dopo, hai pensato male… e perciò hai cessato di amarmi.»
«Può anche darsi che sia andata così.»
D’improvviso provai un sentimento orribile: quel mio tono ragionevole, lo sentii, era falso. Io non ero ragionevole, soffrivo, anzi, acutamente, ero disperato e furioso, ero distrutto; e perché mai dovevo tenere un tono ragionevole? Non so quel che mi avvenne in quel momento. Prima ancora che me ne rendessi conto, ero balzato in piedi, urlando: «Ma non credere che io sia qui a chiacchierare del più e del meno» e le ero saltato addosso e l’avevo afferrata per il collo e l’avevo rovesciata sul divano e le urlavo in faccia: «Di’ la verità… dilla una buona volta… dilla!»
Sotto di me, il suo grande corpo perfetto che amavo tanto si dibatteva, ella si era fatta rossa e come gonfia in volto, dovevo stringere forte, e capii che, in fondo, desideravo ucciderla. Ripetei: «Dilla la verità una buona volta», e nello stesso tempo strinsi con forza raddoppiata e pensai: «Ora l’ammazzo… ma meglio morta che nemica.» Poi sentii che, con un ginocchio, ella cercava di colpirmi al ventre e infatti ci riuscì, con una tale violenza che mi mancò il fiato. Questo colpo mi addolorò quasi quanto la frase: “Non ti amo più”: era infatti il colpo di un nemico, il quale cerchi di far più male che sia possibile al suo avversario. Nello stesso tempo, il mio odio omicida cadde, rilasciai alquanto la presa e lei si liberò dandomi una spinta che quasi mi fece cadere dal divano. Quindi, prima ancora che mi riavessi, mi gridò con voce esasperata: «Io ti disprezzo… ecco quello che provo per te, ed ecco il motivo per cui non ti amo più… ti disprezzo e mi fai schifo ogni volta che mi tocchi… Eccola la verità… ti disprezzo e mi fai schifo.»
Ero in piedi. L’occhio, e subito dopo la mano, mi andarono ad un portacenere massiccio di cristallo che si trovava sul tavolo. Ella certamente credette che volessi ucciderla perché cacciò un gemito di paura e si coprì il viso con il braccio. Ma il mio angelo custode mi assistette: non so come riuscii a dominarmi, riposerai il portacenere sul tavolo e uscii dalla stanza.

Brigitte Bardot e Michel Piccoli ne Le mépris tratto da Il disprezzo di Moravia
Sin dalle prime righe quello che emerge è che il romanzo è in forma autodiegetica ed strutturato come un lungo flashback che il protagonista, Molteni, ripercorre dopo la morte della protagonista. Infatti potremo definirlo quasi un romanzo sul concetto dell’assenza: assenza dell’amore di lei per lui, assenza della possibilità di un film, assenza di una realizzazione intellettuale; per questo nel romanzo, come il passo dimostra, vi è il tentativo dell’omicidio, nel prosieguo del libro quello del suicidio e quindi la morte reale. Emilia nel libro sarà viva soltanto come fantasma/illusione della mente di lui. Un altro personaggio che non sa “rapportarsi” con la realtà in cui vive.
Dice Sanguineti, famoso critico letterario: “E’ ne Il disprezzo che la problematica centrale di Moravia trova la sua summa più precisa e complessa, quasi un’unitaria enciclopedia della sua varia tematica” prosegue Fàvaro “la scrittura, la vita coniugale, le aspirazioni e le frustrazioni, la svalutazione del sentimento e dell’arte, il disprezzo al quale non si può rimanere indifferenti costituiscono la materia di un conflitto senza soluzione, se non con la morte”.

E’ nel ’57 che Moravia, in modo diretto, affronta e supera quelle che in quel tornio di anni possono definirsi tematiche “neorealiste”. Pubblica, infatti, La ciociara uno dei suoi romanzi più riusciti e dal quale Vittorio De Sica trasse, nel 1960, uno dei film più belli della cinematografia italiana, con una strepitosa Sophia Loren, vincitrice del premio Oscar.
Anche questo romanzo nasce da una suggestione biografica: Alberto Moravia ed Elsa Morante, infatti, si erano rifugiati, durante l’occupazione nazista di Roma, a Fonni, paese della Ciociaria (territorio laziale, corrispondente all’incirca nei dintorni di Frosinone). Comincia a progettarlo sin dal ’46, ma si rende conto di dover “sedimentare” l’esperienza per poterne fare materia di romanzo e non di cronaca. Infatti afferma:
Cesira è una contadina della Ciociaria (un luogo posto a sud del Lazio, al confine con la Campania), sposata con un negoziante di Roma. Il romanzo è narrato in prima persona ed è la donna stessa a dirci che, rimasta vedova, gestisce il piccolo negozio del defunto marito. Ha una figlia di nome Rosetta, molto bella, un po’ ingenua e molto devota. Vivono a Roma e cercano in tutti i modi di sopravvivere alle angherie della Seconda Guerra Mondiale. Cesira appena verrà a sapere che l’esercito tedesco è pronto ad entrare a Roma per scontrarsi con l’esercito alleato, metterà da parte le provviste e cucirà i suoi pochi averi nelle fodere dei vestiti ed insieme alla figlia adolescente scapperà nella Ciociaria, in campagna. Durante il viaggio madre e figlia sopporteranno la fame, il freddo, la sporcizia per diversi mesi e nel frattempo attenderanno l’arrivo delle forze alleate. Tra queste ultime vi è divisione marocchina delle truppe francesi che, sorprese Cesira e Rosetta in una chiesa disabitata, le violenteranno. Le due donne verranno sconvolte da questo avvenimento cambiando col tempo anche il modo di concepire la vita.
Come per La Romana anche qui Moravia usa l’io narrante, ma con più efficacia ne sottolinea il ruolo di “vittima” della storia, di chi la legge con strumenti materiali, quali la fame, la difesa della prole (Rosetta), la sicurezza, ma forse, perché più “materiali”, più efficaci se non fossero stravolti dall’annullamento di essi per colpa della guerra; ma chi usa invece strumenti intellettuali non riesce ad opporsi: il Michele de Gli indifferenti, diventa il Michele de La ciociara, ma ambedue saranno due figure di sconfitti.

Sophia Loren e Jean Paul Belmondo: Cesira e Michele
MICHELE
Era l’una, ormai, e così pensammo di mangiare qualche cosa, un po’ di pane e formaggio. Proprio mentre stavamo mangiando, ecco giungere di corsa il figlio di Paride, dicendo, tutto affannato, che erano arrivati i tedeschi. Non capimmo a tutta prima perché pensavamo logicamente che, dopo tante cannonate, fossero gli inglesi a dover arrivare; e io anzi insistetti con lui che era un bambino e poteva aver capito male: «Vuoi dire gli inglesi.» «No i tedeschi.» «Ma i tedeschi sono fuggiti.» «E io ti dico che invece sono arrivati.» Ma ecco Paride a spiegare il mistero: era arrivato effettivamente un gruppo di tedeschi in fuga e adesso stavano a sedere sulla paglia, all’ombra di un pagliaio e non si capiva che volessero. Io dissi a Michele: «Be’ che ce ne importa dei tedeschi?… noi aspettiamo gli inglesi e non i tedeschi… lasciamo i tedeschi a cuocere nel loro brodo.» Ma Michele, purtroppo non mi diede retta: gli si erano accesi gli occhi al racconto di Paride; bisogna credere che al tempo stesso odiasse i tedeschi e ne fosse attratto; l’idea di vederli in fuga e disfatti dopo averli incontrati tante volte superbi e vittoriosi, si vedeva che lo eccitava e gli piaceva. Disse a Paride: «Andiamo a vedere questi tedeschi,» e si avviò. Rosetta ed io lo seguimmo.
Trovammo i tedeschi, come Paride ci aveva informato, all’ombra del pagliaio. Erano cinque e in vita mia non ho mai veduto gente più strapazzata ed esausta di loro. Stavano buttati sulla paglia uno di qua e uno di là, distesi a gambe e braccia aperte, come morti. Tre dormivano o almeno stavano ad occhi chiusi, un altro stava a occhi aperti, supino, fissando il cielo, un quinto, disteso anche lui sul dorso, si era fatto come un cuscino con un mucchio di paglia e guardava dritto davanti a sé. Notai soprattutto quest’ultimo: era quasi albino, con la pelle rosa e trasparente, gli occhi azzurri circondati di peli quasi bianchi, i capelli di un biondo chiarissimo, fini e lisci. Aveva le guance grigie di polvere e rigate come da lacrime che fossero colate sulla polvere e ci si fossero seccate; le narici nere di terra o di non so che di sudiciume; la bocca screpolata; e gli occhi cerchiati di rosso, con due freghi neri di sotto che parevano due unghiate. I tedeschi, si sa, hanno sempre l’uniforme in ordine, pulita e stirata come se uscisse allora dalla naftalina. Ma le uniformi di questi cinque erano gualcite e sbottonate; parevano avere cambiato persino colore come se fossero state investite con violenza da un getto di polvere o di nerofumo. Molti sfollati e contadini facevano cerchio intorno, a qualche distanza, guardando i tedeschi in silenzio, come si guarda uno spettacolo incredibile; i tedeschi stavano zitti e non si muovevano. Michele, dunque, si avvicinò e domandò donde venissero. Aveva parlato in tedesco ma l’albino, senza muoversi, come se la sua nuca fosse stata inchiodata sopra quel cuscinetto di paglia, rispose parlando piano: «Può parlare in italiano… conosco l’italiano.» Michele allora ripeté la domanda in italiano e l’altro rispose che venivano dal fronte. Michele domandò che cosa fosse successo. L’albino, sempre con quel suo atteggiamento di paralizzato, staccando pian piano le parole l’una dall’altra, con un tono cupo, minaccioso e sfinito disse che loro erano artiglieri; che erano stati sottoposti per due giorni e due notti ad un terribile bombardamento aereo; che, nonché i cannoni, persino il terreno sul quale si trovavano era saltato in aria; e che, alla fine, dopo avere veduto morire gran parte dei loro compagni, avevano dovuto sloggiare e fuggire. «Il fronte,» egli concluse lentamente, «non è più sul Garigliano ma più a nord e noi dobbiamo raggiungerlo.» Così, benché fossero ridotti a quel modo che parevano già morti, parlavano ancora di far la guerra e di resistere.
Michele domandò allora chi avesse sfondato il fronte, se gli inglesi o gli americani; e questa fu una domanda imprudente perché l’albino ebbe un sogghigno e disse: «Che le importa a lei chi fossero? Caro signore, lei deve contentarsi di sapere che tra poco i suoi amici saranno qui, ecco tutto.» Michele finse di non accorgersi del tono sarcastico e minaccioso e domandò che cosa potesse fare loro. L’albino disse: «Dateci qualche cosa da mangiare.»
Ora si era veramente agli sgoccioli, tutti quanti, e, forse con l’eccezione di Filippo, tra sfollati e contadini non credo che avrebbero potuto mettere insieme una pagnotta. Così ci guardammo in faccia, costernati; e io, interpretando il sentimento comune, esclamai: «Da mangiare? E chi ce l’ha la roba da mangiare? Se non ce la portano al più presto gli inglesi, qui moriamo tutti di fame. Aspettate anche voi gli inglesi e l’avrete la roba da mangiare.»Vidi Michele fare un gesto di disapprovazione come per dire “stupida” e capii che avevo detto una cosa che non avrei dovuto dire. Il tedesco intanto mi guardava fisso come se avesse voluto ben imprimersi nella memoria la mia faccia. Disse lentamente: «Un ottimo consiglio: aspettare gli inglesi.» Stette fermo ancora un poco e poi, levando a fatica un braccio, andò a frugarsi in seno sotto la giubba: «Ho detto che vogliamo qualche cosa da mangiare.» Adesso nella mano egli stringeva un’enorme pistola nera e la puntava contro di noi, pur senza muoversi né modificare il proprio atteggiamento. Mi venne una paura terribile, e forse non tanto per la pistola quanto per lo sguardo dell’albino che pareva proprio quello di un animale selvatico preso in trappola che, però, minacci ancora e mostri i denti. Michele, invece, non si turbò e disse con semplicità a Rosetta: «Va’, corri da mio padre e digli che ti dia un po’ di pane per un gruppo di tedeschi che ne hanno bisogno.» Disse queste parole in una maniera particolare, come per suggerire a Rosetta che doveva spiegare che quel pane i tedeschi lo richiedevano con la pistola. Rosetta subito corse verso la casa di Filippo. In attesa del pane, restammo tutti fermi, facendo cerchio intono al pagliaio. L’albino, dopo un momento, riprese: «Non abbiamo bisogno soltanto del pane… abbiamo anche bisogno di qualcuno che venga con noi e ci indichi il sentiero per andare a nord e raggiungere il nostro esercito.» Michele disse: «Il sentiero eccolo lì,» indicando la mulattiera in direzione della montagna. L’albino disse: «Lo vedo anch’io. Ma non conosciamo queste montagne. Abbiamo bisogno di qualcuno. Per esempio quella ragazza.» «Quale ragazza?» «Quella che è andata a prendere il pane.» Mi si gelò il sangue a queste parole: se portavano via Rosetta, in mezzo alla guerra, chissà che cosa poteva succedere, chissà quando l’avrei rivista. Ma Michele disse subito, senza perdere la calma: «Quella ragazza non è di queste parti. Le conosce meno di voi.» «E allora,» disse l’albino, «verrà lei, caro signore. Lei è di queste parti, no?» Io avrei voluto gridare a Michele: «Digli che sei forestiero!» ma non ebbi tempo. Troppo onesto per mentire, lui aveva già risposto: «Sono di queste parti ma anch’io non le conosco. Ho sempre vissuto in città.» L’albino, a queste parole, ebbe quasi un riso e disse: «A sentir lei nessuno le conosce queste montagne. Verrà lei. Vedrà che tutto ad un tratto scoprirà di conoscerle molto bene.» Michele, a questo, non rispose nulla, si limitò a corrugare le sopracciglia al di sopra degli occhiali. Intanto Rosetta era tornata, tutta affannata, con due piccoli pani che mise in terra, sulla paglia, tendendo in avanti la mano e sporgendosi, proprio come si fa con gli animali selvatici di cui non ci si fida. Il tedesco notò il gesto e disse con una nota di esasperazione nella voce: «Dammi il pane nelle mani. Non siamo mica cani arrabbiati che mordono.» Rosetta raccolse i pani e glieli porse. Il tedesco rinfoderò la pistola, prese i pani e si levò a sedere.
Adesso anche gli altri si erano levati a sedere, si vede che non dormivano e che avevano seguito tutto il dialogo benché ad occhi chiusi. L’albino cavò di tasca un coltello e tagliò i due pani in cinque parti uguali e le distribuì ai compagni. Mangiarono piano piano, noi stavamo sempre intorno, in cerchio e non dicevamo una parola. Quando ebbero finito e fu una cosa lunga perché mangiavano, per così dire, briciola a briciola, una contadina gli porse in silenzio un concone di rame pieno d’acqua e loro ne bevvero chi due e chi anche quattro ramaiolate: erano propri morti di fame e di sete. Poi l’albino tirò di nuovo fuori la pistola.
«Allora,» disse, «bisogna che andiamo se no si fa tardi.» Rivolse queste parole ai compagni che subito cominciarono lentamente a tirarsi su in piedi. Quindi si voltò verso Michele: «E lei viene con noi per indicarci il sentiero. Restammo tutti atterriti perché credevamo che l’albino l’avesse poco prima detto, così, tanto per dire; e invece, adesso, si vedeva che l’aveva detto sul serio. Anche Filippo era accorso e aveva assistito anche lui in silenzio al pasto dei tedeschi. Ma quando vide l’albino puntare la pistola contro Michele, cacciò quasi un gemito e con un coraggio che nessuno gli conosceva, si parò tra la pistola e il figlio: «Questo è mio figlio, avete capito? è mio figlio.»
L’albino non disse nulla. Fece però con la pistola un gesto come per scacciare una mosca; voleva dire che Filippo si mettesse da parte. Ma Filippo, invece, gridò: «Lui, mio figlio, non conosce le montagne, verità di Vangelo. Lui legge, scrive, studia, come potrebbe conoscere le montagne?»
L’albino disse: «Verrà lui e basta.» Adesso si era levato in piedi e, pur senza abbassare la pistola, si aggiustava con l’altra mano il cinturone.
Filippo lo guardò come se non avesse capito bene. Lo vidi inghiottire e passarsi lingua sulle labbra: doveva sentirsi soffocare e, non so perché, mi ricordai in quella frase che lui ripeteva tanto volentieri: “ccà nisciuno è fesso.” Poveretto, adesso lui non era più né fesso né furbo; era un padre e basta. Infatti, dopo essere rimasto un momento come fulminato, gridò di nuovo: «Prendete me al posto di mio figlio. Io le montagne le conosco. Prima di essere commerciante sono stato merdaiolo ambulante. Le ho girate tutte le montagne. Vi porto io per mano, montagna montagna, fino al vostro comando. Conosco i sentieri più comodi, più segreti. Vi porto, ve lo prometto.» Egli si voltò verso la moglie e disse: «Ci vado io. Voi non state in pensiero, torno domani prima di sera.» Aggiungendo l’azione alla parola, si tirò su la fascia dei pantaloni e, atteggiando tutto il viso ad un sorriso, che in quel momento parve proprio straziante, si avvicinò al tedesco e gli mise la mano sul braccio, dicendo con una disinvoltura forzata: «Be’, andiamo, abbiamo parecchia strada da fare.»
Ma il tedesco non l’intendeva in questo modo. Disse calmo: «Lei è troppo vecchio. Verrà suo figlio, è il suo dovere.» E scostandolo semplicemente con la canna della pistola, andò a Michele e gli fece cenno, sempre con la pistola, di precederlo: «Andiamo.» Qualcuno, non so chi, gridò: «Michele, scappa.» Avete visto il tedesco? Con tutto che fosse sfinito, si voltò come un fulmine dalla parte donde era venuto il grido e sparò. Per fortuna il colpo si perdette tra le pietre della macera; ma il tedesco raggiunse lo stesso il suo scopo che era di intimidire i cittadini e gli sfollati e di impedirgli di fare qualcosa per Michele. Infatti tutti si sparpagliarono atterriti, riformando però il cerchio un po’ più lontano; e quindi guardarono in silenzio il tedesco che se andava, spingendo avanti Michele con la canna della pistola, nella schiena. Così partirono e io ho ancora davanti agli occhi, come se ci fossi presente, la scena della loro presenza: il tedesco con il braccio piegato per puntare la pistola, Michela che gli camminava davanti e, ricordo, aveva un pantalone più lungo che quasi gli andava a finire sotto il tacco e uno più corto che lasciava vedere la caviglia. Camminava piano Michele, forse sperando che noialtri ci saremmo rivoltati contro i tedeschi e gli avremmo dato modi scappare; la maniera con cui strascicava le gambe mi suggerì l’idea che si tirasse dietro una pesante catena. La processione dei quattro tedeschi, di Michele e del tedesco albino sfilò sotto di noi per il sentiero che portava a valle e quindi scomparve lentamente nella macchia. Filippo, che come tutti gli altri, allo sparo era scappato per poi fermarsi a poca distanza a guardare, quando l’albino e Michele furono per svoltare, tutto ad un tratto diede come un ruggito e fece per slanciarsi dietro. I contadini e gli sfollati gli furono subito addosso e lo trattennero che ruggiva e ripeteva il nome del figlio e piangeva a grosse lagrime che gli rigavano la faccia. Adesso erano accorse anche la madre e la sorella e stentavano a capire, domandando spiegazioni a destra e a sinistra; ma appena capirono, si misero a piangere anche loro e ad urlare il nome di Michele. La sorella singhiozzava forte ripetendo tra i singhiozzi: «Proprio adesso che stavano per finire tutte cose, proprio adesso.» Noi non sapevamo che dire perché, quando c’è un dolore vero con cause vere, le parole non possono diminuirlo e bisognerebbe invece annullare la causa del dolore e questo noi non potevamo fare. Alla fine Filippo si riebbe e disse alla moglie prendendola per le spalle e aiutandola a camminare: «Vedrai che tornerà… certo… non può non tornare… indicherà la strada e tornerà.» La figlia, pur piangendo, dava ragione al padre: «Vedrai, mamma, che torna prima di sera.» Ma la madre disse quello che spesso dicono le madri in questo caso e purtroppo il più delle volte ci azzeccano perché, si sa, l’istinto della madre è più forte di qualsiasi ragionamento: «No, no, lo so che non tornerà, ho il presentimento che non lo vedrò mai più.»

Nonostante la materia nuova, che si riallaccia con il clima neorelistico, sia per la tematica (la condizione contadina durante la fine della Seconda Guerra Mondiale) sia per lo stile, (le parole dei protagonisti mimano il linguaggio popolare), il personaggio di Michele – non è un caso si chiami allo stesso modo del giovane protagonista de Gli indifferenti – non riesce ad aderire alla realtà. L’intellettuale sembra non comprendere ciò che la guerra gli pone di fronte, fa “vivere” la sua curiosità di conoscenza non riuscendo “a comunicare con la realtà, a servirsi degli stessi oggetti che lo circondano senza mistificarli” (Carlo Salinari)
LA VIOLENZA DELLA GUERRA
Finalmente, ecco apparire in fondo alla pianura distesa e verde, una lunga striscia di colore incerto, tra il bianco e il giallo; i sobborghi di Roma. E dietro questa striscia, sovrastandola, grigia sullo sfondo del cielo grigio, lontanissima, eppure chiara, la cupola di San Pietro. Dio sa se avevo sperato durante tutto l’anno di rivedere, laggiù all’orizzonte, quella cara cupola, così piccola e al tempo stesso così grande da potere essere quasi scambiata per un accidente del terreno, per una collina o una montagnola; così solida benché non più che un ombra; così rassicurante perché familiare e mille volte vista e osservata. Quella cupola, per me, non era soltanto Roma ma la mia vita di Roma, la serenità dei giorni che si vivono in pace con se stessi e con gli altri. Laggiù, in fondo all’orizzonte, quella cupola mi diceva che io potevo ormai tornare fiduciosa a casa e la vecchia vita avrebbe ripreso il suo corso, pur dopo tanti cambiamenti e tante tragedie. Ma anche mi diceva che questa fiducia tutta nuova, io la dovevo a Rosetta e al suo canto e alle sue lacrime. E che senza quel dolore di Rosetta, a Roma non ci sarebbero arrivate le due donne senza colpa che ne erano partite un anno prima, bensì una ladra e una prostituta, quali, appunto, attraverso la guerra e a causa della guerra, erano diventate.
Il dolore. Mi tornò in mente Michele che non era con noi in questo momento tanto sospirato del ritorno e non sarebbe più stato con noi; e ricordai quella sera che aveva letto ad alta voce, nella capanna di Sant’Eufemia, il passo del Vangelo su Lazzaro; e si era tanto arrabbiato con i contadini che non avevano capito niente ed aveva gridato che eravamo tutti morti, in attesa della resurrezione, come Lazzaro. Allora queste parole di Michele mi avevano lasciata incerta; adesso, invece, capivo che Michele aveva avuto ragione; e che per qualche tempo eravamo state morte anche noi due, Rosetta ed io, morte alla pietà che si deve agli altri e a se stessi. Ma il dolore ci aveva salvate all’ultimo momento; e così, in certo modo, il passo di Lazzaro era buono anche per noi, poiché, grazie al dolore, eravamo alla fine, uscite dalla guerra che ci chiudeva nella sua tomba di indifferenza e di malvagità ed avevamo ripreso a camminare nella nostra vita, la quale era forse una povera cosa piena di oscurità e di errore, ma pur tuttavia la sola che dovessimo vivere, come senza dubbio Michele ci avrebbe detto se fosse stato con noi.

Sophia Loren
La guerra raccontata da Moravia incide nell’esistenza, la trasforma, la disumanizza: infatti essa dà vita allo scatenamento degli istinti bestiali non più controllabili; deturpa le coscienze, le rende simili alle bestie; è l’epilogo di Rosetta che da bambina fragile, sotto la guida della madre che cerca di conservare fino in fondo il senso dell’onestà, diventa infine, dopo la violenza subita, una prostituta. Ma ci dice Cesira, diventare “altro” da quello che si è stato è comunque un ricominciare, un vivere, una prospettiva di un domani, di contro alla cecità feroce di una guerra dal popolo subìta, né voluta, né capita, e prendere atto, senza intellettualismi, che, forte di un sentimento vitale datale dall’essere donna, non bisogna rinunciare a fare patti con la realtà.
Precedono e seguono il romanzo due raccolte Racconti romani (1954) e Nuovi racconti romani (1959), che, insieme con La romana e La ciociara costituiscono la fase cosiddetta “neorealista” di Moravia.
Fra le due raccolte non vi è differenza, né tematica né strutturale, tanto da poter parlare di un’opera unitaria: sono tutti raccontati in prima persona e presentano, per la maggior parte, personaggi “minori” della Roma del dopoguerra: disoccupati, meccanici, faccendieri, camerieri e via dicendo; inoltre hanno tutti la stessa lunghezza, corrispondente, più o meno, allo spazio dedicato loro dal Corriere della Sera, dove vevivano regolarmente pubblicati. Da ciò ne deriva che la loro edizione in volume fosse posteriore e non tenne in considerazione la cronologia con cui il giornale li proponeva. Moravia sottolinea come l’ispirazione per tali racconti sia stata più cinematografica che “letteraria”, sebbene egli prenda spunto dal poeta dialettale romano Belli, per riprodurre, novellisticamente, personaggi dei suoi sonetti. Si è che per Moravia il neorealismo letterario ha una certa dose di “liricità” in quanto racconta l’esperienza partigiana vissuta dagli stessi scrittori, mentre la sua opera, come appunto i film “neorealistici” scendevano sulle strade per filmare, senza filtro ideologico, la situazione che si presentava davanti alla macchina da presa (basti pensare al film capolavoro del neorealismo Ladri di biciclette di Vittorio de Sica)
LADRI IN CHIESA
Che fa il lupo quando la lupa e i lupetti hanno fame e stanno a pancia vuota, lamentandosi e bisticciandosi tra loro, che fa il lupo? Io dico che il lupo esce dalla tana e va in cerca di roba da mangiare e magari, dalla disperazione, scende al paese ed entra in una casa. E i contadini che l’ammazzano hanno ragione di ammazzarlo; ma anche lui ha ragione di entrare in casa loro e di morderli. Così tutti hanno ragione e il torto non c’è l’ha nessuno; e dalla ragione nasce la morte. Quell’inverno io ero come il lupo e, anzi, proprio come un lupo non abitavo in una casa ma in una grotta, laggiù, sotto Monte Mario, in una cava abbandonata di pozzolana. Ce n’erano di parecchie di grotte, ma le più erano ostruite dai rovi, due sole erano abitate, quella mia è quella di un vecchio che è un po’ mendicava e un po’ andava in giro a raccogliere stracci e si chiamava Puliti. Il luogo, a ridosso del monte, era giallo e pelato, con le aperture delle grotte tutte affumate e nere. Davanti la grotta di Puliti c’è da sempre un bidone di benzina che ci serviva da fornello e mia moglie, in piedi, con il bambino al petto, che menava la ventola per accendere i carboni. Dentro, la grotta era perfino meglio di una camera in muratura; spaziosa, asciutta, pulita, con il materasso in fondo e la roba appesa ai chiodi. La famiglia, dunque, la lasciavo alla grotta e andavo a Roma a cercar lavoro; ero bracciante e per lo più lavoravo negli sterri. Poi venne l’inverno e, non so perché, di sterri se ne fecero sempre meno, e io cambiai mestiere tante volte ma sempre per poco tempo, e, alla fine, restai senza lavoro. La sera, quando tornavo alla grotta, e vedevo, alla luce della lampada a olio, mia moglie accovacciata sul materasso che mi guardava, e il bambino che teneva al petto che mi guardava, e i due bambini più grandi che giocavano in terra che mi guardavano, e leggevo in quegli otto occhi la stessa espressione affamata, mi pareva proprio di essere un lupo con una famiglia di lupi e pensavo: “Uno di questi giorni se non gli porto da mangiare, vuoi vedere che mi mozzicano?” Puliti, quel vecchiaccio, che a vederlo con la sua bella barba bianca pareva un Santo e poi invece, appena apriva bocca, subito si capiva che delinquente era, mi diceva: «Perché li mettete al mondo i figli? Per farli soffrire? E tu, intanto, perché non fai il ciccarolo? Con le cicche, sempre, qualche cosa ci rimedi». Ma io non me la sentivo di andare in giro a raccattare cicche: volevo lavorare con le mie braccia. Una sera, dalla disperazione, dissi a mia moglie: «Non ce la faccio più… sai che ti dico? Mi apposto all’angolo di una strada e il primo che viene…» Mia moglie mi interruppe: «Vuoi andare in galera?» E io: «Almeno in galera si mangia.» E lei: «Tu sì… ma noi?» Quest’ultima obiezione, lo confesso, fu decisiva.
Fu Puliti che mi suggerì l’idea della chiesa. Frequentava le chiese per mendicare e le conosceva, si può dire, tutte, una per una. Disse che se mi facevo chiudere la sera in una chiesa, poi, se ci sapevo fare, la mattina potevo scappare senza che mi vedessero. Avvertì poi: «Fa’ attenzione, però… i preti mica sono scemi… la roba buona la tengono nella cassaforte e quelli che vedi sono fondi di bicchieri». Finalmente affermò che se la sentiva, una volta che avessi fatto il colpo, di rivendere la roba. Insomma, mi mise una pulce nell’orecchio, sebbene, poi, non ci pensassi e non ne parlassi più. Ma le idee, si sa, sono come le pulci, camminano da sole e, quando meno te lo aspetti ti danno un morso e ti fanno saltare in piedi.
Così, una di quelle sere, l’idea mi diede il morso e io ne parlai a mia moglie. Ora bisogna sapere che mia moglie è religiosa e al paese, si può dire, stava più in chiesa che in casa. Disse subito: «Che, sei diventato matto?» Io avevo prevenuto l’obbiezione e le risposi: «Questo non è un furto… La roba, nella chiesa, perché ci sta? Per fare il bene… Se noi prendiamo qualche cosa, che facciamo? Facciamo il bene… a chi, infatti, si dovrebbe fare il bene se non a noi che abbiamo tanto bisogno?» Lei parve scossa e domandò: «Ma tu come le hai pensate tutte queste cose?» Io dissi: «Non te ne occupare e rispondi: non è scritto forse che bisogna dar da mangiare agli affamati?» «Sì» «Siamo o non siamo affamati?» «Sì» «Ebbene in questo modo facciamo il nostro dovere… anzi facciamo un’opera buona.» Insomma tanto dissi, sempre insistendo sulla religione che era, come sapevo, il suo punto debole, che la convinsi. Soggiunsi, poi: «Ma siccome non voglio che rimani sola, verrai con me… così, in galera, se ci scoprono, ci andremo insieme». «E le creature?» «Le creature le lasciamo a Puliti… poi ci penserà il Signore.» Così ci mettemmo d’accordo e quindi ne parlammo a Puliti. Lui discusse il piano, approvandolo; ma alla fine disse, lisciandosi la barba: «Domenico, dà retta a me che sono vecchio… i cuori d’argento lasciali stare… è roba da poco… attaccati alle gioie». Quando ripenso a Puliti, alla sua barba e alla gravità con cui mi dava questi consigli, quasi quasi mi viene da ridere.
Il giorno fissato, lasciammo i bambini a Puliti e scendemmo con il tram a Roma. Proprio come due lupi affamati che scendono dal monte al paese; e chiunque, vedendoci, ci avrebbe preso per due lupi: mia moglie bassa e tarchiata, tutto petto e spalle, con i capelli crespi ritti che le facevano come una fiamma sulla testa, la faccia risoluta; io magro scannato, il viso a coltello nero di barba, gli occhi incavati e scintillanti. Avevamo scelta una chiesa antica, dalle parti del Corso, in una traversa. Era una chiesa grande e molto buia per via che ci aveva case tutt’intorno; con due file di colonne e, al di là delle colonne, due navate strette e buie con tante cappelline, piene di tesori. Di vetrine con cuori d’argento e dorati, ce n’erano in quantità, appesa alla pareti. Ma io avevo messo gli occhi su una vetrinetta più piccola, dove, tra pochi cuori più preziosi, stava in mostra una collana di lapislazzuli su un fondo di velluto rosso. Questa vetrinetta si trovava in una cappella dedicata alla Madonna; e, infatti, in cima all’altare, sotto un baldacchino, c’era la statua della Madonna, di grandezza naturale, tutta dipinta, con la testa circondata da un nimbo di lampadine e, ai piedi, molti vasi di fiori e molti candelabri. Entrammo in chiesa che era già notte e, al momento che non c’era nessuno, ci nascondemmo dietro l’altare, in quella cappella dove era la vetrina. C’erano due o tre scalini, dietro la statua, e sedemmo su quelli. A un’ora tarda, il sacrestano prese a girare per la chiesa, strascicando i piedi e borbottando: «Si chiude;» ma dietro quell’altare non ci venne e si limitò a spegnere tutte le lampadine all’infuori di due lumettini rossi, uno per parte. Poi lo udimmo che chiudeva le porte e alla fine traversò la chiesa per tutta la sua lunghezza e se ne andò dalla parte della sacristia. Eccoci dunque al buio, in quel corridoietto, tra l’altare e la parete dell’abside. Io avevo la febbre e dissi sottovoce a mia moglie: «Su, facciamo presto… apriamo la vetrina». La udii rispondere: «Aspetta… che fretta c’è?» e poi la vidi uscire dal nascondiglio. Andò in mezzo alla cappella, fece lì, in quella penombra, un inchino, si segnò, poi, camminando a ritroso, fece un altro inchino e si segnò una seconda volta. Finalmente la vidi inginocchiarsi in terra, in un angolo della cappella, e giungere le mani come per pregare. Che preghiere fossero non saprei, ma capii che non era poi tanto convinta di far bene, come le avevo detto, e voleva premunirsi per quanto poteva. La vedevo chinar la testa nascondendo il viso sotto la massa dei capelli e poi rialzare il viso in quella lucetta rossa muovendo le labbra e poi riabbassarlo, proprio come al rosario. Mi avvicinai e le mormorai, inquieto: «Le preghiere potevi anche dirle a casa, no?» Ma lei, rude: «Lasciami perdere… va’, gira, la chiesa è tanto grande… proprio qui hai da stare?» Sussurrai:«Vuoi intanto che tu preghi, che io apra la vetrina?» E lei, sempre sgarbata: «Non voglio nulla… anzi, quel ferro, dallo a me». Il ferro era un paletto più che sufficiente per aprire quella vetrinetta traballente: glielo diedi e mi allontanai.
Presi a girare per la chiesa, senza sapere che fare. La chiesa, in penombra, mi faceva paura, con le volte alte e buie che a un sospiro rintronavano; con l’altare maggiore, laggiù in fondo, monumentale, luccicante appena, con i confessionali neri e chiusi, appiattati al buio delle navate laterali. Camminando in punta di piedi, andai alla porta, tutto solo, tra le due file di banchi vuoti, e allora tornai indietro e andai a sedermi nella navata di sinistra, davanti a una tomba illuminata da una lucernetta rossa. La tomba, murata nella parete, aveva una grande lapide di marmo nero, lucido, e due figure, una per parte; uno scheletro che impugnava una falce e una donna nuda avvolta dei propri capelli. Ambedue le figure erano di marmo giallino, brillante, scolpito benissimo; e io mi distrasse un poco a osservarle e a furia di guardare mi pareva, forse a causa del buio, che si muovessero e che la donna accennasse a fuggire dallo scheletro e questi, galante, la trattenesse per un braccio. Allora, per rinfrancarmi, pensai alla grotta, ai figli, a Puliti, e mi dissi che, se in quel momento mi avessero proposto di tornare indietro e di scegliere di nuovo quello che dovevo fare, avrei fatto la stessa cosa o perlomeno una cosa molto simile a questa. Insomma, non era un caso che fossi in quella chiesa, e non era un caso che ci fossi per quello scopo, e non era un caso che non avessi trovato niente di meglio da fare. Tra questi pensieri mi venne sonno e mi addormentai. Fu un sonno pesante, senza sogni, sigillato dal freddo che in quella chiesa pareva di cantina. Così dormii e non mi accorsi di nulla.
Poi qualcuno mi scoteva e io, nel sonno, dissi: «Aho, vacci piano… che ti prende?» Finalmente, siccome continuavano a scuotermi, aprii gli occhi e vidi gente: il sacrestano che mi guardava con gli occhi fuori dalla testa; il parroco, un vecchio, coi capelli bianchi spettinati e la veste ancora sbottonata; due o tre guardie e, tra le guardie, mia moglie, più tetra che mai. Dissi, così, senza muovermi: «Lasciateci stare… siamo sfollati e siamo entrati in chiesa per dormire.» Allora una delle guardie mi mostrò qualcosa che, lì per lì, tanto ero intontito dal sonno, scambiai per un rosario: la collana di lapislazzuli: «E questa… anche questa per dormire?» Insomma dopo qualche altra spiegazione, le guardie ci presero in mezzo e uscimmo dalla chiesa.
Era ancora notte, ma verso l’alba, con le strade deserte e bagnate di guazza. Andavamo di fretta, per quelle straducce, tra le guardie, a testa china, muti. Vedendo mia moglie che camminava davanti, poveretta, così tarchiata e bassa, con la gonnella corta e i capelli ritti sulla testa, mi venne compassione dissi a una delle guardie: «Mi dispiace per lei e per i miei figli». La guardia mi domandò: «Dove ce l’hai i figli?» Glielo dissi, e lui: «Ma tu un padre di famiglia… come ti è saltato in mente? Non hai pensato ai tuoi figli?» Io gli risposi: «E’ proprio perché ci pensavo che ho fatto quello che ho fatto.»
Al Commissariato, un giovane biondo, seduto dietro una scrivania, come ci vide, disse: «Ladri sacrileghi, eh.» Ma mia moglie, tutto d’un tratto, gridò con una voce terribile: «Davanti a Dio, non sono colpevole». Io non le conoscevo quella voce e rimasi a bocca aperta. Il commissario disse: «Allora è tuo marito il colpevole». «Neppure». «Sta’ a vedere che il colpevole sono io… e la collana come l’hai avuta?» E mia moglie: «La Madonna è scesa dall’altare, ha aperto la vetrinetta e mi ha dato la collana». «La Madonna eh… anche il piè di porco? ti ha dato la Madonna?» E mia moglie sempre con quella voce, alzando la mano: «Potessi morire se non ho detto la verità». Continuarono a interrogarci, non so quanto tempo, ma io dicevo che non avevo visto niente, come era vero; e mia moglie ripeteva che la Madonna le aveva dato la collana. Ogni tanto gridava: «Uomo inginocchiati davanti al miracolo». Insomma, pareva esaltata o addirittura matta. Andò a finire che la portarono via, mentre continuava a gridare e invocare la Madonna: credo che la mandassero in infermeria. Poi il commissario voleva sapere da me se mi risultava che mia moglie fosse matta e io gli risposi: «Magari lo fosse davvero;» pensando che i matti non soffrono e le cose le vedono come pare a loro. Ma pensavo pure che poteva darsi che mia moglie avesse detto la verità e quai mi dispiaceva di non aver visto con gli occhi miei la Madonna scendere dall’altare, aprire la vetrina e consegnarle la collana.
In Ladri in chiesa, che, come in tutti i racconti delle due raccolte, è condotto da un io narrante, si possono leggere più componenti: sebbene ci presenti una situazione di vera disperazione per la povertà (non senza un taglio che potremmo definire mutuato dalla cinematografia attraverso la zoommata all’interno della grotta), da un lato vira su un registro comico (il protagonista che s’addormenta in chiesa), dall’altro su un registro miracolistico a cui la disuminità della loro condizione li porta a sperare. Da sottolineare l’uso di vocaboli che si richiamano al vernacolo romanesco come mozziccano, ciccarolo, mescolate, invece con espressioni colte come affumate o costruzioni come davanti la grotta.
Prima di riprendere con il romanzo, Moravia, d’altra parte come molti suoi colleghi, pubblica, nel 1958, un libro odeporico (riferito a un viaggio): Un mese in URSS in cui raccoglie le corrispondenze dal paese sovietico per il Corriere della Sera; in effetti in quel periodo l’Unione Sovietica rappresentava un vero e proprio laboratorio politico: la morte di Stalin e quindi dello stalinismo come forma oppressiva per chi osava contraddire il “grande padre” (che, tra le altre cose, godeva di una enorme popolarità); la speranza di un cambiamento con Nikita Krusciov che, nel XX Congresso del PCUS nel 1956, denunziò pubblicamente Stalin e dichiarò il culto della personalità come contrario al marxismo; la repressione per la rivolta d’Ungheria che sottolineava il ruolo dell’URSS come potenza egemone del blocco cosiddetto sovietico.

Il lavoro di Moravia, tuttavia, presenta delle caratteristiche che vanno oltre il “classico” reportage di viaggio: se il fine descrittivo si conserva nell’illustrare le caratteristiche di città come Tibilissi, Erivan e Samarcanda, in molte parti del testo l’autore cerca la specificità sovietica nei grandi intellettuali che, in quanto russi, l’hanno sì preceduta, ma che sono stati capaci di informarla all’interno dell’uomo russo/sovietico: si percepisce per l’attenzione che Moravia presta a Gogol, a Dostoevskij, sino al mitico Tamerlano. Si veda questa pagina tratta da un capitolo in cui Moravia s’interroga sulla difficoltà sovietica ad accettare la prosa del grande autore di Delitto e castigo: l’articolo (il I capitolo del libro) s’intitola Marx e Dostoevskij ed è ambientato nella Leningrado di allora:
LENINGRADO E L’APPARTAMENTO IN CUI ABITO’ DOSTOEVSKIJ
Ed ecco, infine, i quartieri vecchi della città, con le strade brevi e larghe tagliate a scacchiera, fiancheggiate di casamenti tetri e scalcinati, col vecchio acciottolato qua e là interrotto da buche e da pozze, lustro e nero sotto la pioggia. Strade vuote, tranquille e lugubri in cui giocano, noncuranti della pioggia, i monelli. Entriamo in un vasto portone dalla soglia sconnessa e fangosa, ci affacciamo nel cortile ingombrato da alte, nere cataste di legna da ardere. Le pareti di questo cortile sono lebbrose, scalcinate, percorse qua e là da maligne fessure a zig zag. Una donna di mezza età si affaccia da una delle scale e ci domanda se vogliamo visitare l’appartamento in cui abitò a lungo Dostoevskij.
Le rispondiamo che siamo qui per questo e quindi la seguiamo su per la scala. E una scala ampia, di una tetraggine brutale e sinistra: pareti nerastre chiazzate di umidità, scalini di sordida pietra grezza e raschiata, alcuni dei quadri spezzati o mancanti, ringhiera di rozzo legno tagliato senza arte, scura e sommaria. La scala è buia, di una tristezza atroce, e siamo a primavera; bisogna immaginarla nei lunghi inverni nevosi, con le tenebre dentro e fuori.
Perché mi sono soffermato a descrivere questa scala? Perché questa è la scala per cui andava e veniva Dostoevskij il quale abitò per anni in questo casamento; ma è anche la scala per cui andava e veniva l’eroe di Dostoevskij, Raskolnikov, prima e dopo il delitto dell’usuraia. Già, perché io sono qui insieme con due studiosi di Dostoevskij, i quali mi informano che questo è senza alcun dubbio il casamento dove abitava Raskolnikov; pur essendo nello stesso tempo quello in cui abitava l’autore di Delitto e castigo. In altri termini, l’identificazione di Dostoevskij con Raskolnikov fu completa, egli mise Raskolnikov nel proprio appartamento, anzi nella propria stanza, lo fece muovere per le proprie scale e in generale per tutti i luoghi che lui stesso frequentava, in quel tempo, a Pietroburgo.
Ecco il pianerottolo, all’ultimo piano; la donna apre, nell’ombra, una porta nera come il bitume e ci precede in uno stretto corridoio tutto ingombro di armadi, si passa a pena. Su questo corridoio danno due porte dietro le quali, a causa della coabitazione cui sono costretti gli abitanti delle grandi città russe, abitano due famiglie; la terza porta in fondo, è quella della donna, cioè di Dostoevskij, ossia di Raskolnikov. Ma lasciamo parlare Dostoevskij: «La stanzuccia di lui veniva a trovarsi proprio sotto il tetto di un’altro casamento di cinque piani e rassomigliava piuttosto ad un armadio che ad una stanza». Effettivamente la stanza in cui entriamo è molto piccola e soprattutto stretta, quasi una continuazione del corridoio. Per lo stesso verso, sono allineati il letto, un armadio, un tavolino con la macchina da cucire. In fondo alla stanza c’è la finestra con le solite tende tendine e controtendine ma non so davvero come si faccia ad arrivarci perché lo spazio sotto il davanzale è tutto occupato da un tavolo tondo sul quale, accanto ad un servizio da tè di porcellana, c’è un ferro da stiro acceso e una camicetta con le maniche distese che la donna stava stirando al nostro arrivo. In questa stanzetta abitava Dostoevskij il quale, a sua volta, ci fece abitare Raskolnikov. Qui fu meditato dallo scrittore il delitto dell’usuraia e qui fu fatto meditare al personaggio. Ci ritiriamo ringraziando la donna.
Dopo la casa di Dostoevskij e di Raskolnikov, i due studiosi russi mi fanno fare tutto il percorso esatto («settecentotrenta passi in tutto» ci informa Dostoevskij) tra la casa dell’assassino e quello dell’assassinata. Ecco il malinconico, nero canale della Fontanka, ecco il ponte a schiena da asino tra due file di palazzi marmorei, ecco la informe piazza Sennaia, o Mercato del Fieno, ecco la strada dove abitava l’usuraia, molto simile a quella dove abitava Dostoevskij.
Varco di nuovo un tetro portone, salgo di nuovo per una scala tenebrosa, umida, sinistra, mi soffermo sul buio pianerottolo dell’usuraia. Il campanello che Raskolnikov tirò più volte prima e dopo il delitto è là, presso la porta; forse, se lo tirassi, la porta si schiuderebbe piano piano e la testa ripugnante della vecchia si affacerebbe. Ma no, c’è stata la rivoluzione, non ci sno più usurai in Russia. Mentre torniamo indietro, i due studiosi russi mi assicurano che Dostoevskij, così psicologico, così astratto da dare nel fantastico, era, nei riferimenti topografici e in genere nelle descrizioni d’ambiente, di una precisione fotografica. «Noi sappiamo tutto dei personaggi di Dostoevskij e tutto a Leningrado è rimasto tale e quale come ai tempi di Dostoevskij, e Dostoevskij, a sua volta, ha descritto ogni cosa senza cambiare né aggiungere nulla». La mattinata procede sulla Neva, nel punto preciso in cui il demoniaco Svidrigailov si avviò sul fangoso e sdrucciolevole pavimento di legno in direzione della piccola Neva…»

La casa di Dostoevsij
Moravia afferma “io ho scritto un libro sull’Unione Sovietica perché m’interessavano il disgelo, lo stalinismo, il passaggio da una civiltà all’altra” ma è innegabile che l’autore cerchi, oserei dire antropologicamente, di capire la società russo/sovietica e per fare ciò parte dalla convinzione secondo cui “in senso largo, ogni popolo si specchia nella propria letteratura e ne è rispecchiato”, perché “c’è più verità storica e sociale nei libri di poesia che nei gravi studi di molti storici e sociologi”. Ci dice cioé Luca Clerici, prefatore di questo testo di Moravia, che “per capire la realtà sovietica non serve dunque guardarla in faccia ma occorre studiarne il riflesso letterario, la sua rappresentazione astratta”.
Del 1960 è La noia, romanzo che riconcilia Moravia con il suo pubblico di lettori (il libro avrà lo stesso successo de Gli indifferenti):

Dino, di famiglia borghese e ricca, si è rivolto alla pittura per noia: sperando cioè, di realizzare, per mezzo dell’espressione artistica, quel rapporto con le cose che altrimenti non gli riesce di stabilire. Ma dopo dieci anni di lavoro, l’atto di distruggere la tela alla quale sta lavorando gli si rivela come il suo primo vero gesto creativo. Conosce Cecilia, di cui si dice che abbia portato alla disperazione e alla morte un uomo, e ne diventa l’amante, curioso di scoprire che cosa l’aveva resa indispensabile all’altro. La ragazza gli si rivela disponibile a tutto e a tutti, e perciò inafferabile; nonostante il “possesso” fisico, avverte che ella gli sfugge. Vorrebbe sentirla sua perché, venendogli a noia, si ricollegherebbe nella dimensione consueta della realtà. Ma non riesce ad averla né con il denaro, che lei accetta e spende con un altro, né con una proposta di matrimonio, respinta, né con un gesto omicida, dal quale si ritrae appena in tempo. Sopravvissuto a un tentativo di suicidio, Dino si accorge che non desidera più possederla: l’ama in modo diverso, accettando che viva al di fuori di lui.
Con il romanzo La noia Moravia supera il cosiddetto periodo del “neoralismo” (costituito da La romana, La ciociara, Racconti romani e Nuovi racconti romani) per approdare ad un approfondimento della tematica già presente ne Gli indifferenti, prendendo spunto dalla lettura di Wittgenstein e dal dibattito culturale sull’alienazione e la reificazione che la nuova civiltà industriale stava producendo, riducendo le cose intorno a noi “altre” o trasformandole in oggetti senza alcun rapporto con noi.
Tutto ciò viene chiarito nell’incipit del romanzo:
DEFINIZIONE DELLA NOIA
Penso che, a questo punto, sarà forse opportuno che io spenda qualche parola sulla noia, un sentimento di cui mi accadrà di parlare spesso in queste pagine. Dunque, per quanto io mi spinga indietro negli anni con la memoria, ricordo di aver sempre sofferto della noia. Ma bisogna intendersi su questa parola. Per molti la noia è il contrario del divertimento; e divertimento è distrazione, dimenticanza. Per me, invece, la noia non è il contrario del divertimento; potrei dire, anzi, addirittura, che per certi aspetti essa rassomiglia al divertimento in quanto, appunto, provoca distrazione e dimenticanza, sia pure di un genere molto particolare. La noia, per me, è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà. Per adoperare una metafora, la realtà, quando mi annoio, mi ha sempre fatto l’effetto sconcertante che fa una coperta troppo corta, ad un dormiente, in una notte d’inverno: la tira sui piedi e ha freddo al petto, la tira sul petto e ha freddo ai piedi; e così non riesce mai a prender sonno veramente. Oppure, altro paragone, la mia noia rassomiglia all’interruzione frequente e misteriosa della corrente elettrica in una casa: un momento tutto è chiaro ed evidente, qui ci sono le poltrone, lì i divani, più in là gli armadi, le consolle, i quadri, i tendaggi, i tappeti, le finestre, le porte; un momento dopo non c’è più che buio e vuoto. Oppure, terzo paragone, la mia noia potrebbe essere definita una malattia degli oggetti, consistente in un avvizzimento o perdita di vitalità quasi repentina; come a vedere in pochi secondi, per trasformazioni successive e rapidissime, un fiore passare dal boccio all’appassimento e alla polvere.
Il sentimento della noia nasce in me da quello dell’assurdità di una realtà, come ho detto, insufficiente ossia incapace di persuadermi della propria effettiva esistenza. Per esempio, può accadermi di guardare con una certa attenzione un bicchiere. Finché mi dico che questo bicchiere è un recipiente di cristallo o di metallo fabbricato per metterci un liquido e portarlo alle labbra senza che si spanda, finché, cioè, sono in grado di rappresentarmi con convinzione il bicchiere, mi sembrerà di avere con esso un rapporto qualsiasi, sufficiente a farmi credere alla sua esistenza e, in linea subordinata, anche alla mia. Ma fate che il bicchiere avvizzisca e perda la sua vitalità al modo che ho detto, ossia che mi si palesi come qualche cosa di estraneo, col quale non ho alcun rapporto, cioè, in una parola, mi appaia come un oggetto assurdo, e allora da questa assurdità scaturirà la noia la quale, in fin dei conti, è giunto il momento di dirlo, non è che incomunicabilità e incapacità di uscirne. Ma questa noia, a sua volta, non mi farebbe soffrire tanto se non sapessi che, pur non avendo rapporti con il bicchiere, potrei forse averne, cioè che il bicchiere esiste in qualche paradiso sconosciuto nel quale gli oggetti non cessano un solo istante di essere oggetti.
Dunque la noia, oltre alla incapacità di uscire da me stesso, è la consapevolezza teorica che potrei forse uscirne, grazie a non so quale miracolo.
Ho detto che mi sono annoiato sempre; aggiungo che soltanto in tempi abbastanza recenti sono riuscito a capire con sufficienza chiarezza che cosa sia realmente la noia. Durante l’infanzia poi anche durante l’adolescenza e la prima giovinezza, ho sofferto della noia senza spiegarmela, come coloro che soffrono di continui mal di testa ma non si decidono mai a interrogare un medico. Soprattutto quando ero bambino, la noia assumeva forme del tutto oscure a me stesso e agli altri, che io ero incapace di spiegare e che gli altri, nel caso mia madre, attribuivano a disturbi della salute o altri simili cause; un po’ come il malumore dei bimbi più piccoli viene attribuito allo spuntare dei denti. Mi avveniva, in quegli anni, di cessare improvvisamente di giocare e di restare ore intere, immobile, come attonito, sopraffatto in realtà dal malessere che mi ispirava quello che ho chiamato l’avvizzimento degli oggetti, ossia dall’oscura consapevolezza che tra me e le cose non ci fosse alcun rapporto. Se in quei momenti mia madre entrava nella stanza e vedendomi muto, inerte e pallido per la sofferenza, mi domandava che cosa avessi, rispondevo invariabilmente: «mi annoio»; spiegando così, con una parola di significato chiaro e angusto, uno stato d’animo vasto e oscuro. Mia madre, allora, prendendo sul serio la mia affermazione, si chinava ad abbracciarmi e poi mi prometteva di portarmi al cinema quel pomeriggio stesso, ossia mi proponeva un divertimento che, come sapevo ormai benissimo, non era il contrario della noia né il suo rimedio. E io, pur fingendo di accogliere con gioia la proposta, non potevo fare a meno di provare quello stesso sentimento di noia, che mia madre pretendeva fugare, per le sue labbra che si posavano sulla mia fronte, per le sue braccia che mi circondavano alle spalle, nonché per il cinema che lei mi faceva balenare come un miraggio davanti agli occhi. Anche con le sue labbra, con le sue braccia, con il cinema, infatti, io non avevo alcun rapporto in quel momento. Ma come avrei potuto spiegare a mia madre che il sentimento di noia di cui soffrivo non poteva essere alleviato in un modo? Ho già notato che la noia consiste principalmente nell’incomunicabilità. Ora non potendo comunicare con mia madre dalla quale ero separato come da qualsiasi altro oggetto, in un certo modo ero costretto ad accettare il malinteso e a mentirle.
Questo tema della noia, presente quasi ossessivamente in tutto il romanzo, viene condotto in questa pagina con un taglio propriamente didascalico; in essa – attraverso sottolineature esplicative sul chiarirsi riguardo al significato del termine stesso, e sull’uso, per rendere più esplicito il suo significato – ci dà il taglio che potrebbe essere quasi saggistico. Imparentato infatti al romanzo sartriano La nausea (di cui Moravia tradusse un capitolo), l’opera moraviana s’inserisce a pien diritto nel tema dell’ “incomunicabilità” reso “popolare”, in quel periodo, dai film di Michelangelo Antonioni, quali La notte, L’avventura, L’eclisse (tutti recensiti da Moravia per la rivista L’Espresso).
Il libro narra l’incapacità da parte del ricco borghese Dino di creare un rapporto con la realtà: tale mancanza, come esplicitato, dà origine alla noia.
Se la realtà è costituita da elementi, da cose egli cerca di prenderne possesso sia attraverso la pittura, sia attraverso il sesso: nel primo caso il suo tentativo risulterà fallimentare, non riuscendo a dare vita a quadri, foss’anche astratti; nel secondo cercando di possedere Cecilia che, amante del pittore che lo ha preceduto (Balestrieri), dopo la sua morte diventa la sua amante; ma la “realtà” Cecilia, nella sua giovinezza spensierata e nella sua voluttà erotica, gli si offre senza mai diventare sua, sfuggendogli, non permettendo di indagarla in quanto, parafrando un altro testo moraviano, lei è tautologicamente ciò che è, e lui deve accettare che diventi anche amante di altri.

Horst Buchholz e Catherine Spaak
Cecilia nell’offrigli il sesso, gli offre il corpo e quindi il reale, ma egli non vuole solo il sesso, vuole possederla “intellettualmente”, fare di essa un qualche cosa che, esistendo fuori di sé, possa capirla, interpretarla e prenderla. A tale scopo le chiederà di sposarlo, ricoprendola, letteralmente da bigliettoni di denaro, sottratti alla madre. Di fronte alla sua negazione e quindi all’impossibilità di rapportarsi con Cecilia/reale egli tenterà il suicidio, andando a scontrarsi, mentre percorre a tutta velocità una strada di campagna, contro il fusto di un platano. Soltanto all’ospedale, guardando fuori dal suo letto di ricovero, egli scoprirà di vedere le “cose” con occhio diverso, riconoscendole: forse Dino, sfiorata la morte, scopre la vita che gli scorre accanto.
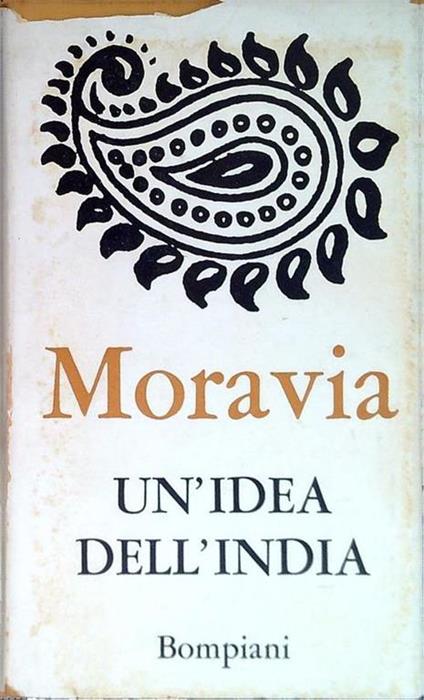
Nel 1962 Moravia scrive il suo secondo libro odeporico: viene infatti invitato dal Corriere della sera a presentare un reportage sull’immenso continente indiano. A fare il viaggio non sarà, però, solo: ad accompagnarlo sarà la sua nuova compagna (dopo la fine del rapporto con Elsa Morante) Dacia Maraini e soprattutto l’amico intellettuale Pier Paolo Pasolini che, anch’egli per il quotidiano Il Giorno, dovrà a sua volta inviare articoli per i lettori. La raccolta di tali articoli diventerà per Moravia un breve testo dal titolo Un’idea dell’India, per Pasolini un’opera pubblicata da Longanesi, L’odore dell’India. I titoli suggeriscono qualcosa: lo sguardo attento e distaccato di Moravia non può che cogliere un’idea dell’immensità del continente indiano; lo sguardo più viscerale dell’autore friuliano non può che coglierne l’essenza sensoriale (in questo caso olfattiva) che questo paese orientale gli offriva.
Moravia rimane impressionato da due caratteristiche della realtà indiana: l’estrema povertà e la onnipresente religiosità, anzi sembra cogliere un rapporto diretto della seconda sulla prima, tanto che questo connubio inestricabile il popolo indiano non può che subirlo; da qui il loro sguardo che potremo definire di serena rassegnazione.
Moravia cerca d’individuare la peculiarità indiana, da cui, secondo il nostro, discendono tutte le sue sovrastrutture, nella religiosità:
INTRODUZIONE
Allora sei stato in India. Ti sei divertito?
No.
Ti sei annoiato?
Neppure.
Che ti è accaduto in India?
Ho fatto un’esperienza.
Quale esperienza?
L’esperienza dell’India.
E in che cosa consiste l’esperienza dell’India?
Consiste nel fare l’esperienza di ciò che è l’India.
E che cos’è l’India!
Come faccio a dirtelo? L’India è l’India.
Ma poniamo che io non sappia affatto che cos’è l’India. Dimmi tu che cos’è.
Neppure io so veramente che cosa sia l’India. La sento, ecco tutto. Anche tu dovresti sentirla.
Cosa vuoi dire?
Voglio dire che dovresti sentire l’India come si sente, al buio, la presenza di qualcuno che non si vede, che tace, eppure c’è.
Non ti capisco.
Dovresti sentirla, laggiù, a oriente, al di là del Mediterraneo, dell’Asia minore, dell’Arabia, della Persia, dell’Afghanistan, laggiù, tra il Mare Arabico e l’Oceano Indiano, che c’è e ti aspetta.
Mi aspetta per che fare?
Per non fare nulla.
Ancora una volta non ti capisco.
O meglio, per non fare, assolutamente.
Va bene. Ma tu non mi hai ancora detto che cos’è l’India.
L’India è l’India.
Dimmelo in una formula, in una sentenza, in uno slogan.
Ebbene l’India è il contrario dell’Europa.
Ne so quanto prima. Bisognerebbe prima di tutto che tu mi dicessi che cos’è l’Europa.
Preferisco trovare uno slogan per l’India. Diciamo così, allora, che l’India è il paese della religione.
E questo sarebbe il contrario dell’Europa. Ma anche l’Europa è religiosa.
No, l’Europa non è religiosa.
Eppure le religioni pagane del Mediterraneo e dei paesi nordici, il Cattolicesino, la Riforma…
Non importa. L’Europa non è religiosa.
Che cos’è l’Europa?
Se fossi un indiano, forse te lo saprei dire. Come europeo mi riesce difficile.
Allora immagina di essere un indiano.
Come indiano ti direi: l’Europa, quel continente dove l’uomo è convinto di esistere e di essere al centro del mondo, e il passato si chiama storia, e l’azione è preferita alla contemplazione; l’Europa dove si crede comunemente che la vita vale la pena di essere vissuta e il soggetto e l’oggetto convivono in buona armonia, e due illusioni come la scienza e la politica sono prese sul serio e la realtà non nasconde niente, eppure, non per questo, è niente; l’Europa che cosa ha a che fare con la religione?
Ecco un indiano un po’ presuntuoso. Se non altro egli ignora il passato dell’Europa, voglio dire il passato religioso, i secoli durante i quali furono costruite le cattedrali.
Il medioevo, stavo per dirlo. Non è vero che il nostro indiano ignori il medioevo; egli, anzi, lo apprezza perché, appunto, è il solo periodo storico dell’Europa che gli faccia pensare all’India. Ma egli sa pure che per la grande maggioranza degli europei il ricordo atavico del medioevo è un ricordo di ignoranza, di infelicità, di rozzezza, di arretratezza e di miseria. Nella persistenza tenace di questo pregiudizio del senso comune popolare contro il medioevo, il nostro indiano ravvisa una prova di più che l’Europa in fondo non è religiosa. E infatti la fine del medioevo gli europei la chiamano Rinascimento; secondo il punto di vista dell’India dovrebbero invece chiamarla Decadenza.
Ma infine non si può negare che senza la religione non si spiega gran parte della storia d’Europa.
L’idea del nostro indiano è diversa. Egli pensa che gli europei così inventivi per quanto riguarda la scienza, la politica, le arti, hanno dimostrato, invece, una mancanza completa di originalità e di capacità creativa nel campo della religione. La storia d’Europa non si spiega con la religione bensì con lo sforzo degli europei per conciliare le esigenze della religione con quelle di tutto ciò che le è estraneo o avverso. In realtà il carattere principale della religione in Europa è il compromesso; quanto a dire che gli europei non sono in fondo veramente religiosi. Del resto, a riprova, dice il nostro indiano, basta vedere che cosa gli europei sono riusciti a fare del cristianesimo nel giro di pochi secoli Che cosa?Una contaminazione con tutto ciò che non è religioso, un’appendice è una giustificazione della vita mondana, un puntello della politica, un ornamento, una comodità, una superfluità, una cosa che non serve a niente e non significa niente.
Beh, lasciamo stare le idee di questo indiano che oltretutto mi è piuttosto antipatico. Torniamo all’India, come l’hai vista tu. Sto ancora aspettando che tu mi spieghi che cosa hai voluto dire con la frase: l’India è il paese della religione. Intanto di quale religione? In India ci sono molte religioni. Del buddismo? Dell’Induismo? Del jainismo? Dell’Islam?
No, di nessuna di queste religioni.
Eppure, che io sappia, ho nominato le principali religioni indiane.
L’India non è il paese di una religione storicamente ben definita, con un fondatore, uno sviluppo, un passato, un presente un futuro. L’India e il paese della religione come situazione esistenziale. Della religione senza più. Per assurdo, anche se in India non ci fossero religioni, l’India sarebbe egualmente il paese della religione.
Ma una religione senza più non esiste. Esistono le religioni; e, per ciascuno degli adepti, la propria religione.
Se dovessi fare un paradosso, ti direi che le le religioni, come dici tu, proprio perché sono religioni cioè hanno un fondatore, uno sviluppo, un passato, un presente, un futuro, non sono già più la religione, Sono, in un certo senso, dei risultati di secondo grado e quasi sempre dei compromessi.
Allora dimmelo tu che cos’è la religione.
Te l’ho già detto: la religione è l’India e l’India è la religione.
L’introduzione è svolta in forma dialogica e questa scelta dà vita ad una struttura fortemente paratattica e, vista l’attenzione che Moravia sin da La noia attribuisce alla tautologia – da lui derivata da Wittengstein – gli fa affermare che l’India è la religiosità e la religiosità è l’India. Ai termini non si aggiunge nulla: il concetto d’identità li rende intercambabili. Da qui derivano tutte le conseguenze, come fosse la religiosità causa della struttura politica, come la divisione in classi e la loro impermeabilità, e dell’economia che genera l’estrema povertà.
Nonostante Gandhi abbia abolito la struttura classista indiana, essa permane proprio come ideologia religiosa ed è quasi impossibile sradicarla.

Il libro inoltre, forse in modo più incisivo di quello dell’Urss, ci descrive le città e i vari templi, tacendo, forse perchè poco conosciuta in Occidente, la cultura indiana, che, nonostante la dominazione inglese, non è riuscita ad incidere sulla mentalità dell’immenso continente indiano. Ci rimangono le sculture nei templi, i volti scuri, le mani tese a chiedere elemosina in qualunque posto andasse (anche questo come dato diffuso, oserei dire – per come ne parla Moravia – “naturale”, come andare al lavoro) i volti scuri dei paria, i perizoma sui corpi scheletrici e la grandezza e lucentezza degli occhi delle donne indiane ed infine la gentilezza e la trascuratezza perchè nulla di questo mondo è importante.
Nello stesso anno pubblica un libro di brevi racconti, forma per lui sempre più congeniale – dal titolo L’automa. Il testo ne presenta 41 e sono tutti della lunghezza di un elzeviro (rubrica fissa, affidata a uno o più giornalisti in rotazione; nel XX secolo a scrivere tale rubrica furono sempre più scrittori: oltre ad Alberto Moravia, Dino Buzzati, Tommaso Landolfi ed Eugenio Montale. Molti di loro, in seguito, raccolsero i loro elzeviri in volume).

Se per automa, come afferma il dizionario, s’intende una “macchina che riproduce i movimenti (e in genere anche l’aspetto esterno) dell’uomo e degli animali, quindi, figurativamente, persone prive di volontà propria, che agiscono o si muovono macchinalmente senza coscienza dei loro atti”, potremo dire che i personaggi protagonisti della raccolta moraviana, questo fanno. Prendiamo ad esempio un racconto:
PICCOLA E GELOSA
La pineta era deserta, avvolta in un’area azzurra e fumosa nella quale i raggi rossi del sole già basso parevano restare impigliati e come incapaci di penetrare fitti intrighi di rovi e di arbusti. Silvio accostò la macchina al marciapiede e disse: «Tre macchine vuote nessuno intorno… in questo momento ci sono in questo bosco almeno tre coppie che si dicono le stesse cose e si vogliono bene più o meno nello stesso modo. Noi saremo la quarta.» Avrebbe voluto che la donna comprendesse dal tono ironico che lui pensava proprio il contrario; ma lei gli sorrise, fiduciosa. Penso che con lei bisognava parlare chiaro e brutale: non era intelligente e questo era ancora il suo minor difetto. Ma come dirle: da oggi non ci vedremo più? Silvio aprì lo sportello e la guardo scendere: bassa ma snella, con la gonna stretta e corta, e una giubba enorme di cuoio; la testa grossa, gonfia di capelli neri; il volto pallido, olivastro, passionale. Ricordò la definizione sommaria che ne aveva dato un suo amico la prima volta che l’aveva veduta: “Piccola e gelosa”, e sospirò pensando che era vero. Ma si accorse pure che poteva ormai gusardarla con freddezza e oggetività, con sguardo sgombro di sentimento. Prima, quando l’amava ancora, pensò, la contemplava senza veramente vederla; adesso la vedeva, come si vede un oggetto qualsiasi, senza contemplarla. Si sentì rinfrancato da questa riflessione che lo confermava nella sua volontà di separarsi da lei. E la seguì per un sentiero, tra i pini.
La donna lo procedeva con passo baldanzoso, quasi correndo verso quel luogo nel bosco, ancora sconosciuto ad ambedue, dove si sarebbero distesi sull’erba e sarebbero stati, come lui aveva previsto, la quarta coppia a fare la stessa cosa in quello stesso momento. Anche questa risolutezza, pensò, un. tempo lo turbava come un tratto insolito in una donna; adesso gli pareva invece un indizio in più della sua ottusità. Camminarono senza parlare per il sentiero che serpeggiava tra la macchia folta e alla fine sbucarono in una larga radura illuminata dal sole, tutta sparsa di cartacce annerite e schiacciate. «Le cartacce di questa estate,» osservò con perplessità, «non vorrai mica sederti qui, in questo mondezzaio».
La donna alzò le spalle: «Per me andrebbe bene lo stesso.» Silvio rispose recisamente: «Non per me.» Adesso gli era venuta un’idea che gli piaceva, forse perchè era crudele: di solito, in passato, la ricerca del luogo adatto in quella stessa pineta era lunga e meticolosa: aveva da essere un luogo pianeggiante, ombroso d’estate, solatio nelle altre stagioni, chiuso dalla macchia agli sguardi indiscreti, non umido né troppo asciutto e polveroso. Era una ricerca piacevole, per la premeditazione e la tacita intesa che ci mettevano. Adesso, pensò, avrebbe fatto il contrario: avrebbe rifiutato uno dopo l’altro tutti i luoghi che la donna gli proponeva finché non si fosse accorta che lui non desiderava alcun luogo e che tra di loro non c’era più alcuna intesa. Un po’ come la quercia alla quale doveva essere impiccato Bertoldo, pensò; la quercia non si trovò mai appunto perché era Bertoldo che avrebbe dovuto sceglierla. Contento di questa trovata, seguì la donna fischiettando.
«Sei allegro» lei disse, voltandosi a metà con una sfumatura quasi di inquietudine nella voce, come se fosse stata gelosa della sua allegria. Silvio rispose: «Sì, è una bella giornata, questa.»
«Anche per me.»
«Perché?»
«Oh, lo sai, perché stiamo insieme. E tu, perché?»
«Indovina.»
«Come faccio a saperlo?»
«Indovina.»
Adesso erano in una radura, di nuovo: protetta, senza cartacce, esposta al sole. Silvio notò tuttavia che era un po’ in discesa e sparsa di sassi. «Mettiamoci qui,» propose la donna.
«Qui? Ma non lo vedi che è in discesa, appena seduti ci sentiremo scivolare giù.»
«Va bene, cerchiamo un altro posto.»
La donna riprese a camminare avanti e disse: «Vediamo intanto se indovino il motivo per cui, per te, questa è una bella giornata. Dimmi fuoco e acqua.» Era, questo, un gioco che facevano spesso. Si chinò, colse un filo d’erba, se lo mise in bocca e soggiunse: «Dunque per te questa è una bella giornata. Motivo?»
«O bella, tu devi indovinare.»
«Ma dammi almeno qualche indicazione.»
Silvio esitò: «Mettiamo che lo sia perché sto per liberarmi di qualche cosa.»
«Liberarti di qualche cosa? Del tuo raffreddore di ieri?»
«Acqua, acqua.»
«Perché non ci mettiamo qui?» domandò la donna indicando il suolo. Era una radura, pianeggiante e ben chiusa d’ogni parte della macchia. Silvio scosse subito il capo: «Non lo vedi che è polverosa? Poi, quando ci alziamo, siamo coperti di polvere dalla testa ai piedi.»
«Uh, quanto sei difficile oggi» disse la donna con civetteria. «Beh, andiamo ancora avanti.»
Andarono avanti. Adesso la pineta era così fitta che non c’erano più sentieri. Al loro passaggio la frasca del bosco ceduo si apriva con un fruscio selvatico; le spine agganciavano i loro vestiti; i rami vi lasciavano invescate le foglie gialle dell’autunno. «Dunque tu stai per liberarti di qualche cosa,» riprese la donna, «vediamo un po’: di un oggetto o di una persona?»
«Prova a dirlo.»
«Di un oggetto.»
«Acqua, acqua.»
«Di una persona.»
«Fuoco.»
«Di una persona?» Erano arrivati in un punto oltre il quale non pareva si potesse andare. L’intrico dei rovi e degli arbusti era così folto che il sole stesso pareva giungerci in brandelli incerti, misteriosi, come se i suoi raggi si fossero strappati e infranti al passaggio. Ma un grande arbusto di forma rotonda si apriva in basso rivelando una cavità ampia, quasi una grotta dentro il fogliame. «Ficchiamoci là dentro, sembra una piccola stanza.»
«Là dentro?» Silvio storse la bocca, «bisogna strisciare, sporcarsi.»
«Nient’affatto. Guarda». Con foga, la donna si gettò a quattro zampe, noncurante di lui che la guardava, penetrò camminando sulle mani e sulle ginocchia, come un animale, dentro la cavità; quindi si rivoltò e gli gridò ridendo: «Vieni subito… è bello qui dentro.»
«No, no,» disse Silvio con accento perentorio, «non ci vengo… e tu fammi il piacere di uscire subito fuori.»
La sua voce dovette suonare sgradevole alla donna perché il riso le morì sulle labbra; senza dir parola, strisciò fuori dalla cavità e uscì levandosi in piedi: «Ma che hai, oggi?»
«Niente, cerchiamo un altro luogo.»
Ella parve sospirare; ma si riprese subito e, precedendolo, disse: «Dunque, tu vuoi liberarti di una persona. Al tuo posto, lo so di chi vorrei liberarmi.»
«Di chi?»
«Della tua cameriera… non la posso soffrire… mi guarda sempre di traverso quando vengo a trovarti… soltanto a causa di questa cameriera, vorrei che ci fidanzassimo… così non avrebbe più niente da ridire. Dunque è la cameriera?»
«Acqua.»
«Allora è Gildo.»
Gildo era il migliore amico di Silvio. La donna ne era gelosa come di tutte le persone che aveva trovato nella vita di lui allorché si erano conosciuti. Silvio disse con voce cattiva: «Acqua di nuovo… non sperarlo neppure.»
«Io non spero niente,» disse la donna, «per me non è un buon amico… ecco tutto.»
«Acqua, acqua, un fiume, un mare d’acqua.»
«Va bene,» disse lei stizzita, «allora, per caso, non sarebbe tua madre?»
Anche la madre era una delle persone di cui la donna era gelosa, sia perché non vedeva di buon occhio i loro rapporti, sia per la sola ragione che Silvio le era affezionato. Lui disse: «Acqua, si capisce. Non ti pare che stai esagerando?»
«Perché? Tua madre non può soffrire me e io non posso soffrire lei.»
«Sì, ma comunque: acqua.»
«Ne sei proprio sicuro?»
Silvio la guardò ed ebbe ad un tratto quasi compassione di lei. Nessuno di coloro che lo circondavano aveva simpatia per lei; e adesso anche lui le si voltava contro. Trasalì, vedendola annunziare trionfante: «Questo è il luogo ideale.»
Era effettivamente una radura alla quale non si poteva obiettare niente: pianeggiante, illuminata dal sole, coperta di aghi di pini, chiusi nella macchia. «Io non mi muovo più di qui» disse la donna con una voce al tempo stesso bellicosa e triste. Silvio notò quest’accento insolito e non osò protestare. Il suo sguardo errò per la radura, Quindi si alzò verso gli arbusti che la circondavano: «Ma siamo a ridosso del viale,» esclamò. Si avvicinò agli arbusti: il viale correva, infatti, proprio a un passo da loro, deserto a perdita d’occhio, già invaso dalla caligine turchina del tramonto. La donna rispose con quella sua strana voce malinconica ed aggressiva: «Non me ne importa niente… Io rimango qui.» Così dicendo, si sdraiò, malamente, restando un momento con le gambe in aria e poi riprendendo l’equilibrio a fatica. Silvio capì che non poteva più rifiutarsi e sedette anche lui dicendo: «Però non mi piace questo luogo… Siamo troppo vicini alla strada.»
La donna non rispose. Gli prese la mano e guardandolo negli occhi domandò con voce chiara: «Sono io, nevvero, la persona di cui vuoi liberarti?»
Silvio capì che doveva rispondere ma non ne ebbe il coraggio e cercò di guadagnar tempo. Domandò a sua volta: «Che cos’è che te lo fa pensare?»
«Poco fa, in macchina, ho detto: che bella giornata, vorrei morire in una giornata come questa. E tu hai mormorato tra i denti: magari. Credevi che non avessi inteso; ma io ho l’udito molto fine.»
Silvio rimase così sconcertato che non trovò niente da ridire. La donna proseguì con fermezza: «Tu desideri addirittura la mia morte. E’ triste questo. Non credi che in questo caso sia meglio lasciarci?»
Silvio levò gli occhi verso di lei quasi sperando di trovare un appiglio per la risposta che doveva dare. Si aspettava di vedere un volto desolato, patetico, insopportabile; fu meravigliato scoprendo invece che la donna appariva calma e rassegnata. Lei lo amava davvero, pensò, al punto di essere anche disposta a perderlo. Poi notò un particolare: come la pineta sotto i raggi del sole, così, via via che il suo sguardo si spostava dal basso in alto, nello stesso tempo il volto di lei si animava. La bocca sorrideva appena, con il suo migliore e più seducente sorriso, un sorriso che lui amava forse perché ambiguo e un po’ crudele; le guance, di solito pallide, parevano leggermente arrossarsi; gli occhi che aveva grandi e torbidi, sembravano farsi più chiari e luminosi. D’improvviso, gli venne in mente che ancor più che amare, era importante, almeno per lui, essere amato. E che la sua decisione non era forse che un puntiglio dell’orgoglio; dopo il quale sarebbe stato solo con sua madre, i suoi amici, la sua cameriera e tutte le persone, insomma, che odiavano la donna, ma non potevano sostituirla. Pronunziò alla fine lentamente: «Stai dicendo delle cose assurde… io non desidero lasciarti.»
«Davvero?»
«Davvero.»
I racconti de L’automa stanno a Il disprezzo e a La noia (e in seguito a L’attenzione) allo stesso livello per cui i Racconti romani stanno a La romana e a La ciociara.
Piccola e gelosa ne esemplifica bene i temi: i protagonisti sono perlopiù (anche se non sempre) formati da coppie e la narrazione si accentra sulla loro relazione. In primo luogo è bene sottolineare come in essi Moravia torni a privilegiare la terza persona, quasi per meglio radiografare, attraverso uno sguardo esterno, le dinamiche che intercorrono tra un uomo e una donna. Ed è quasi sempre l’elemento femminile ad innescare l’azione cui l’uomo soggiace, non riuscendo o essendo incapace di gestirla. Silvio infatti ammette che ancor più che amare, era importante, almeno per lui, essere amato, cioè che più che agire l’importante per lui era essere agito.

Alberto Moravia
D’altra parte Moravia sembra prefigurare la crisi ed il cambiamento che l’istituzione del “fidanzamento” e quindi del “matrimonio” stavano ormai vivendo negli anni del “boom economico”, o meglio di un neocapitalismo in cui il possesso di beni sembrava un vero e proprio imperativo. L’autore non affronta in modo diretto la “nuova borghesia” (non dimentichiamo che fu accusato di aver abbandonato gli ambienti popolari e le sue velleità), ma ne sottolinea la difficoltà dell’identità e della comunicazione. Non a caso L’automa entra a buon diritto tra i testi “esistenzialisti” della contemporanea cultura europea (si pensi a Sartre).
Tali temi saranno affrontati in una raccolta di saggi, pubblicata nel 1964, dal titolo L’uomo come fine e altri saggi. L’editio princeps ne contiene 33, quella, ripubblicata negli anni ’80, solamente 12.
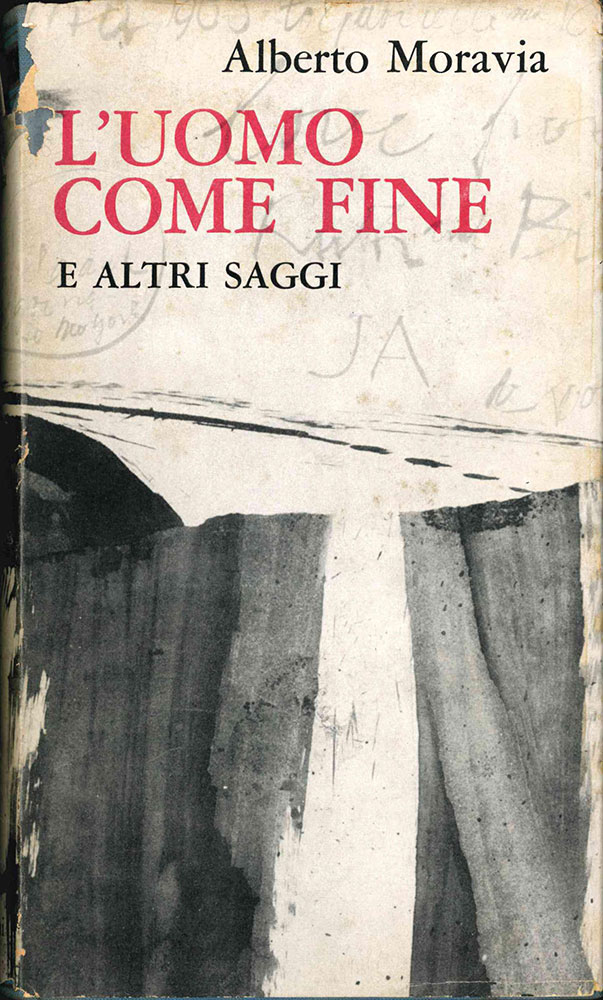
I saggi sono perlopiù letterari: e vanno dal rapporto fra memoria e scrittura a riflessioni sul comunismo e la letteratura, nonché su notazioni su alcuni autori amati (Belli) e non (Pavese ed Hemingway). Essi sono scritti tra il ’42 e il ’62 e riflettono le discussioni “letterarie” che in quel periodo dividevano gli intellettuali: quale fosse il compito di uno scrittore all’interno di un sistema totalitario (è evidente che il riferimento sia l’Unione Sovietica) cosa s’intendesse per realismo narrativo e quindi il romanzo oggettivo e soggettivo, un importante riflessione sull’opera manzoniana ed anche un interessante confessione su come sia nata in lui l’idea della scrittura de Gli indifferenti.
Ma la vera motivazione ce la offre lui nel Prefazione; eccone uno scorcio:
PREFAZIONE
I saggi riuniti in questo volume sono tutti saggi letterari. Questa affermazione sorprenderà perché il saggio che dà il titolo al libro non è un saggio letterario. Ma a parte il fatto che io sono un uomo di lettere e che qualsiasi cosa io scriva non può non riguardare la letteratura, penso che L’uomo come fine riguardi la letteratura direttamente e immediatamente. L’uomo come fine è infatti una difesa dell’umanesimo in un momento in cui l’antiumanesimo è in voga. Ora la letteratura è per sua natura umanistica. Ogni difesa dell’umanesimo è dunque una difesa della letteratura.
Le ragioni per cui il mondo moderno è antiumanistico non sono misteriose. Ci sono certamente all’origine dell’antiumanesimo del mondo moderno un desiderio o meglio, una nostalgia di morte, di distruzione, di dissolvimento che potrebbero essere l’ultimo rigurgito della grande orgia suicida delle due guerre mondiale; ma c’è anche la ragione più normale, più solita propria di certe disaffenzioni: il logorio, la stanchezza, lo scadimento dell’umanesimo tradizionale; la sua immobilità, il suo conservatorismo; la sua ipocrisia di fronte agli eventi tragici della prima metà del seolo.
Per tutti questi motivi, vorrei sottolineare che L’uomo come fine non vuole affatto essere una difesa di questo umanesimo tradizionale ormai defunto; bensì un attacco all’antiumanesimo che oggi va sotto il nome di neocapitalismo; e un cauto approccio all’ipotesi di un nuovo umanesimo.
Alla luce di quanto scritto potremo individuare due motivazioni nel discorso moraviano : uno di tipo socio-politico (palese); l’altro di ordine letterario (taciuto). Nel primo la frecciata dell’autore si dirige sul sistema neocapitalista che facendo di un romanzo una merce, ed essendo un romanzo costruito su personaggi riduce essi stessi “merce”. Affinché il romanzo possa ritrovare la sua funzione deve ridiventare “umanistico” cioè fare dell’uomo un fine e non più un mezzo; come dice mirabilmente affrontando I promessi sposi, in cui il vero protagonista non è un personaggio, ma la religione: infatti per lui le parti meno riuscite saranno proprio le conversioni, dove al centro dell’episodio vi è proprio la religione. Per quanto riguarda il fatto letterario, Moravia, pur non parlandone direttamente sembra “polemizzare” sia con chi predica la morte del romanzo (gli intellettuali del Gruppo ‘63 come Eco, Balestrini, Guglielmi, Sanguineti ed altri) chi centrandosi sull’io, trasformando se stesso come mito perdendo il fine ultimo (come Pavese ed Hemingway).
Quindi nel ’65 è il momento de L’attenzione:

L’attenzione è la storia di un romanziere e del romanzo che sta scrivendo. La forma narrativa è come quella di un diario sul quale Francesco Merighi, un giornalista, tiene nota e analizza, attraverso il suo rapporto con sua moglie Cora e la sua figliastra Baba, la sua personale ricerca dell’autenticità. Egli pensava di averla raggiunta quando conosce Cora, d’origine popolare, che, proprio per questo, “autentica” in quanto, avendo lui sempre vissuto una vita agiata in una società borghese, era stato colpito dalla falsità che vi regnava. Se ne innamora, la aiuta economicamente a metter su un laboratorio di sartoria e va a viverci insieme, ma lei vuole continuare ad avere la sua libertà e una vita autonoma. Francesco accetta le sue condizioni e quindi si sposano. Quando Francesco scopre che Cora, oltre che alla sartoria gestisce anche una casa di tolleranza, capisce che anche Cora crede che i rapporti umani si basino sul profitto economico invece che sui valori ideali. Se ne disamora e incomincia a viaggiare per lavoro sempre più spesso e fa in modo di rimanere all’estero sempre più a lungo, finchè, per motivi differenti, nei periodi in cui fa ritorno a Roma intraprende un rapporto quasi incestuoso con la figliastra. Gli incontri tra Francesco e Baba sono, insensatamente, per amore, favoriti da Cora. Quando l’uomo si accinge a rivedere il diario che dovrebbe costituire la base del romanzo, si accorge di quanto poco esso rispecchi la realtà che avrebbe voluto riprodurre. E’ quasi tentato di rinunciare all’opera quando si rende conto che il diario steso è già un romanzo, non solo “per i pochi avvenimenti accaduti, ma anche e soprattutto per quelli che non erano accaduti affatto e che aveva sognato o inventato”.
L’attenzione si struttura, come del resto La noia, come un romanzo-saggio, in questo caso maggiormente incisivo perchè se sul primo si riflette sul rapporto tra arte e realtà, qui si specifica meglio tra romanzo e realtà, tra trasposizione letteraria degli eventi della vita e la liceità dell’interpretazione di essi, quindi dell’attenzione con cui osservare lo svolgersi della vita stessa; ma se la scrittura romanzesca registra in modo impassibile gli eventi che costituiscono la vita, come insegna la contemporanea école du regard di Alain Robbe-Grillet, che ruolo ha la fantasia/immaginazione autoriale?
DAL DIARIO DI FRANCESCO
Ho riletto le pagine del diario in cui ho raccontato la visita ai genitori di Cora; e sento il bisogno di avvertire, come ho già fatto altrove, che anche qui ho modificato la verità fattuale. Questa volta però la modificazione non è avvenuta quasi mio malgrado come per l’invenzione del rinvenimento dell’Edipo Re di Sofocle sul mio tavolino di notte; ma è stata apportata consapevolmente e volontariamente, anche se per motivi, in fondo, non del tutto chiari. Che vuol dire questo? Vuol dire, credo, che i motivi per cui ogni tanto sento il bisogno di cambiare i fatti via via che li riporto nel diario sono molteplici e variano secondo la natura dei fatti medesimi e il genere di rapporto che ho con essi. Così, in certi casi, amputo, maschero o addirittura sopprimo; in altri, sviluppo, dilato, ricostruisco…
Prendiamo per esempio la visita ai genitori di Cora. Ho riportato fedelmente o quasi (avrò cambiato soltanto qualche parola o omesso qualche frase) i nove decimi della visita; fino, cioè, al momento in cui il vecchio nonno è apparso nella cabina dell’ascensore; ma ho inventato, o meglio ho sviluppato a modo mio tutto l’incidente successivo, quando il nonno ha affermato di non conoscerci, si è rifugiato nell’ascensore ed è tornato a pianterreno.
Nella realtà le cose sono andate in questo modo: il nonno è uscito dall’ascensore, aveva l’aria di essere ubriaco, vacillava, ha perfino inciampato, ci ha salutato confusamente, come se non ci riconoscesse, ed è entrato subito in casa. La vecchia allora si è scusata per il marito dicendo che quando era ubriaco non riconosceva nessuno. Baba ed io l’abbiamo salutata e ce ne siamo andati.
E’ evidente che estendendo e completando la scena quando l’ho riportata nel diario, io ho modificato la verità. Infatti nel diario il nonno non soltanto non ci riconosce, ma anche lo dice, lo conferma, lo sottolinea. In altri termini il suo contegno non è confuso e ambiguo come era nella realtà; è chiaro e deciso. E mentre nella realtà il fatto che il nonno non ci riconosceva poteva essere del tutto casuale e insignificante, ossia nient’altro che un effetto del vino, nel diario il mancato riconoscimento da parte del nonno acquista un significato, sottintende un giudizio.
Nel diario, insomma si direbbe che il nonno non ci riconosce non tanto perché è ubriaco, quanto perché il benessere dovuto al denaro di Cora, denaro di cui il vecchio “sente”, secondo le parole di Baba, la provenienza, ha finito per renderlo straniero a se stesso e agli altri. Cioè nel diario io interpreto la realtà, l’aggiusto, la integro, la completo, secondo una mia idea, o meglio, ideologia. Il denaro di Cora, secondo questa idea, non può, essendo guadagnato com’è guadagnato, non provocare estraneazione e irrealtà. Così inventando che il vecchio non ci riconosce, in realtà non invento niente, mi limito a prolungare una direzione, sviluppare un germe. La verità, intuita e ricostruita, non viene, in fondo, modificata. Ma egualmente, nella realtà le cose sono andate in modo diverso; e l’incidente del mancato riconoscimento, di sicura efficacia in un romanzo, resta pur sempre un’invenzione. E’ vero, il denaro mal guadagnato generalmente corrompe e rende estranei a se stessi e agli altri; questo l’ho notato più volte, ne ho avuto innumerevoli prove. Ma ciò non vuole affatto dire che sia una regola; e che comunque, anche se è una regola, il nonno di Baba non costituisca una eccezione a questa regola.
In altre parole: può darsi benissimo che, in fin dei conti, al nonno di Baba non importi nulla che il denaro di Cora sia guadagnato con la casa di appuntamenti. Egli beve perché gli piace il vino, sa tutto di Cora, o meglio lo sente, e se ne infischia, ama Cora lo stesso, come un padre ama la propria figlia, la coscienza lo lascia lo stesso tranquillo, e magari, lui approva, chissà, il commercio della figlia.
Ed io non so niente del padre di Cora, assolutamente niente. L’ho soltanto visto: una macchia di colore, un oggetto voluminoso, qualche cosa che è passato per un momento nel mio campo visuale e poi è scomparso.
Naturalmente la scena del mancato riconoscimento potrà essere inclusa nel romanzo senza danni, anzi con qualche vantaggio; ma dubito che l’includerò. E questo non tanto perché è inventata, quanto perché ciò che mi ha spinto a inventarla è qualcosa di non schietto, di non genuino, insomma di inautentico, di cui vorrei liberarmi, appunto, scrivendo questo diario.
Ci dice Moravia in una riflessione apparsa su Nuovi Argomenti del 1966: “Il romanziere è prima di tutto un bugiardo; e il romanzo del romanzo serve appunto a dirci la verità che si nasconde dietro le bugie”; aggiungeremo noi che il romanzo del romanzo serve anche a rivelarne la struttura e le norme che lo costuiscono: il metaromanzo moraviano, in ultima analisi, assume la stessa funzione che, circa mezzo secolo prima, ebbe I sei personaggi in cerca d’autore per il teatro, ciò svelare i meccanismi scenici e l’autonomia dei personaggi rispetto l’autore. Ciò non toglie che, per l’autore romano, la facoltà dell’interpretazione e non solamente della registrazione della realtà, concessa da un autore, è dovuta soprattutto all’inautenticità della vita stessa che usando un termine che il Francesco del romanzo applica sulla realtà, si basa sulla “corruzione”; ogni cosa, ogni sguardo è corrotto: l’autore del diario e (diremo noi) Moravia, scava all’interno della corruzione per svelare la “falsità” del nostro vivere.

Pellicola di Mario Soldati del 1985 dal libro di Moravia
L’attività scrittoria di Moravia non conosce soste e insieme a Dacia Maraini ed Enzo Siciliano fonda, nel 1966, il Teatro del Porcospino, raccogliendo sollecitazioni e fermenti a favore del teatro che dal 1964 variamente si sviluppano nella penisola, anche grazie all’esperienza del “Living theatre”. A dare inizio alle rappresentazioni in tale teatro nella stagione 66/67, il 20 ottobre, è L’intervista di Moravia, testo sulla impossibilità di un’informazione attendibile e affidabile, seguito il 23 ottobre dell’anno successivo dall’atto unico Perché Isidoro?, sulla civiltà dell’abuso consumistico. Il Teatro del Porcospino avrà vita breve e a causa dei costi elevati. Moravia raggiunge il successo nel campo della scrittura teatrale con un dramma in due atti: Il mondo è quello che è, messo in scena alla Fenice di Venezia, l’8 ottobre 1966. In quello stesso anno scrive il suo capolavoro teatrale, una vera tragedia Il dio Kurt.

Interessante, da un punto di vista delle sollecitazioni culturali che investivano il dibattito culturale degli anni tra il ’60 e il ’70 è Il mondo è quello che è dove il filosofo/medico Milone insegna ad un gruppo di pazienti “verbali” a distinguere, e quindi usare, parole “sane” e parole “malate”. Alla fine della “cura” così le commiata:
MILONE
(Entrano Semanta vestita da sposa, Piero in abito da cerimonia, Pupa, Buratti, Lucio, Olinda vestiti di festa. Tutti seggono, tranne Milone che sta in piedi, dietro una piccola tavola.)
MILONE: Ci siamo tutti, mi pare.
TARCISIO: Sì, tutti.
MILONE: Come voi sapete, oggi non è una seduta normale. Oggi mi congedo da voi, voi vi congedate da me. Ma voglio che vi rendiate conto che non si tratta del normale commiato di un gruppo di amici che si separano dopo aver passato l’estate insieme. Quello che abbiamo fatto qui durante gli ultimi tre mesi è stato più importante che riposarsi e godere di una gradita ospitalità. Se non mi ripugnasse di adoperare una parola tra tutte malsana e inguaribile come Storia, direi che in questi tre mesi, senza rendercene conto, noi abbiamo fatto, appunto, della Storia.
(Milone si ferma, guarda agli ascoltatori.)
Sì, signori, abbiamo fatto della Storia. Valendomi del mio diritto di parlare come meglio mi piace, voglio spiegarvi questa mia affermazione nel linguaggio che, secondo la cura, dobbiamo considerare malato. Dunque, che cosa vuol dire fare della Storia? Vuol dire, signori, come dice il poeta, andare a cercare il nuovo in fondo all’ignoto, cioè rischiare. Sì, rischiare su quello che non si sa, che non si è mai sperimentato, che non si conosce. Ora è proprio questo che durante i tre ultimi mesi noi abbiamo fatto con la terapia del linguaggio.
(Milone si ferma, guarda agli ascoltatori.)
Che cosa c’è infatti di più antico della comunicazione per mezzo della parola? Gli uomini ancora camminavano a quattro zampe e già parlavano e probabilmente le parole che pronunciavano erano già malate. Via via attraverso i millenni, dalla preistoria fino ad oggi, gli uomini hanno cambiato e infinite abitudini buone e cattive ma non quella, tra tutte difettosa e apportatrice di mali, di comunicare con la parola. Non abitiamo più nelle caverne, non ci vestiamo più di pelli, non divoriamo più i nostri nemici, ma continuiamo imperterriti a parlare. Non soltanto. Con mezzi meccanici di riproduzione di meravigliosa efficacia come la stampa, la radio e l’incisione su dischi, noi moltiplichiamo le parole, quanto dire che spargiamo ai quattro venti, a miliardi, i germi delle nostre future malattie.
(Milone si ferma, riprende fiato.)
Signori, ci voleva molto coraggio per andare controcorrente in una situazione così antica e così irreparabilmente compromessa. Ora noialtri questo coraggio l’abbiamo avuto. Ad un andazzo che durava, si può dire, da sempre, abbiamo avuto il coraggio di dire: basta.
(Milone si ferma, tace un momento.)
Sì, basta. Basta con le parole e le proposizioni malate; cioè basta con le parole e le proposizioni che vanitosamente, stupidamente, velenosamente, pretendono di avere un significato, di dire qualche cosa. Basta, basta, basta.
(Nuovo silenzio di Milone.) Per questo, pur congedandomi da voi, tengo a ringraziarvi in maniera speciale. Avete rischiato, avete avuto fiducia in me voglio dire nella terapia del linguaggio. Siete stati i primi a comprendere, accettare, praticare la cura: un giorno sarete considerati dei precursori, dei pionieri. Grazie, grazie, grazie.
(Milone tace un momento.)
Siete stati i primi ma non sarete gli ultimi. Perché adesso debbo darvi un annuncio importante che vi riempirà, ne sono certo, di soddisfazione e di fierezza.
(Milone si ferma, guarda agli ascoltatori.)
Cosimo, il nostro dottor Cosimo, visti i risultati della cura, ha deciso, con chiaroveggenza pari alla generosità, di porgermi il suo potente aiuto. Signori, l’annuncio di cui vi ho parlato è questo: presto, molto presto, grazie a Cosimo, sarà creato un centro-studi per la terapia dei linguaggi.
(Milone tace un momento.)
Credo che non ho bisogno di sottolineare l’enorme importanza di questo centro-studi. Ciò che era soltanto un’intuizione solitaria oppure un passatempo, diventa in questo modo qualche cosa di serio, di sistematico, di organizzato. Ma c’è di più.
(Milone si ferma un momento.)
Finora la terapia del linguaggio è stata individuale. E’ vero, abbiamo lavorato in gruppo; ma, come voi sapete, alla fine ognuno riusciva ad ottenere un trattamento particolare. Con il centro-studi di Cosimo, la cura esce dalla fase diciamo così sperimentale e perciò individuale. Signori con il centro-studi verrà affrontato il problema fondamentale della terapia di massa.
(Milone tace per un istante.)
Viviamo in un’epoca di masse e a ben guardare la terapia del linguaggio presuppone le masse così come le masse presuppongono la terapia del linguaggio. All’individuo isolato sarà ancora lecito, sia pure per poco tempo, adoperare parole e proposizioni che significano qualche cosa; ma le masse dovranno al più presto essere aiutate a imparare a parlare senza dir niente. Questo, se vogliamo che essi assolvano il loro compito, diciamo così, storico, che è di produrre per consumare e di consumare per produrre.
(Milone tace un momento.)
Il centro studi di Cosimo verrà dunque creato per elaborare la terapia di massa. Sarà situato nei pressi della fabbrica di Cosimo; disporrà di un laboratorio di un adeguato numero di scienziati; In capo a due, tre, quattro anni al massimo dovrà avere messo a punto una teoria della terapia di massa efficace e precisa. (Milone tace per un momento.) Allora e soltanto allora verrà il momento di passare dagli studi alla pratica. E qui, signori, il mio discorso diventa necessariamente vago anche se profeticamente lirico. Vedo delle cliniche, dei pronti soccorso, degli ospedali, dei sanatori per la cura di massa dei linguaggi. Vedo milioni e milioni di pazienti affluire disciplinatamente e volontariamente in queste case di cura. Vedo un numero sempre maggiore di uomini liberarsi per sempre dalle malattie del linguaggio. Vedo un’intera umanità approdare finalmente alla terra promessa del silenzio. Sì, signori, del silenzio. Perché questo è e non può non essere lo scopo ultimo della cura: il silenzio. Il silenzio assoluto, così nella parola come, per modo di dire, nel silenzio stesso.
(Milone tace per riprendere fiato. In questo momento si ode un rumore di voci quindi un servitore entra trafelato e fa un cenno a Milone. Zione va a confabulare sottovoce con il servitore, poi, turbato, torna indietro, fa un gesto come per dire che vuole parlare.)
Signori, qualche cosa di grave è successo.
TUTTI: Ma che cosa? Che c’è? Perché? Come mai?
MILONE: Ecco. Guardate.
(Si ode una voce più chiara che domanda: dove la mettiamo? Poi quattro uomini entrano in scena portando il corpo esanime e sgocciolante di Lena, Tutti si precipitano a guardare il cadavere facendo cerchio in silenzio. Il primo a parlare è Milone.)
MILONE: Sì, guardatela bene, è Lena, la cameriera sordomuta. O meglio: era. Ma al tempo stesso non è nulla.
(Milone tace per un momento, poi riprende.) Portatela laggiù, fuori dalla nostra vista, al padiglione della piscina, adagiatela su una seggiola a sdraio, per ora. (I quattro uomini escono con il corpo di Lena.)
BURATTI: Non è nulla, eh? Ma secondo la cura, beninteso.
MILONE: Precisamente: secondo la cura. Non dobbiamo farci sopraffare da parole come: morte, dolore, vita, anima, amore e simili, signori. Queste parole, signori, potrebbero farci credere che una certa persona di nome Lena esisteva realmente, che essa ha realmente amato, che si è realmente uccisa per amore. Ma sono parole malate e noi non le pronunzieremo e così la realtà che queste parole potevano evocare non albeggerà nelle nostre coscienze. Non solo. Io trarrò occasione da quanto è avvenuto poco fa per mostrarvi una volta di più, come agisca la terapia del linguaggio.
(Milone si ferma, riprande fiato.)
Dunque, in breve: poco fa, Lena, di anni diciotto, domestica, nubile, figlia di Giovanni, quarant’anni, giardiniere, e di Rosa, età trentott’anni, casalinga, abitante nella foresteria di Villa Semantema, Via del Fonema, Numero 89, in un momento di sconforto, forse dovuto all’infermità di cui era afflitta, essendo sordomuta e minorata mentale dalla nascita, si è data volontariamente la morte, gettandosi nella piscina situata nel parco della suddetta Villa Semantema. Alcuni animosi, tra i quali Giovanni di Giovanni, quarantaquattro anni, cameriere, coniugato con Cesira, cuoca, trent’anni, e Italo Paolini, trentaquattr’anni, autista, celibe, si gettavano nell’acqua e ne ritiravano il corpo ormai esanime della sventurata. Ma tutti gli sforzi erano inutili. Nonostante le fosse subito praticata la respirazione artificiale, non era possibile richiamare alla vita la povera suicida. Le indagini sulle cause del folle gesto, affidate al brigadiere Romeo Proietti dei locali carabinieri, proseguono. (Mentre Milone recita l’immaginaria notizia di cronaca nera, tutti lo guardano immobili e attoniti come se davvero, a misura che lui recita la sua filastrocca, la morte di Lena e Lena stessa svanissero dalla realtà. Gradualmente le luci si abbassano, la scena è al buio. Cala il sipario.)

Rappresentazione del testo teatrale allo Stabile di Torino (1966/67)
Il testo teatrale si accentra, come ben si arguisce, sulla proprietà linguistica, o per meglio dire, non proprietà linguistica, in quanto essa è solamente significante, mai significato. Se la parola significato rimanda a qualcosa di oggettivamente determinato, essa è “sana”, se invece si riferisce ad un sentimento o ad un termine puramente astratto, essa è “malata”. Ne risulta che, usando solo le sane, la lingua diventa talmente neutra da non significare nulla, arrivando così al grado zero. D’altra parte afferma Wittgenstein “il mondo è quello che è” perché “il senso del mondo dev’essere fuori di esso. Nel mondo tutto è come è, è tutto avviene come avviene; non vi è in esso alcun valore – né se vi fosse avrebbe un valore” (aggiungiamo noi) determinabile da una proposizione priva di logica.
Wittgenstein rimane così importante per il Moravia di questo periodo che nel 1967, intitola un nuovo libro di racconti con un’espressione tautologica, fortemente debitrice del pensiero del filosofo tedesco: Una cosa è una cosa. Si tratta di 44 racconti tutti con protagonista un uomo medio, ad eccezione dell’ultimo il cui protagonista è un cane. Come afferma Moravia stesso, tutti questi racconti “sono scritti in prima persona” quindi in essi l’autore “esplora il mare della soggettività; cioé quello che avviene quando l’uomo non soltanto si accorge di sovrapporre i propri significati alle cose, ma cessa di occuparsi realmente delle cose e dedica tutta la sua attenzione ai significati. Per quanto possa sembrare strano, è proprio questo i momento in cui, appunto, le cose diventano cose.”
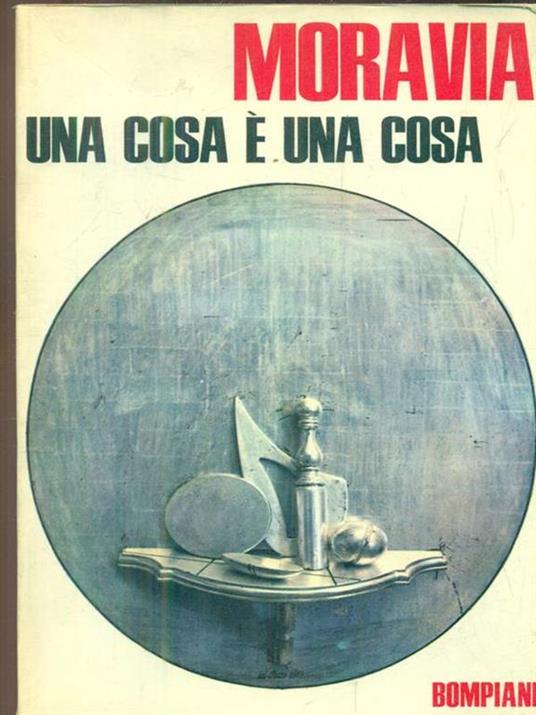
UNA COSA E’ UNA COSA
Non comunichiamo; o meglio comunichiamo in tanti modi ma non con la parola. Le ho chiesto: «Che hai fatto stamane?» Lei mi ha risposto: «Sono stata a spasso.» «Dove?» «In giro.» «Ma dove in giro?» «Per le strade del centro.» «Ma che hai fatto?» «Sono stata a spasso.» Sono rimasto zitto un momento cercando di trasformare mentalmente in immagini quelle parole: spasso, in giro, strade, centro; di vedere cioè mia moglie in atto, appunto, di andare a spasso per le strade del centro; ma non ho visto niente. Ho chiuso gli occhi senza che lei se ne accorgesse, fingendo di guardare al mio piatto; ho pensato a lei, alta, elegante, flessuosa, con quel non so che di maldestro e di provocante nei fianchi stretti e nelle lunghe gambe che mi piace tanto; a lei che andava a spasso per le strade del centro; ma non ho visto né lei, né i negozi, né le automobili, né i marcipiadi, nè nulla. Le parole non mi dicevano nulla, non suscitavano alcuna sensazione; anzi, per poco che le ripetessi più volte, avevano un’allarmante tendenza a cambiarsi in suoni insensati.
Ho socchiuso le palpebre, ho guardato verso di lei, attraverso gli sprazzi aguzzi dei bicchieri e delle caraffe di cristallo. Indossava una camicetta a strisce gialle e arancioni, aperta sul petto; tutto a un tratto sono stato colpito dall’intensa espressività di un bottone, l’ultimo sotto il collo. Questo bottone mi diceva, anzi mi gridava, «Sono il bottone più alto della camicetta. Stamane, quando tua moglie è uscita, ero inserito nella mia asola; adesso ne sono fuori. Può darsi che io sia stato liberato dall’asola per una innocente civetteria, per lasciar vedere il principio del seno; ma può anche darsi che la camicetta sia stata sbottonata da una mano alacre e impaziente, gettata insieme con gli altri panni su una seggiola, in una stanza straniera, e quindi, una o due ore dopo, indossata di nuovo e riabbottonata in fretta, salvo l’ultimo bottone in alto, lasciato aperto per distrazione.» Lungo eh? E per giunta maliziosamente particolareggiato, un vero piccolo racconto o meglio romanzo. Mi sono domandato se per caso stessi diventando geloso, ma mi sono subito rassicurato. Infatti, alzando gli occhi e passando con lo sguardo dalla camicetta al volto di mia moglie, mi sono accorto che ciascun tratto di quella faccia pur così nota, mi inviava un’informazione nella quale era impossibile ravvisare l’espressione inconscia di un mio sentimento. Erano informazioni obbiettive, insomma, io non c’entravo. Gli occhi glauchi, stretti, lunghi, luminosi mi gridavano: «Noi siamo gli occhi;» il naso un po’ grande, leggermente ricurvo: «Io sono il naso;» la bocca carnosa, tumida, imbronciata: «Io sono la bocca.» Era persino imbarazzante; come trovarsi di fronte ad una folla vociante e non sapere a chi dar retta.
Ho deciso di scegliere uno tra tutti quei postulanti, la bocca per esempio. Ma subito mi sono accorto che altri messaggi, altre informazioni mi venivano incontro, attraverso lo spazio, con la fottezza e la violenza vibranti di frecce lanciate da numerosi arcieri: «Io sono la peluria scura, appena visibile che ombreggia il labbro superiore. Io sono la piega grave all’angolo della bocca. Io sono il rossetto chiaro, vivo come il sangue. Il sono il brillare umido, come di madreperla bagnata, dei denti che appena si intravedono. Io sono il calore del respiro che è causa di minuti screpolii sulle labbra. Io sono il disegno sulle labbra, ricurvo e spesso e al tempo stesso curiosamente informe. Io sono la fossetta di sopra del labbro superiore. Il sono la punta rosea della lingua che in questo momento si sporge appena a leccare i denti…» Assordato da tutte queste notizie tumultuose ed esigenti, ho scosso la testa. Quindi ho detto:
«Voglio farti una proposta.»
«Quale?»
«D’ora in poi non parliamoci più.»
«Ma che vuoi dire, che ti prende?»
«Voglio dire quello che dico: non parliamoci più.»
«Ma perchè?»
«Perchè non ce n’è bisogno.»
«Tu non mi vuoi più bene. Vorresti che io non ci fossi, che non esistessi, non potendo farmi scomparire, cerchi di rendermi muta.»
«Al contrario. Tu sei così parlante che la parola è ormai superflua.»
«No, lo so, tu vorresti che io fossi una cosa tra le tante, un oggetto che si guarda e poi si lascia lì. Tu vorresti che io fossi come quel bicchiere.»
Stavo per risponderle che lei era infinitamente più espressiva e più comunicativa di qualsiasi bicchiere, ma sono tutto ad un tratto ammutolito. Infatti, quasi involontariamente, alla sua frase indispettita, ho guardato in direzione del bicchiere e, o meraviglia, ecco l’oggetto, per così dire, levarsi in punta di piedi e gridarmi con quanta voce aveva: «Io sono il bicchiere. Hai capito? Io sono il bicchiere.» Confuso, ho indugiato a considerare il piccolo ma presuntuoso interlocutore. Quando, finalmente, mi sono riscosso dal mio stupore e ho levato di nuovo gli occhi, ho visto che la seggiola di mia moglie era vuota: sdegnata, addolorata, si era alzata, era uscita dalla stanza.
Impensierito, sono rimasto fermo, guardando alla seggiola, chiedendomi che cosa dovevo fare. Ma, improvvisamente, quella vipera, è il caso di dirlo, mi ha gridato in tono offeso: «Ma che guardi? Che cerchi? Io sono la seggiola, te ne rendi conto? Io sono la seggiola.» E allora, irresistibilmente, sono scappato dalla stanza. Di corsa sono entrato nell’anticamera, ho aperto la porta, sono uscito.
Abitiamo al pianterreno di un palazzo che dà su un piccolo giardino pubblico. Quattro aiuole, quatrro alberi per aiuola. Nel mezzo delle aiuole, uno spiazzo ghiaiato con quattro panchine. Nel centro dello spiazzo, una fontanella. Sono andato a sedermi su una di quelle panchine, all’ombra di un leccio. Il giardino era deserto; ma le cartacce sparse dovunque in grande quantità, le siepi schiantate, i fili di ferro divelti, l’erba rognosa, mi hanno subito gridato: «Questo giardino adesso è deserto perché è l’inizio del pomeriggio. Più tardi si riempirà di bambini. Tutto questo squallore e queste distruzioni sono opera loro.» Ho finto di non udire queste informazioni in certo modo deprimenti e ho guardato davanti a me. Sulla panchia di fronte stava seduto un soldato, sola presenza umana in tutto il giardino. Ho cencentrato la mia attenzione sul soldato.
Allora mi sono accorto che tra il soldato e gli alberi, la panchina, la ghiaia, la fontanella, i cespugli e, insomma, tutti gli oggetti che lo circondavano, stava avvenendo, come dire? una gara, o meglio, per essere più precisi, una contesa. Il soldato con voce sommesa, rassegnata, indifferente mi inviava quest’informazione: «Sono un soldato.» Ma tutti gli altri oggetti intorno a lui, affermavano invece la loro identità con voci più perentorie, quasi a dire: «Non ci sono che io. Gli altri non esistono.»
Del resto, nella persona stessa del soldato, c’erano alcuni particolari che mostravano di avere una vitalità maggiore della sua. Le scarpe, per esempio. «Noi siamo scarpe.» proclamavano i due oggetti neri, posati melensamente sulla ghiaia bianca, uno di qua e l’altro di là, «forse non te ne sei accorto, ma noi siamo nientemeno le scarpe.» Sconcertato da tanta sicumera, dopo avere per un poco considerato le due calzature, ho levato gli occhi verso il soldato, ilo quale se ne stava curvo, i gomiti appoggiati alle ginocchia, decifrando, come mi è sembrato, una rivista di fumetti. Non mi ero sbagliato, c’era davvero una contesa tra il soldato e gli oggetti che lo attorniavano. Infatti, adesso, il volto assorto del giovane militare non mi diceva più: «Sono un soldato»; ma, come un postulante che tira fuori un titolo di studio o di nobiltà o onorifico, per farsi ascoltare. affermava con una certa quale enfasi velleitaria e intimamente scoraggiata: «Io sono un uomo.» Ho abbassato gli occhi di nuovo. Una cartaccia in terra, presso la panchina, urlava con violenza sbracata: «Io sono una cartaccia.» Com’era più sicura di sé, più reale e, a modo suo, più profonda, quella cartaccia, del volto opaco e immobile del soldato.
Mi sono sentito quasi soffocare; tanto più che mni era venuta un’idea: e se mia moglie avesse ragione? Se, davvero, lei non fosse stata, per me, che una cosa tra le tante, né più importante né più significativa delle altre? Mi sono alzato, sono tornato quasi di corsa verso casa, sono entrato, ho aperto l’uscio dell’appartamento. Noncurante dei tanti oggetti che, nella penombra, mi chiamavano per farmi notare la loro presenza, sono andato direttamente alla camera da letto. Sapevo che mia moglie doveva essere lì.
La porta era socchiusa, l’ho aperta appena e mi sono affacciato a guardare. Le tendine bianche delle finestre mantenevano la camera in una luce giusta, né troppo forte né troppo bassa; gli oggetti, si sarebbere detto, non avevano né ombre né chiaroscuri; i loro volumi, i loro colori, le loro linee erano chiari, netti, precisi ma senza ineguaglianze di toni o di rilievo: democraticamente, tutti quegli oggetti della camera erano eguali, non ce n’era uno che fosse o sembrasse più visibile, più significativo, più espressivo di un altro. Il vaso di fiori sul cassettone valeva la caraffa dell’acqua sul comodino; il lume accanto al letto valeva la poltrona presso la finestra; l’armadio valeva la toletta. Il mio sguardo è scivolato su tutte queste cose cercando un appiglio, un motivo di preferenza. Ma no, niente. La testa di mia moglie, chiusa e nascosta nell’incavo del braccio, valeva il cuscino su cui stava affondata; il suo corpo, la coperta sulla quale si rannicchiava; i suoi piedi, la trapunta di seta su cui posavano. Ho guardato con intensità al corpo ripiegato su stesso; certo mia moglie piangeva perché ho udito un rumore come di un lamento mischiato a soffi e a suoni sommessi, ma questo rumore non mi è sembrato che fosse più interessante e importante di quello che faceva sul cassettone il transistor acceso su un volume basso, canterellando in sordina. Poi da tutta la persona di mia moglie si è levato un messaggio chiaro, perentorio: «Che hai da guardarmi? convinciti una buona volta, io sono una cosa come le altre, nient’altro che una cosa.» Allora ho richiuso pian piano la porta e me ne sono andato in punta di piedi.
Borghese il personaggio di questo racconto omonimo, in cui gli oggetti rivendicano la loro perentoria presenza di contro ad un uomo che, di fronte ad essi, non sa agire. La dimostrazione è data propria dall’incapacità di contestualizzarli, quindi di leggerli all’interno di una realtà che gli sfugge. Quando alla fine riesce a vederli senza che loro rivendichino la loro perentoria presenza, sarà la donna stessa a rendersi oggetto per rivendicare, di fronte a lui, la sua incapacità interpretiva, tanto che dovrà allontanarsi non essendo riuscito a renderla “viva”. Forse torniamo a Wittgenstein e nell’incacità di definire le “cose” essendo il linguaggio metafisico e gli oggetti fisici; ma sarà anche la “mercificazione” che durante il boom economico pervade in modo totale la società da rendere “autonomi” gli oggetti stessi e noi dipendenti da loro. Aggiunge Walter Pedullà in La letteratura del benessere (1973): “Ma – per chiara volontà dell’autore – tutti questi personaggi sono accumunati dall’appartenenza allo stesso emisfero sociale, cioé alla borghesia e in particolare a quella della fase in cui, conquistate le cose che hanno rappresentato da secoli i suoi valori irrinunciabili, tenta di capirne il significato assoluto attribuitogli e si accorge che esse si afflosciano vuote e inespressive.”
Nello stesso anno pubblica, o meglio raccoglie in volume, gli articoli commissionategli dal Corriere della Sera, a seguito di un suo viaggio in Cina, che compirà insieme a Dacia Maraini coautrice per quanto riguarda l’apparato fotografico. Tale volume prenderà il titolo di La rivoluzione in Cina ovvero Il Convitato di pietra.

La visita in Cina corrisponderà, dopo la rivoluzione comunista del ’49, alla grande rivoluzione culturale voluta da Mao Tze-tung, iniziata nel 1966 e terminata dieci anni dopo con la morte del grande timoniere.
Il viaggio vorrebbe colmare la grande curiosità che l’iniziativa maoista aveva propocato presso gli intellettuali europei; infatti, la presenza dello scrittore romano e della sua compagna (cui spetterà l’apparato iconografico del volume), con l’avvallo governativo cinese, si svolge proprio all’inizio della scelta da parte di Mao, come afferma Moravia, di operare sulle coscienze al fine di mutare ontologicamente il modo di pensarsi dei cittadini cinesi. Non vi sono “individui”, ma masse uniformi nel modo di vestirsi, di comportarsi, di rapportarsi: ciò comporta che Moravia non descrive “personalità” (l’unica eccezione lo scrittore, di cui non ci dice il nome e con cui parla attraverso citazioni tratte dal Libretto rosso ed un vecchio operaio che orgogliosamente gli mostra il suo fornelletto).
La riuscita della rivoluzione culturale per Moravia sta nell’aver coniugato confucianesimo e maoismo e taomismo:
CONFUCIO, MAO, CLAUSEVITZ
Una delle massime di Confucio dice a un dipresso così: «Portare gente ignorante alla guerra vuol dire portarla al disastro.» Possiamo anche ammettere che Confucio abbia voluto intendere per gente ignorante semplicemente gente non addestrata; tuttavia è significativo che si parli anche qui di insegnamento, non di sentimento. Facciamo adesso un salto di molti secoli e veniamo a Mao Tze-tung. Come è noto, Mao, oltre a tante altre cose, è stato anche e soprattutto un capo militare sia durante la guerra civile contro i nazionalisti del Kuomintang sia nella lotta contro gli invasori giapponesi. Il piccolo libro rosso delle citazioni di Mao è in buona parte composto di massime sulla condotta della guerra ed originariamente, prima di diventare il breviario di tutti i cinesi, era stato destinato all’esercito. Ora, proprio nel libro di Mao, si può leggere questa massima senza dubbio marxista; ma di un marxismo non troppo lontano dal confucianesimo: «Tra il civile e il militare esiste una certa distanza ma non c’è tra di loro la Grande Muraglia e questa distanza può essere facilmente varcata. Fare la rivoluzione, fare la guerra, ecco il mezzo che permette di varcare la distanza. Quando noi diciamo che non è facile imparare e applicare quello che si è imparato, noi intendiamo dire che non è facile imparare qualche cosa a fondo e applicarla con scienza consumata. Quando noi diciamo che un civile può rapidamente trasformarsi in militare, noi vogliamo dire che non è difficile essere iniziati all’arte militare. Per riassumere queste due affermazioni conviene qui ricordare un vecchio proverbio cinese: “Niente è difficile per chi si applica a far bene quello che fa. Iniziarsi all’arte militare non è difficile e perfezionarsi è anche possibile pur che ci si applichi e si sappia imparare.”»
La citazione di Mao è lunga; quella di Confucio brevissima; ma il significato è pur sempre lo stesso: la violenza si insegna e si impara. L’uomo non nasce violento, l’uomo nasce colto e civile. Cioè non nasce militare ma nasce letterato. Ma noi sappiamo che in Occidente invece l’uomo nasce violento, privo di saggezza, intriso di sangue e di sesso, primitivo: per secoli il cristianesimo non ha fatto che ricordarcelo. E senza ricorrere a considerazioni di specie religiosa, limitiamoci a notare che il bambino cinese, in passato, era iniziato prestissimo ai riti del rispetto verso i superiori (genitori, maestri, dirigenti, imperatore) nonché alle massime della saggezza confuciana che, appunto, era all’origine di quei riti; mentre il bambino occidentale giocava e tuttora gioca prima di tutto al soldato; per accostarsi poi molto più tardi (e quasi sempre di malavoglia) ai libri.
Del resto paragoniamo adesso alle massime di Confucio e di Mao sull’insegnamento dell’arte della guerra, quelle di un classico occidentale sulla stessa materia: von Clausevitz. Ecco un primo pensiero: «L’intervento del pensiero lucido e ancor più il predominio della ragione, toglie alle forze emotive buona parte della loro violenza…» E ancora: «L’intrepidità costituisce una vera forza creatrice… fortunato l’esercito nel quale l’intrepidità intempestiva è frequente: è una escrescenza lussureggiante ma che sta a denotare un terreno fertile. Anche il colpo di audacia, cioè l’intrepidità insensata non è da disdegnarsi: in fondo è forza d’animo che si esercita in una specie di passione, nell’assenza di qualsiasi controllo della ragione.» Come si vede, mentre i cinesi ma Mao e Confucio pensano che il civile deve imparare la violenza la quale può essere insegnata come qualsiasi altra materia, l’occidentale Clausevitz, invece, consiglia di non sottrarre, con l’insegnamento ossia l’uso della ragione, la violenza alle forze emotive del soldato. Quest’ultimo nasce violento ed è bene che la sua violenza rimanga intatta, senza aggiunte o modificazioni mentali. Tutt’al più si tratterà di avviarla verso il suo fine cioè verso l’omicidio, attraverso una disciplina durissima e indecifrabile».

Questo brano ci offre il modo con cui Moravia si avvicina all’enigma della Rivoluzione culturale cinese: quello dell’argomentazione di tipo sillogistico. Lo scrittore europeo cerca infatti le connessioni che possano spiegare ciò che egli percepisce attraverso lo sguardo: l’uniformità delle giovanissime guardie rosse, con i loro nastro al braccio ed il libriccino di Mao in mano, lo sguardo attento verso le scritte appese che riportavano le massime del grande capo, il modo ordinato e ritmico delle manifestazioni sempre accompagnate dal ritratto di Mao, tutte queste manifestazioni egli le legge come “seconda” natura dell’essere cinese, nata già “colta” sul modo di concepire la vita confuciano. Ed ecco allora la sostituzione di Confucio con Mao e ciò che era religiosamente accettato continua ad esserlo sotto forma politica. Per Morava la Cina non conosce trasformazioni repentine, ma solo una continuità millennaria talvolta interrotta mai poi ripresa nelle sue forme essenziali.
Tra il 1970 ed il 1976 Moravia pubblica tre libri di racconti; il primo, Il Paradiso (1970) contiene 34 storie, il secondo Un’altra vita (1973) 31, il terzo Boh (1976) 30; le 95 storie di queste tre raccolte, hanno l’io narrante femminile. Perché Moravia scelse, questa volta, di dare la parola alle donne? Perché, secondo lui, in questo periodo storico esse hanno superato l’idea maschile d’essere soltanto “oggetto di bellezza” ma, in quanto piene d’imprevedibilità, non sono completamente integrate nella società ma neppure completamente estranee ad essa. Se l’uomo continua a rivestire un ruolo, la donna sta alla ricerca della propria identità e quindi, per Moravia, risulta essere “letterariamente” più personaggio. Risulta evidente che, avendo le tre raccolte una stessa struttura, esse possono essere considerate come un unicum, sebbene si noti una leggera “evoluzione” nell’idea sulla femminilità dell’autore. Tuttavia la critica concorda nel considerare i vari ritratti di donna qui presenti come una chiarificazione/preparazione al personaggio di Desideria del romanzo La vita interiore.
Il Paradiso racconta la difficoltà delle donne di “accettare” la realtà così com’è, sentendosi oggetto in un mondo completamente mercificato che le tratta come oggetti:
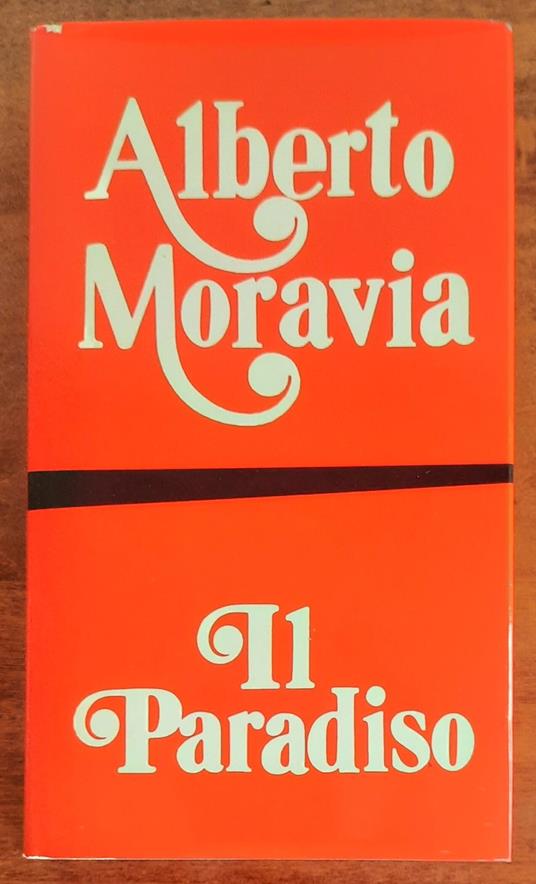
VENDUTA E COMPRATA
Sono una donna giovane e bella, moglie di un uomo giovane e ricco. Una volta alla settimana, salgo nella mia macchina, esco dall’abitato, mi dirigo verso una certa strada di campagna. Parcheggio la macchina in un fosso e quindi cammino forse cento metri. Ecco uno spiazzo davanti uno rustico chiuso con una catena e un lucchetto rugginosi. Al di là della staccionata si intravvede una proprietà in stato di abbandono: erbaccia e arbusti dovunque, alberi da frutta con frutti sparsi in terra che marciscono, grandi alberi fronzuti, mai potati, con i rami e il fogliame secchi mischiati ai rami e al fogliame verdi. Io seggo sopra la staccionata, una gamba penzolante nel vuoto e l’altra con il piede appoggiato molto in su, sopra una sbarra. Indosso invariabilmente una minigonna ma senza calzamaglia e, soprattutto, senza slip. Sono insomma nuda di sotto e ho calcolato che in questa posizione qualsiasi automobilista che sbuchi dalla curva poco lontana, di fronte a me, sia in grado di spingere immediatamente il suo sguardo tra le mie gambe su su fino all’oscurità dell’inguine. Non aspetto mai molto, anche perché per far capire chi sono o meglio chi pretendo di essere, fingo di fumare una sigaretta. E infatti non passano mai più di dieci minuti che un’automobile si ferma e una faccia congestionata si sporge dal finestrino. Mi si chiede quanto voglio; lo dico; quasi tutti accettano; la macchina, su mio consiglio, viene parcheggiata sul lato della strada; quindi prendo per mano il cliente lo guidò lungo la siepe di sambuco fino ad un certo varco che ho aperto io stessa nella siepe. La proda è ripida, aiuto l’uomo a salire, quindi lo precedo per un sentiero in cui l’erba folta (siamo di maggio, quando l’erba è più rigogliosa) conserva la traccia di altri miei precedenti passaggi. Andiamo dritti ad un grande albero, e io mi stendo subito in terra. Quei fa per gettarsi su di me ma io lo respingo e gli dico che voglio il denaro in anticipo: «Scusami sai, ma ho avuto giorni fa una brutta avventura, uno è scappato senza pagarmi, sono sicura che tu non lo faresti, ma insomma che ti fa, dammeli adesso e non ci pensi più.» Gli uomini, quando hanno desiderio, sono buoni e docili. Non c’è n’è uno solo che non tiri fuori il portafogli e non mi dia subito la somma pattuita. Poi lui si butta su di me e allora, proprio in quel momento, fingo di sentirmi male. Gettò un grido, mi rovescio sull’erba, mi comprimo il cuore con una mano. L’uomo esterrefatto si tira indietro, mi guarda. Pur gemendo e comprimendomi con la mano il cuore, prendo con l’altra dalla borsetta ancora aperta il denaro e glielo restituisco balbettando: sono malata di cuore. Ma tu vattene. E’ una cosa che mi prende ogni tanto e poi mi passa. Naturalmente non se ne parla di fare l’amore. Eccoti il tuo denaro, scusami, ma lasciami, vattene.» Figurarsi l’uomo che, per un momento, ha temuto di trovarsi tra le braccia una moribonda. Non ce n’è uno che non prenda il denaro e non se ne vada in gran fretta. Allora, appena sono sicura che se n’è andato davvero, mi levo, raggiungo la strada, cammino fino alla mia macchina, ci salgo, me ne torno a casa, a Roma. Come ho detto, questa specie di rito lo celebro una volta la settimana. Non mi è mai avvenuto di incontrare una seconda volta un cliente. Se uno di loro mi incontra, il ricordo del mio malore gli toglie qualsiasi desiderio di avvicinarmi di nuovo. E del resto anche se mi imbattersi in qualcuno abbastanza invaghito per ritornare, sono ben decisa a ripetere di nuovo la commedia del malessere improvviso.
Questa specie di rituale in un certo modo simbolico attraverso il quale riesco a vendermi senza darmi, ha un’origine precisa, naturalmente, e io so benissimo qual è. Bisogna sapere che quando mi sono sposata cinque anni fa con Siro, mio marito, mi illudevo che lui mi amasse come io l’amavo: appassionatamente, esclusivamente. Appena due mesi dopo il nostro matrimonio, ho scoperto che mi ingannava, in maniera oltretutto per me molto umiliante, cioè senza alcun particolare motivo sentimentale o anche erotico, così, come si fanno tante cose che si sono sempre fatte, per abitudine, per automatismo. Siro era solito far l’amore con molte donne alla volta e non poteva considerare il vincolo coniugale un motivo sufficiente per rinunziare a questa sua abitudine.
Naturalmente ho cominciato a soffrire perché, come ho detto, amavo mio marito di vero amore, appassionato ed esclusivo. Sapevo di essere tradita e più volte ho pensato di vendicarmi col tradirlo a mia volta. Ma a quanto pare sono incapace di essere infedele. Naturalmente avrei potuto lasciarlo. Ma, purtroppo, nonostante il tradimento, continuavo ad amare Siro.
La mia sofferenza aveva un suo ritmo, un suo metodo o meglio li ha acquistati col tempo. Soffrivo soprattutto nelle prime ore del pomeriggio. Era questa infatti la parte della giornata in cui non avevo niente da fare; niente se non pensare a mio marito e alla sua infedeltà.
Non avevo voglia di vedere nessuno, non volevo distrarmi né occuparmi, non sapevo insomma che fare di me stessa. Allora, tutto ad un tratto, dopo aver tentato invano di leggere un libro che gettavo via quasi subito o di ascoltare un disco che fermavo dopo i primi giri o di guardare alla televisione che spegnevo alle prime immagini, indossavo in fretta e furia un soprabito ed uscivo. Salivo in macchina e andavo al centro della città. Che cosa mi attirava laggiù, nella confusione della folla e del traffico? Dapprima ho pensato che fosse la vita senza più, dalla quale mi sentivo esclusa; Poi mi sono accorta che la mia attrazione aveva un oggetto in fondo abbastanza preciso. Erano i negozi che mi attiravano, le loro vetrine piene di oggetti messi in mostra per essere venduti, soprattutto i negozi di abbigliamento.
Parcheggiavo la macchina e quindi, negozio dopo negozio, percorrevo lentamente le strade del centro. A questo punto debbo notare che in passato non avevo mai provato per i negozi che fastidio e ripugnanza. Sono una di quelle donne, raro nel mio ceto, che si vestono alla buona, come viene viene, pur di non perdere il tempo e di non trovarsi nella noiosa necessità di fare una scelta. Inoltre non sono mai riuscita a fare il salto dal necessario al superfluo, dal funzionale all’elegante, dal decoroso a lussuoso. Piuttosto che vestirmi, mi era sufficiente ricoprirmi. Infine mi affezionavo ai vestiti vecchi, forse perché mi annoiava l’acquisto dei nuovi. Adesso, invece, tutto ad un tratto, spuntata da chissà dove, mi scoprivo una vocazione di consumatrice accanita. Questa vocazione mi è stata rivelata dal mio stesso aspetto fisico. Mi è accaduto un giorno di guardarmi nello specchio di un negozio e sono stata sorpresa e quasi spaventata dal cambiamento intervenuto nella mia faccia: sono bruna e magra, ma ho o meglio avevo una faccia dall’ovale regolare ossia senza visibile sproporzione tra la parte superiore e l’inferiore. Ebbene, adesso la parte inferiore del mio viso appariva affilata e smunta. La bocca sembrava più larga, il naso più lungo. E gli occhi, addirittura, mi avevano “mangiato” la faccia. Da grandi si erano fatti enormi, con un’espressione che non ricordavo di avere mai avuto: cupida, avida, vorace.
Con quegli occhi esorbitanti e affascinati ispezionavo minuziosamente la vetrina quindi entravo con decisione nel negozio e compravo. Non compravo un oggetto solo, mettiamo una minigonna, ma cinque, dieci oggetti tutti eguali: cinque, dieci minigonne. Cercavo di darmi un contegno di compratrice normale, dritta contro il banco, le due mani sulla borsa, gli sguardi alla merce che le commesse via via mi mostravano. Ma tutto ad un tratto qualche cosa come un meccanismo scattava dentro di me. Tendevo la mano e dicevo: «Compro questo, e questo e questo. Ma di questo ne prendo quattro, e di quest’altro sei.» La mia voce insieme imperiosa e malsicura risuona aggressivamente tra il cicaleccio e l’andirivieni dei negozi; più di una volta ho sorpreso le commesse scambiarsi sguardi di furtiva e ironica intesa mentre si affrettavano a servirmi.
In realtà l’acquisto, lo sentivo bene, era il risultato di una specie di esplosione dell’angoscia troppo a lungo compressa e respinta. Ho sentito una volta due commesse, nel momento in cui entravo, dirsi sottovoce, in fretta: «Ecco la matta.» Sbagliavano, come spesso avviene in questi casi, non soltanto non ero matta affatto; ma anche facevo tutti quegli acquisti, in apparenza sregolati e caotici, per non diventare matta sul serio, col preciso e consapevole intento di alleviare la mia quasi insopportabile tensione.
Devo dire che pur nella indiscriminata voracità del mio affannoso comprare, si poteva distinguere un criterio di scelta: non compravo, a ben guardare, qualsiasi cosa; compravo in molti esemplari esclusivamente dei capi di vestiario. La mia preferenza andava alla roba più personale, cioè agli indumenti che stanno sotto i vestiti e a contatto con la pelle: le calze, i reggiseni, i reggicalze, gli slip, le calzamaglie, i guanti, le sottane. Avevo cassetti pieni traboccanti di calze mai messe chiuse nei loro sacelli di cellophane; di grovigli di giarrettiere di tutti i colori; di mucchi di reggipetti di stoffe dai più vari disegni. Ma gli slip neri, rosa, verdini, azzurrognoli, traforati, trasparenti, opachi, rinforzati, ornati di merletti, infiocchettati, semplici o complicati, da educanda o da cortigiana erano di gran lunga l’oggetto più collezionato. Subito dopo venivano per importanza le calzamaglie, le calze, i reggiseni. Immaginate adesso che questi indumenti sospesi nel vuoto nell’ordine di cui di solito vengono indossati e avrete l’involucro vuoto del corpo femminile, anzi il corpo stesso come appare agli uomini nel momento breve e, per loro, inebriante, che si frappone tra la conquista già avvenuta e l’amplesso imminente. Ma che cosa realmente significavano per me queste compere? Non lo sapevo ancora. Sentivo però oscuramente che trasformavo in rito liberatorio la situazione contingente e casuale che era all’origine della mia angoscia.
Purtroppo c’era un giorno in cui non potevo fare acquisti e così liberarmi dell’angoscia: la domenica. E infatti, a riprova della virtù terapeutica dell’acquistare, la domenica era per me una giornata spaventosa, la peggiore della settimana. Restavo a casa sola perché Siro che nei giorni feriali mi tradiva, dedicava le domeniche alla partita di calcio; e non sapevo che fare. Non mi riusciva di star ferma, andavo e venivo per le stanze e i corridoi e le terrazze; intanto mi mordevo le labbra, mi torceva le mani; avrei voluto gridare, sbattere la testa contro i muri, strapparmi i capelli, rotolarmi in terra. Ogni tanto andavo nel guardaroba, aprivo gli armadi, guardavo alla roba di cui rigurgitavano i cassetti quasi avessi voluto, contemplandone la misteriosa abbondanza, risalire al rapporto per me ancora oscuro tra l’infedeltà di mio marito e la mia frenesia consumistica. Ma la roba non mi dava la risposta che cercavo. Mio marito mi tradiva: questo era un fatto; io ero una matta che comprava dieci reggiseni alla volta: questo era un altro fatto. Il rapporto tra i due fatti non si svelava ancora.
Una domenica, Siro era uscito come il solito per andare allo stadio e io mi sono sentita addirittura sull’orlo della follia. Poi all’improvviso mi sono detta che forse vendere mi avrebbe fatto lo stesso effetto benefico che comprare. Donde mi venisse quest’idea, non so; probabilmente dalla riflessione che così per vendere come per comprare ci vogliono degli oggetti, cioè delle cose inanimate di cui si dispone come si vuole per mezzo del denaro. Avevo sinora comprato; perché non avrei provato a vendere? Mi sono subito attaccata al telefono e ho fatto il numero di una rigattiera che qualche tempo addietro mi aveva offerto di comprare qualsiasi vestito o altro indumento di cui non avessi più bisogno. L’ho trovata a casa sua; e ha subito mostrato molto interesse sentendomi enumerare convulsamente i numerosi capi del mio corredo di nevrotica. Ma mi sono sentita mancare il cuore quando la donna mi ha detto che oggi, essendo domenica, non si muoveva di casa.
Così non c’era niente da fare. Non potevo comprare nulla e non potevo vendere nulla. Ho infilato, in un turbine di disperazione, il soprabito e mi sono diretta in macchina, come facevo gli altri giorni, verso il centro. Ho parcheggiato l’automobile e ho preso a camminare lungo i negozi di una delle strade più eleganti della città. I negozi erano chiusi, ma le vetrine piene di oggetti esposti in mostra permettevano dei lunghi indugi contemplativi. Era il primo pomeriggio, poca gente passava, si era d’autunno, con il sole d’ottobre che è così dolce a Roma. Allora mentre contemplavo affascinata un’esposizione di camicette, mi sono sentita toccare un braccio. Mi sono voltata io ho visto un uomo né brutto né bello, né giovane né vecchio, proprio un uomo qualsiasi di mezza età, che mi faceva un gesto d’invito indicando una macchina ferma a poca distanza. L’ho guardato appena, ho guardato l’automobile; quindi con la stessa fretta con la quale nei negozi ero solita fare i miei acquisti. Ho accettato con un cenno del capo avviandomi accanto a lui. Siamo saliti in macchina e siamo partiti.
Non abbiamo parlato affatto fino a quando siamo usciti dalla città. Poi d’improvviso lui ha detto: «Ti piacciono le camicette, eh. Oggi è domenica; ma domani col denaro che trappoco ti darò potrai comprartene anche più d’una.» Questa frase mi ha fatto capire finalmente, come per un’illuminazione repentina, il rapporto che collegava l’infedeltà di mio marito con la mia mania dell’acquisto. Mentre il mio, diciamo così, “cliente” continuava a guidare in silenzio, mi sono detta che nel mio rapporto con mio marito, fin da principio, per lui, non ero stata che un oggetto il quale si aspettava di essere “adoperato”, o se si preferisce “consumato”. Nel nostro caso, l’uso, il consumo, erano le carezze, i baci, gli amplessi, gli orgasmi. Ma mio marito, dopo appena due mesi di matrimonio, aveva cessato quasi del tutto di “adoperarmi”, di “consumarmi”, insomma di prendere il suo piacere con me. E allora, dopo essermi illusa di essere stata per lui la moglie che si ama, per la prima volta avevo scoperto che non ero in realtà che un oggetto che si può o non si può adoperare, un bene che si può o non si può consumare e che comunque non ha una sua esistenza autonoma all’infuori dell’uso e del consumo.
Ma degli oggetti ci si stanca e allora vengono riposti o gettati via. Così aveva fatto Siro con me: non mi aveva più adoperata; ed io ero incerta se adesso dovevo considerarmi il vaso rotto che si butta via nella pattumiera oppure il vaso intatto ma il cui disegno ci ha stancato che si ripone nell’armadio.
Naturalmente tutto era avvenuto fuori della mia consapevolezza, nel mio inconscio. Per liberarmi dall’angoscia, inconsciamente avevo finto con me stessa di essere mio marito; io avevo preso a consumare indumenti che in un certo modo, sia per l’uso ai quali erano destinati sia per la loro forma, potevano simboleggiare il mio corpo disprezzato. Ero diventata, insomma, consumatrice in quanto mi ero sentita non consumata. Poiché, per esempio, mio marito aveva smesso, come gli avveniva nei primi tempi del nostro amore, di gettarmi sul letto, dopo colazione, di strapparmi lo slip e far l’amore con me senza vestirmi; io avevo comprato decine e decine di slip. Ma adesso, in questa automobile che correva sulla Flaminia portandomi al luogo dove, come una merce qualsiasi acquistata in un negozio, sarei stata consumata dal mio sconosciuto compratore, io tornavo ad essere l’oggetto che ero stata nei primi tempi del matrimonio. Non mi identificavo più con mio marito, trasformandomi in consumatrice di indumenti che simboleggiavano il mio corpo. Offrivo invece direttamente in vendita il corpo in carne e ossa ad un compratore reale per nulla simbolico. Tuttavia, siccome non cercavo il piacere, non avevo bisogno di denaro e probabilmente amavo ancora mio marito, mi contentavo di fingere la vendita, come in una specie di rito.
D’improvviso avvertito qualcosa di inquietante e di minaccioso nel mio compagno il quale, dopo quella frase sulle camicette, non aveva più aperto bocca. Mi sono voltata un poco e l’ho guardato per osservarlo meglio. Guidava, si sarebbe detto, con ferocia, la testa protesa in avanti, gli occhi cupidi fissi sull’asfalto, spingendo la macchina gran velocità, infilando le strade ai bivi come se fossero state le mie gambe aperte. Quindi, senza voltarsi, ha detto con una specie di concentrato furore: «Tu sei quella che mi ha fatto lo scherzo del malessere l’altra volta. Non mi riconosci? Ma questa volta, malessere o no, l’amore hai da farlo. Anche morta.»
La protagonista di questo racconto è giovane e ricca e vende simbolicamente il proprio corpo lungo una strada di campagna: simbolicamente perché, trovato il compratore, gli prende i soldi ma nel momento in cui è necessario giungere all’atto finge una crisi cardiaca e spinge il cliente spaventato alla fuga. Il simbolismo, con la ritualizzazione della prostituzione, è funzionale al bisogno della donna di sentirsi comprata come uno dei tanti vestiti che lei stessa acquista in modo compulsivo, per alleviare la sofferenza e l’angoscia prodotte dai continui tradimenti del marito.
Le protagoniste di queste storie vengono reificate, ma ciononostante non perdono lucidità e consapevolezza: sanno di essere subordinate ed economicamente dipendenti dagli uomini e così impossibilitate a una diversa forma di realizzazione che non sia riconducibile al ruolo di moglie/madre/amante. Venduta e comprata si conclude con una forma di tragica beffa del caso cui spesso queste donne sono condannate: l’uomo a cui si era sottratta all’inizio del racconto torna ora sulla scena e la costringe – così suggerisce il finale – a passare tramite la violenza fisica dal piano del simbolico a quello del reale.
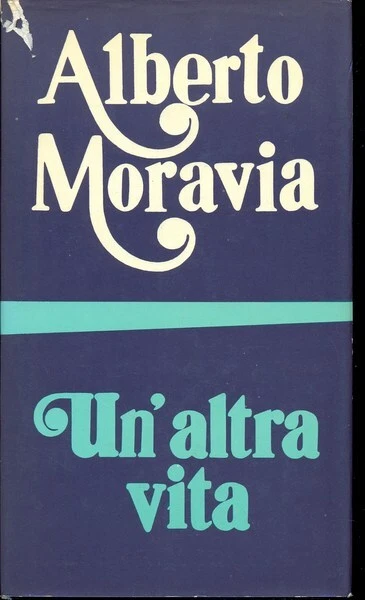
In Un’altra vita le 31 donne che si raccontano sembrano invece mettere l’accento sulla vita che a loro sarebbe piaciuto fare o hanno già fatto o vivono in un sogno: mai sulla vita che conducono: insomma le loro vite sono sempre “altre” rispetto alla realtà.
LINEA ROSSA LINEA NERA
Sono una donna che prende sul serio la vita; ma che, strano a dirsi, non sa mai troppo bene da quale parte prenderla. Così, nel dubbio, ho finito per decidere di fare sempre esattamente il contrario delle cose che mi sento di fare. Spirito di contraddizione, si dirà. Sì, certo; ma verso me stessa, o, se volete, la parte inerte e passiva, pigra di me stessa. Questa mia fissazione di contraddirmi è diventata ben presto ossessiva fino all’allucinazione. Che cos’era, infatti, se non una allucinazione, la linea rossa che, mentre Cosimo, il mio fidanzato, mi esponeva il suo piano, vibrava e si allungava tra me e lui? E la voce che mi incitava: «Salta, ma salta dunque, cretina!»
Il piano di Cosimo era semplice: andare a gettare delle bombe durante la dimostrazione contro l’ambasciata americana. A me, come guidatrice bravissima, si chiedeva soltanto di far da “palo”, aspettando al volante di una macchina, in una strada vicina. Quando Cosimo ha finito l’ho guardato e sono rimasta colpita dal contrasto tra il suo piano il suo aspetto di ragazzo di buona famiglia, dai capelli corti, sbarbato, vestito di grigio, con la camicia bianca e la cravatta scura. Anche la voce, con l’accento romano molle e signorile dei quartieri alti, non andava d’accordo con le bombe. Provavo paura; e proprio per questo, alla fine, ho detto: «Ci sto».
Alla dimostrazione è venuto anche un altro del movimento. E sono rimasta stupita vedendolo, perché era il benzinaio sotto casa nostra da cui, un giorno si e un giorno no, mi rifornivo di benzina. Si chiamava Tito: era un bel ragazzo biondo; ma semplice come il pane. Cosimo sembrava fiero di presentarmelo. Ma io mi sono messa a ridere dicendo che lo conoscevo benissimo.
Siamo andati alla dimostrazione; e a me mi hanno lasciata in una strada tranquilla, sotto le mura, a due passi da una camionetta della polizia che aspettava anch’essa. Mi sono incantata a guardare i poliziotti che chiacchieravano e fumavano. Pensavo che loro ed io eravamo tutti lì per le bombe, ma loro per impedire che fossero gettate ed io per gettarle. Poi, tutto ad un tratto, i poliziotti sono risaliti sulla camionetta che è partita a gran velocità. Dopo un poco, Cosimo e Tito si sono buttati nella macchina e io, come d’accordo, sono scattata via subito. Cosimo ha annunziato con la sua voce beneducata e pariolina: «Ci siamo fatti finalmente il nostro poliziotto.»
Se l’erano fatto davvero; nel senso che, come ho appreso il mattino dopo dai giornali, un agente era rimasto leggermente ferito. Ho accompagnato Cosimo e poi sono tornata a casa mia, passando per la pompa di Tito che doveva tornare al lavoro. Ma quando Tito, dopo avermi rifornito di benzina, ha appoggiato il gomito sul finestrino per darmi il resto, ho visto la linea rossa che vibrava, accesa, tra me e lui. E ho sentito la voce che diceva: «Ma non lo vedi quant’è meglio di Cosimo? Salta.» Anche questa volta provavo ripugnanza; soprattutto per via della differenza sociale. E appunto perché la provavo, ho detto con una voce dolce: «Domani è domenica. La pompa è chiusa. Che fai domani?»
La linea rossa l’ho poi rivista ancora molte volte. Era tra me e mio padre quando gli ho detto che me ne andavo a vivere per conto mio. Era tra me e Cosimo quando gli ho detto di Tito. Era, infine, tra me e una giovane coppia scandinava che, qualche tempo dopo, sono andata a trovare insieme con Tito. Pittrice lei e albina; pittore lui, e albino. Con un magnifico bimbo dai capelli color del lino. Stavano in un grande studio pulito come uno specchio e quasi del tutto vuoto. Colori e pennelli erano tutti disposti in ordine, su una mensoletta, puliti, anch’essi, come mai adoperati. Ci siamo seduti in terra, sulla moquette ad ascoltare dischi. Quando il marito mi ha offerto la cartina già aperta, con la polverina bianca, ho visto di nuovo la linea rossa allungarsi, vibrante, tra me e lui. La solita voce ha sussurrato: «Su, da brava, salta.» La moglie mi ha incoraggiata, strizzandomi l’occhio, tutta allegra. Ma è stata proprio la strizzatina di quell’occhio inumano, freddo e azzurro come un ghiacciolo, a farmi paura. Ho voluto sormontare la paura e ho teso la mano.
Chiodo scaccia chiodo. La droga ha schiacciato Tito che uno di quei giorni si è sentito di troppo e se n’è andato. Adesso, a causa della droga, avevo sempre voglia di volare. Provavo, struggente, il desiderio di andare alla finestra, spogliarmi, salire in piedi sul davanzale. Di sotto, nella strada, ci sarebbe stata una folla immensa a guardare in su, a me che, tutta nuda, stavo in piedi nel riquadro della finestra. Dopo essermi esibita ben bene, avrei spiccato il volo. Prima di tutto avrei fatto alcuni giri sulla folla, planando come un gabbiano al di sopra di un mare in tempesta. Poi sarei partita via come una freccia, verso l’orizzonte.
Quest’idea del volo è diventata un’ossessione; così che un giorno che m’ero drogata più del solito, mi sono levata di scatto dal sofà, mi sono spogliata e sono andata alla finestra. Per fortuna da qualche tempo ero perseguitata dalle attenzioni non disinteressate di una certa ragazzona dalle gambe da giocatori di calcio e dalla faccia di pugilatore che si chiamava Tosca. Lei era presente quando mi sono spogliata per volare. Corrermi dietro, afferrarmi per le braccia con mani di ferro, trasportarmi di peso su un sofà, è stato cosa di un attimo. Poi, mentre lei, chinata su di me, mi prendeva sistematicamente a schiaffi, ho visto la linea rossa accendersi di improvviso tra me e lei. La voce ha detto: «Salta. Meglio una donna come Tosca che la droga.» Ma io provavo orrore di Tosca; ed è stato proprio quest’orrore che, ad un tratto, mi ha spinto a gettarmi singhiozzando tra le sue braccia.
Tosca mi ha soggiogato al punto che vestivamo in maniera identica, con le stesse camicette, gli stessi pantaloni, gli stessi stivali. Grande e robusta, lei; piccola e fragile, io: sembravamo una coppia di teatro di varietà. Mi aveva soggiogata; però non veramente conquistata. E’ vero, sono una masochista; ma ci sono dei limiti a tutto. Tosca, ogni volta che cercavo di affermare la mia autonomia, ripeteva, con ottusa brutalità, la scena che aveva segnato l’inizio del nostro legame: lei che mi prendeva a schiaffi; e io che le buttavo le braccia al collo. Non cambiava, Tosca, insomma; e si deve a questa sua stupidità, se il giorno che Tito, il benzinaio, è rispuntato d’improvviso, ho subito accettato di andarmene con lui.
Tito non era più il ragazzo semplice che avevo conosciuto due anni prima. O meglio, era rimasto semplice ma la sua semplicità adesso era quella del delinquente. La sua idea era che io, come al tempo delle bombe, aspettassi in una macchina col motore acceso. Lui, intanto, insieme con un suo amico, un certo Trapani, avrebbe svaligiato il negozio di un orefice. Mai la linea rossa si era frapposta così vibrante e accesa, tra me la cosa che non volevo fare. La solita voce mi diceva: «Salta. Hai fatto trenta, perché non faresti trentuno?» Avevo una paura terribile. Se non avessi avuto paura avrei rifiutato. Invece ho detto con un filo di voce: «D’accordo.»
Tutto, poi, si è svolto come in un balletto di nuovo genere. Alle tre del pomeriggio, con un tempo freddo e sereno e poca gente per le strade, ho fermato la macchina davanti al negozio dell’orefice. Tito e Trapani sono discesi. Tito ha dato un colpo violento col cric nella vetrina. La quale si è spaccata in molti pezzi aguzzi che sono scivolati in terra. Attraverso lo squarcio, Trapani ha messo il braccio dentro, ha arraffato oggetti, li ha gettati in una borsa di plastica, ha steso di nuovo il braccio. Proprio in quel momento, il motore che tenevo acceso, si è spento.
Ho cercato di riaccenderlo: niente. Girava a vuoto, con un ringhio impotente. Ho alzato gli occhi e allora ho visto due guardie che risalivano di corsa la strada venendo verso di noi. Tutto ad un tratto, ho visto una linea tra me e le guardie; ma questa volta, per la prima volta, nera. Mi sono affacciata, ho gridato a Tito e a Trapani: «Scappate, il motore non funziona.» Li ho visti scappare in su, spargendo, nella fuga sulle pietre pulite e grigie del marciapiede, tanti brillanti oggettini d’oro. Quando le guardie sono state presso la macchina, mi sono affacciata al finestrino e ho gridato di nuovo: «Cercate i ladri? Si sono rifugiati in quel portone.» Le guardie hanno continuato la rincorsa. Nello stesso tempo, il motore si è riacceso. Ho riportato la macchina nel luogo dove l’avevamo rubata. Quindi ho preso un taxi e sono tornato alla casa di mio padre, dopo due anni di assenza.
Dopo quel giorno, non ho più visto che la linea nera. Era tra me e casa mia, quando ci sono entrata. Era tra me e mio padre e mia madre, quando li ho abbracciati. Era tra me e Cosimo, quando lui è venuto a trovarmi e dopo avermi detto che avevamo ambedue molte cose da perdonarci, mi ha informato, fatuo, che aveva scoperto di essere “reazionario, conservatore, codino”. E perché allora non ci sposavamo? Strano, ho provato, di fronte alla linea nera che in quel momento la solita voce mi incitava a saltare, lo stessissimo sentimento di estrema ripugnanza di quando Cosimo mi aveva parlato delle bombe. E proprio per questo, ho accettato di sposarlo.
Quanti cardinali c’erano alla festa delle mie nozze? Io dico almeno una dozzina. Non facevo che inchinarmi a baciare vecchie mani inanellate. Gli zucchetti rossi galleggiavano tra le tante teste degli invitati, come tanti fiori in un acquitrino tropicale. Cosimo andava in giro dicendo a tutti che aveva scoperto di essere reazionario, conservatore e codino: ed io non facevo che saltare linee nere, le quali tutte quante mi ripugnavano e per questo appunto le saltavo.
Adesso siamo sposati e abbiamo due bambini. Cosimo non lavora: amministra i suoi beni ed i miei. E dorme. Oh, quanto dorme quest’uomo! Otto ore, almeno, per notte; e poi, come si dice a Roma, la “pennichella” cioè due o anche tre ore di giorno. Qualche volta mi levo sul gomito e lo guardo mentre dorme. Ci credereste? La linea rossa, la vecchia linea rossa della rivolta, è tornata ad allungarsi e a vibrare tra me e lui. Senonché non so come interpretarla. La voce mi dice: «Salta» ma non mi dice in che modo. Che cosa dovrei fare? Prendere un candeliere e darglielo in testa? Oppure, più semplicemente andarmene in punta di piedi per non più ritornare? Oppure, più disperatamente, svegliarlo con un grido acuto, straziante, il grido della mia serietà e del mio continuo impegno sempre traditi? Ma ancora: perché la vita deve essere tutta una trasgressione? Oppure la trasgressione della trasgressione?
Questo racconto offre una duplice lettura:
- la storia circolare di una donna che, attraverso esperienze che vanno dalla ricca quiete borghese iniziale (simboleggiata dalla linea nera) al ritorno problematico di essa, vive ogni tipo di vicissitudini: la rapina, il tradimento, l’uso di stupefacenti (linea rossa) per poi ritrovarsi infine borghesemente sposata con un ricco “reazionario, conservatore, codino”. Il fatto è che tali scelte sembrano dettate più da uno “spirito di contraddizione” che da una propria volontà;
- l’anticipazione della figura della “voce” che sarà determinante ne La vita interiore, facendo sì che le figure moraviane abbiano un es così “diretto” da prevalere sempre sull’elemento razionale.
Afferma il critico Casini: “Il nuovo Moravia avverte nei suoi personaggi la tendenza a incrinarsi, a contraddire e contraddirsi, a dissociarsi, sdoppiarsi, alienarsi, in forme ora comiche ora patologiche, ora oniriche ora dialettiche” e avverte lo stesso Moravia: “Devo dire che alla crisi del personaggio sono arrivato assai tardi […]. Pirandello lascia che il personaggio si dissolva come individuo, io credo che il personaggio esista comunque, ma il suo essere si rifrange in possibilità molteplici e contraddittorie di azione. (Siciliano 1982, p. 120)
La terza raccolta di racconti femminili. Boh, mette in luce una maggiore corporeità delle donne stesse, in cui l’evidenza fisica sembra risolversi quasi in descrizioni espressionistiche, ma proprio queste descrizioni sembrano nascondere una profonda incredulità nonché rabbia di fronte ad atteggiamenti maschili inspiegabili.
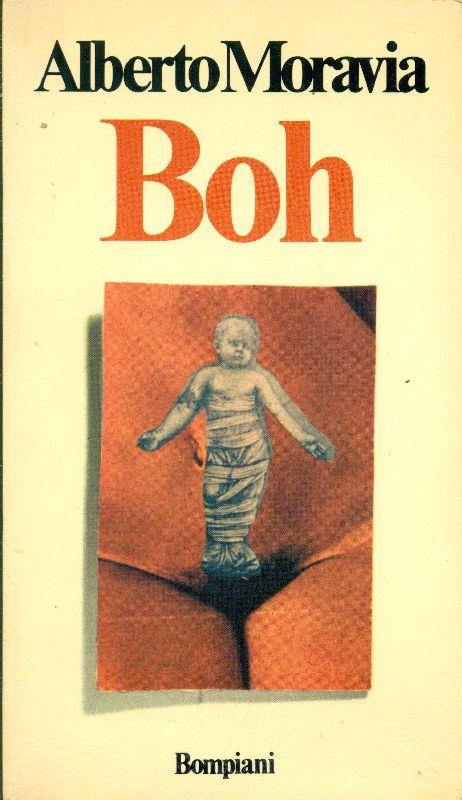
BOH
Gli amici mi dicono che il mio cattivo carattere si vede appena mi metto di profilo. Di fronte ricordo i cani pechinesi: occhi tondi, sporgenti dallo sguardo fisso e malevolo; naso schiacciato; bocca grande dalle labbra serpeggianti. Ma di profilo, secondo loro, la mia faccia fa pensare semplicemente a un pugno chiuso, teso contro qualcuno, con l’intenzione di darglielo sul naso. Bisogna però dire che, più che un cattivo carattere col quale ci si nasce e non c’è niente da fare, si tratta di una rabbia oscura che mi è venuta una certa età, diciamo quindici anni, e poi non mi ha lasciato più. Questa rabbia, come certi orologi a cui non si dà la carica perché si caricano da soli con i movimenti del braccio, si monta da sé senza motivo né provocazione. Dalla rabbia, poi, mi viene una continua voglia di litigio. Sento già, a questo punto, il solito ficcanaso domandare: “Ma perché la rabbia, perché la voglia di litigare?” E, io, come faccio sempre con chi vuole sapere troppo e non sa che, invece, non c’è niente da sapere, gli rispondo precisamente così: “Boh.”
Soprattutto la mattina, appena mi sveglio, mi ritrovo un tale furore che, se il mondo fosse, che so io, un piatto o un bicchiere, non ci penserei un momento a sbatterlo in terra e a mandarlo a pezzi. Eh, sì, ho bisogno di litigare come il fumatore di fumare, il bevitore di bere e il drogato di drogarsi. Purtroppo, però, a casa la voglia di litigio non posso sfogarla. I miei genitori, negozianti senza fortuna (hanno una profumeria in una strada in Prati in cui, di negozi come loro e meglio del loro, ce ne saranno, a dir poco, una decina), sono due anziani, svaniti angeli che si vogliono bene come il primo giorno di matrimonio. Mia sorella, più piccola di me, studentessa alle magistrali, è anche lei un angelo del genere studioso, applicato, pignolo. Mio fratello è un fannullone, magari persino un po’ delinquente; ma per me, siccome gli sono affezionata, è un angelo anche lui. Così, non potendo sfogarmi in questa famiglia di angeli, ho trovato un sistema. La mattina esco di casa e vado ad appostarmi in una strada qualsiasi, preferibilmente presso un semaforo. Qui mi appoggio a un fanale, come fanno le battone di cui imito gli atteggiamenti, tirando indietro il petto e spingendo avanti il ventre, in modo da mettere in evidenza il rilievo del pube, gonfio e oblungo come una saponetta e le gambe, la mia cosa più bella, così perfette da far pensare che non sono mie e che le ho scambiate con un paio di quelle che si vedono nei negozi di calze. Appena scorgo una macchina con un uomo solo al volante, alzo la mano e faccio il gesto dell’autostop. Il guidatore mi guarda la mano, mi guarda la faccia, mi guarda la saponetta del pube, mi guarda le splendide gambe da manichino, e poi la sua corsa, pur proseguendo come per forza d’inerzia, rallenta, finisce, poco più in là, in una frenata. Lo raggiungo, salgo in fretta e furia, chiudo lo sportello. Senza tanti complimenti, domando: «Dove vai?»
Il tu li fa ringalluzzire; non sanno che do del tu a cani e porci, dal tempo della contestazione. Rispondono immancabilmente, gentili, accomodanti: «E tu dove vuoi andare?» Allora faccio un breve calcolo mentale sul tempo che ci vuole per fare una litigata completa e bene articolata; e poi rispondo, poniamo che mi trovo dalle parti mie cioè presso piazza Cavour: «Debbo andare a piazza Bologna.» Be’, credeteci o no, pochi rifiutano; i più ingranano subito speranzosi; e poi, pur gridando, cominciano a fare le solite domande: «Chi sei, come ti chiami, cosa fai, studi, lavori, hai fidanzato, hai il ragazzo, fate l’amore eccetera eccetera». Rispondo brevemente; quindi, senza indugio, passo all’attacco. Mettiamo che alla domanda sulla professione uno risponda: «Faccio il costruttore.» Immediatamente gli piombo addosso: «Che cosa? Fai il costruttore? Bravo, desideravo proprio da tanto tempo incontrare uno della tua categoria per dirgli tutto il male che ne penso. Be’, sai che ti dico? Ti dico che voialtri costruttori fate schifo. Sì, schifo. Speculate sulle aree fabbricabili; comprate a dieci e rivendete a cento; i vostri intrallazzi così al comune come in Vaticano non si contano; lavorate soltanto per i miliardari; fate salire il prezzo degli appartamenti e così la povera gente non può neppure sperare di farsi la casa. E almeno fossero belle, le vostre case! Ma no, fanno schifo, sono come voi, che siete ben vestiti e decorosi di fuori quanto marci e brutti di dentro: E questo lo dico perché lo so. Con un’amica che deve sposarsi ne ho visitate di case, poco tempo fa, non si sa quante. Ma che sono case queste? I pavimenti ballano; gli infissi e le porcellane sono di infima qualità; gli intonaci cascano a pezzi; apri una finestra e ti trovi davanti un muro, ne apri un’altra ti affacci in un cortile che sembra un pozzo. Niente alberi, niente verde, niente giardini. Siete degli affamatori, soltanto che, invece di colpire la gente allo stomaco, la colpite nell’abitazione che è forse anche più necessaria del cibo, eccetera eccetera» Sono stata, ancora giovanissima, nella contestazione, poi me ne sono allontanata; ma mi sono rimaste nella memoria molte delle cose che dicevano i gruppettari; e così, qualunque sia la professione del guidatore di turno, trovo sempre qualche cosa da dire, non rimango mai a corto di argomenti.
Ma ora viene, diciamo così, il bello. Insultato e svillaneggiato, il guidatore non fa quasi mai la cosa prevedibile: aprire la portiera, invitarmi a scendere. Sia che speri di portarmi a letto, sia, più probabilmente, che sia uno dei tanti masochisti, non discute neppure e, curvo e aggrondato sotto la grandinata degli insulti, va avanti a guidare, da un semaforo all’altro, da una strada all’altra, fino al luogo in cui debbo scendere. Quando si ferma, poi, mica mi lascia andare così, come qualcuno che è meglio perdere che trovare. Al contrario, il più delle volte, chiede umilmente, insistentemente e, diciamo pure, abbiettamente, un appuntamento. Ma si può sapere come sono fatti gli uomini? Perché gli piace tanto essere trattati male? Boh.
Uno di questi giorni esco di casa pensando: «Il primo che mi capita oggi, parola, lo mangio vivo.» Vado ad appostarmi al semaforo del Lungotevere, il mio luogo preferito perché c’è posto e gli automobilisti possono mettersi da parte e raccattarmi senza difficoltà. Sono, al solito, in minigonna; mi appoggio al fanale e incrocio le gambe; la saponetta del pube sporge al massimo di visibilità; il petto, che ho cascante e voluminoso, me lo sono tirato su più che ho potuto, quasi mi sfiora il mento. A tutta prima accenno il gesto dell’autostop fiaccamente e neghittosamente, sicura di me e del mio fascino; poi, vedendo che non fa effetto, con più energia: niente. Sconcertata, faccio allora un gesto al quale ricorro di rado, soltanto quando comincio a disperare: porto la mano all’inguine e mi gratto, tirando un po’ su la minigonna, come se avessi un prurito. Subito, una grande automobile bianca, di un bianco vecchio e ingiallito, frena di colpo con un cigolio stridente, fermandosi a poca distanza. Mi slancio di corsa, mi ingolfo dentro, dico: «Vado a corso Trieste, e tu?»
Una grossa voce bene educata mi risponde: «Corso Trieste? D’accordo.»
Il semaforo scatta, lui gira il ponte, lo percorre, imbocca via Tomacelli. Mi assesto meglio che posso poi lo guardo. Ha una testa strana, piatta di dietro e con la fronte a baule davanti, che fa pensare a quella di un gufo. Ha i capelli neri incollati, come dal sudore, sulle tempie; gli occhi tondi perduti in fondo a orbite oscure, sotto sopracciglia di carbone; il naso a becco, così il ricurvo che la punta gli entra quasi in bocca; i baffi irti e neri; il mento ripiegato in su, con una fossetta scura nel mezzo. La faccia è rossa, intirizzita, da contadino o da cacciatore, da persona, insomma, abituata a stare all’aperto. Lo studio attentamente perché nel suo profilo c’è qualche cosa di anormale, che non mi torna. Dico al fine: «Senti un po’, fammi il piacere, girati verso di me.»
Lui si gira subito, dicendo baldanzoso: «Eccomi qui. Qual è il problema?»
Allora capisco. Sotto lo spazzolino nero dei baffi, la bocca appare tirata verso l’alto da una ferita come non ancora rimarginata, di carne viva, che gli parte dal labbro superiore e va a finire dentro la narice sinistra. Dico: «Grazie. Adesso puoi voltarti di nuovo. Ho capito tutto.»
«Hai capito che cosa?»
«Che ci hai una bocca schifosa, con il labbro leporino.»
Per un poco non dice nulla. Poi mormora, con dolcezza: «C’è a chi piace.»
«Non a me.»
«Pazienza.»
«Pazienza un corno.»
Mi sto montando, lo sento, sono già carica, quasi al punto che la chiavetta della molla di questo mio misterioso orologio del furore non gira più se non con uno sforzo estremo. Però do un ultimo giro con questo pensiero: “Ha l’erre moscia, la voce di naso, deve essere un mondano, uno snob, un uomo da salotto.» Quello che vedo mi conferma nella supposizione. Indossa un vestito blu scuro con la riga gessata; ha la camicia bianca; ha la cravatta un po’ all’antica, a strisce; ha i gemelli d’oro ai polsini. Il mio sguardo si sposta sulle mani che stringono il volante: tozze, quadrate, corte, con peli radi e dritti e unghie lucide, piatte, a spatola, molto curate. Deve essere uno di quelli che, dal barbiere, non la finiscono più con i pannicelli caldi, il taglio dei peli nelle radici e nelle orecchie, la frizione, il lavaggio. E intanto abbandonano con languida sufficienza la mano alla manicure chiacchierona rannicchiata alla meglio, con le grosse cosce traboccanti, su un minuscolo sgabello. Insomma, un’antipaticone numero uno. Il mio sguardo passeggia come una mosca riflessiva sulle sue mani, si ferma un momento su un anello che porta al dito medio della destra. L’anello ha un castone con qualche cosa inciso, forse un monogramma, ma non distinguo bene. Domando, a un tratto: «Ma tu che fai?»
«Come, che faccio?»
«Che mestiere, quale professione?»
Non risponde subito, pare riflettere. Poi dice: «Exportimport.»
«Che roba è?»
Spiega con quella sua cortesia mondana, in fondo insultante: «Vuol dire: esportazione-importazione. Scambi commerciali, insomma.»
Commerciante! Come i miei genitori! Come la gente che i miei genitori conoscono e frequentano! Subito mi slancio, a testa bassa: «Commerciante? Sei commerciante? So tutto dei commercianti perché ce li ho in famiglia. La razza peggiore che ci sia al mondo, la più sfaticata, la più inutile, la più dannosa! Già, perché è proprio a causa dei commercianti che i prezzi salgono e tutto costa sempre di più mentre i soldi della spesa bastano sempre di meno. Lo sai cosa siete voi commercianti? Dei parassiti, ma di quelli veri, tipo pidocchi e piattole, che vivono succhiando il sangue, senza farsi accorgere, zitti zitti, ben nascosti, ben dissimulati, ben mimetizzati. La vostra grande trovata, con la quale siete andati avanti per secoli a succhiare il sangue della gente, è di affittare una stanza, metterci un banco e qualche scaffale e poi a comprare a dieci all’ingrosso per rivendere a venti al dettaglio, stando alla cassa oziosi, col culo sulla seggiola, le braccia incrociate e la testa vuota. Eh, so tutto di voi, tutto, non m’incantate, conosco tutti i vostri trucchi, le vostre offerte speciali, occasioni, liquidazioni, novità, sconti, crolli dei prezzi, pagamenti a rate, saldi, ribassi, fallimenti e così via…»
Mi fermo per riprendere fiato; e lui ne approfitta per dirmi, per niente offeso: «Tutto bene. Ma io non sono un bottegaio, come mi sembra che tu abbia inteso erroneamente. Non ho un negozio. Ho un ufficio. Mi occupo di affari.»
Rimango male. Anche perché uomo d’affari è un termine generico, che può voler dire tante cose e sul quale, appunto per questo, non c’è niente da dire. Domando sconcertata: «Uomo d’affari? Ma che affari?»
«Affari.»
Debbo trovare qualche altra cosa. E subito. Siamo infatti già dalle parti di piazza Ungheria; corso Trieste non è molto lontano. Tutto a un tratto il mio sguardo, forse reso più acuto dalla necessità, scopre finalmente ciò che è inciso nel costone dell’anello che lui porta al dito: uno stemma. Sì, è proprio uno stemma, non c’è dubbio, con la corona e i soliti aggeggi: palle, strisce, leoni, gigli e che altro ancora. Con improvvisa, collerica alterazione della voce, domando, indicando l’anello: «Che è questo? Uno stemma?»
«Sì, almeno fino a prova contraria.»
«Allora tu sei nobile?»
«Dicono.»
«Che sei? Conte? Barone? Duca? Principe? Marchese?»
Ci pensa su e poi risponde, evasivo e galante: «Per te sono Paolo e basta.»
Grido gonfia di furore ancora inespresso: «L’avrei giurato che sei nobile. L’avrei giurato perché soltanto un nobile può essere antipatico come te. Vi conosco, voi nobili, ho avuto un ragazzo che era nobile, per un’estate intera siamo in giro col suo macchinone fuoriserie, da una spiaggia all’altra, da un night all’altro, un cretino numero uno, si chiamava Uguccione. Vi conosco e vi dico: ammazza ammazza siete tutti una razza: sfaccendati, ignoranti, presuntuosi, smidollati, degenerati. Ma che ci state a fare al mondo? A portare in giro la vostra superbia, eh? A darvi delle arie perché ci avete il blasone ricamato sulla camicia, eh? A guardare dall’alto in basso quelli che non ci hanno titolo, eh? E perché poi? Perché ci avete l’albero con tutti i cartellini in cui ci sono scritti i nomi dei vostri antenati su su fino al cosiddetto capostipite, eh? Perché conoscete nome e cognome dei vostri avi, eh? Perché sapete o credete di sapere chi erano, eh? Ma tu non sai niente. No, proprio niente. Te lo dico io chi erano i tuoi antenati di cui sei tanto fiero. Erano tutti dei delinquenti, dei criminali, dei briganti, dei rapinatori, dei banditi, sì, dei veri e propri banditi di strada. E così da una prepotenza all’altra, da una rapina all’altra hanno accumulato tutte quelle ricchezze che permettono a voi discendenti di non fare un cavolo nella vita, ciondolando di notte nei night e prendendo su, di giorno, le ragazze che fanno l’autostop; e tu sei un fannullone, nonostante l’export-import, e vale più l’unghia di un ragazzo delle borgate che te tutt’intero, con la tua macchina, il tuo vestito blu, i tuoi gemelli e la tua buona educazione.»
Che sollievo! Che soddisfazione! Mi sto scaricando e mi sento meglio, sempre meglio via via che mi scarico. Continuo ancora un bel po’ con la mia tirata contro la nobiltà; e poi me ne esco con questa conclusione dettata dal furore, inaspettata e stupefacente non soltanto per lui ma anche per me: «E poi, guarda, è meglio che fermi e mi lasci scendere, non è ancora corso Trieste, ma non importa, andrò a piedi, mi siete troppo antipatici, te e la tua classe, sciò, sciò, alla larga.»
Ma lui non si ferma, forse comprende che in realtà non voglio affatto scendere. Si limita a leccarsi con un pezzo di lingua rosso e osceno il labbro leporino e poi dice: «Brava!»
«Brava un corno!»
Non si offende, al contrario. Continua inflessibile: «Sì, brava; perché, anche se con qualche esagerazione, hai detto esattamente quello che penso anch’io. Sì, i nostri antenati, di noialtri nobili, erano dei banditi, dei briganti, dei masnadieri. Erano cioè degli uomini interi, completi, ancora vicini alla natura, con tutti gli appetiti naturali intatti. Uomini da preda, insomma; e la loro preda erano i pacifici, i civilizzati, i sedentari. Intrepidi, forti e feroci divoravano i deboli, i vili. E io e tutti gli altri come me dobbiamo cercare di rassomigliare a questi antenati spietati, a questi banditi. Se non vogliamo scomparire, dobbiamo prenderli come modelli.»
Urlo: «Ah, bene, bene, bei modelli, dei banditi di strada, ma fammi il piacere, vergognati.»
Non se ne dà per inteso. Tace per un momento, poi riprende con quel suo tono insieme didattico e salottiero: «Però non si parla come te se in qualche modo, magari senza saperlo, non si hanno degli antenati simili. Come ti chiami tu?»
Parla sul serio o parla per scherzo? Parla sul serio. Rispondo malvolentieri: «Mi chiamo Sebastiana.»
«Sebastiana, cosa?»
Ora pare impossibile, ma mi ha proprio incastrata. Infatti, ho davvero un nome di nobile anche se non sono affatto nobile. Un nome che, specie a scuola, mi esponeva a facili sarcasmi: “Come ti chiami? Colonna? Allora sei una principessa Colonna.” “No, Colonna, con un negozio in Prati.” “Allora non sei una principessa, sei una qualsiasi bottegaia.” Rispondo, in tono riluttante: «Colonna.»
Dà in un’esclamazione di gioia, come se avesse trovato finalmente la soluzione di un enigma tormentoso. Grida giubilante: «Colonna. L’avrei giurato! Buon sangue non mente!»
Rispondo infuriata: «Macché sangue, macché sangue! Mi chiamo Colonna come potrei chiamarmi, che so io, Rossi, o Proietti. Nessuno è nobile in casa mia, grazie a Dio. Poveri sì, ma non nobili. E poi è inutile che tu cerchi di lisciarmi, di adularmi. Mi stai antipatico, come tutti quelli della tua classe; e tutte le tue piaggerie non servono proprio a niente: Hai una faccia fessa, nei due sensi, quello vero perché ci hai lo spacco del labbro leporino e quello figurato perché sei uno stronzo e puzzi di snobismo lontano un miglio.»
Ma va’ a sapere con i pazzi. Non si scompone, si limita a scuotere la testa, come un maestro di fronte a uno scolaro recalcitrante: «No, Sebastiana, non ci sono classi ma soltanto razze. E le razze sono soltanto due, quella dei signori e quella degli schiavi. E il signore lo riconosci dal fatto che la sua morale consiste nel dominare. E lo schiavo lo riconosci dal fatto che la sua morale consiste nell’obbedire. Ma sia ben chiaro: signori si nasce, non si diventa. E così anche schiavi. E’ una questione di razza non di classe. Si può passare da una classe all’altra; ma qualunque cosa si faccia, non si può passare da una razza ad un’altra. Ora, Sebastiana, certe cose in te mi fanno pensare che anche tu appartieni, magari senza saperlo, alla razza dei signori.»
«Ma quali cose?»
«Per esempio la tua capacità d’indignazione.»
Grido fuori di me: «Ti sbagli, non ne azzecchi una. Quello che mi indigna sei proprio tu, con la tua stronzissima idea di essere un signore. Macché signore, macché signore. Tu signore, con quella faccia, con quei gemelli, con quel vestito! Ma fammi ridere.»
Paziente, mi spiega: «Tu intendi la parola signore come si usa a Roma: signore, cioé elegante, ricco, largo del suo denaro. Ma Sebastiana, questo è il senso corrente. Te l’ho già detto: signore per me vuol dire la bestia da preda che si getta sugli animali più deboli e li divora e ha il diritto di farlo appunto perché è il più forte.»
Mi metto a ridere, isterica: «L’hai detto, bestia. Sì, soltanto un bestione può parlare in questo modo. Ma fammi il piacere. Chi credi di incantare con queste scemenze?»
Non risponde, bada a guidare, calmo, calmissimo. Poi porta una mano al taschino della giubba e prende qualche cosa: «E questo ti incanta?»
Ora bisogna sapere che io non ho mai soldi. Quello che si dice: mai. Il negozio, come ho detto, va male; e i miei genitori, sia pure senza dirmelo apertamente, mi fanno capire che debbo arrangiarmi. E infatti, mi arrangio. Come mi arrangio? Qui si viene la maggiore contraddizione della mia vita. Mentre da una parte ho bisogno di litigare, dall’altra ho bisogno di soldi. Certo, potrei andare a letto con gli uomini dell’autostop, guadagnando così il denaro di cui ho bisogno; ma non posso, questa è una delle tante impossibilità della mia vita. Potrei anche rinunciare alle scenate e sciorinare le mie difficoltà, piagnucolosa, lacrimosa, straziante: mossi da compassione, quelli dell’autostop certo mi aiuterebbero. Ma anche questo mi è impossibile, ho bisogno delle scenate come dell’aria che respiro. Così, non potendo e non volendo fare né la battona né la pitocca, ripiego sulla contraddizione: prima insulto ben bene l’automobilista di turno; poi, nel momento di scendere, cambiando voce, chiedo timida e sommessa: «Di’ un po’, potresti farmi un piccolo prestito?»
Contraddizione, ho detto. Ma si vede che non sono così contraddittoria come credo di essere; oppure gli uomini amano le contraddizioni. Già, perché non è affatto raro che quello stesso individuo da me or ora abbondantemente svillaneggiato, alla mia richiesta di un prestito, si metta la mano in tasca e mi dia del denaro. Anzi ho notato che i più insultati sono spesso più generosi. Ancora una volta: masochismo? E sennò, cosa? Boh.
Adesso, con questo Paolo, mi succede addirittura che i soldi me li dà lui prim’ancora che glieli chiedo. Guardo il biglietto da diecimila che mi tende, con aristocratica negligenza, tra due dita; e intanto mi avviene la solita cosa che sempre mi avviene alla vista del denaro, forse proprio perché ne vedo così poco: la mente mi si annebbia, il furore mi cade, una specie di stupore mi paralizza, mi svuota. Sono in trance, ipnotizzata, magnetizzata, soggiogata. Vedo il biglietto color rosa carne, con il ritratto di Michelangelo da una parte e l’ovale bianco della filigrana dall’altra; e non penso nulla. Alla fine articolo: «Sono diecimila lire.»
«Sono per te.»
«Me le dai?»
«Sì.»
Afferro il biglietto, lo caccio nella borsa. E poi, ecco, mi viene l’avidità, anche questa è una conseguenza della ipnosi in cui mi piomba la fissa del denaro. Aggiungo, infantile e implorante: «Soltanto dieci? Non puoi darmene venti?»
Qualcuno dirà: che sfacciataggine. E invece no: è una specie di timidezza, provocata dalla povertà. Sono così povera, che mi succede col denaro come con la fame a chi ne ha avuta troppa: dopo aver mangiato, gli rimane l’appetito e vorrebbe mangiare di nuovo. Ma Paolo questa volta non cede. Dice: «Dieci bastano. Ma se vieni a trovarmi domani in ufficio, te ne darò altrettante magari anche di più.»
Balbetto: «Ma domani è domenica. Non c’è nessuno negli uffici, domani.»
«Appunto.»
Appunto che cosa? Sarebbe un ottimo pretesto per un’altra scenata, proprio adesso, al momento di andarmene. Ma sono scarica; e il denaro mi impedisce di ricaricarmi, di riprendere quota. Dico, invece, con voce sommessa, come se non volessi farmi sentire da qualcuno che sta ad ascoltarmi: «D’accordo, verrò. Ma tu, intanto, non potresti darmi un accontino, per esempio cinquemila. Per venire da te, ho bisogno almeno almeno di un paio di pantaloni decenti.»
«Non è un ricevimento. Non ci sarò che io. Va benissimo come sei adesso.»
La macchina si ferma, mi guardo intorno: con disperazione, con orrore, riconosco corso Trieste. Una strada come un’altra, in altri momenti; adesso la strada del mio fallimento, della mia sconfitta. Dico, ansiosa: «E a che ora?»
«Vieni alle cinque.»
«E l’indirizzo?»
Si mette la mano in tasca e io, per un momento, spero davvero che tiri fuori un altro biglietto da diecimila. Nient’affatto, è un biglietto da visita. Nome, cognome, indirizzo, export-import e, naturalmente, anche la corona nobiliare, con tanti raggi e tante palline, simile a un insetto, al di sopra del nome.
Metto il biglietto nella borsa e lui mi apre la portiera. Dico in fretta: «E grazie, sai»; e poi, sul punto di scendere, da vera pazza, ecco, piegò il capo sulla sua mano e gliela bacio con abietta gratitudine. E’ vero che al momento di sfiorarla con le labbra provo la tentazione di morderla; ma è soltanto una tentazione; e cos’è una tentazione che non si sfoga? Niente, meno che niente. Ma allora perché quel bacio? Boh. Smonto, poi rimango ferma sul marciapiede a guardare, arrabbiata a morte, la macchina che si allontana.
Domenica, eccomi in una strada di palazzi nuovi. Gli altri giorni sarebbe un caos di macchine ferme e ruggenti, a volte nella nube di gas dagli scappamenti impazienti. Oggi, invece, che è domenica, è un deserto, tanto che addirittura ci incrocio un gatto il quale, in quel momento, traversa calmo calmo l’asfalto in senso inverso. Sì, un deserto; ma l’appuntamento con Paolo mi rende questo deserto, altrimenti piacevole, un po’ sinistro, vagamente minaccioso, certo enigmatico. Paolo non è, infatti, il ragazzo che, mentre i genitori sono in campagna o al mare per il week-end, si va a trovare a casa sua, per passare con lui un tranquillo e rilasciato pomeriggio domenicale a base di sigarette, dischi, alcool, sesso e magari pure un’occasionale fumata. Paolo… è Paolo. Cioè un uomo che mi è antipatico, che mi ripugna e di cui ciononostante accetto l’invito chiaramente equivoco e malintenzionato. Certo, c’è la promessa ancora uno o magari due o tre altri biglietti da diecimila. Ma l’ho già detto: il denaro mi affascina se lo vedo, per così dire, in carne e ossa, squadernato sotto il naso; lontano e invisibile, cessa di ipnotizzarmi e, bene o male, torno me stessa. Ma allora perché sono qui, perché ci vado, perché, insomma, mi sono lasciata incantare? Contraddizione, al solito. E si ritorna al punto di partenza: perché mi contraddico così spesso? Boh.
Basta, ecco il palazzo. Lo guardo di sotto in su e rimango abbagliata dalla facciata tutta cristalli e acciaio, chiara e scintillante, con il riflesso freddo e azzurro del cielo in ciascuna finestra. Strano: tutto questo nitore, questo scintillio, questa purezza di materiali e di linee; e poi, in fondo a una stanza, in uno degli appartamenti, Paolo col suo labbro leporino, i suoi baffi, i suoi sopraccigli di carbone, i suoi occhi di gufo. Mi avvicino al portone, è chiuso. Cerco di guardare attraverso i vetri; ma sono vetri speciali, di quelli trasparenti soltanto dall’interno, e non vedo nulla. Presso il portone, però, c’è una fila di targhe e tra le altre anche quella dell’export-import. Mi decido e premo il bottone del campanello, in un piatto d’ottone grande come una scodella.
Quasi subito, la porta si apre, come se il mio arrivo fosse spiato attraverso quei vetri oscuri da qualcuno che mi aspettava; e, sulla soglia, appare un ragazzo coi capelli lunghi. Ma non lunghi ma la maniera dei ragazzi di oggi; lunghi alla maniera delle ragazzine di ieri. Questi capelli scendono ai due lati di una faccia bianca, liscia e un po’ paffuta, che fa pensare a quelle dei cherubini e serafini, dalle ali attaccate alla testa, che svolazzano in cielo nei quadri delle chiese. Pure angelici sono gli occhi un po’ svenevoli che mi guardano, ispirati e interrogativi; il naso all’insù dalle narici strette; la bocca a cuore, con gli angoli arricciati. E’ piccolo, come un fantino; ma ben proporzionato, con le mani e i piedi che fanno tenerezza tanto sono minuscoli. Gli dico, con simpatia: «Sei il portiere?»
Risponde modesto: «No, il figlio. Papà è andato in campagna.»
«Be’, debbo andare al quinto piano, dall’export-import.»
«Dal signor Paolo? Ti ci porto io.»
Mi precede verso l’ascensore, entra, lo seguo, fa per chiudere le porte. Dico, indicando i bottoni dei piani: «Non ho bisogno di essere accompagnata. Per premere un bottone, sono buona anch’io.»
Mi guarda senza rispondermi; poi disinvolto ma non insolente, stende il braccio e preme il bottone del quinto piano. Insisto arrabbiata: «Ma che sei sordo? Ho detto che non ho bisogno di essere accompagnata.»
Mi lancia un’occhiata ambigua e poi pronunzia: «Ordini superiori.»
«Ma ordini di chi?»
Non risponde. Adesso mi fissa il petto, forse soltanto perché è al livello dei suoi occhi. Ha un’espressione curiosa, che non riesco a interpretare, quasi preoccupata. Dice in fretta: «Oggi è domenica, questo è un palazzo di uffici e non c’è nessuno. Lo sai che siamo soli nel palazzo?»
Rispondo crudemente: «E chi se ne frega.»
«Allora dammi un bacio.»
Così dicendo preme il bottone dell’alt. L’ascensore si ferma.
Ora, un bacio potrei anche darglielo se non altro perché è un tale perfetto angelo da quadro d’altare. Dico di più: forse non mi dispiacerebbe. ma quall’ “allora” mi fa infuriare. Perché “allora”? “Allora” che cosa? Evidentemente: “Allora dammi un bacio, tanto siamo soli e tu sei una debole femminuccia e io posso fare di te quello che voglio.” Lo fisso dritto negli occhi, con sguardo acuminato. Quindi rispondo, marcando le parole: «Un bacio a te? Povero scemo.»
Ci credereste? Ecco che l’angelo, con espressione risoluta e concentrata si avventa su di me, afferra il bordo della camicetta e, in un solo strappo, fa saltare l’unico bottone. Quindi si attacca alla reggipetto, lo tira giù da una parte, con forza e determinazione. Un seno sbotta di fuori; l’angelo, senza esitare, ci dà una crudele stilizzata. Gemo dal dolore; rispondo con un colpo di ginocchio allo stomaco. L’angelo fa un salto, mi acchiappa per i capelli e mi tira la testa in giù, cercando di avvicinare la mia bocca alla sua. Imbestialita, alla cieca, lo graffio in faccia. L’angelo lascia immediatamente i miei capelli; Mi raddrizzo scarmigliata e ansimante; eccolo lì, rifugiato in fondo all’ascensore, che mi guarda, mortificato, passandosi la mano sul viso graffiato. Dice, poi, lamentoso: «Che ti chiedevo, in fondo? Un bacio.»
Rispondo, infuriata, tendendo la mano a premere di nuovo il bottone dell’ascensore: «Guarda, è meglio che stai zitto.»
Implora, con voce supplichevole: «Almeno promettimi che non dirai niente al signor Paolo.»
Buona idea! L’assalto dell’angelo potrà servirmi da pretesto per una ulteriore scenata Paolo. E poi, proprio perché l’angelo, con la sua faccia paffuta rigata dai graffi, mi fa tenerezza, voglio dimostrarmi dura con lui. Grido, violenta: «Non prometto nulla.»
Mi guarda con espressione per niente spaventata. Semmai incuriosita, come chi spia da dietro un vetro, l’evoluzione di un pesce in un acquario. Ma non ho il tempo di approfondire questa sensazione. L’ascensore si ferma, volto alle spalle all’angelo e discendo in fretta, senza voltarmi.
La porta dell’import-export è aperta, la spingo, mi ingolfo con impeto nell’anticamera e poi in un lungo corridoio, tra due file di porte. Moquette grigia, porte rosse, soffitto bianco. Dove sarà Paolo? Apro le porte una dopo l’altra e trovo dappertutto lo spettacolo solito degli uffici nei giorni festivi: macchine per scrivere incappucciate, fogli di carta bianca, foglie di carta carbone sparsi dovunque, come dalla ventata di un temporale. Ogni porta spalancata invano, cresce il mio furore. Mi sto caricando, esattamente come quando faccio l’autostop. Una frase mi gira, come una trottola spietata, per la testa: «Ora l’accomodo io.»
Arrivo in fondo al corridoio, irrompo. Paolo sta seduto in una grande stanza quasi vuota, dietro un tavolo di vetro e di acciaio. Ha il solito vestito blu scuro, i soliti gemelli d’oro ai polsini, la solita cravatta a strisce, stavo quasi per dire il solito labbro leporino. Subito l’investo con inaudita violenza: «Il figlio del portiere mi ha aggredito nell’ascensore. Guarda la mia camicetta, guarda i miei capelli. Mi ha strappato la camicetta, mi ha acchiappato per i capelli, mi ha strizzato il seno. Ma dove siamo? Ma chi credete di essere? Tante arie e poi permettere che si aggredisca la gente degli ascensori eccetera eccetera.»
Urlo; ma Paolo non mi risponde, non mi interrompe. Anche lui mi guarda come, poco fa, l’angelo nell’ascensore: con un’attenzione incuriosita, come attraverso un vetro. Insomma, si può sapere che hanno tutti e due a spiarmi in questo modo? Finisco: «Ma che maniere sono queste? Chi me la ripaga la camicetta? Ma io lo denunzio, quel teppista, sicuro, lo denunzio.» Alla fine Paolo si muove, in maniera studiata, però e come “recitata”. Tende un braccio ad aprire una scatola sul tavolo, ne prende una sigaretta, se l’infila nella fessura del labbro leporino. Gesti assai facili e comuni, direte, che qualsiasi persona compie senza sforzi e senza intenzione, come viene viene. Ma Paolo, questi gesti così normali, a quanto pare, li fa apposta per nascondere qualche cosa di anormale. E infatti li sbaglia, come un attore esordiente e intimidito: mette in bocca la estremità senza bocchino e non se ne accorge se non quando fa scattare la fiamma dell’accendino. Allora rimette la sigaretta nel modo giusto e riavvicina la fiamma. Strano: la mano gli trema così forte che per un momento non ce la fa ad accendere. D’improvviso, allora, ho paura: la mano, è chiaro, gli trema perché c’è nella sua testa, per me, un piano bell’e fatto, premeditato, che a lui stesso ispira turbamento, vergogna, chissà, forse spavento. Lo vedo, intanto, abbassare la mano, riposare l’accendino sul tavolo e restare a occhi bassi, in silenzio, guardandosi, si direbbe, la mano che tuttora gli trema. Dice, alla fine, con una voce strana: «Vuoi che lo punisca?»
Impressionata dal tremito della mano e dal tono della voce, adesso vorrei dire di no, che non lo desidero, che ormai ho perdonato. Ma come sempre, vince in me la contraddizione; e così la curiosità prevale sul timore. Balbetto falsamente: «Certo che lo voglio.»
Silenzio. Adesso Paolo guarda alla tavola sulla quale c’è un foglio di carta. Con la penna traccia ghirigori e pare che rifletta. Alfine tende la mano al citofono, preme il bottone. Si sente un gracchiare indistinto; quindi, molto chiara, la voce dell’angelo: «Sì, signor Paolo?»
«Vieni subito su.»
Domando impressionata: «E adesso che gli fai?»
Non risponde. E’ assorto a seguire con gli occhi i ghirigori che va disegnando sul foglio di carta. O meglio, come mi accorgo, a contemplare il tremito della propria mano mentre fa i ghirigori. Aspetto che mi risponda; e intanto, anch’io, chissà perché, fisso la mano che trema, con affascinata curiosità. Poi sento la sua voce, corta e autoritaria: «Spogliati.»
Lo guardo, incerta. Ha parlato a me o me lo sono immaginato? Dico: «Eh?»
Ripete, questa volta in maniera marcata: «Ho detto: spogliati!»
Com’è strano l’animo umano: O per lo meno il mio, così mutevole, così pieno di contraddizioni. Sono una rivoltata, una ribelle, una contestatrice, si può dire, fin dalla nascita. Eppure, ecco, mi basta adesso un ordine dato con la voce che ci vuole e nel momento giusto, per rendermi obbediente e disciplinata come un soldato di fronte all’ufficiale. O meglio, come mi dico, mentre, fin troppo sollecita e zelante, prendo senz’altro a tirarmi via il vestito per la testa, come un attore di fronte al regista. Già, al regista, perché Paolo mi ha imposto, in qualche modo, non so che parte, in non so quale sua commedia; e io, inspiegabilmente soggiogata, a quanto pare, ormai, ho accettato di recitarla.
Ma che parte è, alla fine? Chi me lo fare, per esempio, una volta sfilato il vestito, di andare in punta di piedi a posarlo in una seggiola? E poi di strapparmi in gran fretta gli slip e reggipetto, col timore complice, si direbbe, di non fare in tempo prima che l’angelo, altro attore della commedia, faccia il suo ingresso? Adesso sono nuda; e poiché mi vergogno del mio seno enorme e cascante, ripiego un braccio a sorreggerlo, come si fa con un infante che si allatta. Impacciata, mi avvicino alla tavola e domando timidamente: «Debbo restare in piedi oppure sedermi?»
«Resta pure in piedi.»
Ecco, si bussa alla porta. Invitato da Paolo, con la solita voce strangolata,, a farsi avanti, l’angelo dapprima si affaccia con precauzione tra i due battenti, come per rendersi conto del punto in cui è giunta la rappresentazione. Quindi, senza dubbio soddisfatto da quello che vede, (Paolo assorto, a occhi bassi, a disegnare sul foglio di carta; me, in piedi, nuda ma con gli stivali, di fronte al tavolo), entra francamente e deliberatamente, dicendo: «Signor Paolo, mi ha chiamato?»
«Sì, ti ho chiamato. Allora tu aggredisci nell’ascensore le persone che vengono a visitarmi?»
C’è un momento di silenzio. Poi avviene qualche cosa che, ormai, mi aspettavo; e che mi conferma definitivamente nell’idea che stiamo recitando tutti una commedia. L’angelo, approfittando del fatto che Paolo sta tuttora a guardarsi la mano che trema, si volta verso di me e, sfacciatamente anche se pur sempre da angelo, mi strizza l’occhio, come per dire: “E’ tutta una cosa convenuta tra me e il signor Paolo. Ma noi due siamo d’accordo con lui.” E’ un attimo. Quindi con voce contrita, ossequiosa e falsa, l’angelo spiega: «Signor Paolo, lei ha ragione. Ma la signorina era, come dire, un po’ svestita, e io allora ho perso la testa…»
Faccio appena in tempo a pensare che l’angelo è un pessimo attore, che, ecco, scoppia un urlo disumano: «Zitto, schiavo.»
«Ma signor Paolo…»
«Taci, paria.»
Alla buonora! Se l’angelo recita male, in compenso Paolo recita benissimo; o, meglio, è se stesso, più vero del vero, tanto se stesso da far paura. Balza in piedi, batte un pugno sul tavolo, urla: «Schiavo, paria, se non vuoi che lo dica a tuo padre, adesso devi inginocchiarti davanti a Sebastiana e baciarle i piedi.»
Così la commedia si sviluppa; e svuluppandosi, mi coinvolge sempre più, pur senza lasciarmi indovinare i prossimi sviluppi. Ero, un momento fa, una povera squillo, che si spogliava di fronte al cliente; adesso che sono? Chissà, dorse una specie di dea. Vedo, infatti, quasi incredula, l’angelo gettarsi carponi ai miei piedi, con un buffo gesto di prosternazione; e poi lo vedo che, con vivo movimento volontario, allunga il collo verso i miei stivali. Paolo urla come invasato: «Non basta. Non soltanto devi baciarle i piedi, ma anche leccarli.»
Esegue, l’angelo, o fa finta? Difficile a dirsi perché, a causa degli stivali, non posso capire se li bacia oppure li lecca. Paolo urla: «Tutti e due, tutti e due»; e l’angelo, obbediente, sposta il capo da un piede all’altro. Quindi trasalisco e faccio quasi un salto. Paolo ha fatto il giro della tavola, è venuto a mettersi alle mie spalle, mi ha afferrato da dietro per le braccia, con una forza tremenda, fino a farmi male. Intanto la sua testa si affaccia sulla mia spalla e la sua voce mi suggerisce all’orecchio, sommessa, intensa, frenetica: «E adesso fagli pipì sul capo. Sì, dài, orinagli sulla testa.»
Che mi succede? Semplicemente che non sono più il personaggio della commedia di Paolo; sono di nuovo me stessa. E, infatti, molto naturalmente, d’istinto, rispondo: «Questo, no.»
«Ma perché, no?»
«Perché non mi va.»
«Perché non ti va? E’ un paria, un servo, uno schiavo. Su dài, fagliela sulla testa. Ti do quello che vuoi; ma fagliela.»
Si vede, però, che nei patti tra l’angelo e Paolo non era compresa questa faccenda dell’orina. Infatti l’angelo, dopo un momento di incertezza, di immobilità, come chi non è sicuro di aver sentito bene, ecco, si scosta con ribrezzo sul pavimento, si leva traballante in piedi e dice, trafelato: «Signor Paolo, questo poi, no.»
Sembra che sia finito. Adesso parrebbe che non ci resti a me e all’angelo, proprio come due attori che hanno terminato di recitare, che fare un bell’inchino e andarcene. E invece no; lo sento, con assoluta sicurezza, che la commedia avrà ancora una svolta. Non mi sbaglio. Paolo mi gira intorno, mi passa davanti, grida: «E allora se non vuoi farla sulla sua testa, falla sulla mia. Sì, sulla mia.» E poi ecco, si butta in terra, si inginocchia, mi mette la testa fra le gambe.
Quadro: io a gambe larghe, uno stivale di qua e l’altro di là, il braccio piegato a sostenermi il seno, appoggiata di fianco al tavolo; l’angelo, in piedi, ha qualche distanza, ancora rosso in faccia per lo sforzo; questo pazzo di Paolo, carponi, davanti a me, le braccia alzate a stringermi le ginocchia e la faccia girata in su, in speranzosa attesa, come sotto una doccia che non si decide a zampillare.
Ora, però bisogna sapere che tutto quello che in qualche modo ha a che fare con i bisogni corporali suscita in me una irrefrenabile, isterica ilarità. Perché la suscita? Boh, è un fatto come un’altro e tanto basta. Il riso mi ha già tentato quando Paolo mi ha ingiunto di orinare sul capo all’angelo; ma adesso che mi implora di farlo a lui, scoppia irresistibile. Rido mio malgrado, come un’idiota, come una demente, con una gioia selvaggia e cretina che io stesso non capisco. Poi Paolo insiste, da laggiù in terra dove si accovaccia: «Su, dài»; e io, allora, gli grido di nuovo, contorcendosi dalle risa: «No, no, e poi no, ah, ah, ah, ah.»
«Dài.»
«Ma ti dico di no. Ah, ah, ah.»
Come fuori di sé, allora lui prende improvvisamente a scuotermi per le caviglie, allo stesso modo che si fa con un albero per far cascare i frutti. Vacillo, pur continuando più che mai a ridere. Ma lui mi dà uno scossone così forte che perdo l’equilibrio e urto col fianco contro la tavola. Dal dolore, mi passa il riso. Grido esasperata: «Basta. E adesso lasciami. Sei pazzo?»
Sì, è proprio pazzo. Mi scuote di nuovo, sto per cascare daccapo; l’occhio mi va ad un portacenere di vetro, sulla tavola. L’afferro, mi piego, gli do un colpo sulla testa, con forza rabbiosa. Subito caccia un urlo, lascia la presa, porta la mano al capo, si rovescia sul fianco, resta immobile, ripiegato su se stesso, nella posizione, mi viene fatto di pensare, del feto nel ventre della madre.
Mi chino, faccio per sollevargli il capo, sento alla mano una sensazione di bagnato, mi guardo la mano, vedo che è sporca di sangue. Mi viene una paura terribile; Ma questa paura non solamente non diminuisce ma cresce quando mi accorgo che lui non è affatto morto come ho temuto. In realtà è vivo, fin troppo vivo. Sta immobile, la guancia contro la moquette, la mano sul capo e quei suoi occhi tondi di gufo sbarrati e fissi, a guardare, si direbbe, qualche cosa che è solo lui a vedere. Proprio questi occhi spalancati, che dovrebbero rassicurarmi perché dimostrano che non l’ho ammazzato, mi spaventano definitivamente. Così, quello che non ho voluto fare poco fa di mia volontà, lo faccio ora, mio malgrado, per il terrore. Sento che orino, non però normalmente, come al cesso; ma a schizzi, a spruzzi, a sussulti, alla spicciolata; e poiché vedo che l’orina gli cade sui capelli, sulla faccia e anche su quei suoi terribili occhi sbarrati, mi muovo per non bagnarlo virgola in direzione della seggiola, sulla quale ho deposto il vestito e gli altri panni. L’orina continua a uscirmi a piccoli getti involontari, riga di una striscia scura di bagnato il tappeto chiaro, mi sgocciola sugli stivali. Afferro il vestito, il reggiseno e lo slip, mi volto verso l’angelo che se ne sta ancora lì stupefatto, e gli dico a bassa voce prendendolo per mano: «Vieni, su, andiamo.»
Ma ci tiriamo subito indietro, spaventati e rispettosi: Paolo si sta alzando, ecco, è in piedi. Forse non ci vede, certo non ci guarda. Si passa una mano sulla faccia, quindi, barcollando, attraversa la stanza. Non va, però, alla porta da cui siamo entrati io e l’angelo. Ci passa davanti, apre un piccolo uscio che non avevo notato, scompare. Per l’uscio aperto, sentiamo il rumore dell’acqua che scorre: Paolo si sta lavando. Mi volto verso l’angelo e gli dico: «Dài, scappiamo.»
So che il palazzo è vuoto perché è tutto di uffici ed è domenica. Così non esito a buttarmi giù per le scale, nuda come sono, seni e capelli al vento, coi soli stivali, e con i panni sul braccio. Tenendoci per mano, io trascinandolo e l’angelo lasciandosi trascinare, giravoltiamo di corsa, da una rampa all’altra, per cinque piani arriviamo all’ingresso. Ma non ci fermiamo. La bussola del portiere ci invita; a un mio sguardo interrogativo, l’angelo risponde con un cenno degli occhi, come per dirmi che ho indovinato. Gli do una piccola stretta alla mano come per suggellare l’intesa, lui fa lo stesso; quindi correndo, eccoci precipitiamo per una scaletta angusta, giù giù, nel seminterrato, dov’è il quartierino del portiere. In fondo, è la fuga dall’ufficio di Paolo che continua; e pur continuando, va a concludersi nel luogo prevedibile: il lettone matrimoniale dei genitori dell’angelo.
Più tardi, stiamo in silenzio, supini, distesi l’uno a fianco dell’altro, sulla coperta di seta dai colori sgargianti. Come mi piacciono i seminterrati, per farci l’amore e poi rilasciarmi a sonnecchiare dopo l’amore. La stanza ha il soffitto molto basso; ed è piena di mobili e di cianfrusaglie; e c’è l’odore di chiuso e di cucina, come in tutte le portinerie. Dietro i vetri opachi delle due finestrelle a bocca di lupo, vedo ogni tanto trascorrere appaiate le ombre delle gambe dei passanti. Lo specchio dell’armadio, laggiù in fondo al letto, riflette di scorcio i nostri due corpi nudi, coi piedi che sembrano attaccati alle ginocchia. Io stringo in mano il membro dell’angelo, circondandolo con due dita come un anello; lui mi posa, a piatto, sul pube, la mano aperta. Alla fine, l’angelo domanda: «Secondo te, il signor Paolo perché fa quelle cose?»
«Perché gli piace.»
«E perché gli piace?»
«Boh.»
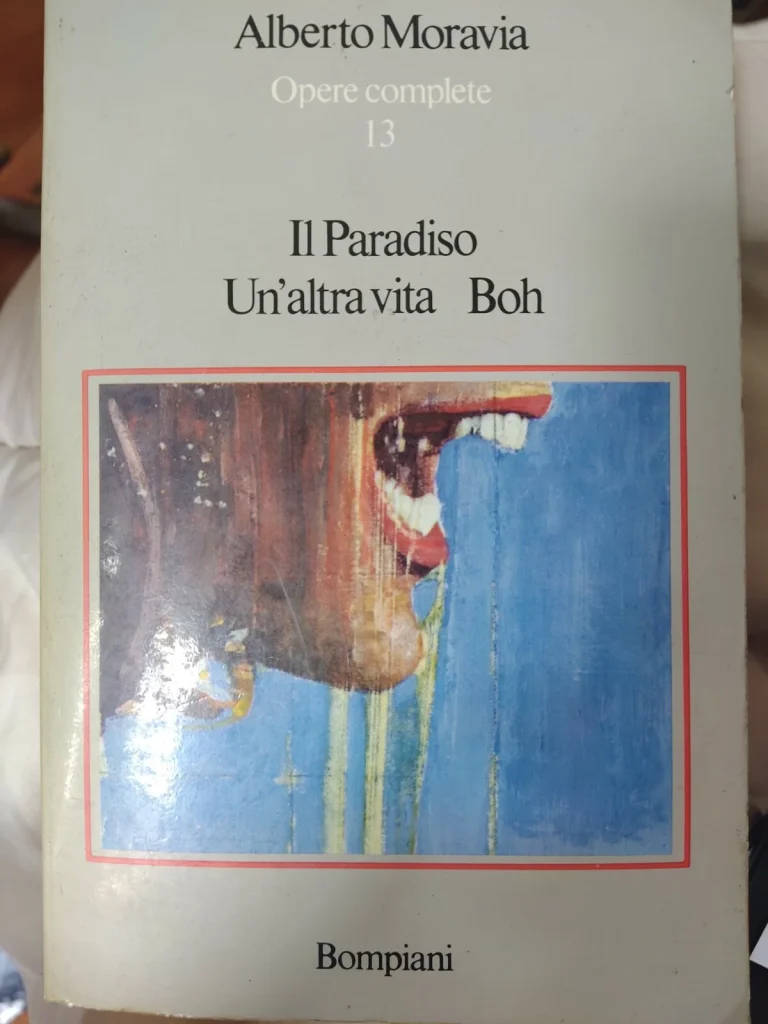 Riccardo Gasperina Geroni, critico letterario, nel suo saggio Donne ribelli, donne oggetto: il mondo femminile nei racconti di Alberto Moravia individua nell’ultima raccolta, appunto, Boh, una “rabbia” nel mondo femminile, così com’è testimoniato nel racconto omonimo, che rivela ciò che appare esternamente, ma senza che ve ne sia un motivo. Sebastiana, infatti, ex sessantottina, sfoga la “rabbia” adescando clienti e quindi ingiuriandoli rispetto alla loro posizione sociale, ma da dove derivi tale rabbia non è dato sapere. Potremo parlare di, a fronte di una mancata rivoluzione, di una rivolta che tuttavia anch’essa non trova un fine pratico/morale, se non, dopo l’attacco d’ira, sentendosi “placata”. Tale disegno non funziona con il cliente nobile e pervertito, che le offre del denaro; ma proprio quando quest’ultimo cerca di obbligarla a dei riti urofagici, lei si riscatta con l’angelo (che ha tentato di sedurla nell’ascensore) scappando e facendoci l’amore. Ma ciò che rimane in loro due incompreso è il meccanismo dell’inconscio, in questo caso, nell’intero racconto, sia dell’esplosione di rabbia, sia delle pratiche sessuali: ciò che la ragione non riesce a controllare bisogna commentarlo, secondo Moravia, solo con un “boh”.
Riccardo Gasperina Geroni, critico letterario, nel suo saggio Donne ribelli, donne oggetto: il mondo femminile nei racconti di Alberto Moravia individua nell’ultima raccolta, appunto, Boh, una “rabbia” nel mondo femminile, così com’è testimoniato nel racconto omonimo, che rivela ciò che appare esternamente, ma senza che ve ne sia un motivo. Sebastiana, infatti, ex sessantottina, sfoga la “rabbia” adescando clienti e quindi ingiuriandoli rispetto alla loro posizione sociale, ma da dove derivi tale rabbia non è dato sapere. Potremo parlare di, a fronte di una mancata rivoluzione, di una rivolta che tuttavia anch’essa non trova un fine pratico/morale, se non, dopo l’attacco d’ira, sentendosi “placata”. Tale disegno non funziona con il cliente nobile e pervertito, che le offre del denaro; ma proprio quando quest’ultimo cerca di obbligarla a dei riti urofagici, lei si riscatta con l’angelo (che ha tentato di sedurla nell’ascensore) scappando e facendoci l’amore. Ma ciò che rimane in loro due incompreso è il meccanismo dell’inconscio, in questo caso, nell’intero racconto, sia dell’esplosione di rabbia, sia delle pratiche sessuali: ciò che la ragione non riesce a controllare bisogna commentarlo, secondo Moravia, solo con un “boh”.
Se abbiamo analizzato le tre raccolte femminili insieme, come figlie di una stessa ispirazione (tanto che la stessa casa editrice ne fa un’edizione unica nel 1976), non dobbiamo dimenticare che, in questa prima metà degli anni ’70, ad un anno del Paradiso pubblica il romanzo Io e lui (1971) e l’anno seguente un ennesimo libro di viaggio, questa volta in Africa, il cui titolo è A quale tribù appartieni? (1972)
Il protagonista di Io e lui Federico, conduce una vita di stile borghese: ha trentacinque anni ed è sposato con Fausta, da cui ha avuto un figlio, Cesarino. Federico ha velleità artistiche, scrive sceneggiature e vorrebbe dirigere il film “L’espropriazione“, ma il suo tentativo rimane frustrato in quanto non riesce a “sublimarsi”, perché il suo “es” (il suo membro “sproporzionato”) non riesce a stare tranquillo, ma interloquisce continuamente facendolo fallire sessualmente, umanamente e lavorativamente. Federico e il suo “lui” seguono da vicino i mutamenti storici e sociali del Sessantotto con curiosità e ammirazione; vorrebbe incarnare il modello di intellettuale militante di sinistra proposto dai movimenti, ma appartiene a una generazione precedente ed è bollato dai gruppi rivoluzionari come reazionario.
Alla base dell’idea della stesura del romanzo ce la offre Moravia in un dialogo con il critico Geno Pampaloni: «volevo da tempo scrivere un libro comico; da sempre consideravo il romanzo comico come una meta da raggiungere. Di fronte ad uno sterminato numero di romanzi seri, i grandi romanzi comici si contano sulle dita di una mano o poco più… […] La comicità mi pare qualche cosa di molto difficile: essa implica l’esperienza indispensabile della serietà, mentre la serietà non implica affatto l’esperienza della comicità. C’era per me anche un altro motivo per scrivere un romanzo comico: ero stufo del mio solito personaggio dell’intellettuale. Ho voluto prenderlo in giro, renderlo ridicolo. L’ho creato sessualmente superdotato e intellettualmente infatuato di psicanalisi o meglio dell’idea di origine psicanalitica che l’arte sarebbe il risultato di quel processo psichico che va sotto il nome di sublimazione. E’ un po’ la stessa idea de L’amore coniugale nel quale il protagonista si astiene dal rapporto sessuale con la moglie per conservare intatta tutta la sua energia creativa che vuole invece dedicare al romanzo che sta scrivendo. Ma L’amore coniugale è in chiave drammatica, Io e lui in chiave comica.»

Già nella descrizione di Rico vi è qualcosa di satiresco: non alto, pelato, con stomaco prominente e un membro di grandezza spropositata. Ma è soprattutto nella banalizzazione che il protagonista fa del concetto freudiano di sublimazione, il quale può essere inteso come «la trasformazione di pulsioni sessuali o aggressive, poco accettabili socialmente, in attività intellettuali o comportamenti ai quali la società riconosce un pieno valore», che troviamo il nucleo “comico” del romanzo. Infatti Rico si sente desublimato in quanto il suo “lui” prevale sul suo “io”, tanto da indurlo alla ricerca di una continua attività sessuale, non permettendogli di indirizzare la sua pulsione erotica verso un qualcosa di artistico, quale, in questo caso, la regia.
Il suo problema potrebbe essere risolto dopo la conoscenza di Irene, incontrata in banca mentre preleva soldi da versare alla “causa” rivoluzionaria che gli ha commissionato la sceneggiatura del film a cui lui vorrebbe fosse affidata, appunto, la regia. Irene, infatti, non ricerca rapporti sessuali con uomini, in quanto si è votata all’autoerotismo; creare un rapporto con lei significherebbe dunque mettere a tacere il suo organo, che tuttavia, “per dispetto” sottolineando la femminilità delle sue gambe lo porta verso la sessualità che Rico vorrebbe reprimere. Di fronte a tanta insistenza del suo organo, decide di punirlo tramite un suo amico di mestiere psicoanalista:
ANALIZZATO!
La mattina, appena svegliato, mentre la mia mente è ancora offuscata e impotente, “lui” si scatena. Come se volesse dimostrarmi che la vera continuità della vita, il vero filo d’Arianna in questo labirinto assurdo non è la mia ambizione sublimatoria bensì la sua ossessiva attività irreparabilmente desublimata, “lui” riprende l’avvenimento del giorno prima e me lo ripropone nel ricordo, beninteso a modo suo. Queste rievocazioni mattutine, per lo più le subisco, insonnolito, intorpidito, e non del tutto ostile, quasi concedendomi nel dormiveglia una vacanza di onirico e inoperante erotismo. S’ intende che “lui” accompagna le rievocazioni con le solite metamorfosi, come a sottolineare la sua completa, proterva autonomia che gli consente di essere attivissimo, non soltanto quando sono sveglio ma anche quando sono addormentato.
Così anche stamane, il giorno dopo il mio primo incontro con Irene. Apro gli occhi e mi accorgo di star coricato su un fianco, con “lui” adagiato sul lenzuolo, così pesante e così enorme da suggerire l’idea che io sono una campana cascata giù dalla sua torre e giacente spezzata sul suolo, con il solo, massiccio battacchio rimasto intatto tra i frantumi. Paragone imprudente; “lui”, infatti, interloquisce subito, tutto vispo: «Sta’ tranquillo, la campana non è infranta, sentirai tra poco che rintocchi!» Trascrivo poi il dialogo così come è seguito tra noi due:
Io: «Ma che diavolo dici? Quali rintocchi? Si può sapere perché sei già così eccitato alle otto del mattino? Non potresti star tranquillo e riposarti, come faccio io, come fanno tutte le persone sensate?»
“Lui”: «Le gambe di Irene!»
Io: «Non ricordarmi la serata di ieri. Hai rovinato tutto. Per colpa tua, forse, non rivedrò mai più Irene. La sola donna al mondo che potrei amare. L’unica. Ma già, cosa ne sai tu dell’amore?»
“Lui”: «Le gambe di Irene!»
Io: «Si era abbandonata, mi aveva fatto delle confidenze che probabilmente non aveva mai fatto a nessuno… e tu, stupido e brutale come un bufalo, eccoti a guastarmi ogni cosa!»
“Lui”: «Le gambe di Irene!»
Io: «Le telefonerò, questo è certo. Ma prima di farmi vivo con lei, voglio esser sicuro che tu non rovinerai di nuovo ogni cosa con il tuo ignobile comportamento.»
“Lui”: «Le gambe di Irene!»
Io: «Amerò Irene, lo sento, ne sono sicuro. Amarla, sarà per me come diventare regista: passare, cioè, dal rango dei desublimati a quello dei sublimati. Ma perché questo avvenga, tu devi riconoscere una volta per tutte la verità della sublimazione.»
“Lui”: «Le gambe di Irene!»
Io: «Ti propongo un patto: libertà, per te, di intervento, sia pure velleitario e votato al fallimento, in tutte le altre occasioni della mia vita. Ma in presenza di Irene, assoluta passività, o meglio, inesistenza.»
“Lui”: «Le gambe di Irene!»
Io: «Adesso devi dirmi se accetti il patto.»
“Lui”: «Le gambe di Irene!»
Io: «Dico a te, canaglia. Accetti o no?»
“Lui”: «Le gambe di Irene!»
Io: «Così questa è la tua risposta, questo ritornello? Ho capito. Dovrò adottare con te delle misure… drastiche.»
“Lui”: «Le gambe di Irene!»
Io: «E’ un pezzo che l’ho deciso. Ho differito finora l’attuazione del mio progetto nella speranza che saresti rinsavito da solo. Questo non è avvenuto. Dunque, sia pure con rincrescimento, mi vedo costretto ad agire.»
“Lui”: «Le gambe di Irene!»
Io: «Oggi stesso andiamo da Vladimiro e questa volta non ci sono santi: vuoterò il sacco fino in fondo. Chi ci rimetterà sarai proprio tu. La tua forza sta nell’oscurità, segretezza, incertezza dei nostri rapporti. Illuminarli con la luce della ragione vuol dire distruggerti. Ma tanto peggio per te. L’hai voluto.»
Per capire questo mio minaccioso discorso bisogna sapere che Vladimiro è un mio amico dei tempi dell’università, il quale esercita o meglio (data la scarsità della clientela) vorrebbe esercitare la professione dello psicanalista. Privo o quasi di malati da curare, Vladimiro, forse anche per questo, è un dottore molto serio. D’altra parte la sua serietà è, per così dire, garantita dal fatto che lui stesso è un perfetto caso di grave nevrosi, manifestamente bisognosa di una prolungata cura psicoanalitica. Ci vado anche per questo. Nevrotico e al tempo stesso medico specializzato in nevrosi, sono convinto che Vladimiro è il solo che possa comprendere il mio particolarissimo caso il quale, a ben guardare, non è propriamente da curarsi (che c’è, infatti, di patologico nell’essere due invece che uno?) ma soltanto da prendere in considerazione con spirito amichevole e privo di pregiudizi.
Così, quello stesso pomeriggio, previa telefonata per fissare l’appuntamento (Vladimiro, al telefono, pretende a tutta prima di non sapere dove infilare la mia visita, ma poi, naturalmente, accetta l’ora che preferisco). Eccolo, il quartiere: strade, o meglio trincee di cemento, tra file e file di casamenti gremiti di inutili balconi; negozi dalle grandi vetrine piene di merce scadente; utilitarie disposte a spina di pesce lungo i marciapiedi; non una sola macchina di lusso: eh, eh, non ha fatto molta strada, Vladimiro! E’ la prima volta che vado da lui; un tempo viveva in famiglia, poi si è sposato, ha cambiato casa ha messo su lo studio. Perché provo soddisfazione al pensiero che non abbia avuto successo nella sua professione? Perché, almeno di fronte lui, non voglio stare “sotto”. Lo conosco troppo bene; so con precisione che anche lui è desublimato, seppure in maniera diversa dalla mia; non ammetto assolutamente che mi stia “sopra”. Fallito io, fallito lui; nevrotico io, nevrotico lui; velleitario io, velleitario lui: perché dovrebbe starmi “sopra”? Tuttavia, pur guidando la macchina attraverso le strade affollate, mi sento sempre più nervoso al pensiero di incontrarmi con Vladimiro. Quale contegno tenere con lui affinché fin da principio si renda conto che con me certe arie di superiorità, sia pure scientifica, deve farsele passare? Ci penso su e decido finalmente: sarò anch’io scientifico come lui, anzi più di lui. Vale a dire che invece di un dottore e di un paziente, ci saranno due dottori e un paziente. Vladimiro sarà uno dei dottori, io l’altro. E il paziente, chi sarà? Ovviamente “lui”.
Rinfrancato da questa soluzione, parcheggio la mia utilitaria tra le tantissime utilitarie di una strada polverosa e sconvolta che (lo noto con soddisfazione) il comune di Roma, da anni, deve aver dimenticato di asfaltare. L’appartamento è al terzo piano di uno di quei casamenti impiegatizi. Vi salgo in ascensore. Eccomi sul pianerottolo; vi danno tre porte: l’appartamento di Vladimiro non può essere molto grande. Suono, mi apre non già un’infermiera in camice bianco o una segretaria occhialuta, ma lui stesso, Vladimiro, in maniche di camicia sbracciata, con il colletto aperto, senza cravatta. Dunque non può permettersi neppure un’infermiera, neppure una segretaria! Mentre ci stringiamo la mano, do un rapido sguardo in giro: ingresso minimo, una carrozzina da bambini in un angolo, un attaccapanni. Per l’aria, un appetitoso, ma non precisamente lussuoso, odore di cucina. Vladimiro mi dice: «Sono contento di vederti,» battendomi la mano sulla spalla in maniera non protettiva, forse veramente amichevole, di un’amicizia tutta sua, però, patetica e nevrastenica. Eccoci nello studio. Una stanza piccola, un cubo, appena lo spazio per il tavolo, la libreria, il sofà degli interrogatori. Alla finestra pendono due tende verdi, povere e smilze, tra le quali si intravede la brutale facciata piena di balconi del casamento di fronte. C’è un’aria pulita, ordinata ma anche irreparabilmente modesta in questo studio. Non posso fare a meno di pensare che su quel sofà non si distende mai nessuno. Povero Vladimiro! Ancora uno che, come me, avrà una moglie insaziabile la quale, in complicità con il suo “lui”, gli sottrae tutta l’energia di cui avrebbe bisogno per avviare un sia pure timido inizio di sublimazione. Ma lui non ha avuto il coraggio di andarsene, come me. E dire che è analista e che non ha neppure la scusa dell’ignoranza.
Vladimiro siede dietro il tavolo e mi fa cenno di prendere posto su una seggiola davanti a lui. E’ alto, magro e secco. Fuori dalle mezze maniche della camicia escono due braccia scarnite, prive di muscoli. I capelli sono corti e ispidi di un bruno incerto che tende al giallo, come la paglia vecchia. La faccia di adolescente precocemente invecchiato è segnata da due grosse rughe tristi, così che pare storta. Gli occhi sono di un brutto colore tra il verde e il giallo, come di cane. Ha il naso appuntito ma con le narici larghe. E un’espressione amara sulla bocca grande sinuosa. Sebbene siano le sette e faccia ancora giorno, accende una lampada fortissima e ne dirige il raggio in faccia, abbagliandomi. Gli dico subito: «Piantala con quella lampada. Non sono uno che si lascia impressionare, non sono il cliente al quale si possano spillare le cento o duecento mila lire al mese. Sono soltanto un vecchio amico che viene ad esporti il suo caso per niente affatto clinico.»
Sorride, di un sorriso buono, anche se nevrotico. Abbassa la lampada e dice: «Scusami, ma la lampada, qualche volta, è utile.»
Prendo il mio tempo. Cavo di tasca un pacchetto di sigarette, ne offro a Vladimiro che rifiuta, ne accendo una, ripongo accendino e sigarette in tasca, aspiro rigetto il fumo dalla bocca e dalle narici. Tutto questo, sedendo curvo, le braccia incrociate sul tavolo, gli occhi rivolti in basso. Dico alla fine: «E tu come te la passi? Ti sei messo bene: un bello studiolo, raccolto, tranquillo, intimo, arredato con gusto sobrio. Scommetto che tua moglie ti ha scelto i mobili.»
«No, a dire il vero li ho scelti io.»
«Ma tua moglie lavora? Ti aiuta nella professione?»
«Mia moglie non lavora.»
«E che fa?»
«Fa la moglie. Voglio dire: lavorava, si occupava di assistenza sociale, ma abbiamo avuto due bambini e allora, siccome non abbiamo la bambinaia, se ne occupa lei.»
Parla lentamente, cercando le parole, con visibile imbarazzo, con un’area di sofferenza, di disagio, come se stesse sulle spine. Noto sul tavolo una fotografia incorniciata d’argento: «Questa è tua moglie?»
«Sì.»
«Permetti?»
Prendo la fotografia e la guardo: l’avrei giurato, una bruna dagli occhi neri, dolci, struggenti, dal visino affilato, dedicato, cereo. Sono queste le donne pericolose. Molto più pericolose di Fausta per esempio, nonostante la vistosa sensualità di quest’ultima. Quegli occhioni sentimentali, chiaro indizio di un sesso vorace, spiegano molte cose: la nevrosi di Vladimiro, il suo fallimento, la modestia della casa, l’odore di cucina nell’ingresso. Eh, sì, con una moglie simile la desublimazione è sicura, fatale, inevitabile, irreversibile. Rimetto la fotografia sulla tavola e dico: «Molto carina, tua moglie.»
Non raccoglie il complimento. Si torce sulla seggiola, pronuncia alla fine: «Rico, tu mi hai telefonato dicendomi che si trattava di una cosa urgente. Beh, di che cosa si tratta?»
Ci siamo! Non rispondo subito. Fumo, meditabondo, guardando in basso. Voglio essere scientifico, e, per esserlo, debbo impostare subito il tono giusto. Alla fine, dico con voce chiara, staccando bene le sillabe: «Vladimiro, prima di tutto devo fare una premessa doverosa.»
«Sentiamo.»
«Devi sapere che, per mia sfortuna o fortuna, non so, la natura mi ha eccezionalmente dotato.»
Ci sono le persone impassibili, la cui impassibilità è dovuta ad una completa mancanza di espressione. Ce ne sono altre, invece, che sono impassibili perché, pur essendo fortemente espressive, hanno una sola espressione, sempre la stessa, qualunque cosa avvenga. Vladimiro appartiene alla seconda categoria. Sempre, inalterabilmente, lui ha in viso un’espressione perplessa, angosciata, preoccupata, imbarazzata; ma poiché questa espressione lui ce l’ha egualmente sia che gli dica “Buongiorno”, sia invece che gli si annunzi: “Dottore, vorrei uccidere mio padre”; è come, a ben guardare, se fosse costantemente del tutto inespressivo e impassibile. Così adesso. Mi guarda con aria angosciata e io penso che quell’aria lì lui ce l’ha sempre e così sento il bisogno di spiegarmi meglio, perché lui, forse, non mi ha neppure udito: «In altri termini, Vladimiro, per dirla in parole povere, ho un organo sessuale di proporzioni veramente straordinarie.»
Faccio una pausa, aspiro una boccata di fumo, rigetto il fumo dal naso e fisso il piano del tavolo. Quindi riprendo: «Tu mi dirai che non è questione di proporzioni ma di educazione. Hai ragione. Ci sono degli organi sessuale giganteschi che però stanno restare al loro posto e così passano quasi inosservati; e ce ne sono invece di molto piccoli che si agitano senza discrezione e si fanno notare. Ma il peggio avviene quando è l’organo gigantesco a agitarsi, a farsi notare. Ora, questo, Vladimiro, è purtroppo il mio caso.»
Faccio una pausa, come per sottolineare le mie ultime parole, aspiro una boccata di fumo, la rigetto dal naso con aria riflessiva e compresa. Vladimiro si sostiene il viso con la mano sinistra e l’indice puntato verso l’estremità del sopracciglio sinistro che, in questo modo, risulta tirato molto in su; ma non apre bocca: aspetta.
Riprendo, spazzando via, con la mano, dal tavolo alcune briciole di cenere cadute dalla sigaretta: «Come avrai capito, si tratta di un organo che sarebbe eufemistico definire invadente. Per essere esatti, non mi lascia letteralmente vivere. Sì, proprio così: vivere. Io non chiederei di meglio che farmi, come si dice, i fatti miei, ma “lui” interviene. Continuamente. Mette il naso, praticamente, in tutto quello che faccio; si rende visibile nei momenti meno opportuni; tenta di forzarmi la mano; e, insomma, pretende da me un’ubbidienza che sono assolutamente risoluto a negargli.»
Pausa e silenzio. Vladimiro mi guarda con attenzione; ma non commenta. Ripiglio il mio discorso: «A questa invadenza, a questa, diciamolo pure, sua prepotenza, cosa posso opporre io? Chiaro: sia una prepotenza pari, o meglio superiore alla sua, sia, invece, la ragione. Questa seconda alternativa è la mia, Vladimiro, va da sé. Sono infatti un uomo di cultura, un intellettuale. Qualsiasi ricorso alla violenza mi ripugna. Così, fin da principio, con “lui”…»
«Chi è “lui”?»
«Il mio organo. Dicevo: così, fin da principio con “lui” ho adoperato la ragione. Discuto, cerco di ragionare, cercò di persuaderlo: tra me e “lui” è un continuo dialogo. O meglio, per essere precisi, un continuo battibecco.»
«Tu gli parli e… “lui” ti parla? Vuoi dirmi che tu veramente gli parli e “lui” veramente ti parla?»
«Sì, veramente. Che c’è di strano?»
«Uhm, nulla. Ma che… voce ha?»
«Dipende. Una voce, comunque, intonata al suo carattere. Il più delle volte insinuante, sussurrante, subdola, viscida. Ma in determinate circostanze, quando gli prende, anche aggressiva, violenta, perentoria.»
«Quando gli prende, eh!»
«Sì. Quando gli prende. Qualche volta, ma più raramente, può essere addirittura sinistra, truce. Se, però, siamo soli, io e “lui”, allora il suo tono più frequente è quello della vanagloria, della prosopopea.»
«Perché… è vanitoso?»
«Vanitoso è poco dire. Si crede assolutamente il più bello, il più forte, il più potente della sua, diciamo così, categoria. Secondo lui, nessuno, nel mondo intero, gli sta a pari. Un mostro di vanità!»
«Ma… parla di qualsiasi cosa? Oppure interviene soltanto per le cose del sesso?»
«Vladimiro, tu sai benissimo che non c’è nulla che non possa essere trattato in chiave sessuale. Letteratura, arte, scienza, politica, economia, storia, tutto può essere guardato da quel punto di vista lì. Non dico che non sia, alla fine, riduttivo. Dico che è una delle cose che si fanno. E “lui” lo fa, oh se lo fa!»
«Ma… per esempio…?»
«Per esempio: cosa c’è di meno sessuale di un paesaggio? Montagne, pianure, fiumi, vallate: dov’è il sesso? Eppure. L’altro giorno, per esempio, faccio una gita in campagna. La strada, a un certo punto, si infila tra due colline rotondeggianti, oblunghe, che via via si abbassano fino a diventare due rilievi abbastanza pronunziati. Ci crederesti? “Lui”, subito, prende a sussurarmi: “Non sono due colline, sono due gambe femminili e anche molto belle. Divaricate, spalancate. E la strada corre dritta verso la gola in cui si congiungono o meglio sembra che si congiungano. E adesso noi, con la nostra macchina, penetreremo con violenza, a 150 all’ora, nella gola” eccetera, eccetera. Vedi il doppio senso, no?»
«Lo vedo, infatti. Ma… in quali altri modi interviene nella tua vita?»
«Coi sogni, naturalmente.»
«Sogni erotici, eh?»
«Non voglio dilungarmi sui sogni, Vladimiro. Quello è il suo, diciamo così, regno. Quello che ci combina alla fine non mi riguarda e non mi interessa. Semmai vorrei esprimere un voto: che lasciasse stare i sogni realistici e si tenesse unicamente ai simbolici.»
«Realistici?»
«Non mi piace, per esempio, sognare che sono a letto con una donna di cui non vedo la faccia perché mi mostra le spalle. Poi la donna si volta e scopro che è mia madre. Preferisco di gran lunga sognare che salgo una scala e in cima alla scala c’è una casa con la porta aperta e io mi dirigo verso questa porta aperta, gradino dopo gradino, e magari la casa ha un aspetto lugubre, con tutte le finestre chiuse ed è circondata da cipressi, e proprio sul punto di varcare la soglia, qualcuno mi pugnala la schiena e io cado in terra e mi sveglio. Si capisce: quella casa dalla porta aperta è mia madre. L’aria lugubre della casa, è il mio senso di colpa. La pugnalata nella schiena, io stesso me la do, per impedirmi di commettere l’incesto e così via. Ma, Vladimiro, siamo pur sempre nel simbolismo, cioè nell’indiretto, nel mediato, nel rebus, nell’indovinello. S’intende, io posso decodificare il sogno, sciogliere il rebus; ma sono anche libero, liberissimo di prendere la rappresentazione simbolica alla lettera, senza ricercarne il significato. Ebbene, Vladimiro, io preferisco il simbolo alla realtà. Sognare una casa con la porta spalancata mi lascia indifferente. Mi dico: “Toh, che sogno strano, chissà cosa vorrà dire.” E poi non ci penso più. Invece sognare mia madre, proprio mia madre con la sua faccia, la sua espressione e tutto quanto, a letto con me, ammetterai che è piuttosto seccante. Ti svegli, ci ripensi e ci rimani male, magari, tutto il giorno. Ora, purtroppo, “lui” da qualche tempo ha quasi completamente abbandonato il simbolismo per il realismo. Non mi fa più sognare, per esempio, un orologio, noto simbolo del sesso femminile, come un tempo; mi presenta, invece, brutalmente, anche se in sogno, il sesso femminile vero e proprio, perfetto in tutti i suoi particolari, con la sua forma, il suo colore, magari i suoi movimenti, così com’è nella realtà della veglia. Ora l’orologio me lo dimenticavo appena sveglio; il sesso, no. E io lo so perché fa così, Vladimiro. Per dispetto. Già, perché, per motivi che sarebbe troppo lungo esporre, io e “lui”, da qualche tempo siamo in pessimi rapporti. Allora, “lui” si vendica in questo modo: abbandonando il simbolismo nel quale, notalo bene, è maestro, per un realismo o meglio naturalismo quanto mai rozzo e grossolano.»
Scuoto il capo, pensoso, deprecativo, meditabondo, guardando in basso e buttando fumo dalle narici. Vladimiro fa un gesto con la mano come per accantonare qualche cosa. «Dei sogni parleremo in seguito. Riprendiamo piuttosto la questione del dialogo. Dunque voi due discorrete tutto il tempo. Ma in che modo? Voglio dire: tu gli parli ad alta voce o che?»
«Soltanto quando sono solo e sono sicuro che nessuno ci ascolta. Già, perché si tratta di cose talvolta, come dire?, un po’ delicate. E allora è meglio prendere qualche precauzione.»
«Quando siete soli, dunque, tu gli parli ad alta voce. E lui cosa fa?»
«Mi risponde.»
«Anche lui ad alta voce?»
«Si capisce»
«Vuoi dire che tu lo senti come senti me in questo momento?»
«Certo.»
«Lo senti con le orecchie?»
«Scusa, Vladimiro, con che cosa vuoi che lo senta? Con il naso?»
«Questo, però, quando sei solo. E quando sei in compagnia? Anche in presenza di terzi parlate ad alta voce?»
«No, in presenza di terzi non parliamo ad alta voce. Parliamo mentalmente.»
«Mentalmente?»
«Sì, cioé io penso una cosa e “lui” ne pensa un’altra e così il dialogo o meglio il litigio fra me e “lui” continua lo stesso. Ma, in presenza di terzi, “lui” a dire il vero, più che dialogare o magari litigare, tende a comandare.»
«Comandare?»
«Sì. Poi, naturalmente, io sono più o meno libero di ubbidire. Ma “lui”, il tentativo di imporsi a me, lo fa sempre.»
«E cosa comanda?»
«Chiaro: di agire secondo i suoi desideri.»
«Per esempio?»
«Beh, mettiamo che ci sia un ricevimento in una villa, in questi giorni d’estate. Una bella ragazza accetta di passeggiare con me per i viali del giardino. “Lui” mi comanda subito di spingere la passeggiata fino ad una certa panchina. Poi mi comanda, una volta seduti, di portare la conversazione su certi argomenti. Quindi, mi comanda di accostarmi molto vicino alla ragazza. Finalmente, dopo qualche approccio preliminare, mi comanda di saltarle addosso.»
«Saltarle addosso?»
«Beh, sì, tirarle fuori un seno, ficcarle le mani sotto la gonna, sbatterla sull’erba, e roba simile.»
«Lui comanda. E tu?»
«Di solito, prima di tutto, cerco di convincerlo che non è il caso. “Gli” faccio osservare per esempio che la ragazza è fidanzata; che mi metterei nei guai; e così via. Niente, fiato sprecato, non mi dà retta. Va a finire che in un momento di debolezza gli cedo. Salto addosso alla ragazza e naturalmente vengo respinto e magari anche schiaffeggiato.»
«Sempre così finisce? Con uno schiaffo?»
«Spesso. Ma intendiamoci, Vladimiro. Non perché io non piaccio alle donne; ma perché “lui” non è affatto psicologo, intuitivo, insomma, diciamolo pure, intelligente; e così non capisce mai quando certe cose si possono fare e quando no. Non è mica un caso che nel linguaggio corrente “lui” sia spesso nominato come il simbolo di un certo particolare tipo di stupidità.»
«Quale specie di stupidità?»
«Beh direi la stupidità che si esprime nella presunzione e nella mancanza di tatto. Sapessi le brutte figure mi fa fare? Da farmi vergognare come un ladro! Da farmi desiderare di scomparire sotto terra!»
Scuoto il capo, pensoso e amaro ma pur sempre scientifico, cioè distaccato e obiettivo. Ho le mani sulla tavola, una delle mani stringe tra le dita la sigaretta; l’altra ha al medio un anello con un cammeo giallo che apparteneva a mio padre. Porto la mano con la sigaretta alla bocca, aspiro un po’ di fumo, tossisco, riprendo con voce seccata e severa: «Nel mio caso, poi, le brutte figure sono aggravate dal fatto che non sono un uomo tutto casa, moglie, bambini, famiglia e basta. Sono un professionista serio, noto e stimato, in un ambiente assai particolare, quello del cinema. Dico particolare perché l’ambiente cinematografico è piuttosto favorevole all’intraprendenza di individui senza scrupoli come “lui”. Centinaia, che dico? migliaia di donne sognano di lavorare nel cinema e cercano di farsi largo in tutti i modi, non escluso, appunto, quello di fare appello non già al giudizio professionale, alla considerazione tecnica, insomma alla ragione, ma direttamente, sfrontatamente, a “lui”.»
Sto zitto un momento, storcendo la bocca con disgusto, sotto lo sguardo attento di Vladimiro. Riprendo, d’improvviso: «E poi c’è la questione dell’indiscriminazione.»
«L’indiscriminazione?»
«Sì. Finora ho parlato di donne giovani a cui posso piacere o meno. Ho parlato di brutte figure. Ma la sua indiscriminazione si spinge molto oltre la brutta figura.»
«Oltre?»
«Sì, oltre. Gli piacciono tutte: le brutte come le belle, le giovani come le vecchie e purtroppo anche le giovanissime. Intendiamoci, Vladimiro, tutto questo rimane puramente teorico perché, dopo tutto, per agire, “lui” ha bisogno di me senza di me non può nulla. Non toglie, però, che qui si esce dal campo della normalità e si entra a vele spiegate nella psicopatologia e, magari, nella medicina legale. Trovare qualche cosa di eccitante nel corpo disfatto di una vecchia o in quello ancora asessuato di una bambina è infatti perversione bella e buona, almeno secondo me: dico bene?»
Vladimiro non risponde. Quel “dico bene?” rimane per aria, sospeso nel silenzio. Insisto: «Tu forse mi troverai troppo severo, troppo rigido. Ma io, su certe cose, non transigo. Assolutamente. E poi, lasciamelo dire, Vladimiro, quel che è troppo è troppo. La misura è colma.»
Vladimiro tace pur sempre, considerandomi fissamente ma come da lontano, quasi mi vedesse attraverso un cannocchiale rovesciato in fondo al quale la mia immagine gli appare piccolissima anche se nitida. Riprendo: «Beninteso “lui” si difende. Si giustifica. Non tanto, forse sul piano morale, perché, come avrai capito è assolutamente amorale, quanto sul piano, come dire?, storico-culturale. Ho detto che è stupido; ma non ho detto che è incolto. Naturalmente si tratta di una cultura raffazzonata, orecchiata, da autodidatta. Del resto dove troverebbe il tempo per dedicarsi agli studi, che richiedono, in ogni caso, una concentrazione di cui è assolutamente incapace? Ma, soprattutto, direi che la sua è una cultura specializzata. Sulle cose che lo riguardano, ha una discreta informazione. Delle altre non sa niente. Dunque… ma perché ho parlato della sua cultura?»
«A proposito dell’incriminazione.»
«Ah, sì, volevo dire che la sua indiscriminazione,“lui” la giustifica con argomenti culturali. Come ho detto, si tratta di nozioni più che altro storiche, pescate qua e là, senza metodo e senza rigore, col solo scopo, eminentemente pratico, di giustificarsi nei nostri battibecchi. E’ una cultura sui generis. Niente di profondo, niente di organico, niente di sistematico. Qualche frettolosa lettura di volgarizzazione sulle religioni primitive; qualche incursione nell’antropologia; qualche scorribanda nell’esoterismo orientale. Ma di tutto quanto, Vladimiro, un pizzico, non più che un pizzico. Non toglie che, con la consueta faccia tosta, “lui” domani, a difesa della propria indiscriminazione, ti scaricherà sulla testa, tutti in un mucchio, i nomi di non so quante divinità: da Siva a Priapo, da Mutunnus Tutunnus a Konsei Myojin, da Hermes a Subigus, da Baal-Peor a Min, da Osiride a Kunado, da Frey a Pertunda che, a suo dire, sarebbero state in passato, altrettante sue precedenti incarnazioni. Così l’indiscriminazione di oggi sarebbe l’universalità di ieri. E “lui”, oggi come ieri, sarebbe un dio, con una scala di valori tutta sua. D’altra parte la sua riduzione a semplice parte del corpo umano, per giunta indecente e vergognosa, andrebbe interpretata come una vendetta del suo maggiore rivale, il Dio cristiano. Vedi il punto? La megalomania? L’egocentrismo? E al tempo stesso la mania di persecuzione che va sempre insieme con la mania di grandezza? Un dio! Come se non bastasse, un dio perseguitato da un’altro dio, rivale invidioso e malvagio! Insomma, se non ci fosse stato il Cristo (continuo a citarlo), “lui”, almeno qui in Italia, sarebbe ancora sugli altari, oggetto di un vero e proprio culto, sotto il bel nomino di dio Fascinus.»
«Il dio Fascinus?»
«Sì, il dio Fascinus. E’ Il suo nome preferito. E’ anche quello che rivela il suo vero carattere, in fondo piccolo-borghese. Dico piccolo-borghese perché soltanto ad un professorucolo di scuole medie di provincia verrebbe in mente di nobilitare le proprie tendenze particolari con riferimenti classicheggianti. Fascinus. Dal latino “fascinum” cioè incantesimo. Vedi il punto? Capisci dove vuole andare a parare? Come dire: affascinante, fascinoso, che emana un fascino al quale è impossibile sottrarsi, cioè che agisce sugli uomini come un incantesimo, come una magia, come una stregoneria. Fascinus! In questo nome c’è tutta la sua vanità, la sua presunzione, nonché il suo pressapochismo, il suo orecchiantissimo culturale!»
Scuoto il capo, con deplorazione, con compatimento, con disprezzo. Ripiglio dopo un momento di silenzio: «Sai cosa gli rispondo quando mi tira fuori il suo Fascinus? Gli rispondo: “Altri tempi. Allora affascinavi, oggi disgusti, quando non fai ridere. Non c’è Fascinus che tenga, certe cose semplicemente non si fanno. non si debbono fare, e tutti i Fascinus della Roma antica non giustificano né tantomeno scusano l’erotomania da strapazzo nella Roma di oggi.” Ma lui ha la risposta pronta, questo bisogna riconoscerlo. Lo sai cosa risponde? “Altri tempi, che vuol dire altri tempi? Io sono fuori del tempo. Non esiste il tempo per me.” Canaglia, sì, quanto vuoi, ma ingegnoso, loico, sofista.»
«Ma sono sempre così erudite le vostre discussioni?»
«Magari! Per lo più invece ci ingiuriamo come due lavandaie. Ma, in fondo in fondo, ci accusiamo di stupidità. “Lui” dice che lo stupido sono io e io dico che lo stupido è “lui”. Secondo “lui” ragione è sinonimo di stupidità; secondo me… beh secondo me il contrario. In realtà, Vladimiro, parliamo un linguaggio diverso. Le parole hanno un senso per me e un altro per lui e così non ci comprendiamo. Già, perché la diversità delle parole adombra la diversità della scala dei valori. E allora come capirsi?»
«Ma questi vostri rapporti sono sempre stato così cattivi?»
Accenno di no con la testa, con l’aria contrita di chi riconosce, con onestà, una verità sgradevole: «No, un tempo, anzi, non posso negarlo, erano ottimi. Ma, Vladimiro, a quale prezzo per me! Al prezzo di una autentica schiavitù! “Lui” comandava ed io ubbidivo. Ero il suo succubo, il suo esecutore. Naturale che ad un certo punto mi sia ribellato.»
«Quanto tempo fa erano ottimi i vostri rapporti?»
«Bisogna risalire ai tempi della mia prima adolescenza. Mettiamo che avessi quattordici anni. Allora mi identificavo così completamente con “lui” che ho provato il bisogno, diciamo così, istintivo, ad un certo momento, di differenziarmi da “lui” almeno verbalmente, dandogli un nome.»
«Un nome?»
«Sì, se non altro per evitare confusioni quando “lui” ed io parlavamo, o meglio quando “lui” comandava ed io ubbidivo. Te lo immagini tu un dialogo così fatto: ‘Federico devi fare questo e quest’altro.’ ‘Sì, Federico, lo faccio subito.’ Vedi il punto? Federico io, Federico lui. Così ho deciso, per quanto lo riguardava, di latinizzare il nome.»
«Fascinus?»
«No, sarebbe stato come riconoscere che “lui” mi aveva incantato, affascinato. Ero succubo, è vero, ma già mi sentivo un poco ribelle. No, siccome io mi chiamo Federico ho pensato di chiamarlo Federicus Rex.»
«Federicus Rex?»
«A dire il vero in un primo momento avevo pensato di chiamarlo Federico il Grande.»
«Perché Federico il Grande?»
«E’ tutta una storia. Un giorno d’estate, a Ostia, dopo aver mangiato i soliti panini, verso le due, stavamo riuniti, tre o quattro ragazzi della stessa età, all’ombra, distesi su quella sabbia piena di detriti che di trova dietro alle cabine. Naturalmente si parlava di donne, qualcuno aveva già fatto l’esperienza, qualcun altro no; ad un certo punto, che è che non è, uno ha lanciato l’idea: ‘Vediamo chi ce l’ha più grande.’ Detto e fatto. Allora, con stupore, perché era la prima volta che mi succedeva di fare certi paragoni, mi accorgo che li batto, è proprio il caso di dirlo, tutti quanti di parecchie lunghezze. Erano tutti miei amici, compagni di scuola; così, venne fatto a qualcuno, molto naturalmente, per scherzo, di chiamarmi ‘Federico, il Grande.’ Ragazzate, anzi, ragazzinate.»
«Ma come mai sei passato da Federico il Grande a Federicus Rex?»
«Questa è ancora un’altra storia. Come sai, io allora abitavo con mia madre dalle parti di piazza Mazzini. Una notte passavo per una strada solitaria, mia madre mi aveva dato i soldi per andare al cinema del quartiere, ci correvo in gran fretta perché ci avevo un appuntamento con un amico. Ed ecco, proprio sul punto più scuro di questa strada, all’ombra di certi alberi che sporgevano da un giardino, una voce mi chiama: ‘Ehi, ragazzo.’ Mi sono fermato, mi sono avvicinato; era una prostituta piuttosto anziana, ma niente male, o almeno così mi è sembrato; non bisogna dimenticare che avevo quattordici anni e portavo da poco i pantaloni lunghi. Non ricordo troppo bene cosa ci siamo detti. Ricordo soltanto che tremavo per tutto il corpo perché era la prima volta, e lei se ne accorta, e mi ha detto: “Perché tremi così? Sta’ calmo. Dimmi piuttosto se hai la grana.” Non ho capito e lei, allora, mi ha spiegato che la grana voleva dire i soldi. Non ho detto nulla, ho aperto la mano per mostrargli il biglietto da mille lire che mia madre mi aveva dato per il cinema, già tutto spiegazzato e fradicio di sudore. Lei ha detto: “Sono pochini.” Ho risposto: “Mi serrvono per andare al cinema.” Lei si è messa a ridere, allora, e ha detto: “Beh, da’ qui. Adesso te lo faccio vedere io il cinema. Scommetto che è la prima volta, non è vero? Ma non tremare, vedrai quanto è bello il cinema.” E così si è presa il denaro e mi ha fatto fare l’amore in piedi, nell’ombra fitta di quegli alberi, stringendosi verso di me. Ora, appena quella donna ha visto “lui”, lo sai che ha detto? ‘Ma questo è il re.’ Io continuavo a tremare; e lei allora ha insistito: ‘Ma di che hai paura? Ci hai il re, i re non hanno paura di nessuno.’ Lì per lì non ci ho fatto caso, poi me ne sono ricordato; e, siccome mia madre, in una scatola, aveva alcune monete antiche tra le quali una di Federico di Prussia, con la scritta ‘Federicus Rex’, l’ho chiamato così, col nome latino.»
Vladimiro mi guarda e pare riflettere. Finalmente dice: «Va bene, gli hai dato un nome. Ma quand’è che hai cominciato a litigare con “lui”? Come mi sembra di capire, quando gli hai dato il nome di Federicus Rex, andavate ancora d’accordo.»
«Vuoi sapere quando mi sono veramente ribellato?»
«Sì. Quando e perché.»
Lo guardo e poi, grave e compreso, accenno affermativamente con il capo: «Ti dirò, mi aspettavo questa domanda. Me l’aspettavo tanto che mi sono preparato a rispondere in maniera esauriente e scientifica. Del resto, oggi, praticamente, sono venuto da te soprattutto per farmi muovere questa domanda e per risponderti. Tu mi comprendi, Vladimiro.»
Sto zitto un momento come per sottolineare l’importanza di ciò che sto per dire; quindi riprendo: «non soltanto ricordo l’anno in cui io e “lui” abbiamo cominciato a litigare, ma anche il mese se non proprio il giorno: marzo del 1950. Siamo nel 1970. Ho trentacinque anni. Sono dunque passati esattamente vent’anni da quando mi sono ribellato a “lui”.
«E quale è stato il motivo… della ribellione?»
«Ci vengo. Diciamo: una divergenza di opinione.»
«Di opinione? E su che cosa?»
«Su quello che è avvenuto veramente una certa notte di quel marzo del 1950.»
«Quella notte è avvenuto qualche cosa?»
«Secondo “lui”, sì. Secondo me, no.»
Vladimiro mi guarda e, questa volta, forse rendendosi conto che siamo giunti al punto centrale della nostra conversazione, tace con aria addirittura atterrita. Aspiro una lunga, abbondante boccata di fumo e poi la rigetto verso il piano lucido della tavola. Riprendo: «Debbo premettere Vladimiro che io allora ignoravo di essere il suo succubo E’ vero, sessualmente, ero molto precoce ma non sapevo che questa precocità la dovevo a “lui”. D’altra parte, non avendo ancora avuto un rapporto carnale con una donna, voglio dire un vero rapporto, non una cosa frettolosa, parziale e furtiva come quella che ti ho raccontata, non potevo fare a meno di pensarci continuamente. Era il mio pensiero dominante, o meglio, Vladimiro, sarebbe più esatto dire: la mia ossessione. Sì, Vladimiro: ossessione. Certo avrei potuto sfogarmi da solo come tutti i ragazzi da che mondo è mondo; ma vi ero contrario, non so perché, forse per orgoglio. Di qui una continua, acuta, insopportabile sofferenza.»
«Soffrivi?»
«Sì, indicibilmente, di desiderio. Vedi, Vladimiro, il desiderio è ciò che fa più soffrire. Ora, di solito, di fronte al desiderio noi ci comportiamo in due modi: o cerchiamo di non pensarci oppure lo soddisfiamo. Ma un desiderio che si prolunghi inalterato e senza soddisfazione oltre un certo limite di tempo, non lo sopportiamo. Io, Vladimiro, arriverei persino ad affermare che come non si resiste a certe temperature più di alcuni minuti, così non si può resistere al desiderio più di qualche ora. Ora te lo immagini tu un desiderio che non dura qualche ora, né qualche giorno, né qualche mese, ma anni, e sempre con la stessa intensità? Se te lo immagini, potrei farti un’idea di quanto io soffrivo.»
Sto zitto, scuotendo il capo. Vladimiro sta zitto anche lui. Quindi arrischia, cautamente: «E la divergenza di opinione?»
«Eccola. Una certa mattina di quel marzo del 1950 io ho pensato, molto ragionevolmente, che una certa cosa non era realmente avvenuta, ma me l’ero sognata. Che si fa coi sogni? Ci si pensa un poco su, si cerca per un poco di ricostruirli, di ricordarli e poi si alzano le spalle e si accantona per sempre il sogno per occuparsi di altre cose più importanti. Così stava per succedere anche quella certa mattina. Senonché, “lui”, rivelandosi, sia detto tra parentesi, per la prima volta come qualcuno distinto e diverso da me, “lui” salta su di improvviso dicendomi alto e forte che quella certa cosa io non me l’ero affatto sognata, bensì era veramente accaduta e che “lui” era lì per testimoniare, appunto, che era accaduta nella realtà e non nel sogno. Sì, Vladimiro, questa è stata la divergenza di opinione di quella mattina fatale. E da allora io e “lui” non abbiamo più cessato di litigare. Vent’anni di litigi. “Lui” continua a sostenere che la cosa è successa realmente; io persisto a rispondergli che è stato un sogno.»
«Ma qual era la cosa che, secondo te, era stato un sogno e secondo “lui” un fatto realmente accaduto?»
Assumo il mio tono più scientifico perché so di certo che in questo momento Vladimiro tiene appuntate su di me tutte le batterie della sua scienza, allo stesso modo che, all’inizio della visita, mi ha sbattuto in faccia la luce della sua lampada di alto potenziale: «Devi sapere, Vladimiro, che mia madre aveva l’abitudine, ancora nel 1950, di venire ogni sera, prima di coricarsi, a darmi il bacio della buona notte. Lo faceva da quando ero bambino. Una abitudine, del resto comune a molte madri. Ma, altolà, che fai?»
«Prendo qualche nota.
«Tu neanche per sogno. Niente note. Butta via quel taccuino e quella biro. Non voglio note. Quello che sto per dirti, oltre tutto, non è degno di essere annotato. Una semplice divergenza di opinioni, su un fatto, a ben guardare, poco importante: che c’è da annotare? E, poi, Vladimiro io non sono qui come paziente; sono qui come amico. Che ne diresti tu, se, puta caso, tu venissi a farmi una confidenza, a chiedermi un consiglio e mi vedessi scribacchiare mentre parli. Via il taccuino, via la biro. Parliamo.»
«Sì, Rico, parliamo.»
«Bravo. Dunque, dove eravamo?… Ah, già, al fatto che mia madre, ogni notte, ancora nel 1950, come tante madri del resto, veniva a darmi il bacio della buona notte. Mia madre entrava, per lo più verso mezzanotte, qualche volta anche più tardi, mi rincalzava le coperte, si chinava, mi dava un bacio in fronte dicendomi: “Dormi bene”, e se ne andava. Devi notare che il mio letto era in un angolo, con tutto un lato contro la parete, di modo che mia madre, quando mi rincalzava le coperte doveva o rincalzarle da una parte sola, oppure, piegarsi attraverso il letto per rincalzarle anche sull’altro lato. Qualche volta tutto questo avveniva in piena luce; io stavo ancora leggendo o magari studiando (avevo l’abitudine di studiare a letto) e allora era mia madre a spegnere la luce; qualche volta, invece, io avevo già spento la luce anche se non ero ancora addormentato. Ma, comunque, con o senza luce, niente di strano, niente di anormale, niente, diciamolo pure, Vladimiro, di interessante. Una madre che augura la buona notte al figlio: punto e basta.»
Vladimiro non dice nulla. Il taccuino e la penna gli stanno davanti, accanto alla mano destra, una mano magra e lunga come lui; ma la mano non si muove. Rimango zitto un momento e allora Vladimiro fa una smorfia come di dolore. Domanda finalmente con sforzo: «Ma… e la divergenza di opinione?»
«Vengo al punto. Io adesso ti esporrò le due versioni di questo fatto del bacio di mia madre, la mia e la “sua”. Prima la mia e poi la “sua”.»
«Vuoi dire prima la cosa come sogno e poi la cosa come evento realmente accaduto?»
«Esatto. Dunque, versione numero uno: la mia, quella del sogno. Mia madre viene a darmi la buona notte. Io ho già spento la lampada ma sono sveglio. Mia madre entra senza accendere le luci, si avvicina al letto, si china su di me, mi rincalza le coperte, prima da una parte poi dall’altra. Per far questo, naturalmente, è costretta a chinarsi su di me. Chinandosi, mi sfiora involontariamente con il gomito all’altezza del ventre. Mia madre, per qualche motivo che non comprendo, non riesce ad incalzare troppo bene la coperta e così lo sfioramento del gomito si tramuta in pressione, e questa pressione si direbbe che sia voluta, consapevole, intenzionale. Vorrei dirle: “Mamma sta’ attenta a quello che fai, potrebbe accadere qualche cosa di irreparabile, rialzati, te ne prego, rialzati e vattene”; ma, come avviene appunto nei sogni, non riesco a parlare. Intanto lei continua a star chinata, continua a rincalzare la coperta e il gomito a premere. Finalmente succede quello che temevo. Nello stesso momento mi sveglio e mi accorgo che ho avuto una polluzione notturna. Questa è la mia versione.»
Vedo un momento il racconto e ne approfitto per schiacciare la cicca nel portacenere e accendere un’altra sigaretta.
Gesti calmi, precisi, esatti. Tutto freddo, tutto scientifico.
Riprendo: «Versione numero due. Quella di “lui”, secondo la quale l’evento si sarebbe realmente verificato. Mia madre entra nel buio, io sono sveglio e, al solito, sto soffrendo per il desiderio. Mia madre si avvicina al letto, si china su di me mi rincalza le coperte prima da una parte e poi dall’altra. Per far questo, naturalmente, è costretta a chinarsi su di me e, chinandosi, esattamente come nel sogno, mi sfiora senza volerlo con il gomito all’altezza del ventre. A questo punto le due versioni divergono. Secondo “lui”, mia madre avverte la mia, chiamiamola così, sofferenza, si rialza senza finire di rincalzare le coperte, mi passa una mano sulla fronte, sente che brucia, mi domanda sottovoce come sto. Io rispondo che sto bene; ma, a quanto pare, almeno secondo “lui”, emetto un sospiro. Mia madre mi dice sottovoce: “Cerca di dormire, è tardi”; poi si china di nuovo attraverso il letto, come per rincalzarmi definitivamente le coperte sul lato contro la parete. Ma il suo gomito preme con forza, muovendosi, nello stesso tempo, in su e in giù con frettolosa, sbrigativa, affannata violenza. Finché, nel giro di pochi secondi, ottiene l’effetto che puoi immaginare. Il gomito si immobilizza, allora, duramente appoggiato, come per darmi il tempo di riavermi. Quindi mia madre un po’ ansimante ma pur sempre silenziosa, si rialza, mi dà il solito bacio in fronte e se ne va. Fine della seconda versione.»Segue un lungo silenzio. Sto a testa china e fumo silenziosamente, come per dar tempo a Vladimiro di radunare le idee. Finalmente commento: «Naturalmente, questa seconda versione, è tutta falsa, tutta inventata, tutta fantastica. Non toglie che “lui” la sostenga a spada tratta, inflessibilmente, da vent’anni. Adesso capirai perché ho detto che la mia vita, da vent’anni, è avvelenata da una divergenza di opinione tra me e “lui”.»
Silenzio. Osservo ancora con amarezza: «Ma già lo leggo nei tuoi occhi, tu, Vladimiro, sei inclinato a credere più a “lui” che a me.»
Vladimiro trasalisce profondamente come destandosi dal sonno e risponde in fretta: «Per niente, Io credo a te. E poi, a chi dovrei credere, se non a te? Qui, davanti a me, non ci sei che tu.»
«Giusto. Ora tornando alla divergenza di opinione, ti puoi facilmente immaginare, Vladimiro, il turbamento che ha provocato nel mio animo l’insinuazione inqualificabile del solito subdolo e malvagio individuo. Naturale che, sapendomi innocente, io abbia sviluppato un forte senso di colpa. Alla fine, mi sono veduto costretto a mitigare il senso di colpa con una spiegazione, diciamo così, razionale e, in un certo modo, scientifica, la quale si può riassumere in questo modo: “Sì, io sono convinto che è stato un sogno. Un sogno, naturalmente, ispirato da “lui”. Ma anche se, per assurdo, dovresti ammettere che non è stato un sogno ma un evento reale, ebbene anche in questo caso improbabile, io non c’entro, né tanto né poco. E’ stata insomma, una cosa tra “lui” e mia madre, non voluta né tanto meno approvata da me. Io non ho fatto che assistere. Perciò la cosa non mi riguarda e non voglio saperne nulla.” Che ne pensi, Vladimiro, di questa spiegazione? Non taglia forse, come si è soliti dire, la testa al toro?»
Vladimiro non mi approva né mi disapprova. Si torce sulla seggiola. Contrae tutta la faccia in una smorfia di intenso disagio. Alla fine riesce a dire: «Ma lui, quali prove adduce a favore della sua versione?»
Rispondo scioltamente: «Due prove, una fattuale e l’altra psicologica. Prova fattuale: mia madre, dopo quella sera, ha cessato del tutto di venire ad augurarmi la buona notte. Prova psicologica: il senso di colpa, secondo “lui”, sarebbe in me così forte da farmi addirittura inventare un sogno che non ho mai sognato pur di non riconoscere che le cose che pretenderei di aver sognato sono invece avvenute nella realtà della veglia.
Vladimiro non dà a vedere alcun sentimento; col solito sistema, già accennato, di mostrarsi ansioso, perplesso, afflitto né più né meno di quanto lo sia stato durante tutta la mia visita. Dice, finalmente, a fior di labbra: «La prova, diciamo così, fattuale ha un certo peso.»
«Ma quando mai! Sì, mia madre dopo quella notte non è più venuta a darmi il bacio in fronte. Ma non perché quella cosa sia veramente accaduta. Perché avendomi sfiorato senza volerlo il ventre col gomito, ed essendosi accorta del mio turbamento, ha temuto che un giorno o l’altro potesse accadere. Vedi il punto?»
Una volta Vladimiro non si pronuncia. Domanda: «E poi?»
«E poi cosa?»
«E poi cosa è avvenuto?»
«Niente. Te l’ho già detto. Vent’anni di litigi, durante i quali “lui” ha mantenuto la sua versione e io la mia.»
«Ma dopo quella notte, come è stata la tua vita?»
«La mia vita? E’ stata come prima, non è cambiata.»
«No, voglio dire: la tua vita interiore.»
«Ah, la mia vita interiore? Beh, non tanto felice. Mettiti nei miei panni, Vladimiro. Volevo bene a mia madre. Questo bene adesso mi veniva avvelenato da un individuo, a dir poco estraneo, per motivi tutti “suoi” che non mi riguardavano in alcun modo. A dirla breve: vent’anni di inferno. Per fortuna, di lì a sei anni, nel 1956, mia madre è morta.»
«Tua madre è morta?»
«Sì, purtroppo, è morta.»
Mi colpisce il fatto che Vladimiro si faccia ripetere due volte la notizia della morte di mia madre. E’ vero, è stato appunto verso il 1956 che Vladimiro ed io, ormai ventenni, ci siamo separati, siamo andati ciascuno per la propria strada. Questo non toglie, però, che Vladimiro dovrebbe saperlo che mia madre è morta. Lo guardo, mi guarda di rimando, con la sua solita inespressiva anche se dolorosa perplessità. Poi dice dolcemente ma fermamente: «S’intende, Rico che tua madre non è morta.»
Sento di arrossire. Sento di sprofondare. Dove? Nel pozzo tenebroso della più insondabile desublimazione. E’ vero, infatti: mia madre non è morta. E’ viva, vivissima, e io mi domando perché mai mi è venuto in mente di dire che è morta. Segue un lungo silenzio. Vladimiro mi guarda, fisso; e io guardo Vladimiro. Poi, d’improvviso, assurdamente, mi prendo la faccia tra le mani e scoppio in singhiozzi. Che mi succede? Semplice: uno dei soliti perfidi sgambetti della desublimazione. Mi rendo conto, con acuta consapevolezza, che questo pianto inopinato manda per aria, irreparabilmente, il tono distaccato, scientifico con il quale avevo contato di fronteggiare la scienza di Vladimiro; ma non c’è niente da fare. Senza pudore, senza ritegno, senza freni, mi abbandono ad un dolore oscuro quanto cretino. Singhiozzo, la faccia tra le mani, di fronte a Vladimiro impassibile, che immagino, pur tra i singhiozzi, intimamente gongolante per il mio capitombolo emotivo. Finalmente, come certi effimeri anche se abbondanti acquazzoni di primavera, il pianto si dirada, cessa. Cavo di tasca il fazzoletto, mi asciugo gli occhi, mi soffio rumorosamente il naso. Dico seccamente: «Scusami.»
Vladimiro non risponde nulla. Riprendo dopo un minuto di silenzio: «Io lo so cosa stai pensando in questo momento.»
«Che cosa?»
«Che la mia salute non è… in perfetta condizione».
Con una sollecitudine un po’ sospetta, Vladimiro si affretta a rassicurarmi: «No, per niente. Tutto normale. La sola cosa, semmai, sulla quale farei qualche riserva, è il tuo dialogo con “lui”, Federicus Rex. Possibilmente, tu dovresti fare in modo che questo dialogo cessi.»
Rispondo acceso di repentino entusiasmo: «E’ proprio questo che cerco di fare tutto il tempo: metterlo a tacere, ridurlo al completo. Ma c’è una sola maniera per toglierlo di mezzo: sublimare la pulsione sessuale che, per il momento, “lui” confisca arbitrariamente per “suo” esclusivo uso e consumo. Finché non avvierò seriamente il processo di sublimazione, finché sarò un desublimato, quello che tu chiami il dialogo tra me e “lui” ho molta paura che non potrà non continuare.»
Strano, questi termini pur così canonici della sua scienza, non sembrano fare alcuna impressione a Vladimiro. O meglio, si direbbe che gli ispirano addirittura fastidio, preoccupazione, forse angoscia. Si torce sulla seggiola, si agita, osserva alla fine: «Non sarebbe meglio che tu prendessi la cosa un po’ più semplicemente?»
«E come?»
«Beh, sostituendo questi vostri dialoghi, diamo pure, immaginari con conversazioni vere e proprie con altre persone. Voglio dire persone reali della tua vita.»
«Ma anche “lui” è una persona reale, Vladimiro. Se non capisci questo, scusami, non capisci nulla.»
«E soprattutto dovresti dedicarti al tuo lavoro, alla carriera.»
«Qui sono d’accordo con te. Senza meno. E’ proprio questo, del resto, che finora mi sono affannato a dire. Sì, bisogna che “lui” collabori ad un piano sistematico di sublimazione. Una volta ottenuta la sua collaborazione, sono a posto.»
Sfrego le mani l’una contro l’altra, come a significare che, appena “lui” collaborerà, non ci saranno più problemi. Ma Vladimiro scuote il capo, poco persuaso: «No, vedi, tu continui a parlare di “lui”. E invece, dovresti fare come se non esistesse.»
«Ma esiste. Purtroppo esiste.»
«Va bene, esiste. Ma intanto sarebbe già molto che tu chiamassi le cose col loro nome.»
«E non le chiamo col loro nome?»
«No, vedi, Rico, voglio dire il loro nome corrente. Lascia stare la sublimazione, la desublimazione, dimentica di essere un intellettuale che ha letto Freud, immagina di essere, che so io? il garzone del fornaio.»
Rimango male e borbotto: «Siete bravi, voialtri: inventate certe parole e poi vorreste che non se ne facesse uso.»
«Sono termini scientifici che, in tutti i casi, vanno adoperati con misura.»
«Ma quale misura? Come si può essere misurati in questioni, come queste, di vita o di morte?»
«Dove sta la vita e la morte nella tua questione?»
Tutto ad un tratto, mi infurio e urlo, battendo un pugno sulla tavola: «La vita per me è sublimazione, la morte desublimazione. Se sublimerò, vivrò, cioè sarò un uomo degno di questo nome. Altrimenti, morirò alla mia umanità. Sarò un desublimato, cioè un disgraziato, un inferiore, un incapace, un impotente, tutto sesso e niente creazione. Farò parte, irrimediabilmente, della razza inferiore, soggetta, che esiste in tutto il mondo, nei paesi ricchi come nei poveri, e non è caratterizzata dal colore della pelle o dai tratti somatici, ma dalla congenita incapacità di sublimare.»
Mi tiro indietro, rosso e ansimante, afferro a caso il pacchetto delle sigarette e poi lo butto via, accorgendomi che, mentre facevo la mia sfuriata, ho posato sull’orlo del portacenere la sigaretta appena accesa. Vladimiro non pare affatto sconcertato dalla mia scenata. Impassibile e doloroso, si limita a guardarmi. Appena mi vede un po’ calmo, domanda: «Che cosa hai fatto finora… per essere un uomo?»
Vorrei riprendere il tono distaccato, scientifico dell’inizio della visita. Ma ci riesco soltanto in parte, lo sento. Rispondo enumerando con le dita, ma tuttora trafelato e ansimante: «Primo: mi sono separato da mia moglie. Abito per conto mio in un appartamento che ho preso in affitto per un anno. Secondo: in questo appartamento non entrano né entreranno donne. Queste due misure, separazione e castità, sono misure, diciamo così, negative. Sul piano, invece, positivo, posso già vantare due successi. Primo: sto per fare la regia di un film di grande importanza. Secondo: amo una donna di eccezionale bellezza e intelligenza e ne sono riamato. Non posso non ravvisare, Vladimiro, un rapporto, un nesso, una relazione, insomma, tra la separazione e la castità da una parte e la regia è l’amore dall’altro. Forse non è ancora proprio la sublimazione; ma poco ci manca. Girerò il film, amerò, e allora vedrò se c’è stata realmente sublimazione o meno.»

Antonia Santilli e Lando Buzzanca in una scena del film
Il capitolo termina, naturalmente, con l’invito da parte da parte di Vladimiro di un percorso psicoanalitico che Rico, altrettanto normalmente rifiuta: primo, perché vede nello psicoanalista suo amico un desublimato (non ha fatto i soldi, ha lo studio in casa propria senza infermiera e quindi non è riuscito a sublimarsi nel lavoro che lo avrebbe reso un famoso e ricco analista); secondo: si rende conto di esser solo e il dialogo con “lui” non vuole né desidera cessarlo. (Viene in mente un altro grande autore novecentesco certamente presente a Moravia stesso, Svevo, con cui il protagonista Zeno condivide con Rino lo stesso problema individuato dai rispettivi analisti: il complesso d’Edipo).
Rimaniamo dunque all’interno del tema moraviano: il doppio. In questo romanzo il doppio fra istinto e ragione viene piegato freudianamente con il concetto di sublimazione e desublimazione, cioè con l’ “essere sopra” e l’ “essere sotto”, con il successo o l’insuccesso. Ciò fa del duplice Rico, un altro fratello di Riccardo de Il disprezzo, Silvio de L’amore coniugale, Dino de La noia, Francesco de L’attenzione: tutti intellettuali che non riuscono a dar forma alla propria creazione artistica.
Il tema del doppio, come ci dice lo stesso Moravia, che esplicita il suo riferimento, per Io e lui, a Dostoevskij de Il sosia, si arricchisce qui con il tema erotico che deriva da I gioielli indiscreti di Diderot, e soprattutto dalla riflessione sul sesso che in quel tornio di anni diventa culturalmente centrale: si pensi ai film di Bertolucci L’ultimo tango a Parigi e alla Trilogia della vita di Pier Paolo Pasolini. Questa tema non è mai mancato in Moravia, sin dai tempi de Gli indifferenti e soprattutto di Agostino, ma non era stato mai così evidente tanto da sfiorare la pornografia. Per questo tema Moravia afferma: “Il realtà il tema dell’erotismo non è propriamente dominante nel mio lavoro, ma appare solo come una variazione del tema principale che è quello del rapporto con la realtà. E’ abbastanza ovvio che la possibilità o meno dell’azione determina uno spostamento di questa problematica sul piano erotico. L’erotismo è quindi solo un’altra forma di azione, spesso addirittura l’ultima risorsa possibile. (…) In effetti, è probabilmente l’unica forma di attività giustificata in sé; o siamo “erotici” o non lo siamo (Moravia – Duflot, 1970).
L’erotismo si sposa, nel romanzo, con la liberazione sessuale prodotta negli anni della contestazione giovanile della fine degli anni Sessanta. Nel romanzo a Rico viene affidata la sceneggiatura di un film, L’espropriazione commissionatagli da un gruppo “rivoluzionario” capeggiato da un tal Maurizio. Ma tale sceneggiatura appare troppo borghese, per questo Rico accetta di confrontarsi con un gruppo di studenti al fine di correggerla:

CONTESTATO!
Ma eccoci a Fregene. Nella notte estiva, alla luce di rari fanali, la pineta coi suoi tronchi inclinati qua e là, sembra scompigliata da una recente tempesta. Svoltiamo, prendiamo per un viale diritto, fiancheggiato di giardini. Attraverso i cancelli si intravedono le facciate delle ville. Alcune sono illuminate: sotto i portici, si vede gente che siede sulle seggiole a sdraio, conversando, mentre camerieri in giacca bianca girano coi vassoi delle bevande. Sulla ghiaia dei viali, i bambini, a quest’ora già a letto, hanno abbandonato grandi palloni a spicchi colorati, tricicli verniciati di rosso e di giallo. Ecco, in fondo al viale, due file di automobili parcheggiate contro i marciapiedi. Maurizio rallenta e si ferma. Domando, scendendo: «E’ qui?»
«Sì, è qui.»
Maurizio mi precede, varca il cancello, si inoltra lentamente, le mani in tasca, per un viale in fondo al quale scorgo la villa, una costruzione bassa, di mattoni rossi, di un piano solo. Camminiamo sulla ghiaia pulita, tra aiuole di un verde brillante, stridulmente illuminate da lampade dissimulate nelle siepi di bosso. Sotto il porticato, siede qualcuno che, come entriamo nel giardino, si alza e ci viene incontro. E’ Flavia, la fidanzata di Maurizio. Mentre si avvicina, faccio in tempo a guardarla. Ha la faccia lunga, bianca e cavallina, sotto una gonfia capigliatura rossa. Mi colpiscono gli occhi, grandi e smorti, di un blu opaco che spicca nella bianchezza fantomatica del volto. Cammina dinoccolata, muovendo le lunghe gambe con forse voluta goffaggine mondana. Un vestitino sbilenco, dalla cui scollatura si erge, diritto, il collo, si gonfia, poco al disopra della vita, come per un grosso pacco. Un altro rigonfio, simile anch’esso a quello di un pacco voluminoso, le solleva la veste in fondo alla schiena. Eccola, ormai, per così dire, in primo piano: ha proprio occhi e pallore da fantasma; e, sulle guance, sul collo, sul petto, sulle braccia, sulle gambe, una tempesta di efelidi rosse. Dice, con voce anch’essa, come le movenze, affettata e piena di sottolineature mondane: «Siete dei veri lentoni. Il gruppo è al completo da un pezzo. Scalpitano e protestano. Ma si può sapere cosa avete fatto?» Maurizio dice: «II traffico. Questo è Rico.»
«Come stai?»
Flavia mi siringe la mano in una maniera curiosa: mollemente e sensualmente; ma, proprio quando pare che la stretta stia per trasformarsi in carezza, le dita si aprono e la mia mano cade nel vuoto. Le dico: «Sono molto contento di incontrare il vostro gruppo. Sono sicuro che il dibattito sarà molto interessante. Sarà un incontro tra due generazioni. Questi incontri sono molto utili, si dovrebbero fare più spesso. Peccato soltanto non averlo saputo prima. Avrei buttato giù qualche appunto.» Flavia ha una risatina ben educata che soffoca sotto la bianca mano lentigginosa. Dice ambiguamente: «Anche senza appunti sono sicura che il dibattito andrà benissimo.»
Mi cammina accanto, dinoccolata, affabile e insieme un po’ altezzosa, come per una abitudine inconscia di ripudiati snobismi. Intanto “lui”, evidentemente impressionato dall’avvenenza di Flavia, sussurra le solite assurdità: «Fingi di fare un passo falso sulla ghiaia e urtale il fianco, un po’ di traverso, in modo che si renda conto della mia esistenza, della mia ammirazione, del mio desiderio.»
Insopportabile individuo! Farmi questi discorsi proprio adesso che sono finalmente in procinto di essere presentato al gruppo! Col rischio di dare a Flavia un’idea errata di me e di rovinare ogni cosa! Naturalmente, mi guardo bene dall’ascoltare i suoi suggerimenti. Dico, invece, tutto allegro a Maurizio: «Ti sono grato per questo incontro con il gruppo. Ho dato cinque milioni ma non me ne pento affatto, Ci sono delle esperienze che non si pagano mai abbastanza.»
Maurizio risponde: «Hai ragione.»
Flavia ci precede in casa. Passiamo per il porticato, entriamo per una portafinestra nel soggiorno, e ci troviamo di colpo dietro una tavola, di fronte a tre file di seggiole occupate da una trentina tra ragazzi e ragazze: il gruppo. Il soggiorno è lungo e stretto, con il soffitto basso; i mobili sono stati tolti per far posto alle seggiole; dell’arredamento non rimangono che le decorazioni di tipo marinaro consuete in simili dimore balneari: fiocine, salvagenti, timoni, reti, nasse, polene, gusci di tartaruga, qua e là appesi alle pareti. Sulla tavola, ricoperta da un tappeto rosso, ci sono un microfono, una bottiglia d’acqua e due bicchieri. A sinistra della tavola, sospeso per aria, vedo qualche cosa che mi sorprende: un vero e proprio semaforo, con tre luci, verde, rossa e gialla, in tutto simile a quelli dei crocicchi stradali, anche se più piccolo. Seguo con gli occhi il filo del semaforo. Corre lungo la parete di sinistra e poi discende all’estremità opposta della sala fino ad un tavolino sul quale sta una scatola nera con un quadrante pieno di bottoni. Un ragazzo siede a questo tavolino, davanti alla scatola.
Domando sottovoce a Flavia: «A che serve il semaforo?»
«A regolare gli interventi.»
Guardo alla sala. Sono tutti ragazzi e ragazze, come si dice, di buona famiglia; anche se non tutti, necessariamente, di famiglie così ricche come quelle di Maurizio e di Flavia. Magliette, scialli, golfini, ponchi e pantaloni di tela, di velluto e di lana dai colori squillanti: sandali e scarpe di fogge insolite; parecchie barbe e numerose chiome lunghe; ma, a contrasto con tanta vivacità nei vestiti e nelle acconciature, una singolare, imprevista, sorniona compostezza negli atteggiamenti. Mi sento guardato, osservato, valutato, soppesato, giudicato. Poi, d’improvviso, mentre mi sto ancora domandando cosa significa questa accoglienza, ecco sento lo scatto del semaforo sopra la mia testa. Alzo gli occhi e vedo che si è accesa la luce gialla. Nello stesso tempo, con evidente rapporto come di causa e di effetto, tutti i ragazzi si levano in piedi e applaudono. L’applauso non sembra, però, spontaneo. I ragazzi battono le mani con una unanimità e un ritmo troppo regolari per non essere studiati. Quanto dura l’applauso? Forse un minuto. In tutti i casi ho l’impressione che duri molto, troppo, per essere un applauso sincero, dovuto al solo sentimento. Poiché immagino che applaudono me, mi sento imbarazzato e mi sforzo di nascondere l’imbarazzo applaudendo a mia volta. Ma allora, stranamente, come per significarmi che io non debbo applaudire, un altro clic del semaforo fa cessare di colpo i battimani nella sala. Alzo gli occhi. La luce del semaforo è verde. Maurizio si avanza verso il tavolo, leva un braccio come per annunciare che desidera parlare. Poi dice nel silenzio: «Vi presento Rico a cui, come sapete, il produttore Protti ha dato l’incarico di collaborare con me per la sceneggiatura dell’Espropriazione.»
Clic. Guardo al semaforo e vedo che questa volta si è accesa la luce rossa. Rifletto velocemente: luce gialla uguale applausi; luce verde uguale intervento; e luce rossa? Lo apprendo subito. I ragazzi prendono a ripetere in coro, restando seduti e strisciando i piedi in terra: «Ché si, Protti no.»
Dunque la luce rossa significa il contrario della luce gialla; vale a dire il contrario degli applausi; cioè: disapprovazione, ostilità. Non mi sento questa volta di unirmi al coro contro Protti. Oltretutto, se Protti venisse a saperlo, potrebbe facilmente vendicarsi, non facendomi più lavorare. Mi rendo conto che si tratta di una riflessione poco rivoluzionaria: ma come si fa a non pensare certi pensieri? Cosi abbozzo un sorriso di comprensione e aspetto che il coro finisca. Inopinatamente, a questo punto, “lui” sussurra: «Guarda per favore Flavia.» Guardo. Flavia sta in piedi accanto a me e io, per guardarla, mi tiro lievemente indietro. “Lui” riprende subito, infervorato: “Guarda come è alta, magra, allampanata, dinoccolata, longilinea! E, tuttavia, come è carica e ingombra al petto e in fondo alla schiena! E con quanta conturbante trasandatezza sta gettato di traverso, su questi volumi, lo straccetto del suo vestitino, incollandosi col tessuto sottile sulle parti più convesse. E’ un palo. Ma con tante cose belle e appetitose appese, come ad un albero di cuccagna!»
«E io, per farti piacere, dovrei arrampicarmi sul palo?»
«Proprio così.»
Clic. Alzo gli occhi: luce verde. Di colpo cessa il grido: «Ché si, Protti no.» Maurizio si fa avanti, assesta sul tavolo il microfono e dice: «Durante la nostra ultima riunione, vi ho esposto i cambiamenti che Rico aveva introdotto nel soggetto. Vi ho anche detto che mi ero opposto a questi cambiamenti, che l’avevo costretto a riconoscere che la nostra versione era la sola giusta e corretta e che lui si era impegnato a rispettarla. A questo punto, mi corre l’obbligo di informarvi che, come prova del suo pentimento e della sua buona volontà, Rico ha rinunziato ad ogni compenso e ha versato la somma di cinque milioni alla nostra amministrazione.»
Clic. Sono tanto sicuro che la luce sia gialla che non alzo neppure gli occhi per accertarmene. Mi atteggio, invece, ad un’aria di modestia compunta e discreta, in attesa degli imminenti, sicuri applausi. Ma mi succede invece come a chi, collocandosi tutto nudo sotto la doccia, sbaglia rubinetto e invece dell’acqua calda, sprigiona un getto d’acqua fredda. Gli applausi non vengono. Scoppia, invece, un coro ostilissimo, accompagnato dai soliti strusciamenti dei piedi in terra: «Ché si, Rico no.» Allora mi decido ad alzare gli occhi verso il semaforo: la luce è rossa, proprio cosi. A questa vista sento la mia faccia cambiare espressione e perfino forma, passando mio malgrado dalla finta e gonfia modestia ad un sincero e smagrito sgomento. Ascolto incredulo, quasi sperando di aver udito male. Ma no, ho udito benissimo, è proprio vero, i ragazzi gridano in coro: “Ché si, Rico no” E i cinque milioni?
Clic. Luce verde. Di botto il coro tace. Maurizio riprende, come se avesse indovinato il mio pensiero e intendesse rispondermi: «Voi non avete applaudito alla notizia dell’offerta dei cinque milioni e avete fatto bene. I cinque milioni versati alla nostra amministrazione non provano affatto che Rico sia un rivoluzionario. Adesso, poi, si è verificato un fatto nuovo il quale dimostra che la nostra diffidenza verso di lui era più che giustificata.» Maurizio tace un momento, guarda la sala e poi, inspiegabilmente, guarda me. Dico: inspiegabilmente, perché non comprendo il motivo di questo sguardo inespressivo, atono, inerte, apatico. Proprio uno sguardo da personaggio dipinto in un quadro, in un museo. Sono rabbioso, sono sgomento, sono confuso; ma Maurizio non pare rendersene conto, perché non è “vivo” ma “dipinto”. Riprende, dopo un momento di silenzio: «Ecco il fatto nuovo. Rico è andato pochi giorni fa da Protti, e gli ha detto che noi avevamo intenzione di fare un film contro di lui e contro il sistema. Lo scopo di questa che bisogna pur chiamare delazione controrivoluzionaria, è chiaro: allarmare Protti, fargli preferire la propria versione alla nostra, sabotare il film. Per fortuna, Protti, per motivi suoi, non ha aderito. Anzi, è stato proprio lui ad avvertirmi della mossa di Rico.»Clic. Sono sicuro che la luce non può essere che rossa e questa volta non mi sbaglio. Pur restando seduti, i ragazzi riprendono a ripetere in coro: «Che sì, Rico no,» strusciando i piedi sul pavimento. Sono annichilito. Con, per giunta, la consapevolezza bruciante di essere caduto, a causa della mia buona fede di desublimato bonaccione ed esuberante, in una trappola accuratamente preparata da una scatenata tribù di supersublimati in erba. Già, perché, qui, son tutti quanti più o meno simili a Maurizio: sublimati per nascita, per tradizione familiare, per ambiente sociale. Tutti ragazzi di buona famiglia, infatti; e buona famiglia in questo caso vuol dire famiglia i cui membri sono stati dei sublimati per almeno cinque generazioni. Che importa se in passato erano funzionari statali, banchieri, generali, giudici, medici, avvocati e adesso, invece, sono, o almeno si credono, rivoluzionari! La sublimazione era pur sempre uguale, così allora sotto i doppipetti di grisaglia all’inglese, come oggi sotto le magliette. E io, il desublimato per antonomasia, mi sono lasciato attirare, con l’esca della vanità, nel trabocchetto di un sedicente dibattito che, in realtà, si sta configurando sempre più come un vero e proprio linciaggio.

Moravia rievoca in maniera narrativa il confronto reale avvenuto con gli studenti:
“Nel febbraio del 1968, si era recato alla «Sapienza», con Dacia Maraini e Laura Betti, per prendere la parola nel corso di un’occupazione, e sostenere gli studenti, ma viene contestato e viene considerato alla stregua di un oppositore, e prende piena coscienza di essere divenuto la controparte, soltanto quando viene colpito come da un sasso dallo slogan con il quale viene apostrofato all’entrata nell’aula 1 della Facoltà di Lettere: «Mao sì, Moravia no!». L’accusa ricorrente rivolta al romanziere romano dai giovani contestatori è che lui scrive per il «Corriere della Sera», «giornale della borghesia imperialistica». All’«Espresso» viene predisposto un dibattito con alcuni studenti, e in tal modo entra nel vivo il ’68 di Moravia: egli prova sulla sua persona quale sia il significato di quello slogan, lungamente ripetuto: «Non fidarti di nessuno che abbia più di trent’anni»; tanto ribadito da divenire martellante e quasi un mantra.” (Angelo Favaro)
Il rapporto dello scrittore romano con il movimento del ’68 potremo definirlo ambivalente: se da una parte egli, come il suo amico Pier Paolo Pasolini, imputa loro che sono: Tutti ragazzi di buona famiglia, infatti; e buona famiglia in questo caso vuol dire famiglia i cui membri sono stati dei sublimati per almeno cinque generazioni. Che importa se in passato erano funzionari statali, banchieri, generali, giudici, medici, avvocati e adesso, invece, sono, o almeno si credono, rivoluzionari! e lo stesso Pasolini, in una famosa poesia così esordisce contro gli studenti sessantottini:
Avete facce di figli di papà.
Buona razza non mente.
Avete lo stesso occhio cattivo.
Siete paurosi, incerti, disperati
(benissimo) ma sapete anche come essere
prepotenti, ricattatori e sicuri:
prerogative piccoloborghesi, amici.
dall’altra non può far meno di affermare che il Michele de Gli Indifferenti, se fosse vissuto in quegli anni, sarebbe stato certamente un contestatario. Tuttavia lo scrittore ne mette in luce, con “cattiveria” ironica le contraddizioni, ed esse (in un romanzo erotico come Io e lui) non possono che essere sessuali: di fronte ad un movimento che si fregia, con diritto, di aver portato avanti le istanze per una piena libertà sessuale, Maurizio teme l’omosessualità e rivendica il diritto di sposarsi e metter su “borghesemente” famiglia con la sua fidanzata.

Nel 1972 esce il quarto libro odeporico, questa volta a seguito di un viaggio in Africa, terra a cui, da questo momento, sarà sempre legato: A quale tribù appartieni? Il volume contiene le corrispondenze pubblicate sul «Corriere della Sera» tra il 1963 e il 1972, stesso anno della pubblicazione e, come è riportato sulla quarta di copertina a firma di Moravia stesso: “Questo libro è stato scritto nel modo seguente: viaggiando in Africa per svago e desiderio di estraniamento, senza fare inchieste né ricerche né nulla di tutto ciò che, quando si ha intenzione di scrivere un viaggio, si fa «apposta». In Africa ho voluto portare soltanto me stesso, così com’ero, con la cultura e l’informazione di cui già disponevo e niente di più. Se ho letto dei libri sull’Africa l’ho fatto per curiosità, non per crearmi una competenza, d’altra parte impossibile. Insomma si tratta di un libro di impressioni; cioè della storia di una felice e invaghita disponibilità. Così il fine che il libro, modestamente, si propone non è di informare, nè di istruire né tanto meno di giudicare ma di ispirare al lettore lo stesso interesse e la stessa simpatia che mi hanno spinto a viaggiare per il continente nero”.
AFRICA PREISTORICA E MAGICA
Qualche volta mi sono posto il quesito: l’Africa nera, in senso storico, è più vecchia o più giovane dell’Europa? A ben guardare, in confronto all’Africa primitiva, ossia ancora avvolta nel bozzolo della natura, l’Europa che da quel bozzolo è uscita da un pezzo dovrebbe essere più vecchia. D’altra parte, però, è facile rendersi conto che l’Africa nera sta ad uno stadio della cultura che fu proprio dell’Europa alcune migliaia di anni or sono; dunque è l’Africa ad essere più vecchia. Ma l’Africa accede soltanto adesso alla civiltà industriale che in Europa è già impiantata da due secoli, perciò l’Africa è più giovane. Tuttavia non si può negare che l’africano non comprende il senso profondo di questa civiltà industriale, l’accetta senza capirla e non la capisce perché le sue concezioni religiose sono non soltanto anteriori al calvinismo, che è all’origine di quella civiltà ma anche, addirittura, al cristianesimo; dunque l’Africa è più vecchia. Ma non è forse l’africano più giovane dell’europeo in quanto più irrazionale, più spensierato, più infantile, più portato al ballo, al canto, alla pantomima ossia forme d’arte che non esigono maturità intellettuale, e così via? In realtà a conti fatti, gli africani sono insieme giovani e vecchi cioè la cultura dell’Africa e arcaica e al tempo stesso il suo innesto nel mondo moderno è ancora problematico e immaturo.
Gli africani dopo essere rimasti per millenni fermi a questa cultura, passano oggi, con un salto vertiginoso, alla cultura neocapitalista ed industriale. Così un viaggio in Africa, quando non è una scorribanda insipida per i grandi alberghi che gli occidentali hanno disseminato sul continente nero, è un tuffo nella preistoria.
Ma che cos’è questa preistoria che tanto affascina gli europei? Prima di tutto, diremmo, la conformazione stessa del paesaggio africano. Il carattere principale di questo paesaggio non è la diversità, come in Europa, bensì una terrificante monotonia. Il volto dell’Africa è dunque più simile a quello di un infante con poche fattezze appena accennate che a quello di un uomo sul quale la vita abbia impresso innumerevoli tratti significativi; ossia è più simile al volto della terra nella preistoria, quando non c’erano stagioni e l’umanità non era ancora comparsa che al volto della terra oggi, con le innumerevoli modificazioni apportate così dal tempo come dall’uomo. Questa monotonia, d’altra parte, presenta due aspetti propriamente preistorici: l’iterazione, ossia il ripetersi di un solo tema o motivo fino all’ossessione e al terrore; e l’informità, ossia l’incapacità del limite, del finito, della figura, della forma, insomma.
Preistoria, per esempio, è la savana che fascia l’Africa per migliaia di chilometri da ovest a est, cioè dall’Oceano Atlantico all’Oceano Indiano. La savana è una sterminata steppa color verde pallido sparsa, a perdita d’occhio, di una sola specie di albero, la piccola acacia africana, irta di spine, coi rami disposti a ombrello, e di una sola specie di cespuglio di forma rotonda, color verde scuro. Si corre e si corre. in macchina, per strada o per piste, per centinaia di chilometri e la steppa non finisce mai. non fa che ripetere se stessa, ossia i due motivi che le sono propri, l’acacia e il cespuglio.
Lontanissimo, talvolta, in quelle solitudini remote, si scorgono miriadi di punti neri che si spostano con rapidità tra il pullulare delle acacie e dei cespugli: sono branchi di zebre e di gazzelle che fuggono chissà dove, spaventati da chissà che cosa. Se ci si ferma in mezzo alla savana, al rombo dell’automobile subentra improvvisamente un silenzio vergine, sospeso, veramente preistorico nella sua profondità e trasparenza. Si ode il vento soffiare in sordina; il sole inonda di luce implacabile l’immensa steppa; ad un tratto ci si sente osservati e si scopre che, infatti, al di sopra degli ombrelli delle acacie, si levano, immobili, in cima ai colli enormi, le piccole teste occhiute di alcune giraffe. Questi animali timidi e curiosi stanno qua e là tra gli alberi e più alti degli alberi; poi ad un gesto o ad una voce fuggono via, attraversando uno dopo l’altro la strada coi salti lenti, goffi e pesanti dalle gambe altissime e dai corpi massicci. Si riprende allora la corsa e la savana ricomincia a ripetere il motivo dell’acacia e del cespuglio milioni e milioni di volte, per centinaia, per migliaia di chilometri. Ogni tanto la savana pare sollevarsi un poco verso il cielo e configurarsi in colline lunghe e molli che sembrano doverle chiudere e darle la forma di una vallata; ma è un tentativo inane che invariabilmente si perde e si scioglie nella solita informità.
Preistoria è anche la foresta pluviale che si stente immediatamente sotto la savana, anch’essa per migliaia di chilometri, anch’essa di un solo colore, ininterrottamente, che, mentre nella savana è il verde pallido, nella foresta è il nero. Ho percorso la foresta, per esempio, sulla strada che, in Nigeria, va dal Lagos alla leggendaria Benin, un tempo sede di meravigliosi scultori e fabbri. La strada è stretta, diritta, di terra rossa come il sangue; si direbbe che la foresta sia una carne nera nella quale è stata tracciata una lunga ferita ancora aperta e viva. Si corre anche qui per centinaia e centinaia di chilometri senza che il paesaggio cambi: la foresta, come la savana, non fa che ripetersi, fino all’ossessione. Il motivo dominante è l’intrigo nero degli alberi, degli arbusti, delle liane e dei rampicanti che si leva, come una muraglia, ai due lati della strada è quasi impedisce la vista del cielo, ridotta ad una striscia azzurra parallela alla striscia rossa della strada.
Questo intrico, a tutta prima, appare assai vario e ricco di arborescenze, di tronchi, di rami penzolanti; ma anche questa varietà si ripete e alla fine l’occhio, sazio, cessa di ricercarla e di apprezzarla. Se ci si ferma all’improvviso nella foresta, anche qui si è colpiti dalla verginità e trasparenza del silenzio. La foresta sta ritta ai due lati della strada; un fiumicello si addenta, nero, putrido e immobile tra gli alberi; qua e là in riva a quell’acqua bassa e melmosa si scorgono tronchi enormi che sono caduti per vecchiezza e si disfanno in pace, la pace eterna e mortuaria della preistoria. La foresta è funerea, tetra, muta e vuota; a quanto pare non ci sono nella foresta che serpenti e insetti. Anche la foresta, come la savana, sembra ogni tanto voler uscire dall’informità e accennare a qualche cosa di finito, di riconoscibile, di formato, come una radura, un sentiero, un albero isolato, un gruppo di alberi; ma quasi subito questo accenno si disfà, svanisce nell’informità verde buia della vegetazione equatoriale.
La preistoria in Africa non è soltanto nella conformazione del paesaggio ma anche nella presenza universale della sola tendenza religiosa veramente autoctona, la magia. In Europa il mondo magico sopravvive con relitti modesti e indecifrabili, come rottami sul mare dopo un naufragio; ma in Africa si avverte tutto il tempo che il mondo magico è ancora completo, intatto e funzionante. Ora il mondo magico non è altro che il mal d’Africa visto non più dalla parte degli europei ma da quella degli africani. Il mal d’Africa è un fascino con un fondo di paura, che è poi paura della preistoria cioè delle forze irrazionali che l’uomo da tante migliaia d’anni è riuscito in Europa a respingere e a dominare e che qui in Africa sono ancora invece invadenti e scatenate. E’ una paura alla quale l’europeo finisce per abituarsi, anche perché egli ha le sue radici altrove e la sua personalità è più solida e meno labile di quella dell’africano; una paura insomma, angosciosamente piacevole. Ma la paura dell’africano privo di storia, con una personalità vacillante come la luce di una candela, è paura sul serio, spavento senza nome, terrore perpetuo e oscuro. La magia è l’espressione di questa paura della preistoria; essa è tanto laida, tetra e demenziale quanto il mal d’Africa è afrodisiaco anche se disgregante e annientatore. In realtà la magia è l’altra faccia del mal d’Africa.

I reportage moraviani sull’Africa avvengono proprio negli anni della decolonizzazione dei paesi europei dall’Africa: il nostro ne mette in luce gli aspetti più contradditori, quali la persistenza di confini tracciati con il “righello” dalle varie potenze del vecchio continente e la non coincidenza con le varie tribù africane; l’ottenuta “libertà” politica e la mancata libertà economica per quello che storici e Moravia definiranno neocapitalismo coloniale. Dice a tal proposito lo storico Jack Woddis: «Gli investimenti occidentali, i prestiti, le politiche commerciali e i programmi di “aiuto” sono tutti rivolti allo scopo di mantenere questi territori quali produttori di materie prime, retroterra dell’imperialismo, importatori dai paesi metropolitani della maggior parte dei loro macchinari e manufatti. Gli investimenti privati, per esempio, sono diretti principalmente verso le imprese minerarie le piantagioni, fonti di immenso profitto per l’imperialismo. […] Ben scarsi capitali sono invece investiti nelle attività manifatturiere, con il risultato che nei paesi sottosviluppati non riescono a formarsi le premesse per lo sviluppo. Stando così le cose, le nuove nazioni si trovano nei guai: e si vendono il loro petrolio e minerali a condizioni nettamente favorevoli ai compratori e da qui sono prodotti finiti a condizioni vantaggiose per i fornitori, mentre le loro difficoltà sono aggravate dagli accordi internazionali sui trasporti marittimi in base ai quali i nodi sono manovrati in modo tale da recare ulteriori svantaggi ai paesi nuovi». Ciò non toglie, da parte dello scrittore romano, una certa fascinazione, che farà dell’Africa il continente più amato per la sua incommensurabile assenza di tempo: la presenza animale, le capanne, le nudità, le danze tribali, i colori e non per ultimo le immensità spaziali fanno dell’Africa un luogo senza tempo, preistorico, appunto, dove per preistorico Moravia intende il prevalere della natura sull’uomo.
Sebbene, come detto prima, Moravia rimanga affascinato dall’Africa, il suo “razionalismo”, oserei dire il suo antropologismo illuministico non viene meno quando visita Zanzibar, in Tanzania, luogo da cui mercanti arabi praticavano il commercio degli schiavi:
LO SCHIAVISMO
La schiavitù è uno dei misteri dell’Africa, tanto più oscuro quanto più noto nei suoi aspetti storici. Il motivo economico, al solito, non spiega niente: la schiavitù prim’ancora che un fatto economico è un fatto umano cioè psicologico e, in senso lato, religioso e di cultura. Il mistero della schiavitù è doppio: dalla parte degli schiavisti e dalla parte degli schiavi. Per gli schiavisti ci limiteremo ad osservare che essi erano così crudeli, insensibili e avidi perché, in buona fede, credevano che la loro cultura fosse la sola cultura possibile e vedendo che la cultura dei negri era diversa dalla loro ne inferivano che i negri non erano uomini ma bestie. In altri termini lo schiavista era un razzista di specie molto moderna; il nome della cultura, negava agli schiavi l’umanità ossia la fratellanza; da questo a trattare il negro come merce non c’era che un passo. Ma che altro hanno fatto in anni recenti i nazisti con le popolazioni dell’Europa orientale?
Dalla parte degli schiavi, viene invece fatto di domandarsi quanta parte di responsabilità avessero in questa tragedia della schiavitù gli africani stessi. Siamo costretti a rispondere che alcuni caratteri storici della cultura africana certamente hanno favorito la schiavitù. Per prima cosa è noto che i mercanti di schiavi arabi ed europei trovarono un’attiva collaborazione nei re e capi tribù di tutta l’Africa nera. Questi monarchi consideravano i loro sudditi non come cittadini sia pure fortemente limitati nelle loro libertà individuali ma come oggetti di proprietà, né più né meno. Così gli pareva del tutto naturale barattarli con le conterie, i fili di rame e di ottone, le stoffe e le armi da fuoco dei negrieri. In principio a quanto sembra, i re negri consegnavano agli schiavisti soltanto i sudditi che avevano commesso qualche delitto; ma in seguito si propagò l’usanza di razziare intere popolazioni innocenti. In altri termini i negrieri facevano un po’ come i cacciatori di safari oggi; pagavano un prezzo per il diritto di rapire tante giovinette, tante donne con bambini, tanti ragazzi, tanti uomini adulti. E’ comprensibile che vedendo il re accettare questa metamorfosi dei propri sudditi in merce, essi non provassero scrupoli più tardi a vendere o lasciare deperire o addirittura distruggere quella stessa merce.
Resta poi da dire qualche cosa sul cannibalismo che i due secoli or sono era frequente in Africa e che secondo noi è connesso con la schiavitù di allora e di sempre. Il cannibalismo era quasi sempre rituale e magico; ma agli schiavisti non poteva non fare l’effetto di essere invece puramente economico cioè dovuto alla cronica penuria alimentare dell’Africa. I negrieri ignoravano completamente la magia che era all’origine del cannibalismo; e non potevano non notare che l’uomo il quale serve da alimento ad un’altro uomo, ha tutti i caratteri di un oggetto, anzi è l’oggetto per eccellenza in quanto viene utilizzato completamente e immediatamente attraverso l’inghiottimento, la masticazione, la digestione e la defecazione. Così, proprio la magia, che nell’intenzione degli africani doveva servire a confermare, attraverso il cannibalismo rituale, la superiorità dell’uomo di fronte alla natura, cioè di fronte agli oggetti; proprio la magia, invece, per un equivoco quasi ironico, incoraggiava gli schiavisti a trattare i negri come cose inanimate.

“Quello che è successo in Africa dagli anni Novanta in poi – sotto la spinta di una globalizzazione e modernizzazione selvaggia, dell’incancrenirsi delle situazioni e dell’avvento di spaventosi fondamentalismi razziali e religiosi – ha segnato una discontinuità così netta e drammatica, che l’Africa pur così vicina nel tempo visitata da Moravia sembra non esistere più.” (Simone Casini, Moravia in Africa)
Come molti viaggi, Moravia visitò parte dell’Africa con Pier Paolo Pasolini, il quale cercava le location per il suo film con la Callas, Medea. La sua morte, avvenuta il 2 Novembre 1975, viene così pianta dallo scrittore:
ORAZIONE DI ALBERTO MORAVIA AI FUNERALI DI PASOLINI
trascrizione dell’orazione di Moravia ai funerali di Pasolini, il 5 novembre 1975

«Poi abbiamo perduto anche il simile. Cosa intendo per simile: intendo che lui ha fatto delle cose, si è allineato nella nostra cultura, accanto ai nostri maggiori scrittori, ai nostri maggiori registi. In questo era simile, cioè era un elemento prezioso di qualsiasi società. Qualsiasi società sarebbe stata contenta di avere Pasolini tra le sue file. Abbiamo perso prima di tutto un poeta. E poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo (applausi). Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe esser sacro. Poi abbiamo perduto anche un romanziere. Il romanziere delle borgate, il romanziere dei ragazzi di vita, della vita violenta. Un romanziere che aveva scritto due romanzi anch’essi esemplari, nei quali, accanto a un’osservazione molto realistica, c’erano delle soluzioni linguistiche, delle soluzioni, diciamo così, tra il dialetto e la lingua italiana che erano anch’esse stranamente nuove.
Poi abbiamo perso un regista che tutti conoscono, no? Pasolini fu la lezione dei giapponesi, fu la lezione del cinema migliore europeo. Ha fatto poi una serie di film alcuni dei quali sono così ispirati a quel suo realismo che io chiamo romanico, cioè un realismo arcaico, un realismo gentile e al tempo stesso misterioso. Altri ispirati ai miti, il mito di Edipo per esempio. Poi ancora al grande suo mito, il mito del sottoproletariato, il quale era portatore, secondo Pasolini, e questo l’ha spiegato in tutti i suoi film e i suoi romanzi, era portatore di una umiltà che potrebbe riportare a una palingenesi del mondo. Questo mito lui l’ha illustrato anche per esempio nell’ultimo film, che si chiama Il fiore delle Mille e una notte. Lì si vede come questo schema del sottoproletariato, questo schema dell’umiltà dei poveri, Pasolini l’aveva esteso in fondo a tutto il Terzo Mondo e alla cultura del Terzo Mondo. Infine, abbiamo perduto un saggista. Vorrei dire due parole particolari su questo saggista. Ora il saggista era anche quello una nuova attività, e a cosa corrispondeva questa nuova attività? Corrispondeva al suo interesse civico e qui si viene a un altro aspetto di Pasolini. Benché fosse uno scrittore con dei fermenti decadentistici, benché fosse estremamente raffinato e manieristico, tuttavia aveva un’attenzione per i problemi sociali del suo paese, per lo sviluppo di questo paese. Un’attenzione diciamolo pure patriottica che pochi hanno avuto. Tutto questo l’Italia l’ha perduto, ha perduto un uomo prezioso che era nel fiore degli anni. Ora io dico: quest’immagine che mi perseguita, di Pasolini che fugge a piedi, è inseguito da qualche cosa che non ha volto e che è quello che l’ha ucciso, è un’immagine emblematica di questo Paese. Cioè un’immagine che deve spingerci a migliorare questo Paese come Pasolini stesso avrebbe voluto (applausi)».
Moravia non è stato solo un amico fraterno per Pasolini, ma è stato anche l’intellettuale con cui ha condiviso momenti di analisi e riflessione sulla realtà che circondava entrambi. Perchè per Moravia l’intellettuale ha il compito di essere testimone di realtà, non dimenticarsi mai di avere senso civico, farsi testimone con passione attraverso la scrittura, la pittura, e le immagini del mondo. Per questo Moravia riscopre il senso del vates, dando al poeta Pasolini quella sacralità che l’essere poeta aveva nella cultura classica, e come sacro vates, al pari di Tiresia, con la stessa forza di “scandalo” contro la mediocrità del pensiero omologato, viene colpito dall’autorità statale a cui dava fastidio.
Moravia torna al romanzo con La vita interiore, opera di lunga gestazione (sette anni), tanto che qualche critico ipotizza l’inizio della sua elaborazione nello stesso periodo di Io e lui. La storia di Desideria esce nel 1978, poco prima della rottura di Moravia con la compagna Dacia Maraini (con cui si manterrà sempre in contatto).
Desideria è una ragazzina obesa che vive con la madre Viola, vedova e ricca, che un giorno le confessa di averla comprata da una prostituta. Dopo aver assistito a una scena di sesso a tre della madre, Desideria cambia e crescendo diventa un’adolescente bellissima che scatena in Viola una morbosa attrazione sessuale. Durante una vacanza Desideria conosce Emilio, che cerca di educarla al marxismo, inoltre prende coscienza che Viola è incestuosamente attratta da lei, avendola masturbata nel sonno. Desideria si ribella, vuole diventare una prostituta, ma ha come unico cliente un siciliano spiantato, Erostrato, che le fa credere di essere parte di un gruppo di estrema sinistra che organizza sequestri per finanziare l’imminente rivoluzione antiborghese; Desideria pensa di servirsi di lui per sequestrare Viola, in modo da estorcerle un riscatto. Il luogo in cui tenere Viola prigioniera, secondo Desideria, potrebbe essere la garçonniere della madre, attirata lì con la promessa di un’orgia con la figlia adottiva ed il siciliano più un uomo di Milano, Quinto, in grado di organizzare il rapimento. Quinto dopo aver fatto il sopralluogo nell’appartamento dove tenere in ostaggio Viola, violenta Desideria. A questo punto, Desideria gli rivela che Erostrato è in realtà una spia infiltrata dalla polizia nel suo gruppo rivoluzionario, come provato in un dossier dei carabinieri in mano ad un amante della madre, Tiberi, e gli chiede di accompagnarla da lui per farsi dare il fascicolo. Tiberi però quando incontra Desideria tenta di violentarla. Quinto, che non sa nulla di quanto accaduto con Tiberi, la porta in una casa di appoggio per terroristi dalle parti di San Giovanni; Desideria però prende la pistola dal suo giubbotto e lo uccide. Uscita dalla casa, Desideria non si reca alla garçonnière per l’orgia con la madre adottiva e con Erostrato, interrompendo improvvisamente il racconto asserendo che quanto detto basta per conoscerla “come personaggio”.
L’opera sembra avere alcuni punti di contatto con il romanzo precedente: come in Io e lui anche qui si tratta di una scissione del personaggio: Desideria, infatti, ha una Voce che l’indirizza all’azione; allo stesso modo di Io e lui anche qui il rapporto con la realtà politica nella quale si trovano sia i personaggi che l’autore, assume un’importanza fondamentale: nel primo il ’68 e la contestazione giovanile, qui gli anni ’70 ed il terrorismo: non è un caso che qualcuno ha definito La vita interiore come un “Io e lei“.

IL MIO NOME E’ DESIDERIA
Desideria: Il mio nome è Desideria. E ho avuto una Voce.
Io: Una Voce? Quale Voce?
Desideria: Ti risponderò con il passaggio di un libro.
Io: Quale libro?
Desideria: La vita di Giovanna D’Arco. Anche lei aveva una Voce. Ecco il passaggio: “Arrivò questa Voce verso l’ora di mezzodì, un giorno d’estate, nell’orto di mio padre. La vigilia avevo digiunato. Raramente la udivo senza vedere il chiarore dalla parte da dove la Voce si fa sentire. La prima volta che udii la Voce, votai la mia verginità finché fosse a Dio piaciuto”.
Io: Perché Giovanna d’Arco? Cos’ha a che fare Giovanna d’Arco con te?
Desideria: In questo passaggio si parla di due cose che ho avuto in comune con Giovanna d’Arco: la Voce e la verginità. Per alcuni anni una Voce mi ha parlato, mi ha guidato, mi ha comandato. E, al tempo stesso, ho voluto, come Giovanna D’Arco, votare la mia verginità finché non fosse accaduto un certo avvenimento. Insomma, come Giovanna D’Arco, in me Voce e verginità erano collegate, l’una giustificava l’altra, l’una c’era perché c’era l’altra.
Io: Ma questa verginità tu non l’hai votata a Dio, no?
Desideria: No, l’ho votata a qualche cosa di diverso; che è pur sempre una specie di divinità, oggi, per molti.
Io: Che cos’è?
Desideria: Preferisco non dirlo. Si capirà dal mio racconto.
Io: Adesso sei ancora vergine?
Desideria: No, non lo sono più.
Io: Allora vuol dire che quel certo avvenimento per cui avevi votato la verginità è accaduto.
Desideria: No, non è accaduto.
Io: E la Voce?
Desideria: La Voce se ne è andata.
Io: Così non sei più vergine e non hai più la Voce?
Desideria: Sì è così. Sto per raccontarti appunto la storia di come ho perduto insieme la Verginità e la Voce.
Io: Cioé la storia del voto.
Desideria: Diciamo pure: la storia del voto.
Il passo è indicativo per due aspetti fondamentali del romanzo: quello strutturale e quello “contenutistico”:
Strutturale: Il romanzo è tutto in forma dialogica, vi è un Io che domanda e Desideria che risponde. Chi è Io? Qualcuno lo indica come l’autore stesso, Moravia (nelle diverse redazioni) ora lo vede come lo psicoanalista, o ancora come il giudice che interroga Desideria, infine decide di renderlo senza identità. Quindi la storia viene ricostruita attraverso, diciamo così, l’intervista, per questo tutto il racconto si struttura come un flashback, in cui la protagonista racconta (in un non tempo) il tempo in cui da bambina diventa adolescente; ma è proprio nell’adolescenza che le appare la Voce; quindi Desideria risponde all’intervistante (in un eterno presente) ciò che la Voce, incalzandola continuamente, la “costringeva” ad agire. Ciò vuol dire che il romanzo si struttura su tre voci parlanti: l’Io che interroga, la Voce che interagisce e comanda, Desideria che racconta. Il romanzo narra la storia di Desideria sin da quando era bambina sino all’anno della “maturità; e rileggendo la sua vita Desideria rivede il tempo in cui “adolescente” brutta e grassa, si risveglia “ragazza” bellissima e nomen omen “desiderabile”.
Contenutistico: Sacralizzazione e desacralizzazione; prendendo come spunto Giovanna d’Arco e il ruolo che la Voce ha affinché ella possa votarsi a Dio, il romanzo ci narra la storia di una vocazione “rivoluzionaria” in cui la stessa rivoluzione ha lo stesso ruolo che Dio aveva per Giovanna D’arco; per giungere alla palingenesi proletaria Desideria deve desacralizzare i valori alto borghesi di cui fa parte; e affinchè tutto questo possa avere luogo, Desideria si deve votare al terrorismo.
Il fine ultimo che la Voce (il suo super-Ego) comanda a Desideria è la desacralizzazione familiare. La ragazza non ha padre, Viola, la madre l’ha comprata da una prostituta; il fatto di “essere figlia” e nel contempo “non essere figlia” genera in Viola un desiderio sessuale morboso, riproponendo, in un certo qual modo, quel rapporto edipico che aveva caratterizzato Agostino. Qui il tutto viene “complicato” dall’atteggiamento sessuale di Viola e dal desiderio saffico di possedere Desideria.

L’immagine di Viola è un altro capolavoro moraviano: il suo essere nevrotica e sola ci viene illustrato quasi all’inizio del romanzo, con Desideria ancora piccola:
VIOLA
Io: Chi era la tua vera madre?
Desideria: Una donna del popolo che, a quanto pare, si era disfatta di me per essere più libera di fare la vita che le piaceva. Ho il sospetto che questa donna fosse stata cameriera in casa nostra; e che, anche se Viola non era mia madre, suo marito fosse davvero mio padre. Ma soltanto il sospetto. Del resto non mi sono mai curata di chiarire il mistero poco interessante delle mie origini; ciò che mi importava, come vedrai, non era di sapere chi erano i miei veri genitori, ma a quale classe appartenevano. Anzi, in qualche modo, ho evitato di risalire fino alla persona di mia madre; mi bastava essere sicura che era una del popolo. Ma tu volevi sapere come era la mia madre adottiva. Prima di tutto era ricca.
Io: La ricchezza non è un carattere individuale.
Desideria: In lei, sì. Era anzitutto ricca. Come altre donne sono anzitutto brune o bionde, lei era anzitutto ricca.
Io: Era molto ricca?
Desideria: Sì, era ricchissima; ma non è questo il punto.
Io: Qual è il punto?
Desideria: Era “soltanto” ricca.
Io: Soltanto?
Desideria: Voglio dire che, per molti motivi, non aveva che il denaro sul quale ricadere, nella vita.
Io: Cosa vuoi dire con “ricadere”?
Desideria: Viola era una specie di apolide, ma non nel senso che si dà di solito a questa parola. In un senso, come dire? molto più completo. Era apolide non soltanto per quanto riguardava la patria, poiché era al tempo stesso americana, greca e italiana; ma anche per quanto riguardava la società e la famiglia, perché, allo stesso modo che aveva una patria soltanto legale, cioé soltanto iscritta nel passaporto (era cittadina americana) così non aveva che un simulacro di famiglia e non faceva parte che di una apparenza di società. Era, insomma, la persona più fantasticamente sradicata che abbia mai conosciuto. Figurati che non parlava nessuna lingua.
Io: Si parla sempre una lingua, anche se la si parla male.
Desideria: Forse non mi sono spiegata bene. Viola non si esprimeva in alcuna lingua, si limitava a farsi capire, un po’ come i turisti in viaggio in un paese straniero.
Io: Che lingua parlava?
Desideria: L’inglese, ma quello degli emigrati, povero e gergale, perché, pur essendo nata negli Stati Uniti, non aveva fatto che pochi studi; l’italiano, ma anche questo in maniera sommaria, inframezzandovi parole dialettali (i suoi genitori erano emigrati in America dalla Calabria); un po’ di francese; un po’ di greco, un po’ di arabo. Normalmente, in casa, si esprimeva in italiano. Quando si arrabbiava e voleva essere dura e altezzosa, allora, curiosamente, veniva fuori l’inglese. Il francese, il greco e l’arabo si limitavano a poche parole che risalivano ogni tanto alla superficie del discorso, come relitti di un naufragio dopo la tempesta. Insomma era apolide anche linguisticamente: nel suo genere, un vero e proprio mostro.
Io: Allora vuoi dire che la ricchezza era una specie di patria per lei. Che le sue radici erano il denaro, il benessere che il denaro le assicurava. Il mondo è pieno di gente così.
Desideria: Ti sbagli. Non riusciva a dare importanza al denaro. Era invece ossessionata dalle cose che non aveva, soprattutto la famiglia e la società.
Io: Vuoi dire che la sua vita si imperniava sul fatto di avere una figlia adottiva, di appartenere alla società romana.
Desideria: Ti sbagli ancora una volta, la sua vita si imperniava sull’erotismo. Forse c’era stato un tempo, quando era venuta per la prima volta a Roma, in cui la vita in famiglia, il posto nella società erano stati la sua preoccupazione principale. Ma questo tempo era ormai lontano; adesso non le restava che è una specie di cocciuta nostalgia, di ostinata speranza.
Io: Nostalgia, speranza di che cosa?
Desideria: Di avere un giorno, per qualche miracolo, tutto ciò che per volontà non era riuscita ad ottenere. Intanto, però, con sua piena ma impotente consapevolezza, l’erotismo era diventato il centro della sua vita.
Io: Che era? Una maniaca sessuale?
Desideria: Non lo era nel senso di chi ha fatto una scelta definitiva; lo era, per così dire, in mancanza di meglio o, se preferisci, in mancanza di ciò che lei si ostinava a considerare il meglio. Avrebbe preferito essere una buona madre di famiglia, una rispettabile signora borghese; ma queste due cose le si presentavano, purtroppo, come due convenzioni o meglio come due parti da recitare, piuttosto che da vivere. Al contrario, l’erotismo, con sua disperazione, era la cosa vera reale, autentica che lei si sentiva portata a fare spontaneamente.
Io: Come fai a sapere tante cose del passato della tua madre adottiva?
Desideria: Ti ho già detto che affiorava continuamente in lei la speranza di qualche miracolo che la strappasse dall’erotismo e la restituisse, o meglio l’inserisse davvero e per la prima volta in una realtà di segno diverso. Qualche volta le avveniva di agire per favorire volontariamente questo inserimento. Per esempio, per quanto riguarda la sua ambizione sociale, mi è rimasto ricordo preciso sebbene remoto e quasi incredibile, Di una specie di catastrofe mondana avvenuta quando ero ancora bambina.
Io: Una catastrofe?
Desideria: Sì, un grande, solenne, ricevimento, al quale lei aveva invitato, diciamo, un centinaio di persone e, come se si fossero messi d’accordo tra di loro, non venne nessuno.
Io: Nessuno?
Desideria: Sì, per quanto possa sembrare incredibile, proprio nessuno. Ricordo i preparativi, soprattutto gli immensi vassoi disposti su due grandi tavole, pieni fino al lordo di pasticcerie e di cibarie. Ricordo pure Viola in uno straordinario vestito da ricevimento.

Io: Perché straordinario?
Desideria: Hai presente i cappucci che si mettono sulle teiere affinché il tè non si raffreddi? Oppure i vestiti immensi, tenuti da armature di vimini, che indossano le donne nei quadri di Velasquez? Ebbene, Viola, per l’occasione del ricevimento, aveva fatto l’acquisto di un vestito simile. Ho assistito, ammirata e sbalordita, alla vestizione della mia madre adottiva. Per prima cosa, la cameriera l’ha aiutata a fissare alla vita la crinolina, cioè una specie di gabbia dentro la quale il corpo di Viola mi è apparso improvvisamente esile, quasi il corpo di una adolescente, per contrasto con la smisurata larghezza dell’armatura; poi, le ha infilato il vestito per la testa, e ha fatto scendere fino ai piedi la gonna, coi suoi volanti e i suoi festoni. Il vestito aveva una scollatura posteriore molto profonda che arrivava fin sotto le reni e metteva in valore il dorso che era la cosa più bella di Viola. Sul davanti, invece, il petto sfornito era chiuso in un corpetto attillato. Io non dubitavo che questo vestito fosse elegantissimo, che Viola fosse la donna più bella del mondo e che la sua festa sarebbe stata un grande successo; ricordo che le saltellavo intorno ripetendo: “Mamma, sarai la più bella di tutte.” Ahimè, non prevedevo che questa competizione non ci sarebbe stata, poiché, come ti ho detto, come se gli invitati si fossero passati la parola, nessuno, proprio nessuno, è venuto al ricevimento. Viola, una volta finito di vestirsi, si è mossa maestosamente anche se con impaccio; per passare attraverso la porta, si è messa di sbieco; poi, camminando piano e facendo dondolare ad ogni passo la crinolina, è andata a sedersi nel soggiorno, davanti alle tavole del buffet, su un divano che quella gonna smisurata ha subito ricoperto quasi del tutto; e lì è rimasta ad aspettare. Dietro le tavole del buffet due camerieri se ne stavano in piedi, cercando di occupare il tempo con lo spostare le bottiglie o i vassoi; dal fondo del soggiorno giungevano gli arpeggi di un gruppo di suonatori sistemati sopra una specie di pedana; Viola stava ferma, le braccia aperte e distese sulla gonna, il busto eretto, gli occhi fissi su uno dei vassoi, nel quale troneggiava un grosso tacchino arrostito. E’ passata così un’ora, si poteva ancora supporre che gli invitati, come avviene spesso a Roma, fossero in ritardo. Ma quando anche la seconda ora è trascorsa senza che venisse nessuno, e i due camerieri, stufi di starsene in piedi, si sono seduti dietro il tavolo del buffet fumando e chiacchierando a bassa voce, e dal fondo del soggiorno non è più giunto alcun suono, come se i suonatori si fossero addormentati tutti e cinque sui loro strumenti; allora Viola ha detto a uno dei servitori che le portasse un whisky. Non so perché, questo whisky, bevuto in solitudine davanti al buffet intatto, nel silenzio del grande soggiorno illuminato e deserto, mi ha fatto capire, ad un tratto, che il ricevimento era fallito, che nessuno sarebbe venuto, che nessuno voleva saperne di mia madre e di me. Ero rimasta fino a quel momento anche io seduta su una delle immense poltrone del soggiorno; ma poiché ho visto Viola portare alla bocca il bicchiere e vuotarlo in un solo sorso e poi subito dopo far cenno al cameriere che gliene portasse un altro, sono scappata in camera mia, mi sono gettata sul letto, ho preso a singhiozzare per un senso oscuro di umiliazione e di offesa. Non ero stata io ad essere offesa e umiliata, ma mia madre; proprio per questo tanto maggiore era il mio sentimento di amarezza e di vergogna. Sono poi rimasta sul letto, al buio, senza avere il coraggio di alzarmi. Ogni tanto tendevo l’orecchio ad ascoltare se si sentiva il rumore degli arrivi; ma tutto era silenzio. Alla fine mi sono addormentata, forse avrò dormito un paio d’ore. Poi mi sono destata di soprassalto e, senza indugio, quasi meccanicamente, ravviando i capelli e stendendo con le mani la veste spiegazzata, sono tornata nel soggiorno. Senza dubbio licenziati da Viola, i camerieri e i suonatori erano scomparsi. Ma Viola stava tuttora seduta sul divano nel suo incredibile vestito, davanti al tavolino sul quale ho subito visto il bicchiere ancora mezzo pieno e la bottiglia quasi completamente vuota. Guardava davanti a sé, come due ore prima, gli occhi fissi all’enorme e ironico tacchino troneggiante sul vassoio del buffet; quasi avesse voluto evocare, con quello sguardo sbarrato, la folla assente degli invitati alla festa. Mi sono avvicinata, ho detto sottovoce: “Mamma, non è venuto nessuno. Forse ti sei sbagliata, era per domani”; e come risposta mi è subito arrivato un manrovescio violentissimo sulla bocca e sulla guancia, reso ancor più doloroso dai massicci anelli che aveva alle dita. Quindi si è alzata e, barcollando nel suo vestito oscillante e smisurato, si è avviata verso il fondo del soggiorno. Camminava in maniera incerta; si vedeva che era ubriaca. Nonostante il dolore del ceffone, ho provato, vedendola andarsene via così, con quella sua enorme gonna sbilenca, un senso forte di compassione. Poi è arrivata alla porta, ne ha aperto un battente, e si è messa di lato per far passare il vestito e… è cascata in terra e vi è rimasta, immobile, simile ad una gigantesca bambola dalle giunture spezzate.
Viola è un personaggio importante nell’economia del romanzo: donna fondamentalmente sola, la cui origine nonché straordinaria ricchezza la isolano ancor di più, viene descritta in questo passo come piena di una inconcludente nostalgia; Viola è, infatti, un donna sbagliata, desidera sempre ciò che sarebbe bene non desiderasse.
Vorrebbe essere una “normale” madre borghese, ma non riesce ad allontanare da sé il richiamo sessuale che la figlia adolescente le ispira: sarà forse perchè una normale “madre borghese” non si fa trovare dalla figlia adottiva in un atteggiamento di ménage a trois con l’amministratore e una cameriera, nell’atto di farsi sodomizzare. Atto “cristallizzato” nella mente di Viola, tanto da “rapire” i fidanzati di Desideria per ripetere quella situazione, insieme alla figlia. Non è un caso che, se si parla di desacralizzazione dell’ideologia borghese, tale scelta deve colpire l’erotismo materno, se, come dice Moravia stesso, i terroristi sono fortemente moralisti.
Dapprima Desideria desacralizza il linguaggio, rivolgendo a Viola parole oscene e triviali che riguardano sempre la sfera sessuale, poi passa a desacralizzare la cultura, e non è un caso che ad essere oggetto di tale atto non può essere che il libro sacro per la letteratura italiana, e più specificatamente, per il romanzo italiano: I promessi sposi.

DISSACRAZIONE CULTURALE
Io: Torniamo al piano. Quale è stata, la trasgressione-dissacraziane che hai affrontato dopo quella del linguaggio?
Desideria: Quella della cultura.
Io: Ecco qualche cosa di importante: quale cultura?
Desideria: A quindici anni, per lo più per cultura si intende tutto ciò che viene insegnato a scuola. Così la dissacrazione è stata infantile ed esterna, non mi è neppure venuto in mente che la cultura dovessere essere trasgredita e dissacrata con un’altra cultura o, come si dice oggi, con la controcultura. Ho invece organizzato una specie di rito scatologico col quale mi sono illusa di rigettare una volta per sempre la cultura di tutti i tempi e di tutti i luoghi, dalle origini fino ad oggi.
Io: Un rito scatologico?
Desideria: Sì, scatologico, escrementizio. Uno di quei pomeriggi che Viola era uscita e io ero rimasta a casa sola per preparare i compiti, ho preso I promessi sposi in una bella edizione di carta sottile, sono andata in bagno, ho posato il libro sul bordo del lavandino, ho tirato giù i pantaloni, mi sono seduta sulla tazza, ho defecato. Quindi ho messo il libro sulle ginocchia, l’ho aperto ad un passaggio scelto in precedenza, ho strappato la pagina, mi sono pulita il sedere, ho guardato per un momento alla pagina tutta gualcita e insudiciata, l’ho gettata sull’escremento, in fondo alla tazza, e ci ho orinato sopra.
Io: Perché proprio I promessi sposi?
Desideria: Forse perché a scuola attribuivano una grande importanza a quel romanzo; ma forse anche per quello che c’era scritto nella pagina che avevo strappato.
Io: Che pagina era?
Desideria: La pagina finale, in cui il personaggio di Renzo dice: “Ho imparato a non mettermi nei tumulti, ho imparato a non predicare in piazza, ho imparato a non alzare troppo il gomito,” eccetera, eccetera.Io: Chi aveva scelto questa pagina? Tu o la Voce?Desideria: Naturalmente, la Voce. Io non sapevo nulla di tumulti, di piazze, di alzare il gomito; quella pagina mi lasciava indifferente. Ma la Voce pareva intensamente irritata da quella pagina. “Pulisciti ben bene il culo con quella pagina,” mi ha detto in tono furioso, “mettiti bene in mente che nel momento stesso che ti pulisci il culo con quella pagina, e con tutta la loro maledetta cultura che te lo pulisci, in maniera definitiva e irreversibile.”Io: Loro, chi?Desideria: Loro, cioè Viola, la gente dei Parioli, gli insegnanti, eccetera, eccetera.Io: E tu avevi l’impressione che questo fosse veramente accaduto?Desideria: Questo, che cosa? Hai
Io: Voglio dire che quella pagina de I promessi sposi simboleggiasse davvero l’intera cultura dalle origini a oggi?
Desideria: Io non avevo alcuna impressione perché non ero colta. La Voce invece era colta E per lei l’operazione simbolica che ti ho or ora descritto, ha funzionato. Ha esclamato mentre premevo il bottone e scatenato il getto d’acqua sulla pagina insudiciata: “Non ti senti meglio adesso?”
Moravia aveva un rapporto che potremo definire complesso con I promessi sposi: imputava loro una sovrastruttura cristiana ideologica che ne inficiava il disegno generale: le parti migliori, per l’autore romano, sono quelle “decadenti”, riferite alla monaca di Monza e alla peste. Ma perchè qui la Voce sceglie l’ultima pagina? Se la Voce spinge Desideria all’azione rivoluzionaria antiborghese non può che scegliere, per dissacrare, la pagina in cui Renzo da filatore, diventa un borghese dai valori cattolici, un piccolo imprenditore er un buon padre di famiglia: tutto ciò contro cui deve lottare Desideria.
Erostrato è un personaggio che entra in contatto con Desideria quando lei, nella sua furia iconoclasta, decide di prostituirsi; il siciliano Erostrato sarà l’unico cliente. Desideria lo conquista, ma a farlo suo sarà Viola che “lo assume” come amministratore, ma in realtà ne fa il suo prostituto. La ragazza cercherà di coinvolgerlo nell’atto terroristico di rapire Viola e, con il riscatto, pagare le azioni rivoluzionarie. Ma di fronte ai suoi tentennamenti, così Desideria lo investe:
EROSTRATO

Vittorio Mezzogiorno interpreta la parte di Erostrato
Desideria: “Vigliacco, bugiardo, ero venuta qui con l’intenzione di essere sincera con te e di fare in modo che tu lo fossi con me. Io non ti amo anche se il giorno del nostro primo incontro abbiamo fatto l’amore; non ti amo e non ti amerò mai; ma provo per te un sentimento di affetto come può provarlo una sorella per un fratello. E lo sai perché? Perché io sono una trovatella, una bastarda, una figlia del popolo venduta da sua madre ad una signora pariolina è introdotta a forza e senza il suo consenso in questa borghesia di merda e so anche, bada bene, Nonostante tutte le frottole che mi hai raccontate, so di certo che tu sei come me, sei un proletario, un figlio del popolo sprofondato fino agli occhi nel pantano borghese. Ma la differenza fra me e te è che io tutto questo non soltanto lo so, ma anche lo accetto e tu invece non lo accetti e a forza di non accettarlo quasi ti convinci di ignorarlo. Io ero venuta oggi affinché fra di noi ci fosse la verità, soltanto la verità con il suo coraggio e la sua luce; ed invece che cosa ho trovato? Un vigliacco che non parla e non risponde scappa via come un topo di fogna stanato dal suo buco. Sì, tu sei un bugiardo, non posso provarlo ma lo so di certo; non è vero che sei figlio di un barone siciliano proprietario di terre, non è vero che sei laureato in scienze economiche, non è vero che sei mantenuto a Roma da tuo padre; non è vero niente. Tu sei figlio del popolo, ma la vergogna di esserlo, la smania che ti divora di essere un borghese hanno fatto di te un uomo volgare, un tipo losco, un tanghero. Invece di ribellarti, ti sei adattato, hai mentito a te e agli altri, ti sei venduto, ti sei prostituito. Sei corrotto a fondo, fino al midollo, sei una vera e propria merda. Quanto al gruppo, all’azione rivoluzionaria e a tutte le altre balle, è chiaro che ti sei inventato ogni cosa, per abbindolarmi, per portarmi a fare l’amore a tre, come vuole Viola, di cui c’è il servo, il mantenuto, il mezzano. Adesso vorrai sapere come faccio ad essere così sicura, che sei un bugiardo, un vigliacco e una merda ed io ti rispondo che lo so perché ti ho capito fin dal nostro primo incontro e ho penetrato il tuo segreto, come se tu fossi stato trasparente e io ti avessi letto dentro. E quale è il tuo segreto? Il tuo segreto e che, dopo tutto, anche tu hai una coscienza, magari sepolta sotto un monte di merda, Stessa coscienza consiste nel fatto che sai di essere corrotto fino al midollo e siccome lo sai desideri morire, non esistere più, tornare ad essere quello che eri prima di nascere, vale a dire un feto, un embrione, nulla. E sai come me ne sono accorta? Me ne sono accorta dal modo con il quale quel giorno hai fatto l’amore orale. Mentre stavo supina, con le gambe spalancate e tu inginocchiato davanti a me mi baciavi il sesso, ho sentito con precisione che non cercavi il tuo piacere, ma volevi semplicemente morire, sì, morire dentro il mio ventre che per te virgola in quel momento, era il ventre di tua madre, cioè di fare a ritroso il cammino che avevi già fatto venendo al mondo, acciambellarti dentro di me, come il feto, con le braccia conserte e gli occhi chiusi, un embrione, un grumo di vita, un nulla. Sì, questo è ciò che mi chiedevi con la coscienza di chiedermi l’impossibile; infatti facevi un gemito triste e disperato che mi ha commosso, perché ci ho sentito tutto il tuo orrore della vita e tutta la tua nostalgia della morte. Mi ha commosso e mi ha ispirato il sentimento fraterno che oggi mi ha fatto venire qui per proporti il sequestro di Viola. Già, perché questa è la tua ultima occasione per tirarti fuori dalla merda ed essere un uomo e non avere più la nostalgia del nulla ed amare la vita. Se tu fai con me questo sequestro, anche se il gruppo non c’è non esiste, come sono convinta, fai qualche cosa che ti salva. Ma se rifiuti la mia proposta, allora non ci sarà più nulla da fare, sarai perduto senza rimedio e continuerai a battere alle porte del nulla, tra le gambe delle donne, a tentare l’impossibile e naturalmente non ti sarà aperto e perciò continuerai fino all’ultimo ad essere un vigliacco, un bugiardo, un uomo volgare, un prostituto, un tanghero!“
Erostrato viene letto da Desideria, ma a far parlare Desideria è Moravia, quindi lo scrittore romano ci disegna un personaggio maschile fortemente ambiguo che risponde in modo perfetto alla complessità dei tempi. Erostrato è, infatti, oggi si direbbe, un doppiogiochista: informatore della polizia, mezzo mafioso che si è “infiltrato” nei gruppi rivoluzionari. Il tono con cui Desideria lo investe certamente non può essere capito da lui, che lo ignora. Egli tuttavia incarna, e qui la protagonista in qualche modo ripete il Moravia “africano” il binomio già dello schiavismo merce = nullità di umanità; Erostatrato si prostituisce a Viola, viene pertanto “comprato” da Viola, quindi è un nulla, e come un nulla sparirà, a fine romanzo, senza che noi lettori, potessimo sapere la sua fine.
La pagina è importante perché ci porta ad affrontare un altro discorso dell’autore Moravia: quello del sesso, descritto in modo esplicito. Ci riporta Daniela Mangione nell’Introduzione un riferimento su questo tema: “Nel mio libro il sesso serve a caratterizzare i personaggi, né più né meno come la redingote serviva a caratterizzare i personaggi di Balzac e di Dickens” ripete perentorio Moravia ai molti che lamentavano gli eccessi sessuali de La vita interiore. Notava Giuliano Gramigna, “Moravia configura ogni esercizio erotico come l’articolazione di una lingua nella quale ciascun ‘parlante’ prende atto di sé”. Il sesso svela e definisce l’identità dei personaggi; segna ritmi, modi e modelli di vita.
 Klaus Löwitsch e Lara Wendel in una scena del film
Klaus Löwitsch e Lara Wendel in una scena del film
Il libro, alla sua uscita, 1978, ebbe un’accoglienza piuttosto fredda da parte della critica, quanto invece certamente positiva da parte dei lettori (a tutt’oggi rimane, forse, il romanzo, al netto de Gli Indifferenti, più letto di Moravia). Ciò in parte è avvenuto, secondo noi, per l’eccessiva attesa che l’opera stessa aveva suscitato in un periodo che, in qualche modo, aveva cancellato la sua peculiarità letteraria. Afferma Simone Casini, curatore del 5° vol. delle Opere complete di Moravia: “Ma La vita interiore è anche un azzardo molto maggiore di quanto Moravia avesse mai osato. Mettersi a scrivere un romanzo sul terrorismo degli anni settanta senza in realtà conoscerlo da vicino o da coetaneo, senza studiarne zolianamente ambiente e psicologie, senza naturalmente condividerne le idee e le abitudini, ma solo da acuto e assiduo osservatore critico, e inseguendo in effetti una problematica sì necessaria e pertinente ma anche diversa, modellata di fatto sui Demoni di Dostoevskij e sui propri personaggi da Gli indifferenti in poi, era un’operazione destinata inevitabilmente a creare una sorta di monstrum e a provocare quel disorientamento che infatti produsse, uscendo per fatalità nei giorni del delitto Moro.”
Due anni dopo escono, a cura di Renzo Paris, i saggi raccolti in Impegno controvoglia, il cui sottotitolo recita: saggi, articoli interviste: trentacinque anni di scritti politici. Si tratta perciò di un’opera saggistica in cui il curatore ha raccolto ciò che Moravia ha pubblicato su varie riviste (Corriere della Sera, La Repubblica, L’Espresso, Nuovi Argomenti, per citare le maggiori) dal 1943 al 1978, precedute da un’intervista dello stesso Paris con lo scrittore romano.
L’opera inizia con tre saggi che lo pongono nettamente “contro” il fascismo (fra questi ricordiamo il fondamentale La Speranza ossia Crisianesimo e Comunismo scritto nel ’44); quindi procede con una serie di scritti che analizzano la “realtà politica e sociale” sia nazionale che internazionale: (i sessantottini; la guerra in Vietnam, il referendum per il divorzio. Molto interessanti, perché ancora estremamente attuali, le riflessioni sul conflitto israelo-palestinese; sul terrorismo e le BR, sulle stragi di Stato). Insomma un libro composito, tenuto insieme dalla forza ragionativa e dalla capacità di leggere in modo profondo dello stesso Moravia.
A chiarire il compito che lo scrittore romano affida all’intellettuale, illuminante è la risposta, nell’Introduzione dell’opera, che Moravia offre a Renzo Paris:
COMPITO DELL’INTELLETTUALE: IMPEGNARSI O DISIMPEGNARSI?
R.P.: Accettando l’esistenza della lotta di classe nelle civiltà industriali avanzate, non ti sei mai spinto verso la militanza politica vera e propria, in polemica con Sartre, per non dover deperire come scrittore?
A.M.: Non sono tanto sicuro che la lotta di classe sia propria della civiltà industriale avanzata. Direi anzi che la storia dimostra il contrario; la lotta di classe caratterizza semmai il passaggio dalla civiltà contadina alla civiltà industriale e sbocca spesso in una rivoluzione là dove come nella Francia del 1789 e nella Russia del 1917 questo passaggio non avviene in maniera graduale e pacifica. Ma una volta che la rivoluzione industriale sia stata veramente e completamente realizzata la lotta di classe pare essere sostituita da altre lotte, magari anche più eversive e violente ma non basate sulle differenze sociali. La rivoluzione francese e la rivoluzione russa sono due buoni esempi di lotta di classe rivoluzionaria dovuti al passaggio infelice dalla civiltà contadina alla civiltà industriale. In ambedue i casi si trattava di abbattere un nemico personalizzato e riconoscibile, il grande proprietario terriero, il padrone paleocapitalista. Ma nella civiltà industriale avanzata, la lotta di classe sia perché il proletariato, così nei paesi capitalisti come in quelli del socialismo reale, e stato coinvolto nel processo produttivo, sia perché hai latifondisti e hai padrone subentrano adesso le astratte multinazionali e le non meno astratte burocrazie statali, la lotta di classe, diciamo, si trasforma nella ben più temibile lotta per la qualità umana della vita, lotta priva di progetti alternativi che non siano utopistici e, per questo, sempre sull’orlo del rigetto totale, del nichilismo sistematico. Così, nel futuro, vi saranno forse ancora classi privilegiate e classi oppresse, ma esse serviranno sempre più a mascherare un destino alienante e disumanizzante comune a tutta la società presa nel suo insieme. Qualcuno giudicherà fantascientifiche queste previsioni. Ma il fatto che l’abolizione conclamata delle classi e dunque anche della lotta di classe nei paesi del socialismo reale non abbia portato alla fine dell’alienazione, sta dimostrare che l’alienazione è inerente alla natura stessa della civiltà industriale, nella quale, in realtà sono le masse ad alienare le masse. Lo stesso avviene a maggior ragione anche nei paesi più industrializzati dell’Occidente sia pure con una differenza: che le masse vi alienano le masse nel contesto di una società individualista e capitalista, mentre nei paesi dell’est si deve piuttosto parlare di una società socialista e castrense. Certo a est, non vi sono le differenze offensive di ricchezza che vi sono a ovest; ma il punto non è questo. Il punto è che nè la borghesia coi suoi manager né il proletariato coi suoi burocrati sembrano capaci di risolvere i problemi profondi della civiltà industriale. La quale, avanzando da ovest a est padre portare all’annullamento delle classi attraverso l’adozione di un modo di vita uniforme che vede da una parte la proletarizzazione della borghesia e dall’altra l’imborghesimento del proletariato.
In queste condizioni, la militanza politica dell’intellettuale è per lo meno problematica: al contrario delle masse che per lo più sono l’oggetto inconsapevole della storia, l’intellettuale dovrebbe esserne il soggetto lucido e consapevole. E infatti oggi abbiamo l’intellettuale impegnato che lotta senza desiderare veramente di vincere perché sa che la vittoria non potrà non portare alla propria sconfitta.
E quanto al fatto di accettare di deperire come scrittore, penso che nel caso di J. P. Sartre Si tratti di razionalizzazioni, peraltro molto umane, di una situazione personale: Sartre ha abbandonato la letteratura per la politica; da molti anni è più un politico che uno scrittore. Adesso mi sia consentito di razionalizzare a mia volta la mia situazione personale. Per conto mio, come ho già detto altre volte, l’impegno ossia il cosiddetto “engagement” Non è questione di necessità esterna, per cui, in determinate circostanze lo scrittore “deve” cessare di scrivere e “deve” invece impegnarsi nella politica, bensì di vocazione interiore: ci sono scrittori “impegnati” anche in tempi di distinzione politica e ci sono scrittori disimpegnati anche in tempi di turbolenza politica. Quanto a dire che in ambedue i casi si tratterà di vedere se lo scrittore si sentiva “chiamato” a deperire come scrittore. Che utilità può ricavare infatti qualsiasi società da uno scrittore che volontaristicamente si snatura e rifiuta se stesso per far piacere alla società stessa? E più radicalmente, perché non viene il sospetto che l’arte in generale assolve nella società una funzione diversa anzi opposta a quella della politica? E che il caso del realismo socialista ossia di una società letteraria nella quale gli scrittori accettarono con entusiasmo e con zero di deperire come scrittori, e istruttivo se non altro perché dimostra che la letteratura non è un corpo separato dallo Stato? E d’altra parte, formulata l’ipotesi che l’arte non sia “ingegneria delle anime” ma espressione individuale del represso collettivo, non si va più vicino alla verità dicendo che per l’artista il solo impegno degno di questo nome e l’impegno artistico? Anche perché l’impegno artistico e l’impegno più politico che sia possibile ad un’artista.

Renzo Paris
In modo più chiaro Moravia, rispondendo ad un intervistatore televisivo, spiega, come afferma da quanto riportato, il titolo contradditorio o ossimorico dell’opera: «Ogni volta che ho scritto di politica ho sentito che qualche cosa mi resisteva, questo qualche cosa è molto semplice: l’artista si occupa diciamo così della ricerca dell’assoluto, il politico del possibile; perciò in me resiste l’artista quando parla di politica, perché la tentazione dell’artista parlando di politica è di andare verso l’assoluto, che in politica è detestabile e invece bisogna tenersi possibile, al contingente. Però sono anche un cittadino voglio dire è innegabile che sono un cittadino un uomo che sente la politica, non soltanto, la segue con curiosità ma la sente come qualcosa di reale, perciò ci sono portato naturalmente. E perciò sì in fondo il “controvoglia” è falso: va bene ammetto che vi sia una certa falsità nel termine».

Dopo un anno, nel 1981, la casa editrice raccoglie un’altra serie di reportage dal continente africano, scritti per il Corriere della Sera tra il 1975 e il 1981, dando al volume il titolo Lettere dal Sahara. Il testo, sempre di carattere odeporico, è strutturato in quattro parti (Diario d’Avorio; Lettere dal Sahara; Kenia e il Lago Rodolfo; Viaggio nello Zaire).
L’intento della raccolta giornalistica ce lo offre lo stesso Moravia:
DIARIO D’AVORIO
Inizio Il giornale di viaggio in Costa d’Avorio e mi domando che cosa scriverò. Non ho che l’imbarazzo della scelta. La Costa d’Avorio è un paese non grande poco meno dell’Italia con quattro milioni di abitanti ma con contrasti molto forti: a nord tribù animiste tra le più tradizionali di tutta l’Africa, i malinké, i senufo, sopratutto i lobi: a sud la grande città di Abidjan, la più bella e la più moderna del continente nero. Anche dal punto di vista naturale, la Costa d’Avorio è un paese, come si dice, di contrasti. A nord c’è la fascia della boscaglia; a sud, la foresta equatoriale, in parte ancora inesplorata (in francese forét à galerie, Cioè la foresta i cui alberi giganteschi, congiungendosi coi rami, creano delle vere e proprie gallerie vegetali). A questi aspetti più ovvi se ne aggiungono tantissimi altri di tutti i generi, così che, in fondo, potrei scrivere di tutto ossia, come si dice oggi nel gergo dell’industria culturale, ” a livello” indifferentemente sociologico, politico, culturale, antropologico, religioso ecc. ecc. Ma, dopo riflessione, alla fine, mi dico che non ne farò nulla. Scriverò invece un diario di pure e semplici impressioni; e poiché mi trovo in un paese che si chiama Costa d’Avorio lo chiamerò ” diario avorio”, immaginando di scriverlo via via in un libro dalla rilegatura d’avorio, simile agli antichi messali ornati di avori intagliati.
Le impressioni che consegnerò in questo diario saranno soprattutto “visive”; quanto a dire che descriverò quello che vedo nonché il “senso” di quello che vedo ma non più che il senso, cioè quello che penso della cosa nel momento stesso che la vedo. Sarà, insomma, il diario di un turista. So bene che le parole turista e turismo sono screditate; e che fanno pensare subito alle agenzie di viaggi, alla pubblicità delle crociere, agli autobus di Rome by night. Ma, dopo tutto, il turismo non è sempre stato soltanto consumismo; originariamente era una forma di educazione sentimentale; si partiva per il tour o per il grand tour per conoscere il mondo e, attraverso il mondo, se stessi; cioè, per constatare con l’esperienza diretta che, pur sotto diversissime apparenze, il mondo era pur sempre uno solo. Il turismo, insomma, era un modo di vedere la realtà non di spiegarla; di raccontarla non di smascherarla. Questa maniera di viaggiare richiedeva soprattutto sensibilità e curiosità; ma alla fine si rivelava più proficua delle inchieste dei cosiddetti esperti, perché informava il lettore non già delle cose divulgabili e approfonditi che tutti possono sapere ma di quelle che il viaggiatore era stato solo approvare, cioè appunto, come ho detto, delle sue impressioni.
D’altra parte le cose che si vedono cambiano molto meno di quelle che si pensano; e se cambiano questo avviene a causa del passare non già della moda ma del tempo. E infatti il turismo in passato è stato praticato da viaggiatori cui libri si leggeranno ancora quando quelli di molti sociologi, economisti, etnologi e storici saranno dimenticati perché, come si dice, superati. A questa categoria di scrittori turistici che ci hanno tramandato le loro impressioni, appartiene, per esempio, Stendhal, tanto per fare un solo nome. Stendhal non è mai stato in Africa; ma sono sicuro che se ci fosse stato, mi avrebbe parlato, come ha parlato dell’Italia: impressionisticamente, senza cercare di spiegarla e giudicarla, limitandosi ad evocarla e a descriverla.
«Lettere dal Sahara all’epoca della prima pubblicazione fu accolto abbastanza tiepidamente e duramente criticato da sinistra: si accusava Moravia di superficialità, di mancato approfondimento sociale e politico, di scarsa empatia con le popolazioni locali, di avere un approccio paternalistico, quasi da colonialista illuminato. Lui si difese rivendicando la propria natura di scrittore, precisando di non essere un giornalista ma piuttosto un artista “che dipinge la realtà che vede, affascinato dalle sensazioni che questa produce in lui, senza dover per forza svolgere delle inchieste, fare il punto della situazione e quindi spesso sorvolando su questioni importanti del contesto politico o sociale dei luoghi che visita”. E a dire il vero proprio in Lettere dal Sahara Moravia sottolinea: “Le impressioni che consegnerò in questo diario saranno soprattutto visive; quanto a dire che descriverò quello che vedo nonché il “senso” di quello che vedo ma non più che il senso, cioè quello che penso della cosa nel momento stesso che la vedo. Sarà, insomma, il diario di un turista”». (Mangialibri, blog on line).
Nel 1982 Moravia pubblica un nuovo romanzo, 1934, strutturato in 15 brevi capitoli con un narratore autodiegetico:![1934 da Moravia, Alberto [A. Pincherle]: (1982) | Libreria Antiquaria Pontremoli SRL](https://pictures.abebooks.com/inventory/18889144324.jpg)
Ambientato a Capri, vi si racconta la storia di Lucio, giovane intellettuale antifascista italiano, che si domanda, alla stregua del Werther di Goethe, se sia possibile vivere nella disperazione senza desiderare la morte. Sul battello per l’isola, incrocia gli occhi di una giovane tedesca con cui intesse un’intensa e articolata conversazione fatta di sguardi. Lucio se ne innamora perché legge negli occhi di lei la sua disperazione; Lucio, nonostante lei si accompagni ad un marito geloso, ormai innamorato, li segue. Riesce ad alloggiare nello stesso hotel e, durante la cena si siede accanto alla coppia, riprendendo a “dialogare” con gli occhi con la giovane ragazza, il cui nome è Beate, tentando in ogni modo di strapparle un appuntamento, perché Lucio, alla ricerca di “stabilizzare” la disperazione attraverso l’amore o la letteratura, percepisce che la giovane tedesca è sinceramente interessata a lui. Nei giorni seguenti Lucio rincorre Beate dovunque, cercando il suo sguardo: sente, nel vedere quegli occhi, che ha qualcosa di grande in comune con lei, quella stessa disperazione che in Lucio vuole essere “stabilizzata”. Capisce dunque che lui stesso potrebbe “salvarla”, e condividere il lo stato comune, risparmiando a entrambi il suicidio. Inaspettatamente Lucio riesce, dopo svariate “conversazioni” fatte solamente di sguardi, a parlare con Beate: poche parole, e uno strano appuntamento: Beate si accorda con Lucio di venirlo a trovare quella stessa notte; in cambio Lucio avrebbe dovuto fare con lei “una certa cosa”; siccome Lucio era venuto a conoscenza della passione nutrita da Beate per Kleist, sul quale lo stesso Lucio si era laureato all’università di Monaco e di cui sta traducendo un racconto, egli subito associa quella “certa cosa” al suicidio a due: Kleist infatti si suicidò nel 1811 con l’amica Henriette Vogel. In attesa di Beate Lucio fa la conoscenza di una governante caprese di origini russe, Sonia, un ex appartenente al Partito Socialista Rivoluzionario, una “morta vivente” di cui Lucio si interessa e con la quale trascorre il tempo prima della mezzanotte. Di qui un improvviso cambio di scena: Beate parte senza far visita a Lucio. Il giorno prima aveva però annunciato a Lucio l’arrivo a Capri della sua sorella gemella Trude insieme alla madre; eccola, infatti, la sera stessa: con sorpresa egli vede Trude e fa subito la sua conoscenza assieme alla madre, Paula. Dopo la cena Lucio e Trude passeggiano per le vie del paese al chiaro di Luna, ma Lucio è confuso e lo sarà anche nei giorni seguenti; lui ama Beate, eppure Trude le assomiglia così tanto fisicamente, ma si rende conto di avere di fronte due persone caratterialmente opposte: Beate riservata, misteriosa, dagli occhi oscuri e profondi; Trude vulcanica, irriverente e sfacciata, dagli occhi scintillanti. Di nuovo, Lucio cade in una profonda riflessione: Trude aveva materialmente soppiantato Beate, ma Lucio amava la spiritualità di quest’ultima. Trude, interessata a Lucio, propone al giovane italiano di inscenare una sorta di teatro in cui la stessa Trude avrebbe preso le parti, anche quella spirituale, di Beate e con cui lui avrebbe potuto soddisfare le sue voglie. Lucio è ancora più confuso, ma improvvisamente Paula dialogherà con il giovane intellettuale raccontandogli che Beate non è mai esistita e che lo scambio di persona è stato solo un gioco innocente: lei in realtà non è la madre di Trude bensì l’amante, ed insieme volevano solamente divertirsi alle spalle di un casanova italiano qualsiasi. A questo punto, stordito ma allo stesso tempo cosciente, Lucio capirà “il teatro nel teatro” messo in piedi da Beate; anche Paula stava mentendo: Trude era un’invenzione, una caricatura, mentre la donna reale è lei, Beate, la disperata Beate dagli occhi tristi. Ma la verità e lo “scherzo” venuto alla luce nulla saranno di fronte al destino mortale di Paula e Trude, rivelatesi disperate amanti e complici, in un intreccio “pieno di letteratura” e dettato dal sottile legame di amore e morte.
Parlando di 1934 non possiamo non riflettere su un dato: nel 1934 Moravia era un ventisettenne antifascista letterato come il Lucio del romanzo; ma il dato si ferma lì: lo stesso Moravia sottolinea come non vi sia nulla autobiografico. Un elemento più importante è la presenza culturale tedesca: Nietzsche con il suo Così parlò Zarathustra e una poesia al suo interno che diventa “messaggio” esplicito del protagonista per Beate; lo stesso filosofo tedesco che, differenziando caratterialmente le due “supposte” gemelle sembra ricalcare lo spirito apollineo e dionisiaco de Lo spirito della tragedia e, centrale in tutto il romanzo, Kleist e Henriette Vogel, suicidatosi insieme, risposta per Lucio dell’impossibilità di scindere Eros e Thanatos; ancora Dürer e l’Espressionismo nella descrizione di un tedesco che si accinge ad ascoltare il discorso del Fuhrer in radio, richiamato per il quadro Ritratto di un giovane uomo; inoltre non bisogna dimenticare il titolo del romanzo, 1934, anno della Notte dei lunghi coltelli e quindi dell’edificazione del nazismo in Germania. Letterariamente invece il romanzo si distingue per un richiamo alle tematiche pirandelliane che affermano che la vita è una maschera e quindi tutto è teatro; infine, vi è un esplicito riferimento alla sua ultima produzione, in cui si affronta il tema del doppio: Rico e Federico Rex (Io e lui); Desideria e la Voce (La vita interiore) e qui Beate e Trude due anime in una persona.
STABILIZZARE LA DISPERAZIONE
Devo dire che, posando sulla scrivania la cartella del romanzo, non ho potuto fare a meno di provare un senso di colpa. Ero andato pochissimo avanti e invece non si trattava di un romanzo qualsiasi, La cui scrittura si può rimandare ad un futuro anche lontano; ma proprio di un certo romanzo particolare, collegato coi problemi attuali della mia vita e, nelle mie presenti condizioni, assolutamente necessario. Forse non sarà male che chiarisca questo punto.
Come ho già accennato, da alcuni anni ero ossessionato dall’idea di “stabilizzare” la disperazione. Soffrivo di una forma di angoscia che, appunto, consisteva nel loro sperare nulla né nel futuro immediato né in quello più lontano; il mio pensiero accarezzava frequentemente la soluzione del suicidio sia come liberazione dall’angoscia, sia come sbocco logico è inevitabile della mancanza di speranza. Ma, purtroppo o per fortuna, non siamo completamente uomini; anzi, lo siamo soltanto minima parte, diciamo un due per cento; per il rimanente novantotto per cento siamo animali. Di conseguenza, alla soluzione del suicidio, così razionale e umana si opponeva la parte animale e irrazionale, non abbastanza forte per abolire la disperazione, ma sufficiente a impedire quello che nella cronaca nera dei giornali va di solito sotto il nome di “gesto insano”.
Era un alternarsi continuo, nel mio animo, del due per cento di umanità e del novantotto per cento di animalità, per cui ora mi pareva che il suicidio fosse altrettanto maturo che è un frutto su un albero e bastasse alzare la mano per coglierlo, e ora invece mi avveniva, come adesso, per esempio, dopo l’incontro sul vapore, di tendere con ogni mezzo alla soddisfazione dei miei desideri. Quest’alternarsi contradditorio della disperazione e del desiderio mi umiliava. Come? Ero disperato, disperatissimo; ciò nonostante, nello stesso tempo, mi imbarcavo ad occhi chiusi nelle passioni proprie della mia età!
Alla fine mi e venuta l’idea che, immobilità per immobilità e contraddizione per contraddizione, tanto valeva “stabilizzare” consapevolmente e volontariamente la disperazione. Cosa intendevo per “stabilizzare”? In qualche modo, immaginando che la mia vita fosse uno Stato, istituzionalizzare la disperazione, cioè riconoscerla, diciamo così, ufficialmente come legge dello Stato medesimo; tutto questo grazie ad una presa di coscienza che mi avrebbe permesso di creare un equilibrio infrangibile tra disperazione e desiderio. Ma in che modo raggiungere la presa di coscienza? Qui interveniva il romanzo che avevo intenzione di scrivere. Nella misura in cui sarei avanzato nella scrittura, la mia vita interiore si sarebbe allontanata dall’idea del suicidio, pur restando imperniata su quella della disperazione. E questo perché avrei raccontato, appunto, nel romanzo, la storia di un uomo che finisce per uccidersi; cioè avrei trasferito sulla pagina ciò che restava lo stato di intenzione nella vita. In questo modo, attraverso l’esercizio della letteratura, avrei ottenuto che la disperazione ormai “stabilizzata” perché intellettuale, diventasse quello che credevo fermamente che, ai nostri giorni, doveva essere: la condizione normale dell’esistenza.Tutto questo, però, per quanto sentito come necessario, anzi indispensabile per continuare a vivere, era soltanto uno schema, qualche cosa, cioè, di simile a uno scheletro che andava a rivestito di carne o, se si preferisce, ha un tema narrativo che andava articolato e risolto in un racconto, con situazioni, personaggi, ambienti, ecc.
Allora sono cominciate le difficoltà. Mi sono accorto, infatti, che per mettere in piedi un personaggio sul quale scaricare l’ossessione del suicidio, non bastava la motivazione generica che era disperato; dovevo anche trovare il motivo per cui lo era. Dopo molte riflessioni, ho finito per identificare questo motivo dell’avversione irriducibile per il regime fascista che, in questo giugno del 1934, sta aumentando nel settimo anno di permanenza al potere. Era questo, certamente, un motivo plausibile di disperazione per un personaggio di romanzo; ma, per quanto mi riguardava personalmente, sapevo benissimo che pur nutrendo la stessa avversione non mi sarei certamente ucciso a causa del regime politico allora dominante in Italia.
Alla riflessione, mi appariva infatti che il suicidio, almeno nel mio caso, era una tentazione, per così dire, “prepolitica” a cui la politica avrebbe potuto, al massimo, fornire una giustificazione in più. In realtà, come pensavo, non mi sarei sentito meno disperato se il fascismo fosse caduto o, addirittura, fosse cambiato l’intero sistema sociale. Ma il mio personaggio doveva invece avere un motivo preciso, concreto e, soprattutto, unico, di uccidersi. Se i motivi fossero stati vaghi, astratti e soprattutto numerosi, sospettavo che avrebbe forse finito per non uccidersi affatto, impedendomi così di stabilizzare la disperazione e costringendomi a fare direttamente nella vita quello che non ero riuscito a fare indirettamente nel romanzo. No, il mio personaggio doveva uccidersi per permettermi di non uccidermi; e doveva uccidersi per una disperazione causata da un preciso motivo politico allo scopo di permettermi di continuare a vivere in una disperazione priva di motivi.

Elsa Morante e Alberto Moravia a Capri
Ci dice Minore, nell’Introduzione all’opera: «che il romanzo è (anche secondo le intenzioni più volte rese esplicite da Moravia nelle interviste che lo hanno accompagnato) volutamente “retro” nel senso che esso assume una data immediatamente allusiva per i lampi ed i segnali che essa contiene: appunto il 1934, che segna il definitivo trionfo nazista, con la “notte dei lunghi coltelli” (la cui eco si riverbera nelle pagini finali). E’ l’inizio di quella mutazione antropologica di massa che porta alla catastrofe. In questo anno si svolge la storia di Lucio, ventisettenne italiano in vacanza a Capri, il quale è costituzionalmente antifascista, ma soprattutto appare immerso in una permanente condizione di “disperazione” che si direbbe letteraria ed esistenziale. Essa appare diversamente connotata rispetto ad altri sentimenti moraviani: come l’“indifferenza” o la “noia” che, in modi non omologhi, sono la constatazione di un rapporto con la realtà, con gli oggetti o le persone. La disperazione nasce da una sorta di eccesso di vitalità e di attenzione “romantica” al destino che non trova sfogo, se non attraverso la puntigliosa consapevolezza della sua esistenza, degli interrogativi che il sapone, delle specificità comportamentali che vuole». La consapevolezza, appunto come dice Minore, non può che trovarla nell’“istituzionalizzazione” del dolore, cioè nel ritenerlo come dato costitutivo dell’essere umano, quindi “interno“ all’uomo stesso. Da qui il tono razionale del testo: Lucio s’interroga e indaga se stesso sulla disperazione confrontandosi con quella di Beate quindi con la sua negazione di Trude.
Sempre nello stesso anno escono le Storie della preistoria, che potremo definirle un divertissement il cui pubblico di riferimento, per l’unica volta in tutta la sua produzione, è quella dei ragazzi (ne uscirà anche un’edizione scolastica).
Si tratta di 24 fiabe che, come tali, hanno come protagonisti animali antropomorfizzati: se gli animali sono “preistorici” è evidente che il riferimento per la stesura di questo volume non può essere che l’Africa da lui spesso definita, nei suoi viaggi, continente prima della storia; ma sentiamo nel suo interno anche l’eco dei grandi favolisti classici (Esopo e Fedro) europei (Le Fontaine), nonché per lo spirito il Leopardi delle Operette morali:
I SOGNI DELLA MAMMA PRODUCONO MOSTRI
Alcuni miliardi di anni fa, tutto era molto più alla buona di oggi e si poteva andare da Na Tura ed esporle delle lagnanze sul modo col quale lei andava creando il mondo. Madre Na Tura era una donnona gigantesca, così grande che, se uno le saliva sulla testa, anche con un buon cannocchiale non arrivava a vederne i piedi; stava distesa in una pianura sterminata, avendo come guanciale una montagna e come giaciglio un deserto; e creava il mondo sognando. Ma i suoi sogni non erano come i nostri, che una volta svegli, addio, chi se li ricorda più; i sogni di madre Na Tura diventavano immediatamente realtà. Per esempio: uno di quei giorni madre Na Tura sognò un animale strano davvero: una specie di ombrello che camminava con quattro zampe e aveva una testa e una coda. Ed ecco, subito, nel grembo di madre Na Tura, ecco annaspare penosamente la ridicola Tarta Ruga. E volete sapere perché mai avesse sognato un animale così? Perché qualcuno era venuto a dirle che sarebbe stato bene creare un animale il quale, quando pioveva, potesse ripararsi dalla pioggia senza ricorrere a qualche caverna o anfratto. Questo per dirvi che madre Na Tura aveva carattere affettuoso e compiacente, proprio come si conviene ad una madre.
Basta, uno di quei giorni una deputazione di Maia Lini, dopo una scalata di molte ore arrivò fino alla cima della montagna sulla quale madre Na Tura appoggiava la testa: Il capo della deputazione, fattosi sotto l’orecchio colossale, urlò, con quanta voce aveva in gola: «Mamma! Mamma! Mamma». Madre Na Tura sollevò una palpebra grande come una cupola, con ciglia ognuna grossa come un tronco d’albero, scoprendo la pupilla glauca che pareva un lago, e domandò languidamente: «Caruccio, che hai? Dillo alla tua mamma che hai.» A questa affettuosa domanda, il Maia Lino rispose: «Come tu sai, noi Maia Lini, siamo una comunità pacifica, in cui tutti godono gli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri. Ma da qualche tempo non è più così.» «E cioè?» «Cioè, alcuni di noi, non sappiamo se per tua volontà o per caso, si sono trasformati e, duole dirlo, non per il meglio: la delicata pelle rosea si è ricoperta di setole nere; dalla bocca sporgono alcuni denti aguzzi e ricurvi che è difficile non chiamare zanne. Questi individui che si sono, da sé, denominati Cin Ghiali, sono violenti e prepotenti e, grazie alle loro zanne, hanno creato una vera e propria tirannide per cui loro comandano e noi dobbiamo ubbidire. Madre Na Tura provvedi un po’ tu.»
Madre Na Tura obiettò: «Io, veramente, vi avevo creati tutti uguali. Che storia è questa? Dite la verità?»
I Maia Lini le assicurarono in coro che era la verità: Madre Natura rifletté, sospirò; poi disse: «Quelle cosiddette zanne mi fanno pensare che ho fatto un sogno, diciamo, un po’ brutto, qualche cosa come un incubo. Si sa, certe volte mangio pesante e allora può accadere di sognare mostri. Come infatti chiamare se non con il nome di mostro un Maia Lino dalla cui bocca spuntino fuori due zanne?»
«E’ quello che pensiamo anche noi,» esclamarono i Maia Lini.
«E poi,» continuò madre Na Tura, «simili creature prepotenti e sanguinarie contraddicono assolutamente all’idea che mi faccio del Creato nel quale, invece, dovrebbe regnare la ragione.»
I Maia Lini non avevano mai sentito parlare della ragione. Chiesero in coro: «La ragione? Che è la ragione?» Madre Na Tura rispose: «E’ qualche cosa, diciamo, come il sale nelle vivande. Di solito non dimentico di metterne un pizzico in qualsiasi animale mi venga fatto di sognare. Vuol dire che d’ora in poi, ce ne metterò una manciata abbondante. Del resto da qualche tempo provo come un desiderio oscuro di mettere al mondo un certo animale piuttosto complicato che, appunto, dovrebbe essere fornito di ragione in misura maggiore degli altri. Adesso, a cena, starò attenta a mangiare cose leggere, poi mi farò una bella dormita, e mi sa che questa volta sognerò l’animale del tutto ragionevole che, tra l’altro, visse servirà dai vostri malvagi Cin Ghiali. Così, cari Maia Lini, tornate fiduciosi a casa, lasciate fare alla vostra mamma che vi vuole bene e vedrete che tutto si risolverà per il meglio.»
Naturalmente i Maia Lini si ritirarono subito pieni di gratitudine e di timore reverenziale: madre Na Tura, in quei tempi lontani, oltretutto, perdeva la pazienza facilmente: tutta una razza di animaloni chiamati dinosauri virgola che erano venuti un po troppo spesso a esporre le loro lagnanze (avrebbero voluto essere più piccoli e meno stupidi) erano stati spazzati via fino all’ultimo; eppure erano andati avanti a vivere la bazzecola di centocinquanta milioni di anni. Se ne andarono i Maia Lini e, per qualche tempo, diciamo sette o ottocento milioni di anni, non successe nulla. Madre Na Tura, come aveva promesso, si era tenuta leggera cena: appena uno o due vulcani con tutta la lava, innaffiati da un fiume di media portata: adesso dormiva della grossa. Soltanto ogni due o tre secoli, dava un sospiro oppure si rivoltava su un fianco. Ma vedete un po cosa vuol dire essere madre Na Tura! Quei sospiri crearono i venti che ancora oggi soffiano per l’aria; e quanto al rivoltarsi sul fianco, ogni volta che accadde ci fu un terremoto che cambiò in qualche punto la faccia della Terra.
Arrivò finalmente il giorno del risveglio. Era una giornata perfetta, di mattina presto, col cielo del più puro azzurro ancora tinto di rosa; senza un alito di vento; con un sole mite, una luce di limpida, gli alberi mai così verdi, i fiori mai così smaglianti. Madre Na Tura si svegliò, sì levò su un gomito e fece appena in tempo a intravedere, laggiù, in fondo al deserto sul quale stava distesa, due figurette remote che si allontanavano tenendosi fiduciose per mano: un uomo e una donna. Camminavano su due sole gambe; madre Na Tura pensò che questa volta aveva sognato il suo capolavoro. Soddisfatta, segui con gli occhi di due figure che, circonfuse di luce, si allontanavano sempre e alla fine scomparvero. Allora si voltò su un fianco e si addormentò di nuovo.
Il suo sonno durò poco: appena un miliardo di anni.
Aprì gli occhi, sentì in confuso delle voci, si girò: ecco, laggiù, ai piedi della montagna che le serviva da guanciale la solita deputazione dei Maia Lini. Madre Na Tura sporse la mano, ne prese uno tra due dita e se lo portò all’altezza degli occhi. Domandò, poi: «Ebbene, siete ancora voi. Come è andata?»
E quello: «Benissimo, non poteva andare meglio. Hai sognato la cosa giusta al momento giusto.»
«E cioè?»
«Sono venuti dei Maia Lini in in tutto simili a noi, altrettanto rosei, teneri, dolci e inermi, con la sola differenza che noi camminiamo a quattro zampe e loro a due; e ci hanno portati via, lontano dai detestabili Cin Ghiali, in un luogo magnifico, in cui non manca nulla, proprio nulla, per essere felici.»
«E com’è questo luogo,» domandò madre Na Tura con curiosità.
«Sono capannoni ad un piano solo con tanti reparti in ciascuno dei quali può stare alloggiata un’intera famiglia. I Maia Lini a due gambe provvedono affinché non manchiamo di nulla. Così, ad ore regolari, ci servono un pasto prelibato composto di semola, crusca, ghiande e una deliziosa brodaglia nella quale abbondano le mele marce e le patate andate a male. Quindi ci lavano tutti quanti, a fondo, con la pompa.
Ci tengono bene, insomma: tutto è terso, specchiante, scintillante. Figurati che per non farci cascare sugli scalini, allorché usciamo dal capannone per passeggiare all’aperto, hanno persino costruito un piano inclinato sul quale i nostri zoccoli non possono scivolare.»
Madre Na Tura commentò con compiacimento: «Bene, bene, mi sa che questa volta ho sognato l’animale più razionale tra quanti ne ho messi al mondo. Adesso, figli miei, ho sonno e desidero schiacciare un pisolino. Ma voglio che mi teniate informata. Tornate, diciamo, tra un migliaio di anni. Buona notte.»
Passarono mille anni. Madre Na Tura si svegliò, sì stiro e, che è che non è, si trovò naso a naso con il solito Maia Lino che subito le urlò come un forsennato: «Mamma, tradimento, tradimento!»
«E cioè?»
«Quegli esseri che abbiamo chiamato Maia Lini a due gambe, sono dei mostri, degli autentici mostri. Ci trattano bene, ci tengono puliti e pasciuti, ci ingrassano; ma lo sai perché?»
«No, perché?»
«Per mangiarci. Ad un certo momento, quando siamo grassi al punto giusto, ecco, ci legano per i piedi ad una specie di catena che scorre. La catena scorre con un fracasso terribile, e loro, via via, ci sgozzano, ci dissanguano, ci fanno a pezzi. Non insisto sul modo con il quale questi pezzi vengono poi preparati; basti dire che veniamo trasformati in tanti oggetti che loro, a quanto pare, chiamano salsicce, prosciutti, zamponi, salami e così via, secondo la parte del nostro corpo che vi è stata adoperata: orrore, orrore, orrore. E tu ci avevi promesso che avresti sognato l’animale più fornito di ragione del Creato. Ahimè, lui la ragione l’adopera per divorarci! E per giunta per divorarci con la nostra stessa collaborazione! Ahimè, mamma, anche tu ci hai tradito!»
Adesso qualcuno vorrà sapere che cosa rispose madre Na Tura acquisto accuratissimo e disperatissimo rimprovero. Nessuno ci crederà: non rispose nulla. Prese tra due dita il Maia Lino, lo depose con delicatezza in terra, 15 giro su un fianco e si addormentò di nuovo.

Un disegno che accompagnava Le storie della preistoria
Moravia nel descrivere la Na Tura di questa fiaba non può non essere stato suggestionato dalla famosissima Operetta morale leopardiana Dialogo di un islandese e la natura: “Ma (l’islandese) fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e non finta ma viva; di volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi,» anche la Na Tura è gigantesca, e forse anche nello scrittore romano “indifferente”. Ricordando il finale dello scrittore recanatese in cui la Natura affermava il “disinteresse” per la felicità dell’uomo, la Na Tura moraviana è altrettanto “inconsapevole”: è il sogno a determinare il Creato: il fatto poi che l’ultimo sogno abbia generato un essere razionale e che questo essere razionale usufruisca della propria ragione per fare del male, non ci allontana dalla disillusione leopardiana rispetto alla Natura. Infatti il testo è puntellato di storie in cui il mondo primordiale “animale” ripete le nostre inquietudini e incapacità: è che Moravia, al contrario di Leopardi, non vuole “rivestire” i suoi racconti di verità; le basta sorridere sulla vanità, sull’impossibilità del desiderio, sull’amore impossibile: tutto con estrema leggerezza ed il sorriso.

Nel 1983 Moravia pubblica La cosa e altri racconti dedicando il volume alla nuova compagna Carmen Llera che le starà a fianco sino alla morte. Si tratta di 20 racconti, in cui il nostro si misura, per la gran parte di essi, sull’erotismo: ci dice Moravia che essi sono nati allo stesso modo in cui è venuto alla luce il suo primo romanzo, Gli Indifferenti.
Infatti egli scrive sdraiato a letto, a seguito di un incidente stradale che le ha procurato la frattura del femore, meditando sulle sua “capacità vitale” alla soglia del settantacinquesimo anno e neosposo di una giovane donna (ben 44 anni di differenza di età). Tuttavia il sesso descritto in queste pagine continua ad essere l’unica tensione in personaggi incapaci di rapporti con la realtà; per meglio dire è solo attraverso la pulsione sessuale, il suo vagheggiamento, l’agognato rapporto fisico con l’altro che l’uomo può ritrovare se e la conoscenza di se. Quindi per Moravia la sessualità ha un vero è proprio compito gnoseologico.
Nell’opera non vi sono soltanto racconti erotici; ne è un esempio Tuono rivelatore in cui, attraverso ellissi narrative, ci viene rappresentata la fuga di un uomo adulto da una situazione di pericolo e l’approdare, attraverso il flash-back, in un’epoca lontana, sicura, dal sapore edipico: quindi il suo perdersi indefinito nell’uscire dalla scena e quindi da sé:
TUONO RIVELATORE
Erano cinque giorni che fuggivo a zig zag per far perdere le mie tracce, da Parigi ad Amsterdam, da Amsterdam a Londra, da Londra ad Amburgo, da Amburgo a Marsiglia, da Marsiglia a Vienna, da Vienna a Roma, ora in treno e ora in aeroplano, senza dormire o dormendo poco e scomodamente; avevo ormai più voglia di dormire che di vivere Virgo e credo che mi sarei addormentato anche davanti a quello stesso plotone di esecuzione del quale cercavo scampo con questa mia fuga senza fine. Avevo tanto sonno, al mio arrivo a Roma, che quando, alla stazione Termini, mio figlio, come d’accordo, mi è venuto incontro, gli ho chiesto per prima cosa se mi aveva trovato un luogo dove potessi dormire al sicuro. Mi ha risposto che avrei avuto un appartamento tutto per me e che lì potevo dormire a quanto volevo, Nessuno al mondo conosceva l’esistenza di questo appartamento all’infuori di lui.
Intanto mi aveva preso di mano la valigia e mi camminava accanto mentre uscivamo dalla stazione. Non ho potuto fare a meno di guardarlo: erano quasi due anni che non lo vedevo. Mi è sembrato, così in confuso, data la mia estrema stanchezza, che non fosse cambiato in nulla salvo in due particolari: la barba che un tempo non aveva; e la fissità inquietante degli occhi, anche questo una cosa nuova. L’ho ringraziato di essere venuto e di avere trovato l’appartamento; gli ho detto che sua madre, rimasta a Parigi, lo mandava a salutare; gli ho anche detto, con sincero compiacimento, che avevano un aspetto buonissimo, migliore dell’ultima volta, due anni prima, che ci eravamo visti. Mi ha risposto che questo dipendeva dalle soddisfazioni del lavoro: era entrato a far parte di una impresa di export-import; guadagnava bene; per ora abitava all’albergo ma presto avrebbe messo su casa tanto più che si era fidanzato con una ragazza italiana e contava di sposarsi al più presto. Intanto che mi forniva sorridendo queste informazioni, eravamo arrivati all’automobile. Ho messo la mia valigia nel portabagagli, sono salito, lui si è seduto sul volante e siamo partiti.
Non conosco troppo bene la città di Roma; però ho seguito con attenzione, più che altro per curiosità, il percorso della macchina e ho riportato l’impressione, che da un semaforo all’altro, abbiamo attraversato tutto il centro antico della città, quindi abbiamo varcato un ponte e siamo passati dall’altra parte del Tevere. Mio figlio, pur guidando, non cessava un momento di discorrermi affettuosamente; diceva quanta era contento di vedermi dopo una così lunga separazione; faceva dei progetti per l’avvenire mio e di sua madre.
Ora correvamo lungo il Tevere. Dalla macchina potevo vedere la sponda opposta, dall’altra parte del fiume, folta di alberi in cui gonfi fogliami argentei arrivavano a sfiorare le acque gialle e lucide. Dietro gli alberi si allineavano le case; al di sopra delle case, grandi nuvole temporalesche, nere e minacciose, salivano su rapidamente ad occupare la parte del cielo rimasta ancora azzurra. Mio figlio mi ha detto che senza dubbio stava per venire un temporale; era sempre così, da alcuni giorni: la mattina faceva bel tempo, poi la giornata si guastava e, nella notte, infallibilmente, scoppiava un uragano, con vento, tuoni, lampi, pioggia.
La macchina corso per un pezzo sul largo asfaltato del lungotevere, sapendo da una parte i parapetti del fiume e dall’altra una fila ininterrotta di casamenti; quindi si è fermata in un punto tranquillo e privo di traffico, attraversato da una di quelle barriere dipinte di rosso e di bianco che si mettono quando una strada non è transitabile. Mio figlio mi ha spiegato che in quel tratto il greto del fiume era crollato; vi si facevano da tempo dei lavori di sistemazione; per questo motivo non ci passavano le macchine e così era una vera e propria oasi di pace nel mezzo della città affollata e tumultuosa. Sono disceso dalla macchina e mi sono guardato intorno: effettivamente il lungotevere qui era quasi deserto: due o tre monelli si rincorrevano con i pattini; una coppia di innamorati camminava lentamente tenendosi per la vita; in una macchina ferma presso il parapetto, un uomo e una donna ascoltavano la radio.
Ho alzato gli occhi verso il cielo: il temporale si stava addensando sempre più; l’azzurro era ridotto ad un piccolo squarcio intorno il quale le nuvole premevano tumultuosamente, l’una contro l’altra, come per mancanza di spazio. Mio figlio, tutto ridente, mi ha fatto notare ancora una volta la tranquillità del luogo: «Non è forse un posto ideale per chi non vuole farsi notare?» Quasi senza pensarci, ho risposto: «E’ anche un luogo ideale per assassinare qualcuno, appunto, senza farsi notare.» Mio figlio mi ha battuto la mano sulla spalla: «Via, via; d’ora in poi non devi più pensare a cose simili. D’ora in poi devi fidarti di me; ci penserò io a organizzarti una vita serena e sicura.»
Adesso aveva estratto un mazzo di chiavi e si era avvicinato al portone di una di quelle palazzine; ha detto che non c’era portiere che, in tal modo, potevo uscire ed entrare quando volevo senza essere né visto né sorvegliato. Siamo entrati nell’androne ma non abbiamo preso l’ascensore: l’appartamento stava pian terreno. Mio figlio ha aperto la porta e mi ha preceduto nell’ingresso del quartierino che mi è subito apparso assai squallido, di quel particolare squallore opaco e stanco che è proprio delle case che sono rimaste a lungo disabitate. I mobili erano del tutto anonimi, quasi più da ufficio che da abitazione; ed erano ridotti al puro necessario: nel salotto c’erano soltanto un divano e due poltrone; nella camera da letto, soltanto il letto, una seggiola e un tavolino. C’era pure una cameretta, presso il piccolo ingresso, con un giaciglio disfatto sul quale qualcuno pareva aver dormito di recente. Siamo passati davanti alla cucina, e allora ho visto, ritta davanti al fornello, una giovane donna africana. Ho chiesto a mio figlio chi fosse quella donna e lui mi ha risposto che era una cameriera somala che mi avrebbe cucinato e fatto le pulizie per tutto il tempo che avrei abitato nell’appartamento. «Parla la nostra lingua,» ha soggiunto mio figlio, «di lei ti puoi assolutamente fidare».
Ci siamo messi a sedere nella camera, io sul letto e mio figlio sulla seggiola; quasi subito, la somala è entrata portando sul vassoio la cena or ora cucinata. Mentre il con gesti e aggraziati, chinandosi in avanti, disponeva i piatti sul tavolino l’ho guardata e ho notato che era alta, flessuosa ed elegante, con le spalle larghe, le braccia tonde e forti, i fianchi stretti, nel suo genere una vera bellezza. Ha disposto i piatti, ha fatto un leggero inchino, guardandomi direttamente negli occhi, come se avesse voluto farmi capire qualche cosa virgola e poi se ne è andata. Mio figlio mi ha invitato a mangiare; ho gettato uno sguardo ai piatti e ho visto che contenevano il cibo tradizionale del nostro paese, cucinato, a quanto si sarebbe detto, con ogni cura; ma appena ho pensato distendere la mano a prendere qualche cosa, ho provato una insormontabile quanto misteriosa ripugnanza e ho detto a mio figlio che non avevo fame, avevo soltanto sonno e mi lasciasse adesso riposare e poi ci saremmo visti il giorno dopo e allora avrei fatto tutte le cose normali della vita, a cominciare dal fare onore all’ottima cucina nazionale preparata dalla cameriera somala.
Mio figlio è rimasto un po’ sconcertato da questo mio rifiuto; ha insistito affinché io mi nutrissi almeno un poco; altrimenti, ha detto, mi sarei ammalato, visto che secondo la mia stessa ammissione non mangiavo da un giorno. Ho risposto che la paura mi aveva tolto ogni appetito; adesso avrei dormito; dormendo la paura mi sarebbe passata; al mio risveglio, avrei avuto fame di nuovo e allora avrei pensato a mangiare. Malcontento ma rassegnato, mio figlio ha chiamato per nome la cameriera; la somala è riapparsa; mentre rimetteva i piatti sul vassoio, chi è di nuovo inchinata pezzo di me, guardandomi dritto negli occhi, prima di uscire. Mio figlio adesso si era alzato in piedi improvvisamente, vi accettato le braccia al collo, baciandomi sulle due guance e dicendo che adesso dormissi pure: ci saremmo rivisti il giorno dopo.
Non so perché, nonostante il tormento di quella terribile voglia di dormire, appena mio figlio è uscito dalla stanza, ho ricordato che mentre mi abbracciava, avevo sentito la sua mano palparmi non già sulle spalle che sarebbe stato normale, ma lungo i fianchi giù giù fino alla base della schiena, un gesto insolito e improbabile da parte sua: a quel modo si palpano le persone sospette, per vedere se hanno armi. A questo ricordo, e seguito un desiderio improvviso di osservare di nuovo mio figlio. Mi sono precipitato alla finestra, ho disserrato le imposte, ho guardato fuori.
Proprio in quel momento lui usciva dalla casa e saliva in macchina. Ancora una volta senza motivo, ho indugiato alla finestra per seguire con gli occhi la macchina mentre si allontanava. Ma la macchina non è andata molto lontana. Alla bandiera rossa e bianca, si è fermata. Un uomo che stava seduto in posa oziosa, con le gambe penzolanti, sul parapetto, ne è disceso, è accorso alla macchina. Mio figlio gli ha aperto lo sportello e la macchina è ripartita.
Non ho pensato nulla. La mia mente era occupata dal sonno allo stesso modo che una fitta nebbia occupa un paesaggio impedendo di veder quello che sia. Ho chiuso la finestra, mi sono gettato sul letto, tutto vestito com’ero e sono rimasto per poco supino e con gli occhi aperti. La porta della camera era socchiusa; mi sono detto che avrei dovuto chiuderla a chiave; ma non ce l’ho fatta. La somala doveva essere in cucina; la sentivo cantare sottovoce non so che nenia del suo paese. Cullato da questo canto sommesso che pareva, come gli sguardi di poco fa, destinato esclusivamente a me, mi sono addormentato.
Ho dormito con violenza, come protestando contro qualche cosa, forse contro il sonno stesso. Tutto il tempo sentivo che stringevo con forza i denti e con rabbia i pugni. Ad un certo momento, nella notte, ho sentito il tuono rotolare cupo e fragoroso e poi, negli intervalli di questo rotolare, propagarsi il fruscio della pioggia. Allora, pur dormendo, mi è sembrato di vedere il vasto asfalto del lungotevere tutto ribollente sotto lo scroscio dell’acquata; poi lampeggiava forte e io scorgevo un uomo seduto sul parapetto in atteggiamento ozioso, il quale, di improvviso ne scendeva e si dirigeva verso una macchina ferma sotto la pioggia e io sapevo che nella macchina si trovava mio figlio. Ho rivisto questa scena parecchie volte: l’uomo stava seduto, poi scendeva e correva verso la macchina e poi eccolo di nuovo seduto che scendeva e correva e così via e così via.
Alla fine, però, pur nel sonno, a forza di sentire suonare e scocciare la pioggia, nella mia mente si è formata questa domanda: “Dove e quando ho sentito questi tuoni, questo scroscio?” Pur sempre dormendo mi sono dato la risposta: dell’infanzia. Sono più vicino ai sessant’anni che ai cinquanta; mi ricordo mi faceva tornare indietro di mezzo secolo. Ero nella casa paterna, mi svegliavo di soprassalto nel buio, sentivo lo scroscio della pioggia e il fracasso del tuono, allora mi levavo dal letto e correva a rifugiarmi nella camera accanto, tra le calde sicure braccia di mia madre. Così adesso. Mi sono alzato ad un tratto con istintivo, irresistibile impulso, ho attraversato la stanza e sono uscito nel corridoio.
La porta della camera in cui dormiva la somala era socchiusa; c’è il buio nero come la pece e la luce violenta ed effimera dei lampi, mi sono affacciato. Non ho voluto accendere la lampada; pensavo che mi sarebbe bastato intravedere la donna tra un lampo e l’altro, come avevo intraveduto mia madre quella notte, cinquanta anni addietro. E così è stato. Ogni tanto lampeggiava e allora vedevo la somala che dormiva profondamente, la guancia appoggiata sulla Palma della mano, il corpo avvolto nel lenzuolo, il braccio nudo ripiegato. L’ho spiata così, tra un lampo e l’altro, a lungo; ricordavo il suo sguardo direttamente rivolto verso di me mentre serviva e sparecchiata la cena; e mi domandavo che cosa avesse voluto dirmi che se veramente era lei che voleva dirmi qualche cosa o ero io che desideravo che qualche cosa mi fosse detto. Alla fine mi sono sentito più calmo e padrone dei miei nervi. Allora mi sono ritirato chiudendo dietro di me la porta, sono tornato nella mia camera. In realtà mentre contemplavo la donna addormentata, avevo preso una decisione e adesso non mi restava che metterla in atto.
Ehi ho aspettato disteso supino sul letto ancora un paio d’ore; quindi nel primo chiarore, mi sono alzato, ho preso la mia piccola valigia e sono uscito in punta di piedi dalla stanza. Nel corridoio, posso stato un momento davanti alla porta della somala e ho ascoltato, chissà perché. Ma non mi è giunto nessun rumore: dormiva. Ho aperto l’uscio, ho attraversato l’atrio che sono uscito sul lungotevere. Era l’alba, con tutti gli alberi inzuppati di pioggia; l’asfalto sparso di lucide pozze d’acqua; il cielo color mastice, tra il bianco e il grigio. Nel momento in cui chiudevo il portone, i fanali ancora accesi dei marciapiedi si sono spenti tutti insieme. Ho preso a camminare di buon passo verso il ponte più vicino.

Alberto Moravia con la nuova compagna Carme Llera
“Il racconto s’inserisce in una posizione mediata tra il reale e il mito che ad esso direttamente si aggancia. Da tale punto di vista, la fuga del padre dal plotone di esecuzione, la fuga dal figlio, la tecnica del flash-back (il ritorno all’infanzia che è piuttosto il ritorno al grembo materno), la corsa del protagonista al ponte più̀ vicino e pertanto il desiderio d’evasione da una realtà̀ insopportabile, il monologo interiore, sono tutti segni che rispecchiano la disintegrazione dell’uomo storico.” (Carolina Messi Albanese)
Moravia torna al romanzo con L’uomo che guarda, edito nel 1985:

Edoardo detto Dodo è un giovane professore universitario di letteratura francese, ex sessantottino, che vive, con la giovane e bella moglie, Silvia, in due stanze nella casa “principesca” del padre al centro di Roma, avendo rifiutato per “contestazione” l’eredità materna di un appartamento nello stesso palazzo. Tranne qualche rara eccezione, le sue giornate si svolgono così: si alza la mattina molto presto, si lava e rade, si veste da intellettuale, scende a comprare i giornali, risale in casa e prepara la colazione per suo padre, barone universitario della facoltà di Fisica, costretto a letto dai postumi di un incidente stradale. La sua caratteristica è guardare il mondo e soprattutto virato verso la scopofilia determinata dalla vigoria sessuale paterna e dall’esibizionismo di Silvia: Nel corso della vicenda scoprirà che la moglie diventa l’amante del padre, riproponendo, in forma rovesciata la vicenda edipica. Il tutto viene amplificato dalla fantasia di Dodo che immagina la fine del mondo per una esplosione nucleare sulla cupola di San Pietro.
DODO
Ore sei e trenta. Dormo poco, non più di sei ore per notte e, appena mi sveglio, dedico cinque, dieci minuti a quella rara occupazione che va sotto il nome di pensiero. A che cosa penso? A dirlo così può persino parere ridicolo: alla fine del mondo. Non so quando e in che modo è cominciata questa abitudine; forse non tanto tempo fa, in seguito alla lettura di un libro che per caso ho trovato sulla scrivania di mio padre che è professore di fisica all’università, un libro tra i tanti sulla guerra nucleare. Oppure sarà stato un altro motivo venuto da chissà dove e poi scomparso dalla mia memoria, come scompare il seme una volta che la pianta è cresciuta. D’altra parte improprio dire che penso alla guerra nucleare. Semmai penso all’impossibilità di pensarci. Ma è fuori dubbio che in quei cinque, dieci minuti dopo il risveglio non penso ad altro
Devo dire che quei pochi minuti della prima mattina quando penso alla bomba sono forse il momento della giornata in cui mi accade di pensare veramente cioè astrattamente e questo perché io vivo soprattutto attraverso gli occhi e quei dieci minuti sono i soli in ventiquattro ore durante i quali mi avviene di essere in condizioni favorevoli al pensare: al buio, senza far nulla, e soprattutto senza alcun oggetto da guardare. Il resto del tempo faccio e vedo sempre qualche cosa e fare e vedere mi impediscono di pensare. Ma cinque, dieci minuti di pensiero in un giorno non sono forse sufficienti? E infatti, il pensiero della fine del mondo ha fatto presto a diventare ossessivo. Durante la giornata lo dimentico, è vero; ma appena mi sveglio, ventiquattro ore dopo, mi accorgo con stupore che è sempre lì, inalterabile, incombente e soprattutto impensabile.
Ore sette. Mi alzo avendo cura di non svegliare Silvia che mi dorme accanto. Cammino tutto nudo e a piedi scalzi (non ho mai posseduto un pigiama, vestaglia, pantofole chissà perché, forse per inconscia polemica contro l’edonismo borghese) e vaso nell’angusto asimmetrico stanzino che mio padre ha ricavato per me e mia moglie in un angolo del suo vasto appartamento. Non c’è vasca, soltanto una doccia là dove il soffitto obliquo è più basso, che Silvia più piccola di me riceve a testa alta e io invece, più alto di lei, a testa bassa.
Dopo la doccia, con gesto abituale, tolgo l’appannatura del vapore dal vetro della piccola finestra e guardo nel cortile, al di sopra delle pareti ritte e nude, verso il cielo, per vedere il tempo che fa. Quindi mi metto davanti allo specchio del lavandino per farmi la barba.
Nasce adesso la questione della barba: debbo raderla o no? Ho una barba fitta e dura che rado con difficoltà; inoltre sono pigro e trasandato e così, praticamente, finiscono per radermi un giorno sì e un giorno no. Intanto che dibatto il dubbio dell’opportunità di radermi un giorno sì e un giorno no, ne approfitto per guardarmi: la mia immagine mi incuriosisce come se fosse quella di un altro.
Sono un bell’uomo sui trentacinque anni, ma non sono un uomo bello: la differenza è importante: Ho un volto dai tratti insieme virili e deboli: occhi chiari, dallo sguardo scrutatore e spesso ironico ma con sopracciglia poco energiche, voltate in giù; naso dritto e deciso che, però, si increspa alle narici con aria schifiltosa; bocca con dentatura bianca e aguzza di lupo ma labbra carnose e molli; capelli neri e vivi ma già radi sulla fronte e alle tempie; mento forse volitivo in partenza che si ripiega su se stesso formando una fossetta nel mezzo. Che più? Vorrei vedere anche il resto della persona ma l’altezza dello specchio me lo impedisce; almeno fino a quando cambierò casa, sarò costretto, la mattina, a vedermi soltanto in faccia.
Tuttavia il resto della persona lo vedo poco dopo essermi vestito, quando passo per l’anticamera e lanciò un’occhiata di sfuggita all’antico specchio oscuro e graffiate che sovrasta la console. No mi riconosco, allora, tra indispettito e compiaciuto, com’è quel particolare personaggio che di solito viene designato col nome di intellettuale. Sì, sono un intellettuale e si vede subito se non altro nel mio modo di vestire, come è da crederci che nel medioevo si vedesse chi era chierico tra i panni che indossava: camicia azzurra, cravatta nera, pullover blu oppure marrone, giacca di velluto a coste verde o beige con fondelli di cuoio ai gomiti, blue-jeans ovvero pantaloni di flanella grigia, scarpe cosiddette da deserto, di camoscio scuro. Ma la spia alla qualità di intellettuale lo fa soprattutto l’aspetto logoro e stanco di questi indumenti: il cuoio dei fondelli è lustro, la camicia è lisa, la cravatta è vecchia e attorcigliata, i pantaloni da tempo hanno perduto la piega. Del resto, all’infuori di questo cosiddetto “spezzato”, non dispongo che di un abito blu per le grandi occasioni: cerimonie, riunioni ufficiali, ricevimenti ecc. ecc.
Ore sette e trenta. Appena vestito, scendo nel vicolo della vecchia Roma in cui si trova il palazzo e vado all’edicola dell’angolo a ritirare i giornali per mio padre. Da quando ha avuto il grave incidente di macchina che lo costringe a letto da ormai tre mesi, sbrigo per lui questa e altre piccole incombenze che non mi sarei mai sognato di addossarmi “prima”. Perché metto tra virgolette “prima”? Perché dal giorno dell’incidente oh, per così dire, scoperto di essere oltre a un intellettuale, anche un figlio.
Nel secondo capoverso Dodo afferma: “io vivo soprattutto attraverso gli occhi e quei dieci minuti sono i soli in ventiquattro ore durante i quali mi avviene di essere in condizioni favorevoli al pensare”. Il protagonista ci sta dicendo che la realtà egli la registra attraverso lo sguardo, osservandola. Ciò significa che lo stesso protagonista, attraverso l’io narrante, ci narra la storia che noi leggeremo “immaginandola” attraverso le parole, ponendoci di fronte ad essa da spettatori, allo stesso modo di un voyeur che guarda la vita essendone estraneo. Moravia sembra ricordare la frase “Chi vive quando vive, non vede, vive” de La carriola di Luigi Pirandello: Dodo infatti guarda, osserva, scruta, attraverso lo sguardo la realtà, ma seguendo l’adagio dello scrittore siciliano, non vive o meglio vive “riservandosi“ di mettersi un po’ in disparte. In “disparte” rispetto a chi? Ma al padre, con cui, seguendo il classico rapporto “conflittuale“ tra padre e figlio si “materializza“ nello sguardo del figlio al membro paterno “estremamente” vitale e senza remore morali (sino ad arrivare a far sesso con la nuora more ferarum), mentre lui, mentre possiede la moglie non può che “guardarla” come una Madonna, cioè un essere divino.
Come può un giovane uomo figlio amare e odiare un altro uomo padre nello stesso tempo?
Come può un giovane uomo figlio sposato con una giovane e bella moglie tollerare e sopportare un altro uomo anziano padre che fa l’amore con la piacente, sensuale, nonché un po’ esibizionista sposa di Dodo?

L’uomo ghe guarda di Tinto Brass tratto dal libro di Moravia
Certamente Moravia ricorre ancora alle tematiche freudiane, sulle quali costruisce una narrazione che vede, come tutta la sua narrazione precedente, un borghese intellettuale che ha difficoltà a vivere, o meglio come tutti i personaggi maschili dei suoi romanzi, siano essi indifferenti o desublimati, incapaci di entrare in sintonia con la vita vera. Non possiamo dimenticare, tuttavia, che tra il padre di Dodo e Silvia possiamo leggere la vera storia di Moravia con la sua nuova giovane compagna, Carme Llera, dando al romanzo una certa vena autobiografica.
L’altro grande tema è quello nucleare: riecheggiano tra le pagine del libro l’interesse quasi ossessivo di Moravia – che nel 1982 aveva visitato Hiroshima realizzando commossi reportage, dal 1984 era deputato europeo nelle liste del PCI e contemporaneamente a questo romanzo scriveva il saggio L’inverno nucleare – per la questione della possibile (e si scoprirà poi, decenni dopo, sfiorata davvero) guerra atomica tra USA e URSS.

Tale discorso non viene meno nemmeno nella pièce L’angelo dell’informazione, dalla struttura di commedia borghese: Dirce (la donna), Matteo (il marito), Vasco (l’amante). Ma l’immancabile tema del “triangolo” amoroso, del tradimento da parte di una moglie spigliata, che rivendica il proprio diritto di amare il marito senza rinunciare al rapporto con l’amante, viene come irrigidito in una sorta di schematismo dimostrativo: se il suo matrimonio è messo in crisi da una mancanza di verità all’interno della coppia, dall’innata tentazione di occultare la relazione clandestina dietro una cortina di menzogne, lei reagisce puntando a un eccesso di verità, a uno sfoggio di dettagli intimi spinto quasi a un’esibizione maniacale. Inoltre il marito della donna fa il commentatore politico per un importante quotidiano, per il quale sta seguendo un grave incidente internazionale, il famoso abbattimento – avvenuto nell’83, da parte di un Mig sovietico – di un jumbo sud-coreano con 250 passeggeri a bordo: e, destreggiandosi fra lanci d’agenzia, aggiornamenti, conferme o smentite dell’ultima ora, teorizza il fatto che nella moderna industria dell’informazione vi siano due modi per impedire la conoscenza di quanto realmente sta accadendo, nascondere le notizie, non darle proprio, o fornirne una tale quantità che la verità ne resti schiacciata e sostanzialmente inaccessibile.
(Matteo strappa dalla macchina per scrivere il foglio già scritto per metà, lo getta nel cestino, mette un altro foglio. Dirce rientra nella camera, dal bagno.)
DIRE LA VERITA’
DIRCE: Che stai scrivendo?
MATTEO: Il pastone.
DIRCE: Che cos’è il pastone?
MATTEO: Te l’ho già detto altre volte: è un insieme di informazioni sugli avvenimenti internazionali del giorno.
DIRCE: E quali sono oggi gli avvenimenti del giorno?
MATTEO: E’ scoppiata una gravissima crisi tra Stati Uniti e Unione Sovietica.
DIRCE: C’è sempre una crisi.
MATTEO: Hanno abbattuto un grande aeroplano nel mare del Giappone. Un Jumbo.
DIRCE: E tu devi scriverne?
MATTEO: Si capisce. I lettori vogliono essere informati e io li informo.
DIRCE: Anche nella vita privata c’è sempre una crisi. Ma la differenza tra la vita privata e la vita pubblica è che nella prima non c’è la possibilità di risolvere la crisi, dicendo la verità. Invece nella vita pubblica lo potete fare.
MATTEO: Chi ti dice che io dica la verità?
DIRCE: Tu ai lettori fornisci delle informazioni esatte, no?
MATTEO: Certo.
DIRCE: Dunque tu dici la verità.
MATTEO: Nient’affatto. Ci sono due maniere per nascondere la verità. O non dare alcuna informazione, che è la maniera, diciamo, così tradizionale. Oppure darne troppe, con tutti i mass-media di cui disponiamo, che è la maniera veramente moderna.
DIRCE: Non ti capisco. Tu dici: il Jumbo è stato abbattuto. Questa è un’informazione ma anche la verità.
MATTEO: Prendiamo un caso celebre: l’assassinio del presidente Kennedy. Di questo assassinio sappiamo tutto, più che tutto. Ma appunto perché disponiamo di una massa enorme di informazioni, in realtà non sappiamo né sapremo mai nulla. Invece dell’assassinio di Enrico IV di Francia, benché in quel tempo non ci fossero i mass-media cioè informazioni di alcun genere, sappiamo tutto, cioè, appunto, la verità.
DIRCE: Sarà. Ma il Jumbo è stato veramente abbattuto e noi lo abbiamo saputo subito. Non è forse questa un’informazione che è anche una verità?
MATTEO: No, è una notizia. Poi ne verranno molte altre, e alla fine ricopriranno la verità come la neve ricopre la terra sulla quale cade.

L’angelo dell’informazione rappresentato nel febbraio 2018 al Teatro Out Off di Milano
Il tema della “commedia” moraviana è certamente quello della “verità” e nasce anche da quell’aspetto voyeuristico che abbiamo già incontrato in L’uomo che guarda: Matteo non può fare a meno di conoscere il modo di far l’amore con l’amante allo stesso modo di Vasco che esige che la donna racconti tutto su come il marito faccia sesso con lei; insomma Moravia stigmatizza l’ipocrisia borghese del “non dire” la verità per non mettere in crisi il rapporto di coppia. Ma questo tema non può non riflettersi nel compito mass-mediologico del giornalista Matteo: così come il coprire la verità con l’inganno è tipico di ogni tradimento sentimentale il riempire di troppi contenuti un episodio importante (come l’abbattimento del Jumbo coreano in territorio russo, con 256 morti) possa in qualche modo nascondere la “realtà” della possibile futura guerra nucleare tra USA e URSS.
Ed è proprio questo il tema che, come dice Moravia stesso, lo “ossessiona”, tanto da presentarlo sia in uno dei racconti di La cosa (C’è una bomba anche per le formiche) che, com’è detto, nel romanzo. Per questo parallelamente all’opera letteraria viene alla luce un volume a cura di Renzo Paris che raccoglie “interviste, articoli, saggi scritti dal 1982 al 1985 sulla questione nucleare” dal titolo de L’inverno nucleare (1986)
Nel testo c’è un capitolo in cui Moravia si intervista, o meglio il Moravia scrittore intervista il Moravia candidato al Parlamento Europeo il cui compito precipuo è quello di intervenire per il disarmo nucleare: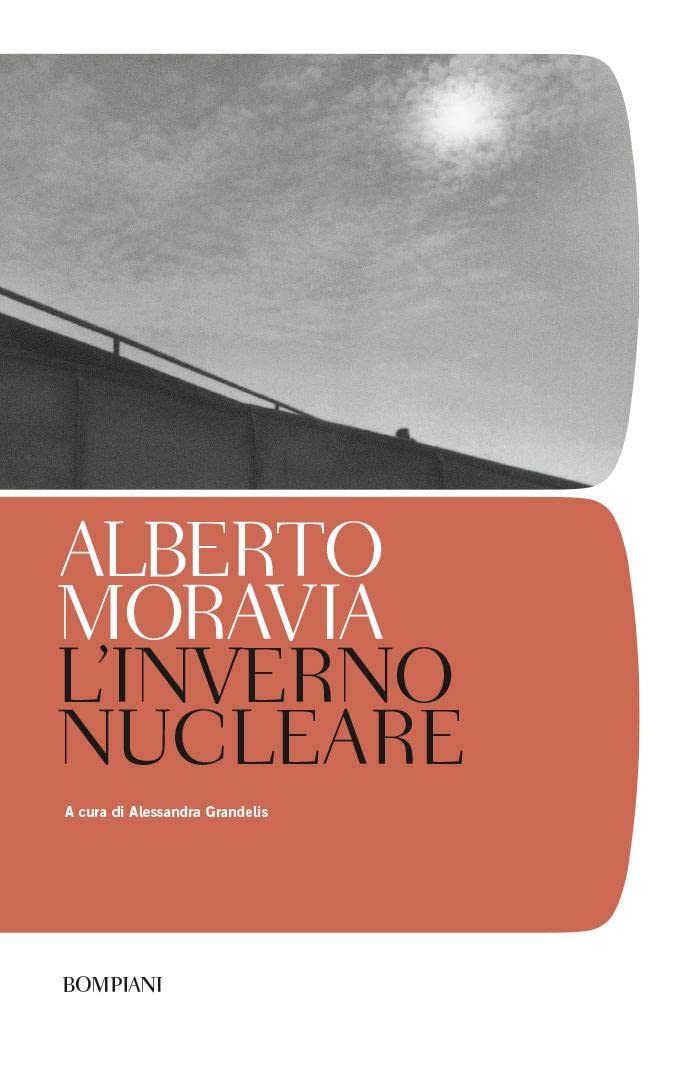
OSSESSIONATO DAL PROBLEMA NUCLEARE
D: Ora che te ne importa degli armamenti nucleari? Non hai forse detto che sei un artista? Che cosa hanno a che fare gli armamenti nucleari con l’arte?
R: Hai ragione; poco o niente. Ma la questione non si pone così, almeno per me. La questione è che il problema nucleare tra qualche tempo si è installato nella mia mente con gli stessi caratteri di necessità espressiva che sono propri dei problemi artistici. Ad occuparci del problema nucleare per dirla con una frase infantile “Ehi non lo faccio apposta”. E perciò la mia candidatura al Parlamento Europeo non è dovuta a un motivo di interesse certamente personale ma ad una necessità, diciamo così, interiore. In parole poverissime: da qualche tempo io sono ossessionato dal problema nucleare.
D: Vuoi dire che ne hai preso coscienza?
R: Sì, ma in maniera ossessiva. Non posso dire le origini di questa ossessione, non posso indicarne le cause. Due anni fa sono stato invitato In Giappone dal Japan Foundation, una grande istituzione culturale. Prima di me era stato invitato Borges che non è certamente ossessionato dal problema nucleare. Da notarsi che ero stato altre volte in Giappone, avevo già visitato a Hiroshima il luogo dell’esplosione nucleare ma non me ne ero occupato più di tanto. Questa volta, invece, di fronte alla lapide dei martiri di Hiroshima che porta la scritta enigmatica “riposate in pace perché noi non ripeteremo l’errore”, mi sono accorto, cioè ho preso coscienza, che il problema nucleare, alla fine, mi riguardava personalmente.
L’approccio moraviano al tema nucleare non è politico, ma metafisico: infatti se l’uomo a in sé il senso della propria fine che non cancella l’eternità della persistenza dell’essere umano, che ne sarà quando un’esplosione nucleare cancellerà l’uomo dalla faccia della terra, che ne sarà della sua “speranza” di eternità quando tutto verrà meno se mai il mondo dovesse oggi essere cancellato? Il tema è quindi l’uomo, la scienza che crea strumenti di distruzione totale per mano dell’uomo stesso e il destino del mondo: per questo si tratta di temi che toccano la fine dell’umanità e quindi temi filosofici.
L’altro volume pubblicato come raccolta di suoi articoli, terzo dedicato all’Africa, dopo un viaggio compiuto con Dacia Maraini tra il 1983 e il 1986 è Passeggiate africane edito nel 1987. Gli articoli appartengono tutti alla terza pagina del Corriere della Sera.

L’ANIMA DELL’AFRICA
Mi è stato rimproverato che nei molti viaggi che ho fatto in Africa non mi sono abbastanza occupato delle situazioni politiche, sociali, economiche, ideologiche ecc. ecc. del continente nero.
Questo è vero almeno in parte ma paradossalmente è un effetto del mio grande amore per l’Africa. Per fare un paragone esatto è come se, parlando con amici di una donna che amo, parlassi soprattutto delle sue opinioni politiche, della sua situazione economica, della sua posizione in società e non piuttosto della sua bellezza. Bellezza! ecco la parola che da sola spiega il mio silenzio, su tanti aspetti dell’Africa nera che gli africanisti considerano, del resto a ragione, importanti. Bellezza! Io sono stato affascinato dalla bellezza dell’Africa e per bellezza non intendo la bellezza delle cartoline illustrate in tricromia, bensì qualche cosa di inspiegabile, di misterioso, di indicibile che si direbbe aleggia sul continente nero allo stesso modo dell’anima secondo i greci, Cioè qualche cosa di superficiale e di esterno e appunto per questo affascinante per la sensibilità che è il mezzo privilegiato di ogni visione estetica.
Perché l’Africa è bella? Perché è il luogo della terra nel quale la natura ha eretto a se stessa un monumento in cui pare di ravvisare il metodo, l’ordine, il disegno, l’intenzione e la regolarità che sono proprie delle opere d’arte umane. Altrove, questo disegno è questo metodo sono incerti e in parte cancellati dagli uomini. In Africa per motivi storici, geografici e climatici il metodo è stato applicato fino in fondo e il disegno è perfetto. Si noti per esempio la sistematica divisione dell’Africa in tante zone parallele dal nord al sud. A nord c’è la fascia mediterranea temperata. Poi viene il deserto. Al deserto succede la savana. Dopo la savana subentra la boscaglia. Alla boscaglia segue la foresta. Poi sotto l’equatore tutto ricomincia: foresta, boscaglia, savana, deserto, zona temperata. Come se la parte superiore dell’Africa si specchiasse riflettendo la propria immagine nella parte inferiore. Ciascuna di queste zone in se stessa è perfetta. Nella zona mediterranea si vive con quattro stagioni, con la vegetazione, con i cieli e i paesaggi della Grecia e dell’Italia, della Spagna meridionale. Nel deserto, il più grande, il più bello di tutti i deserti della terra, regna il sole.
Nella savana convivono gli uomini e gli animali selvaggi in una simbiosi primordiale. La boscaglia e pullulante di arbusti e di piante, è stregata e piena di spettri. Infine la foresta è pura vitalità che si esprime in una lotta tra pianta e pianta, tra albero e albero, tra liana e liana, in un terreno buio e pieno di acquitrini, senza altri animali che i serpenti e le scimmie. Anche il clima ha una simmetria e un ordine che sembrano umani perché in qualche modo metodici: nel deserto non piove mai; nella foresta chiamata pluviale, piove a stagioni e ore fisse.
Ma nella bellezza dell’Africa non c’è soltanto questo metodo e questa simmetria che sembrano umane; c’è pure un mistero che è senz’altro disumano o se si preferisce extraumano. E’ il mistero che si è espresso nella religione autoctona dell’Africa, l’animismo, e che ci avverte che l’Africa ha soprattutto e prima di tutto un’anima. Tutti gli altri paesi del mondo hanno una storia; L’Africa, lei, ha invece un’anima che tiene il luogo della storia. Cosicché la storia dell’Africa, alla fine quando tutto è stato detto, è la storia della sua anima.
Rispetto ai libri “africani” che hanno preceduto Passeggiate africane, A quale tribù appartieni?, Lettere dal Sahara, questo testo appare più lirico: certo continuano ad esserci le “pennellate” di squarci paesaggistici: ma non possiamo notare lo sguardo “meravigliato” di fronte alla foresta o alle Cascate Vittoria, nonché lo sguardo disilluso di un neocapitalismo feroce che uccide la foresta per costruire la ferrovia transgabonese uccidendo una “perla” di biodiversità vegetale e animale (così come gli illustra un ecologo francese) o che costruisce alberghi elegantissimi per accogliere uomini d’affari di paesi capitalistici e ancora la divisione “razzista” in Rhodesia (nonostante la recentissima legge Vecchio signore il soprannome appuntoche derivava dalla vittoria dei neri sui bianchi). E’ l’Africa destinata a cambiare (in peggio), ma certo, almeno per l’autore romano, non si riuscirà, finché ci saranno lembi di non storia, a strapparle l’anima.
L’ultimo romanzo pubblicato in vita è Il viaggio a Roma:
Il protagonista, Mario De Sio, parte da Parigi per raggiungere a Roma il padre, che non vede da quindici anni, essendo stato allevato da uno zio. Ha vent’anni, non lavora ma si definisce poeta, pur non avendo scritto alcuna poesia in quanto già tutte scritte da Apollinaire. Sull’aereo incontra Jeanne e sua figlia Alda ed accetta l’opportunità che l’incontro e in seguito la vita gli offriranno, in virtù di quella dote che lui chiama disponibilità. A partire dalla visita della casa in cui egli ha passato l’infanzia gli sovvengono dei ricordi, fra i quali una scena vista in infanzia. La mamma che lo guarda mentre fa l’amore con un uomo biondo che non è il padre. Tale immagine diventa un’ossessione, che gli impedisce altre storie.
 Il tema portante del romanzo, ad una prima lettura, è l’incesto: Mario, infatti, superando una porta su cui poggia, lasciando un piccolo spazio per il passaggio, un divano, vede la madre stare a cavalcioni su un uomo che non è il padre e che durante l’orgasmo l’osserva quasi ad invitarlo a non distogliere lo sguardo. Questa scena primaria non verrà mai superata da Mario se lui non farà l’amore con una donna che, almeno negli occhi e nello sguardo, non riveda gli occhi e lo sguardo della madre. Quindi la sua è una ricerca di un “ideale” femminino. Ideale femminino che possiamo vedere (non vi è Jeanne) nelle tre donne apparse insogno a Mario stesso:
Il tema portante del romanzo, ad una prima lettura, è l’incesto: Mario, infatti, superando una porta su cui poggia, lasciando un piccolo spazio per il passaggio, un divano, vede la madre stare a cavalcioni su un uomo che non è il padre e che durante l’orgasmo l’osserva quasi ad invitarlo a non distogliere lo sguardo. Questa scena primaria non verrà mai superata da Mario se lui non farà l’amore con una donna che, almeno negli occhi e nello sguardo, non riveda gli occhi e lo sguardo della madre. Quindi la sua è una ricerca di un “ideale” femminino. Ideale femminino che possiamo vedere (non vi è Jeanne) nelle tre donne apparse insogno a Mario stesso:
TRE DONNE
Guardo spesso a questo anziano è un po’ maniaco giardiniere e non posso fare a meno di ricordare ogni volta, altra citazione letteraria, la frase con la quale si conclude il Candido di Voltaire: “Bisogna coltivare il nostro giardino.”
Ancora un ammonimento ad agire, in questa frase, come nei versi di Apollinaire! In questi ultimi e nella vita che dovrei agire; nella frase di Voltaire, nella letteratura. A causa della sua passione per il giardinaggio, ho appioppato al vecchio signore il soprannome appunto di “Monsieur Voltaire”. “Ecco Monsieur Voltaire che coltiva il suo giardino,” penso ogni volta che lo vedo, “ecco che coglie i fiori per farne un mazzo.” C’è dell’ironia in questi pensieri; ma forse, chissà, anche un po’ di ammirazione.
Ma adesso, nel mio sogno poiché sto sognando, Monsieur Voltaire non si vede. Tuttavia sono consapevole di aspettare non so quale apparizione, la sua o di qualcun altro. Infatti ora leggo e ora guardo alla finestra. Forse guardo più spesso che leggo.
Ecco, infatti, apparire, invece di Monsieur Voltaire, tre donne in atto di incedere lentamente, le spalle rivolte verso di me. Riconosco subito Alda, mia madre e Esmeralda, sia per il modo di vestire, sia per l’aspetto fisico, caratteristico, come mi rendo conto immediatamente, d tre età successive: l’adolescenza, la giovinezza, la maturità. Alda, con la sua maglietta succinta e i suoi blue jeans corti e striminziti mi ricorda ancora una volta il saltellare mal sicuro di un puledro o di un vitello appena nato; mia madre con la camicetta aperta sulla spalla nuda e la minigonna che le copre appena il sedere, dimena, provocante, i fianchi; infine Esmeralda incede ieratica, stampando ad ogni passo le forme oblunghe delle natiche nella tunica lunga fino ai piedi.
Mi dico, guardando, che sono manifestamente la stessa persona in tre età diverse e mi accorgo che questo pensiero è dettato dallo stessissimo inconfessabile desiderio che tutte e tre mi ispirano mentre camminano. Sì, mi attraggono egualmente il saltellare dinoccolato di Alda, lo sculettamento sfrontato di mia madre, l’ancheggiamento pesante di Esmeralda.
Le tre donne camminano piano, come passeggiando, tenendosi per mano eppure, curiosamente, sembrano estranee l’una all’altra. Questa vicendevole estraneità è sottolineata dal fatto che non soltanto non si parlano ma neppure si guardano: Esmeralda rivolge gli occhi verso terra, come chi teme di inciampare; Alda, verso il cielo, su su, al di sopra del cortile; mia madre, più sorprendente, ecco si volta e, sfacciatamente, mi strizza l’occhio. Penso, a questo punto, di aprire la finestra e di chiamarle; mi alzo, cerco di spalancare le imposte, ma la maniglia non gira, non ci di riesco. Intanto, con mio amaro rammarico, Le tre donne salgono lentamente gli scalini sotto la pensilina, scompaiono dentro il portoncino, non senza che mia madre, sola delle tre, Si volti di nuovo e mi lanci un’occhiata di intesa. Intanto, qualcuno mi preme la mano sulla spalla e io cerco di liberarmi da questo contatto insistente che sento connesso in maniera oscura con la mia impossibilità di aprire la finestra. Così vado avanti per un poco, tentando nello stesso tempo di disserrare le imposte e di scrollare da me la mano che mi preme sulla spalla. Finalmente, inviperito, mi volto e allora mi sveglio.
Nel brano, che sembra riandare alle Tre età klimtiane, vediamo la sfrontata Alda, lolita che, secondo i suoi piani, dovrebbe diventare dapprima la figlia quindi l’amante di Mario, una volta che lui s’insidasse in casa dalle madre Jeanne, fornendo lei l’idea di una nuova famiglia; Esmeralda, amante e futura moglie del padre, in cui il rapporto “rovesciato” farebbe di lui un figlio amante della matrigna e quindi la madre che occhieggia verso il figlio ma rappresenta l’impossibilità di varcare la porta (la maniglia non gira) che rappresenterebbe l’infrazione del più terribile dei tabù.
Mario non risolverà (come gran parte dei protagonisti maschili dei romanzi moraviani) i suoi turbamenti: giovane indeciso, irrisolto, poeta senza essere poeta, citazionista letterario per l’incapacità di essere un letterarato, dapprima Apollinaire, quindi Voltaire, sembra vagare e cadere nelle situazioni per la naturale “disponibilità” a lasciare trascinare negli eventi. A questa sua condizione conribuisce anche la descrizione di Roma: “Eppure Roma, questa Roma del viaggio a Roma è incredibilmente più precisa e dettagliata che in altri romanzi. Un dato non trascurabile: lo notò, all’uscita del romanzo, anche Antonio De Benedetti, che ne chiese ragione all’autore in un’intervista mobile, sui luoghi del libro. Spiegava Moravia: «Nei romanzi e racconti, che ho scritto prima del Viaggio a Roma, la città è un fondale mai descritto nei particolari. La ragione è semplice. La capitale, in quei romanzi e in quei racconti, non ha funzione nella psicologia dei personaggi. Nel Viaggio a Roma, viceversa, come dice il titolo, definisce e determina i problemi del protagonista». Deve esserci stata una minuziosa mappa mentale, all’origine di questo romanzo. Tanto che, passando per piazzale delle Belle Arti, ci si convince che la casa del personaggio Mario De Sio sia esattamente questo «pretenzioso palazzo dalla facciata coperta di nicchie, cornicioni, balconcini, colonne […] in un curioso stile tra coppedè e piacentiniano». E d’altra parte il quartiere Parioli si annuncia molto presto le romanzo: nel secondo capitolo già si imbocca via Bertoloni, e si arriva di corsa a un appartamento di via Archimede.” (Paolo di Paolo, Nuovi Argomenti, 2007)
Mentre cominciano, per la casa editrice Bompiani, le raccolte di tutte le opere di Moravia, Opere (1927-1947) (1986) e Opere (1948-1968) (1989), escono i racconti La villa del venerdì e altri racconti, la cui pubblicazione avverrà l’ultimo anno della sua vita, 1990.
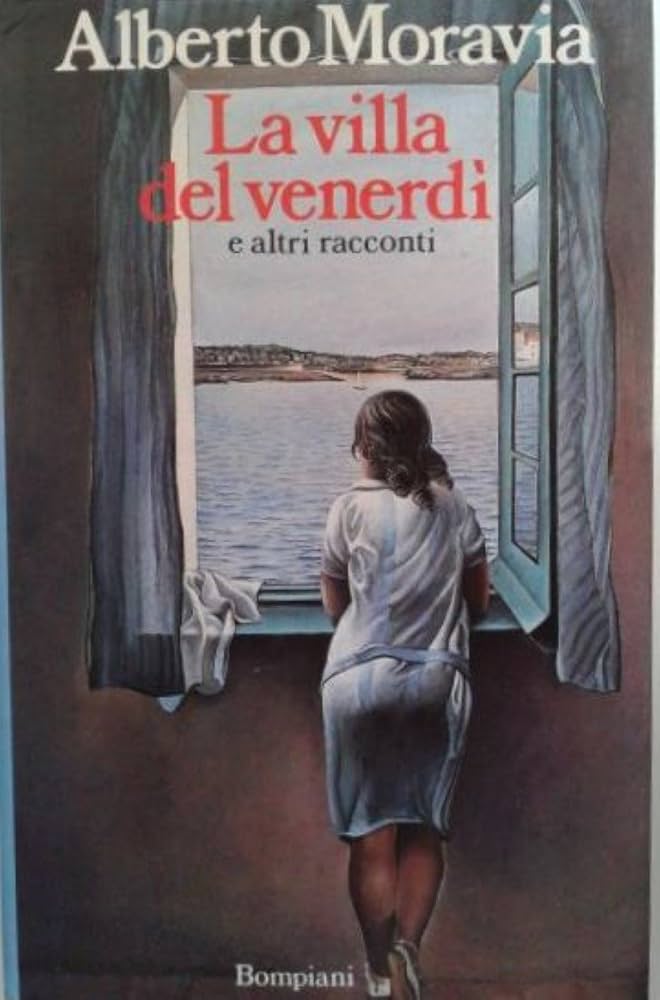
Non è nuova la struttura di questa raccolta, a due racconti “lunghi” (o “romanzi brevi”) ne seguono 14 ” brevi”, forse, per rispettare, maggiormente; il primo dei due dà il titolo all’intera raccolta, La villa del venerdì, e affronta il tema della gelosia: Alina e Stefano hanno affittato una villa in un famoso luogo di villeggiatura per due motivi: “l’uno di lavoro e l’altro sentimentale. Il motivo di lavoro è che su quella stessa spiaggia passa l’estate il regista con il quale sta scrivendo una sceneggiatura. Il motivo sentimentale è di far piacere alla moglie, Alina. La moglie ha un amante e Stefano lo sa. Quest’amante ha anche lui una villa dove abita solo, a circa trenta chilometri di distanza da quella di Alina e Stefano”.
Alina si reca ogni venerdì dall’amante per poi tornare da Stefano la domenica sera. Pur accettando il tradimento della “moglie”, la quale afferma di amare ambedue, Stefano non può fare a meno, in quel fine settimana di assenza, di “rodersi” dalla gelosia.
LA GELOSIA
Di solito, dopo la partenza di Alina, esce dalla camera e va a sedersi in una sdraia, sulla terrazza, di fronte al mare. Fuma, guarda la distesa nera del mare sulla quale brillano qua e là le luci quiete delle barche dei pescatori e pensa ad Alina. La vede, con gli occhi dell’immaginazione, filare dritta sull’autostrada nella macchina piccola e agile, suo dono recente per il ventinovesimo anniversario di lei. Corre veloce verso il piacere e gli pare che persino nella corsa della sua macchina metta un ritmo di danza. Corre attraverso i gruppi sfavillanti di luminarie degli alberghi, dei ristoranti, dei bar, poi corre per lunghi tratti bui di macchia disabitata. Corre inflessibilmente, arriva e… Adesso lui la vede già a cose fatte cioè ad amplesso avvenuto. Sta seduta su una sdraia accanto all’amante, magari mano nella mano, silenziosa, intenta come lui a guardare al mare nero sparso delle luci ammiccante e tranquille dei pescatori. E Stefano si accorge di soffrire indicibilmente per quest’immagine casta e appagata, molto più che se se la figurasse nuda, supina su un letto, con l’uomo tra le gambe spalancate. Sì, soffre della loro felicità e, soprattutto, del carattere normale e, in qualche modo, coniugale di questa felicità.
Quest’idea che la moglie e l’amante si amino allo stesso modo che lui e Alina si sono amati e tuttora si amano, gli riesce talmente insopportabile che ad un tratto non c’è la fa più, si alza, vanno nel suo giorno a prendere una bottiglia di whisky, la sua bevanda preferita. Poi torna alla sdraia, e col proposito lucido e dichiarato di ubriacarsi, tracanna in un solo sorso uno, due, tre bicchieri con molto whisky e poco ghiaccio. Non è abituato a bere; dopo il terzo bicchiere, è già ubriaco. Allora si alza, va nella camera da letto, si butta tutto vestito sulle lenzuola, si addormenta di un sonno pesante e disperato. Durante la notte, si sveglia, confusamente si spoglia, si riaddormenta.
E’ letteratura la capacità di Moravia di scandagliare l’animo umano: il modo di vivere la gelosia da parte del protagonista del racconto è realistica, veriterio fors’anche di un vissuto che lo stesso scrittore romano andava vivendo: non dimentichiamo che probabilmente anche Moravia, nella sua senilità, si era sposato con Carmen Llera di quarantesei anni più giovane; probabilmente poteva essere ossessionato dalla sua giovinezza e quindi dalla sua maggiore libertà; ci dice Aldostefano Marino: “Un amore per la libertà che Moravia cercò sempre in tutte le donne con cui ebbe a trascorrere anche solo qualche ora d’amore. Eppure, in quella relazione con Llera, Moravia detestava quella libertà: era ciò che li faceva litigare di più, perché lui negli anni era diventato geloso e molto attento a lei. Tuttavia Moravia preferiva sapere anziché essere ingannato, e così, Llera gli raccontava tutto, senza menzogne, in virtù di quella libertà che non si esauriva nella sola narrazione.”
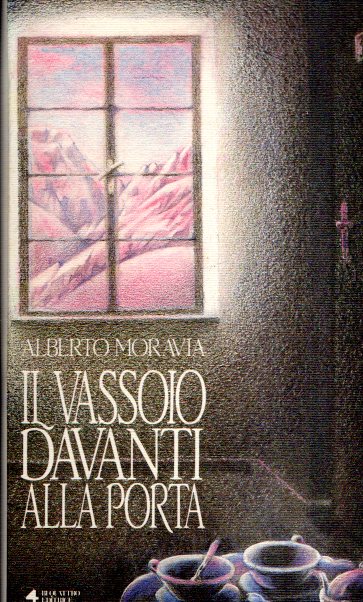
L’altro famoso racconto è Il vassoio oltre la porta che ci riporta in quel clima di “scoperta” del sesso che già Moravia aveva magistralmente affrontato in Agostino:
GIAN MARIA, LA MONTAGNA, IL CORVO E LA DONNA
Il cielo, prima di tutto: remoto, appena visibile lassù in alto, in fondo alla gola, come respinto indietro dalla montagna gonfia e poderosa, di un blu duro di smalto sul quale si tagliavano i picchi rosa del Gruppo del Brenta, striata di bianche falde di neve. Sotto, la massa imponente serpeggiante del nevaio. Poi ancora, come una barba irsuta sotto un volto ostile, la foresta con gli abeti incalzanti i ranghi serrati all’assalto del pendio. Infine, i prati del fondovalle, di un verde luminoso, con le macchie bianche e nere delle vacche che pascolavano.
Gian Maria, ti steso al sole sulla sdraia della terrazza dell’albergo, guardava questo paesaggio con occhi perplessi; non era alpinista e neppure amante della montagna: quasi stupito, si domandava che cosa era venuto a fare quassù virgola in questa valle solitaria e arcigna, invece di passare l’estate come gli altri anni in qualche affollata e cordiale località marina. La risposta alla domanda la sapeva in anticipo: per lavorare, cioè per scrivere un dramma o meglio (la distinzione per lui era importante) una tragedia; ma, pur formulandola, si rendeva conto che non era così. In realtà, sotto questa idea della tragedia da scrivere, c’era, assurda ma insistente, quella della tragedia da vivere. Gian Maria aveva diciotto anni ed era convinto di avere sino ad ora soltanto vegetato. Quello che nel suo linguaggio interiore chiamava la “vera vita”, secondo lui non l’aveva neppure sfiorato. Ora, forse perché la parola tragedia indicava insieme intensità e letteratura, la “vera vita” non poteva essere che tragica. Di qui il pretesto della tragedia da scrivere in questo luogo severo e drammatico, forse favorevole alla tragedia da vivere.
Pensava a queste cose con sufficiente chiarezza, ma senza trarne alcuna conclusione. Poi stornò gli occhi dalla montagna e guardò alla terrazza. In fila sulle sdraie, gli ospiti dell’albergo giacevano distesi al sole, immobili e come assorti in una contemplazione fisiologica. Altri alternavano senza troppa curiosità, oziosamente, intorno ad un cannocchiale, montato su un sostegno a tre piedi, attraverso il quale si poteva sfruttare la montagna intorno. Ma in quel momento stava avvenendo una piccola scena che si ripeteva ogni giorno: un grosso corvo addomesticato, tutto nero e lucente, saltellava lungo le file delle sdraio e come cercando qualche cosa. Ogni tanto si fermava, girando il capo di lato come fanno gli uccelli per guardare, quindi tendeva il collo ad afferrare col becco il laccio di una scarpa che sporgesse da una sdraia e tirava con tutta la sua forza finché il nodo non si scioglieva. Questa esibizione era seguita con divertimento e simpatia dai clienti dell’albergo che ridevano e la commentavano facetamente. Dalla sdraia immediatamente vicina a quella di Gian Maria sporgeva una scarpa di donna, un elegante scarponcino di camoscio. Il corvo si fermò, adocchio il laccio, lo afferro col becco e tirò. Ma il nodo non si sciolse. La donna a cui apparteneva la scarpa ritrasse il piede con violenza, esclamando: “Vattene, brutta bestiaccia!”.
Gian Maria fu colpito dal tono singolare della voce, come di un’esasperazione costante e antica; e, forse, Ancor più dal fatto che questa reazione, invece di riuscirgli antipatica, gli ispirasse un sentimento di simpatia. Sorpreso, guardo la donna e subito si meravigliò di non averla notata prima. Una gonfia, folta capigliatura fulva e un’enorme paio di occhiali neri le riducevano il viso al naso minuscolo e alla larga bocca rossa e sensuale. Era un viso felino, ma non veniva fatto di pensare al gatto, bensì ad un animale più feroce della stessa specie, per esempio, a causa della mascella tonda e sporgente, ad una pantera punto al contrario delle altre clienti dell’albergo, per lo più infagottate in maglioni e pantaloni sportivi, era vestita da città, con giacca e gonna dritte di taglio maschile. Gian Maria fu anche impressionato da un particolare che gli parve significativo: ai lobi delle orecchie, al collo, ai polsi, alle dita, la donna ostentava una quantità di gioielli vistosi e massicci. Una catenella d’oro le circondava la caviglia. Aveva spalle larghe, vita ristretta e fianchi ampi; le gambe distese sulla sdraia erano magre ed eleganti. Gian Maria cercò pure di indovinare l’età e giudicò che fosse vicino ai quarant’anni.
Gian Maria era timido nella parola; forse per questo, quasi illudendosi che non si notasse, che gli accadeva di essere sfrontato negli sguardi. Prese così ad osservare con insistenza la donna e intanto cercavo una frase sul corvo e sulle sue prodezze che gli fornisse il pretesto per attaccare discorso. Pensò a qualche cosa come: “Che sfacciato quel corvo!”, che esprimesse solidarietà, oppure: “Come si chiama quel corvo?”, ma si accorse che, comunque la rigirasse, non sarebbe stato capace di pronunziarla a causa della timidezza. Fissava gli occhi sulla grande, enigmatica bocca rossa e carnosa e provava una sensazione di completa incapacità di parlare, accompagnata, però, tra la bizzarra idea che forse gli sarebbe stato più facile chinarsi e sfiorare con le proprie labbra quelle della sconosciuta.
La montagna e la volontà dell’intellettuale diciottenne di scrivere una tragedia, ci rimandano alla sua adolescenza quando, malato di tubercolosi, trascorreva le giornate ad Asiago meditando Gli indifferenti che dovevano avere una forma tragica. Ma qui il tutto si “complica” con la presenza femminile. Moravia non smette di paragonare la bellezza muliebre al mondo animale: il richiamo alla “pantera” sembra prefigurare il romanzo che non riuscirà a pubblicare, al quale stava, presumibilmente, già lavorando; ma come sempre è l’estrema sensualità femminile che mette in scacco la capacità maschile di affrontare “naturalmente”, la realtà.
Gli altri 14 racconti, tutti di un’estensione ridotta, in linea con lo spazio dedicatogli dal giornale, più o meno riprendono il tema della gelosia; ma ve ne sono due particolarmente efficaci da un punto di vista politico, ambedue scritti con piglio sarcastico: Pensa!, in cui si stigmatizza l’uso improprio del denaro pubblico da parte di un ente statale e la Donna dagli occhi strabici, in cui sottolinea come, nella società contemporanea, esista ancora la figura del libertus, cioè di colui che “servendo” un personaggio importante, si specializza così tanto sulle sue necessità e voglie da, pur annullandosi, diventare ricco grazie alle sue prebende.
Il 26 settembre 1990 Alberto Moravia muore, nella sua casa sul Lungotevere, accudito dalla sua ultima compagna, Carmen Llera. Postumi usciranno varie pubblicazioni: il romanzo La donna leopardo, l’interessante intervista rilasciata ad Alain Elkann con la quale il nostro ripercorre la sua vita, Vita di Moravia, appunto e una ennesima raccolta di racconti non ancora riuniti in volume, Romildo, a cura di Enzo Siciliano.
Ne usciranno altre di tipo episolare o di resoconti politici quand’era parlamentare europeo, che se aggiungono curiosità sull’uomo Moravia, nulla ci dicono sul suo suo essere grande narratore del Novecento italiano.

La donna leopardo narra la storia di Lorenzo e Nora: il primo fa il giornalista e viene invitato dal direttore del suo giornale a scrivere un reportage sul Gabon. In Africa Lorenzo porta anche Nora e viene raggiunto dal direttore Colli e sua moglie Ada. Nora prova attrazione per Colli, creando così una situazione in cui non solo Lorenzo viene tradito e tenta di tradire a sua volta, ma assume anche il ruolo del marito geloso degli ipotetici incontri amorosi tra Colli e la moglie. Lorenzo li immagina, Ada li comprova, invitandolo a tradire “come specchi” i loro rispettivi coniugi. Si è tuttavia che questi supposti amori sono talmente “evanescenti” allo stesso modo di come lo siano i loro. il libro sembra alludere all’impossibilità di afferrare la “verità”.
Il brano da noi scelto segue una discussione tra Colli e Leonardo sul compenso del giornalista e sul modo in cui il direttore possa aumentarglielo. Ma ad un tratto la discussione assume una piega diversa:
LA DONNA LEOPARDO
Lorenzo pensò: “Così alla fine l’ha detto Che potrebbe aumentare i miei compensi. E io non mi offendo. Che mi succede?” Ma non ebbe il tempo di rispondere, perché Colli che pareva adesso a guardare al di là di lui e come attraverso lui, esclamò d’improvviso: «Guardi, guardi, là dietro di lei.»
Lorenzo si voltò. Colli soggiunse a bassa voce: «Secondo lei che cosa può essere?»
Al di là delle ceppaie della natura così simili a tante piovre a congresso Lorenzo vide allora sospese a mezzaria nell’oscurità della foresta due piccole luci fosforescenti, circolari. Erano ciecamente due occhi ma avevano la singolare proprietà di risplendere io al tempo stesso di non guardare. Colli disse sottovoce, il tono di complicità avventurosa: «E ora che si fa?» Lorenzo pensò ad un tratto: “Gli occhi di Nora”. Quasi nello stesso momento gli occhi si spensero e ci fu lo spostamento frusciante di un corpo massiccio entro il fogliame tenebroso.
«Ha visto,» interrogò Colli, «cosa crede che fosse?»
Lorenzo capì che Colli non voleva riprendere la discussione e si strinse nelle spalle dicendo malvolentieri: «Qualche animale. Forse una gazzella.»
«Gazzella no di certo. Intanto erano gli occhi di un felino. E poi stavano più su degli occhi di una gazzella. Stavano quasi ad altezza d’uomo. Per me erano occhi di un grosso felino arrampicato su un albero.»
«Ma quale felino?»
«Un gatto selvatico. Oppure un leopardo».
Ormai il tono della conversazione era diventato del tutto amichevole. Lorenzo domandò: «ci sono dei Leopardi nel Gabon?»
«Ci sono,» informò Colli versandosi della birra, «e se non bastano quelli reali, ci sono quelli immaginari.»
«Immaginari?»
«Sì», spiegò Colli ion ormai piacevole e ozioso racconto, «ci sono individui, a quanto pare, dotati a loro insaputa di facoltà magiche ai quali viene attribuita la capacità di trasformarsi in animali. Sono persone qualsiasi e come ho detto non sono consapevoli di questa loro proprietà. Senza volerlo e saperlo possono trasformarsi in bufali, in antilopi o magari, come potrebbe essere stato il caso poco fa, in leopardi e via dicendo. Anzi, a proposito di bufali, la prima volta che venni nel Gabon mi fu raccontata una bella storia. In un villaggio, nei pressi di Franceville, dopo il tramonto un bufalo ammazza una donna che dopo il lavoro si affrettava verso casa. Passano alcuni giorni ed ecco apparire di nuovo il bufalo vespertino: a cornate ammazza un vecchio contadino. Ancora altri due giorni, e questa volta viene ammazzata una bambina. Allora si riunisce il consiglio del villaggio e viene deciso di assoldare un cacciatore professionista, un bianco. Ma il bufalo fa fuori anche il bianco. Nuova riunione dei saggi del villaggio: decidono allora che non si tratta di un bufalo vero e proprio ma di un uomo bufalo cioè di un uomo che ogni giorno, dopo il tramonto, si trasforma in bufalo. Naturalmente i saggi sanno chi è l’uomo bufalo: è tal dei tali, contadino con famiglia, indirizzo, nome, tutto. Detto e fatto, viene inviato un commando di animosi hai l’indirizzo dell’uomo bufalo. Lo trovan, beve tranquillamente la birra, fuori della capanna: “Tu sei l’uomo bufalo?”
“No, non sono l’uomo bufalo.”
“Sì, sei l’uomo bufalo, lo dicono i saggi del villaggio.” “Allora benissimo, se lo dicono i saggi vuol dire che è vero.” In breve lo prendono, lo legano, lo portano al villaggio, lo condannano a qualche anno di prigione. Poi tutta la comunità decide di trasferire il villaggio a qualche chilometro più in là. E chi s’è visto s’è visto.»
Lorenzo domandò: «Allora secondo lei quei due occhi che abbiamo visto nel buio erano gli occhi di un uomo leopardo o magari di una donna leopardo?»
«Secondo me, naturalmente, no. Ma secondo qualche gabonese, probabilmente, sì.»
Ci fu a questo punto un allegro clamore: «E’ pronto» Gridò sonora uscendo dalla casetta con una zuppiera tra le mani, seguita da che portava su un vassoio i piatti e le posate. Nora, molto eccitata, posso la zuppiera sulla tavola e disse: «abbiamo fatto la cucina internazionale: spaghetti italiani, olio di semi francese, tonno spagnolo, peperoncino africano, olive greche. Come secondo ci sarà carne in scatola inglese Le sardine portoghesi. Invece del pane, gallette gabonesi.» Ada disse in tono scontento: «peccato che i letti non sono all’altezza della cucina. Dormiremo in terra, in mezzo agli scarafaggi.»
«Via, via, bando alle lamentele. Poteva andare molto peggio,» gridò Colli. «Abbiamo trovato tutto. Perfino la donna leopardo.»
Nora domandò: «Che è la donna leopardo?»
Colli si servì gli spaghetti, poi spiegò raccontando per la seconda volta la storia dell’uomo bufalo. Come Colli ebbe finito, Lorenzo non poté fare a meno di dire alla moglie: «Quei due occhi assomigliavano ai tuoi. Appena li ho visti ho pensato: toh, gli occhi di Nora.»
Nora si infatuò subito scherzosamente di questa spiegazione: «Ma si capisce, sono la donna leopardo, soltanto che io so di esserlo, attento Colli ora ti mangio,» e ridendo fece il gesto di avventarsi con le dita protese contro Colli. Ada disse a bassa voce, tra i denti: «buon appetito.»
Ci racconta Siciliano: “La mattina in cui è morto, sulla sua scrivania c’era l’ultima stesura de La donna leopardo, conservata con cura in una rigida cartellina blu. Vi aveva apposto la parola «fine» da qualche giorno. Aveva preso appuntamento per l’indomani con la dattilografa. Lo avrebbe dettato, come era solito fare, e, magari, qua e là corretto nella forma. Il romanzo, a quel punto, sarebbe passato dalla versione manoscritta a quella battuta a macchina.

La donna leopardo in versione teatrale
Dalle parole di Siciliano arguiamo che La donna leopardo manca dell’ultima revisione, ma, sempre nella testimonianza dell’amico scrittore, l’impianto sarebbe stato quale quello che oggi leggiamo. Dopo tanti viaggi in Africa, a cui, come detto dedicò tre volumi, è questo l’unico romanzo ambientato nel continente nero. Ma questa ambientazione non costituisce soltanto una “scenografia” su cui interagiscono i personaggi: si è che l’inconoscibilità di Nora (donna-leopardo), capace di divorare il suo uomo facendolo consumare nella gelosia, corrisponde al mistero africano, la sua impenetrabilità è la chiusura con cui lei si chiude alle sue domande e il suo non poter essere catturata richiama alla mente la libertà dei grandi felini africani.

Se La donna leopardo è un romanzo che, se fosse vissuto un po’ più a lungo avrebbe certamente aggiunto un altro tassello alla sua opera di narratore, Romildo risulta solo un’operazione editoriale: vengono qui infatti riuniti, sempre da parte di Enzo Siciliano, racconti che non erano stati inseriti da Moravia in nessuna delle sue pur non episodiche nelle sue raccolte. “In questo volume sono riuniti i racconti che Moravia, lungo l’arco della sua vita, senza mai radunarli in volume, pubblicò su giornali e riviste. Sono pagine sparse, perdute talvolta su testate di cui non c’è più notizia: molti sono ritagli ritrovati fra le sue carte, in casa, ammucchiati nel caotico disordine che per lo scrittore era abituale. Ad esempio, del testo che titoliamo Insulti è stata conservata solo la traduzione inglese apparsa in USA su Playboy (giugno 1974): scomparso l’originale italiano, mediamo in appendice una versione possibile. Può darsi che altri testi, attraverso un attento scrutinio in emeroteca, possono essere rintracciati. Comunque, la maggior parte di questi racconti sono quelli che Moravia medesimo scelse di non perdere, certamente in vista di qualcosa che non compì mai.” (Enzo Siciliano, dall’Introduzione al volume Romildo).
Forse di questa raccolta la parte più interessante è quella dedicata ai testi di natura autobiografica, come quello in cui il nostro ci racconta un suo incontro con Eugenio Montale:
A CENA CON MONTALE
Sto a tavola con Eugenio Montale e, pur pensando che non sarà facile intervistarlo (come si fa a intervistare un poeta?), lo guardo e mi accorgo che non è affatto cambiato da quando, molto tempo fa, ci siamo conosciuti. Se lo vedessi ora, per la prima volta, mi colpirebbero gli stessi caratteri che mi hanno colpito allora: la curiosa forma della capigliatura che gli cresce, rigogliosa e ostinata, fin nel mezzo della fronte; l’ingenuità dolce un po degli occhi celesti; l’imperiosità del naso di curvo; il broncio che gli gonfia la bocca e che ancora oggi potrebbe sfogarsi sia in un solfeggio meditabondo sia nella breve, stupefatta e canzonatoria risata nella quale si esprime il suo particolarissimo, quasi straziante senso del comico. Ma Eugenio Montale è un critico letterario tra i nostri migliori. Mi dice:
«Non ci sono più i generi letterari. Direi quasi: purtroppo.»
«Non ci sono ma potrebbero rinascere. Da qualche anno si assiste al fenomeno della creazione, da parte della critica, di un elenco di modelli, tutti più o meno d’avanguardia. Dai modelli ai generi letterari il passo è breve, non ti pare?»
«Non credo che la critica moderna, per quanto si sforzi, potrebbe trasformarsi in retorica e creare, come dici tu, dei modelli. L’avanguardia, ha come fine il continuo superamento e la continua distruzione dei modelli. La retorica tendeva invece alla conversazione e, magari, all’imbalsamazione.»
«Tuttavia, se si legge certa critica, non ti sembra, Montale, che gli stessi nomi si ripetono continuamente, in maniera ossessiva, senz’alcun accenno di superamento e tanto meno di distruzione: Joyce, Proust, Kafka, Musil, Rimbaud, Lautréamont, Eliot ecc. ecc.? Tu stesso sei stato, sei tuttora, un modello. Quanti saggi ti sono stati dedicati finora?»
«A dire il vero, Ossi di seppia, che è del 1925, ebbe alla pubblicazione un numero ristretto di articoli critici. Ma da allora, ogni anno, fino ad oggi, i saggi sulla mia opera si sono seguiti con regolarità, senza interruzione, anzi, con accrescimento numerico continuo. Tornando ai generi letterari, il fatto che non esistano più presenta non pochi svantaggi accanto a vantaggi innegabili. Già, perché, secondo alcuni, l’opera d’arte non comincerebbe ad esistere se non quando è stata, per così dire, creata dal fruitore, il quale, senza sforzi, si sostituisce all’autore e crea, lui, l’opera d’arte.»
«Non pensi che la parola “fruizione” stia ad indicare, in fondo, il fenomeno tutto moderno del consumo?»
«Non lo so. Direi piuttosto che fruizione sta per successo, mentre consumo sta per popolarità. Si ha fruizione, ossia successo, con poche migliaia di lettori. Io, per esempio, ho venduto quarantamila copie di Ossi di seppia in quarant’anni. Si ha popolarità, cioè consumo, oltre le poche migliaia. O l’uno o l’altro.»
«Eppure, in Italia, l’Ulysses di Joyce ha superato le cinquantamila copie.»«Sì, ma quanti l’anno letto? I fuitori sono quelli che lo hanno letto davvero. Gli altri sono… gli altri.»
Non ti pare allora, Montale, che la buona letteratura non può ormai aspirare che alla fruizione, cioè al successo? E’ nel cinema, oggi, che si verifica il fenomeno della qualità congiunta alla quantità. In Francia, per esempio, Godard è al tempo stesso fruito e popolare. Ma Robbe-Grillet è soltanto fruito.»«Sono d’accordo, la letteratura ha perduto molto del suo prestigio.»
«Abbiamo fatto il nome di Robbe-Grillet. Che ne pensi del nouveau roman?»
Per quanto riguarda i romanzi, sono piuttosto incline alla tradizione. I romanzi del nouveau roman saranno nuovi e importanti, non discuto; ma sono noiosi e quindi difficilmente leggibili, almeno per me.»
«Forse non sono romanzi, ma lunghi poemi in prosa. Vogliono mettersi fuori dalla durata. Automaticamente si mettono anche fuori dalla narrativa.»
«Dirersti che il romanzo è legato alla durata e che, senza durata, non c’è romanzo?»
«Sì, il romanzo deve narrare, cioé avere una durata. Infatti non ci sono buone poesie narrative (sono sempre le meno valide nell’opera dei poeti) come non ci sono, in fondo, buoni romanzi lirici. Tu, per esempio, sei un poeta non narrativo; anche se il romanzo s’intravede spesso dietro le tue poesie. Prendiamo La casa dei doganieri, una tua poesia che per una quantità di motivi mi ricorda irresistibilmente un’altra poesia famosa, A Silvia di Leopardi. Perché me la ricorda? Forse perché in ambedue queste poesie c’è il romanzo, cioè non sarebbe difficile recuperarvi dei personaggi (almeno due), una storia, un ambiente fisico e sociale e via dicendo. Ma, al tempo stesso, il romanzo non c’è, perché sono due poesie, cioè due composizioni poetiche che si mettono fuori dalla durata, cioè non raccontano bensì “illuminano”. Ma, dimmi, in questo momento stai preparando un nuovo libro?»
«Ho ventotto poesie nuove. Quattordici Verranno pubblicate prossimamente da Strumenti critici.»
«Non si può dire che la tua produzione sia abbondante.»
«La mia produzione è scarsa perché sono vissuto più di quanto credessi di vivere. Certi poeti hanno avuto il presentimento che sarebbero morti giovani e allora si sono affrettati a dare il più presto possibile il meglio di sé. Anch’io, quand’ero giovane, avevo questo presentimento di morire presto, forse perché sapevo di avere delle cose da dire e temevo di non fare in tempo. Poi mi sono accorto che vivevo, che continuavo a vivere e allora non ho più avuto alcuna fretta, è così sono arrivato a settant’anni con l’opera che altri, scomparsi precocemente, avevano già dato a venticinque anni.
Ho aspettato, insomma, pazientemente, quasi distrattamente e in tutti i casi liberamente, che un’intuizione oscura, un sentimento ineffabile si precisassero, un po’ come si forma, in maniera lentissima, strato dopo strato, la perla intorno al nucleo originario. Del resto, non si può mai sapere quando la poesia è giunta al punto di maturità. La poesia è imprevedibile. La differenza tra la poesia e il prodotto meccanico è tutta qui: nell’imprevedibilità della prima, nella prevedibilità del secondo. Questo deve essere progettato in tutti i particolari, la poesia no.»

Questo passo viene pubblicato su Il corriere della sera il 3 marzo del 1968.
E’ evidente che i due tra i maggiori letterari ci fosse stima, pur nella diversissima “carriera” letteraria, uno poeta e l’altro narratore. Importante è tuttavia sottolineare come ambedue esordissero nello stesso clima letterario e continuassero, attraversando l’intero secolo a produrre opere e a riflettere sulla contemporaneità: infatti Ossi di seppia è del ’25, Gli indifferenti del ’29.
Qui si discute e si riflette sul compito della letteratura in un periodo in cui sembra venir meno la funzione sia della poesia che del romanzo. Gli anni che vanno dal ’63, anno in cui a Palermo “nasce” la neoavanguardia da parte di alcuni intelletuali, tra i quali Guglielmi, Eco e Sanguineti, fino al ’68, anno dell’articolo, sono ricchi di “messa in discussione” di tutti i modelli; opere come Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e Metello di Vasco Pratolini vengono accusati di obbedire a logiche di consumismo letterario che le apparentano di più ai romanzi d’appendice che alla letteratura. Di contro a loro Moravia e Montale sembrano ribadire la funzione della narrativa e della poesia: se Sanguineti con Laborintus frammenta completamente il linguaggio e Manganelli con Il serpente annulla il senso del racconto, se pure vogliono rappresentare il caos della realtà e l’incomunicabilità dell’uomo contemporaneo, al fine perdono proprio il concetto di rappresentatività, risultando per lo più opere illegibili se non agli addetti ai lavori.
Ed eccoci all’ultimo lavoro che non si può dire di Moravia, ma frutto di una lunga intervista che il vecchio scrittore concedeva ad un giovane autore Alain Elkann, secondo lo stile, allora molto in voga in Francia, dell’entretiens, che potremo banalmente tradurre “conversazioni”. Tale intervista divenne in seguito un libro postumo, pubblicato nel ’92 con il titolo Vita di Moravia.
DOSTOEVSKIJ IN MORAVIA E NELLA CULTURA EUROPEA
A.E.: Mi hai detto che io non posso immaginare che posto occupava allora Dostoevskij nella cultura europea. Perché?
A.M.: Sei di un’altra generazione, non puoi immaginare perché non sei vissuto in quell’epoca. Se tu pensi che un grande borghese come Gide ha scritto un romanzo che si chiama Les faux monnayeurs (I falsari) unicamente perché aveva scoperto Dostoevskij allora capisci che la mia infatuazione per l’autore di Delitto e castigo aveva la radice nella cultura europea del momento. Era insomma l’equivalente di ciò che è stata la moda dell’esistenzialismo nel secondo dopoguerra, ma una moda che era l’indizio di un profondo smarrimento, che Dostoevskij ha descritto meglio di qualsiasi altro romanziere. Del resto Dostoevskij è stato in un certo modo il creatore dell’esistenzialismo: al rapporto tra individuo e società, come in Balzac, Flaubert, Dickens, Tolstoj ecc., ha sostituito il rapporto dell’individuo con se stesso. Delitto e castigo non è la storia di un ambizioso che fallisce, come in Le Rouge et le Noir di Stendhal, ma quella di un uomo che ha ucciso e ne prova rimorso e il rimorso è un rapporto tutto interiore dell’uomo con se stesso. Io sono nato alle lettere in quel momento storico lì. Oltre ad Dostoevskij, fui molto influenzato dai surrealisti sul sogno e l’inconscio, come fonti di ispirazione. In realtà la mia avanguardia è stata il surrealismo. E questo spiega anche una cosa, che i miei romanzi, a tutt’oggi, partecipano di un’ambiguità che li distingue, cioè sono realistici, ma al tempo stesso simbolici. Un po’ com’erano i surrealisti. E’ una cosa che ho in comune con una generazione intera, mettiamo quella di Buñuel, he aveva la mia età. Dico Buñuel perché è l’autore cinematografico al quale mi sento più affine.
Qui Moravia ci conferma di come la grande letteratura russa sia penetrata profondamente nella cultura occidentale: d’altra parte lo stesso Freud considerava Dostoevskij un precursore della psicoanalisi, così come sicuramente i surrealisti consideravano il sogno l’unica vera realtà, sogno che sta alla base del percorso analiico di Freud. Moravia che si considera un esistenzialista non può che ammettere la sua filiazione a partire dall’atto mancato di Michele ne Gli indifferenti. Ci piace ricordare che La coscienza di Zeno, pubblicata da Svevo nel 1923, con la psicoanalisi come protagonista, subì un vero e proprio silenzio fino al 1925, proprio quando il giovane Moravia inizia a scrivere il suo primo romanzo.
QUALE FUTURO PER I GIOVANI?
A.E.: Ammesso che si riesca ad evitare la catastrofe, come saranno la vita e la società di domani?
A.M.: Penso che la scienza occuperà un posto sempre più grande nella vita degli uomini. Dico questo perché se si guarda allo stato delle cose del mondo nel suo insieme, si deve constatare che la sola attività umana che abbia segnato un progresso innegabile e la scienza nonché le sue applicazioni tecnologiche. Ora, ciò che mi colpisce e il contrasto misterioso e probabilmente significativo tra il vertiginoso progresso scientifico e l’altrettanto vertiginosa degradazione della natura. Tutto ha un significato magari insensato. Qual è il vero significato di questo contrasto? Forse non è affatto un contrasto ma qualche cosa di logico: la conoscenza porterebbe alla morte.
A.E.: Insomma, come si devono preparare alla loro vita futura i ragazzi di oggi?
A.M.: È difficile rispondere. Il fatto che spesso la loro risposta consista nell’uso della droga ci fa capire che le giovani generazioni potrebbero semplicemente voltare le spalle alla verità. Io mi auguro che questo non avvenga e che venga trovato un nuovo rapporto tra la conoscenza è la vita.
A.E.: In che senso?
A.M.: Nel senso che la conoscenza serva non già la morte ma alla vita.
A.E.: Con questa frase consideri che il libro sulla tua vita sia finito?
A.M.: Sì.
Un Moravia che sembra malinconicamente disilluso sulla capacità dei giovani di trovare una nuova via alla conoscenza. Muore a 83 anni e durante tutti questi anni ne ha visti di giovani sin a partire da quel ’22, quando dal balcone di casa li vede con i mitra in spalla inneggiando Mussolini, o quando intorno agli ’70 borghesi velleitari lo processarono (non li accusò come fece Pasolini) o ancora quando li vide ammazzare innocenti durante il periodo delle Brigate rosse.

E’ che lo scrittore romano è stato forse il testimone più importante di quasi l’intero Novecento: se si escludono le opere di D’Annuzio e di Pascoli (certamente fondamentali ma immersi ancora ad una cultura fortemente umanistico/ottocentesca), Moravia partecipò con il primo romanzo alla grande stagione creativa che vedeva le immense opere di Joyce e di Proust, ma anche la narrativa di Céline, di Gide e del nostro Pirandello; ma l’autore romano seppe anche andare avanti, inaugurando un rapporto fruttuoso tra romanzo e cinema (quest’ultima la forma più importante narratologicamenre parlando del Novecento) e intervenendo spesso al dibattito pubblico, partecipando a dibattiti televisivi. Un intellettuale certamente moderno il cui studio può illuminare la storia sia popolare che borghese dell’Italia.
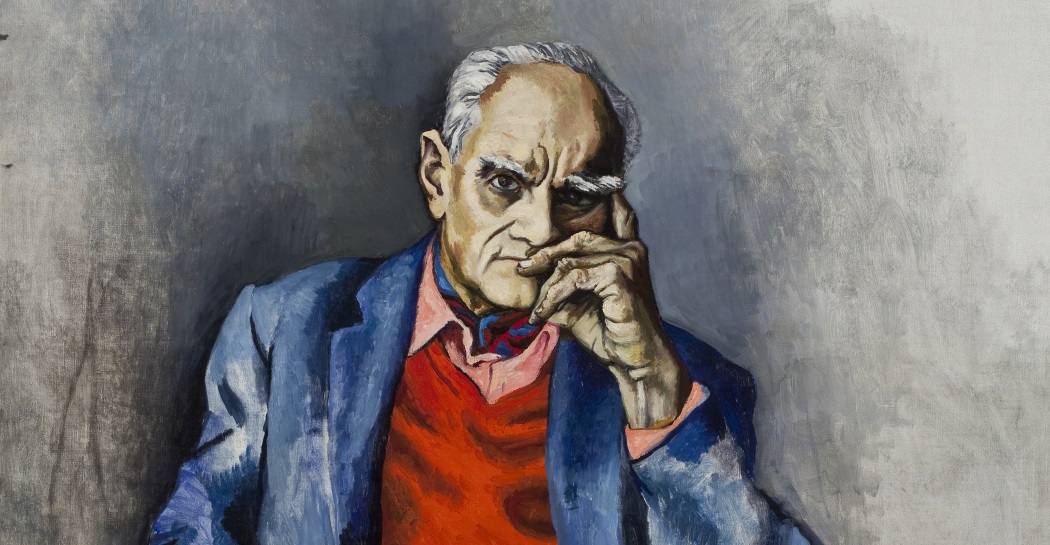
Moravia ritratto da Renato Guttuso

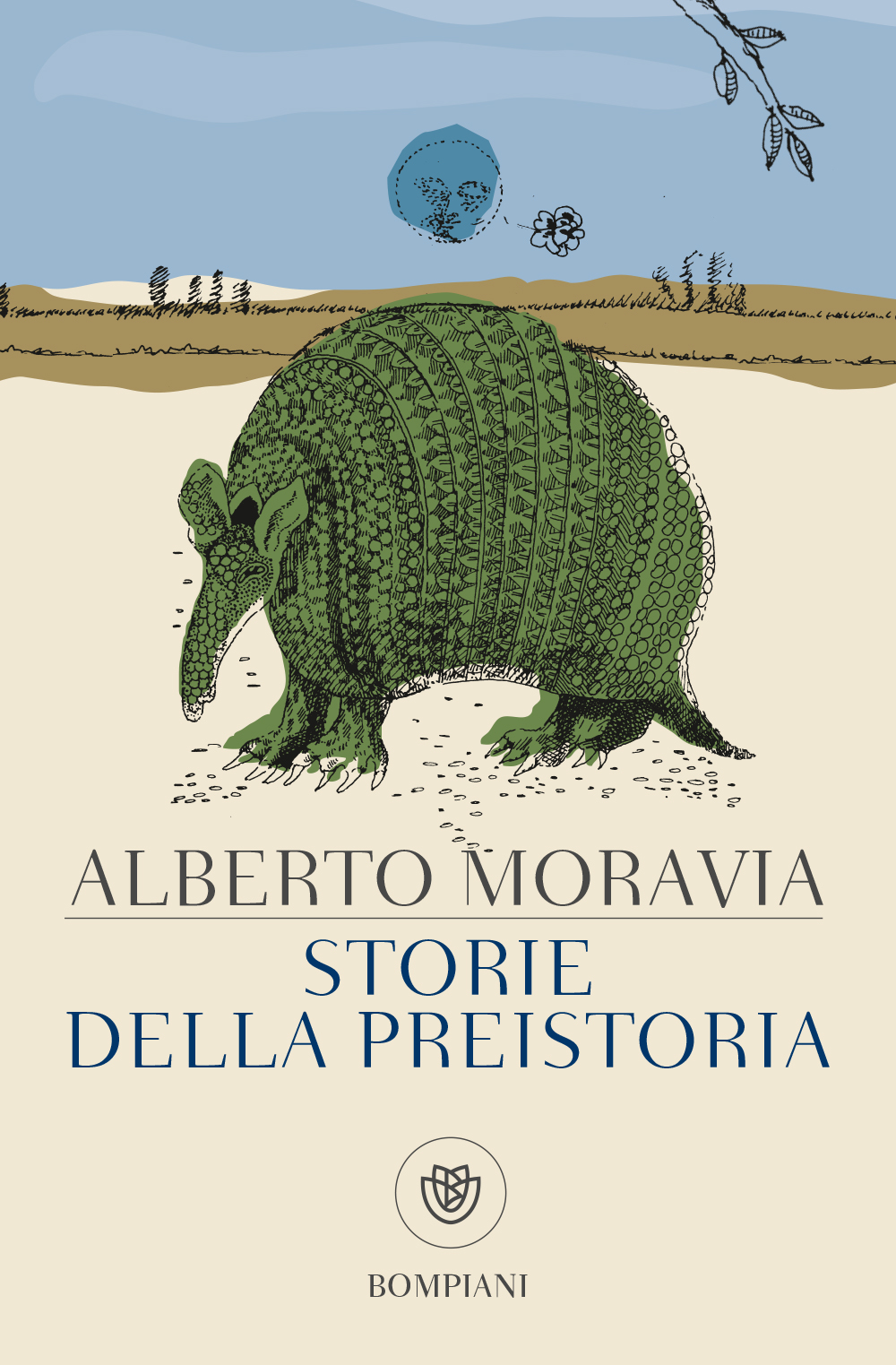
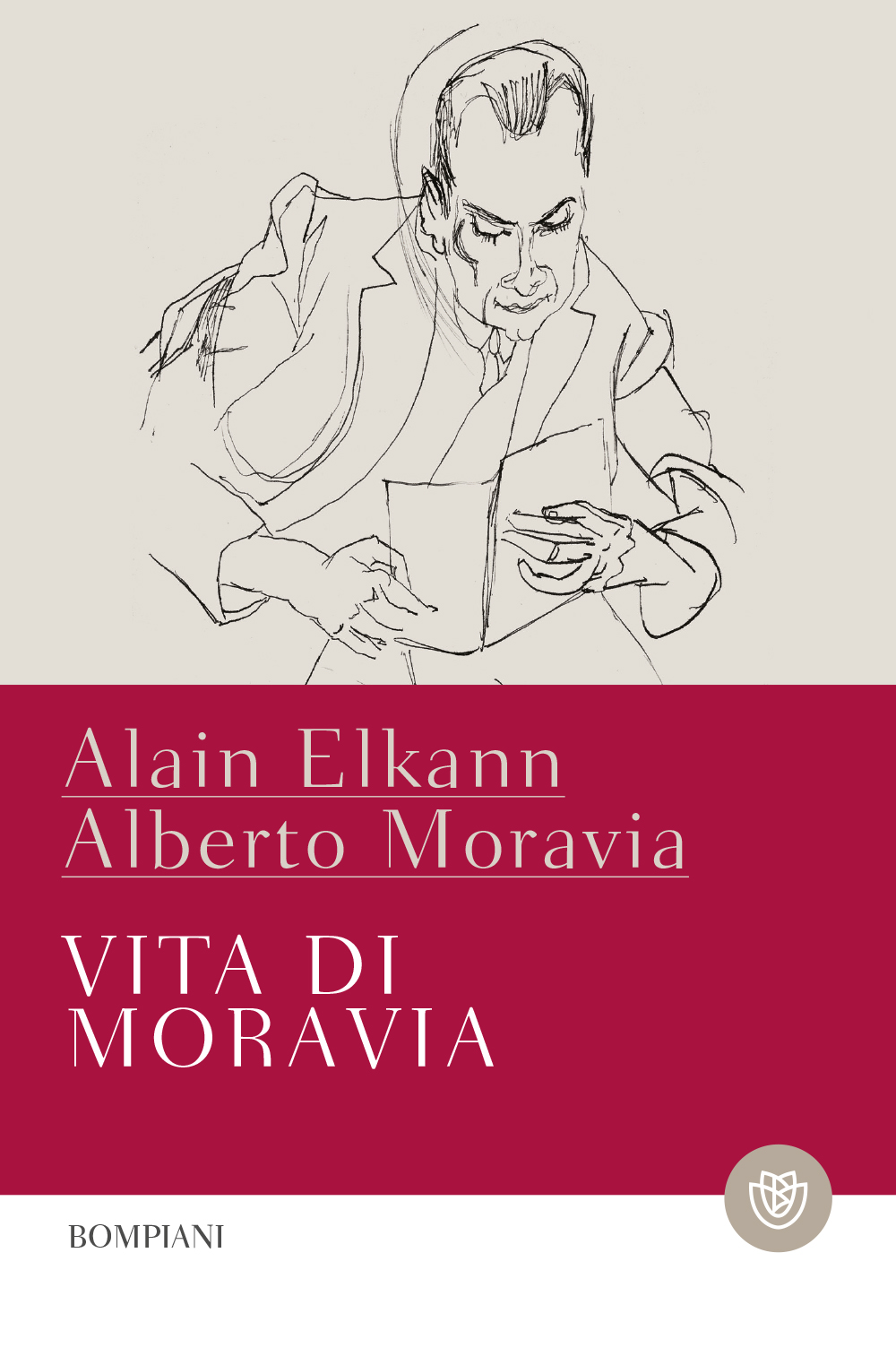







 Biografia
Biografia

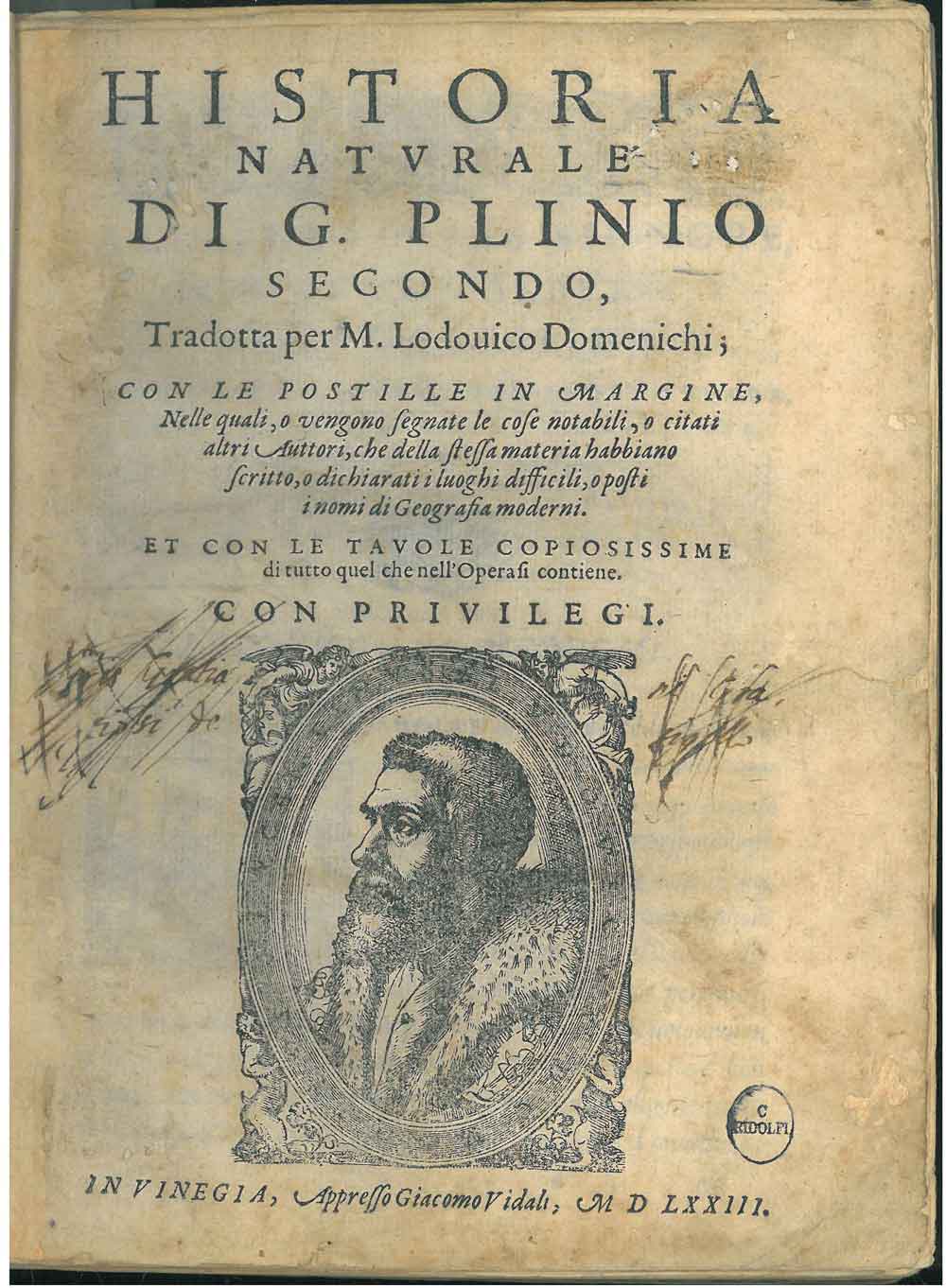















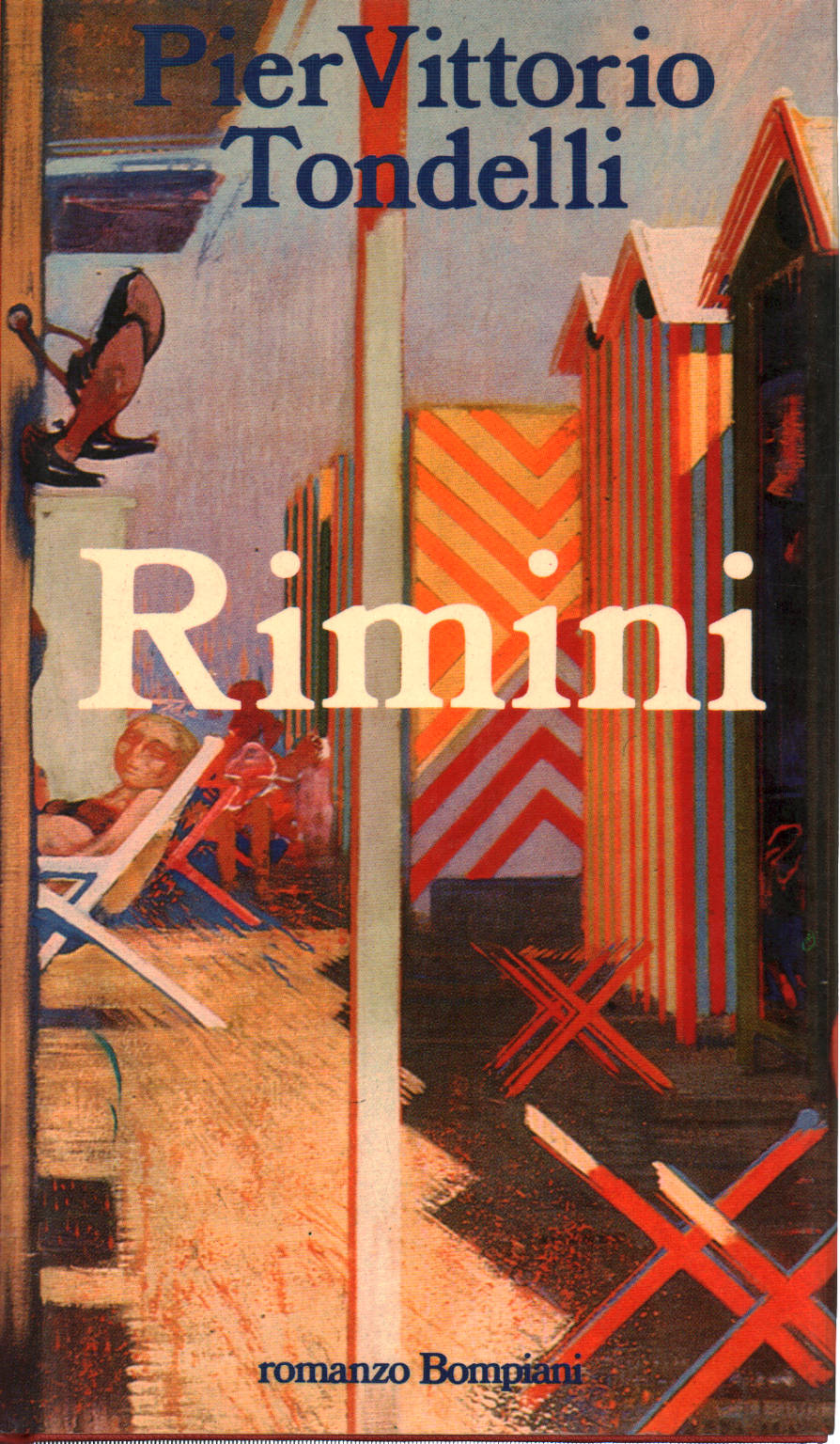



















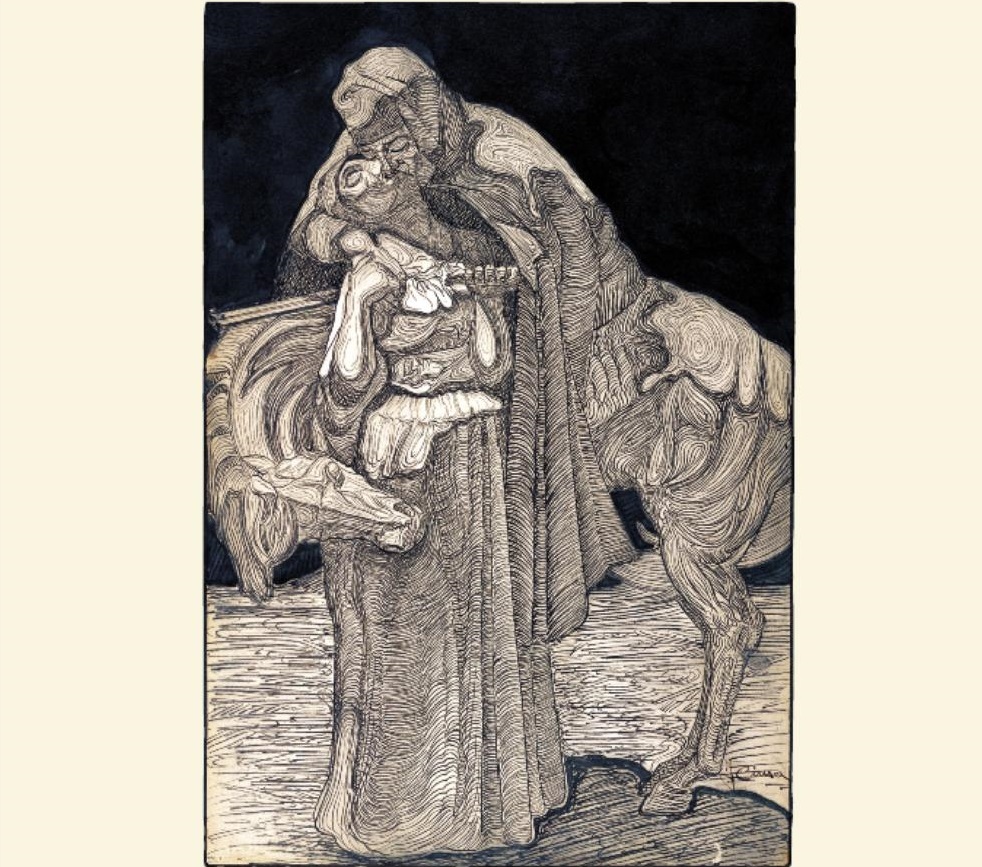





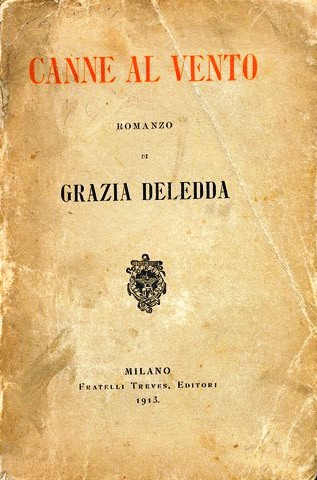





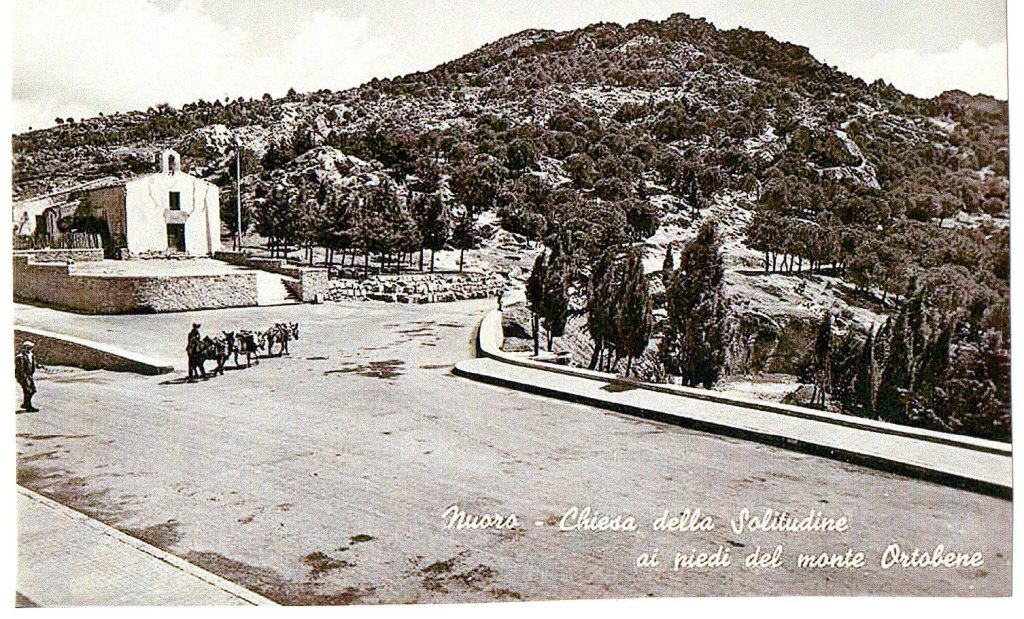

 Qualcuno reputa il suo libro più intenso, quello pubblicato postumo, nel 1937 con dapprima il titolo Cosima quasi Grazia, e poi solo Cosima
Qualcuno reputa il suo libro più intenso, quello pubblicato postumo, nel 1937 con dapprima il titolo Cosima quasi Grazia, e poi solo Cosima


 Certo non si può dire che la scrittrice sarda sia aliena da influenze culturali, ma a caratterizzare la sua scrittura sta sia la sua auto formazione, fatte di letture le più disparate, sia l’impulso “quasi naturale” del narrare. Infatti la sua vocazione appare sin da subito più parte integrante della sua personalità e tale vocazione trova forma soprattutto nella lettura biblica, che le offre sia la semplicità del dettato e la sua esemplarità su ciò che è colpa e peccato. Vi è in lei quasi l’intuizione di come questa colpa, in una realtà così chiusa ed ancestrale come quella nuorese, vada a riferirsi sempre in un impulso represso dell’eros, coercizzandolo come se fosse l’unico modo attraverso cui l’uomo possa essere “salvato” dal peccato originale. Ed è qui che sta la sua peculiarità, non per niente apprezzata da David Herbert Lawrence autore del celeberrimo L’amante di Lady Chatterley.
Certo non si può dire che la scrittrice sarda sia aliena da influenze culturali, ma a caratterizzare la sua scrittura sta sia la sua auto formazione, fatte di letture le più disparate, sia l’impulso “quasi naturale” del narrare. Infatti la sua vocazione appare sin da subito più parte integrante della sua personalità e tale vocazione trova forma soprattutto nella lettura biblica, che le offre sia la semplicità del dettato e la sua esemplarità su ciò che è colpa e peccato. Vi è in lei quasi l’intuizione di come questa colpa, in una realtà così chiusa ed ancestrale come quella nuorese, vada a riferirsi sempre in un impulso represso dell’eros, coercizzandolo come se fosse l’unico modo attraverso cui l’uomo possa essere “salvato” dal peccato originale. Ed è qui che sta la sua peculiarità, non per niente apprezzata da David Herbert Lawrence autore del celeberrimo L’amante di Lady Chatterley.

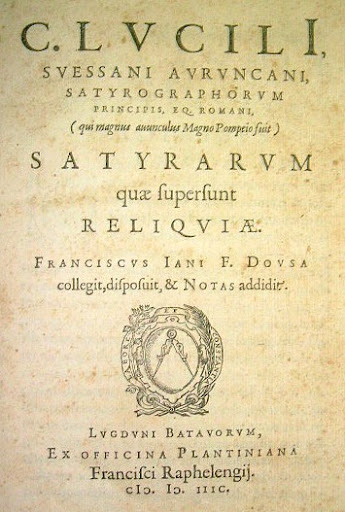 E’ questo il frammento più lungo e più celebre di Lucilio, figlio della filosofia stoica che si seguiva nel circolo degli Scipioni. Ma ci dà inoltre un vivido esempio di come dovesse essere il comportamento e quale invece esso era, sottolineando un forte moralismo e una rigidezza di costumi che, ben diversa da quella di Catone, cercava di stigmatizzare il vizio delle classi al potere.
E’ questo il frammento più lungo e più celebre di Lucilio, figlio della filosofia stoica che si seguiva nel circolo degli Scipioni. Ma ci dà inoltre un vivido esempio di come dovesse essere il comportamento e quale invece esso era, sottolineando un forte moralismo e una rigidezza di costumi che, ben diversa da quella di Catone, cercava di stigmatizzare il vizio delle classi al potere.





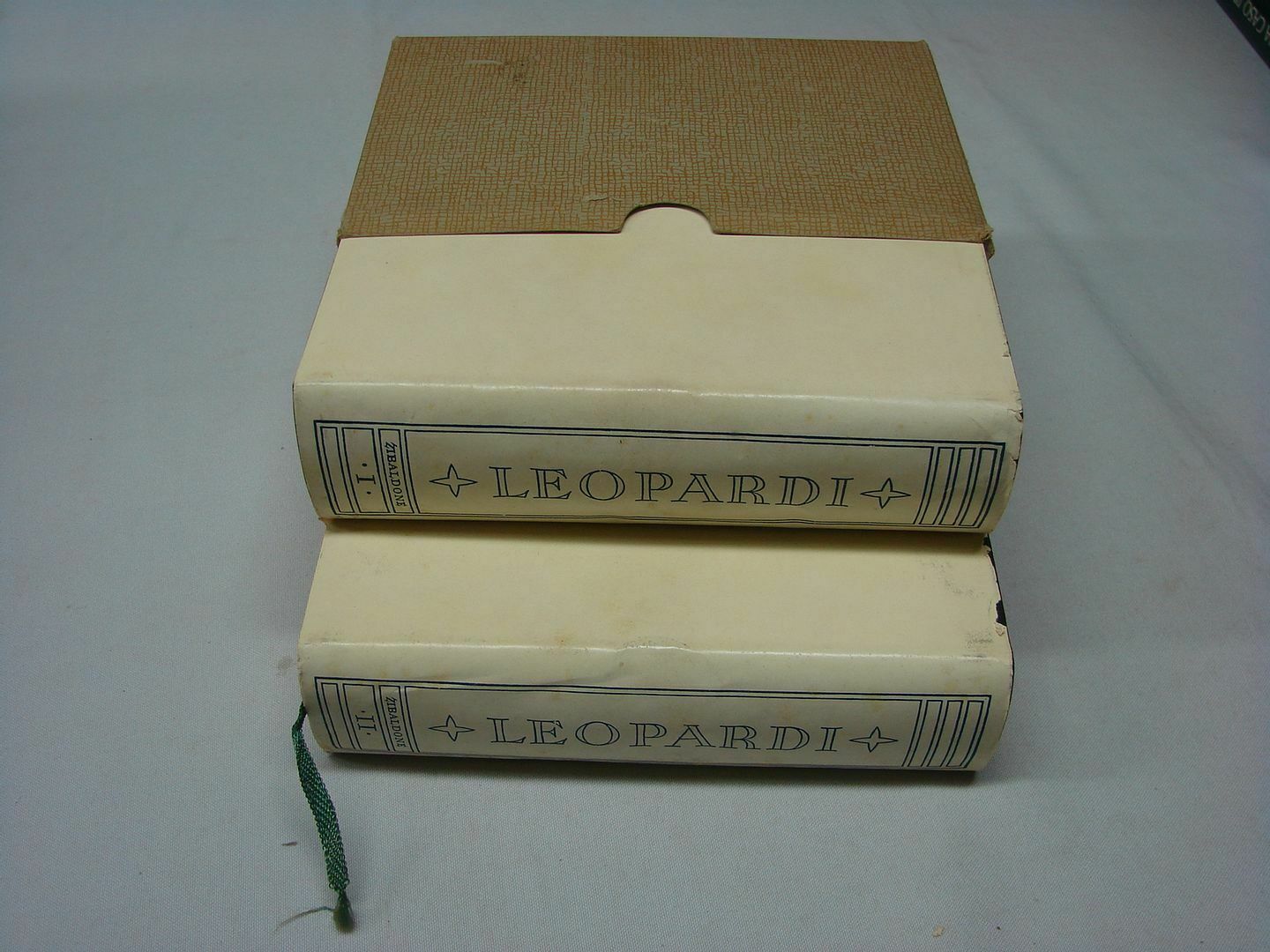


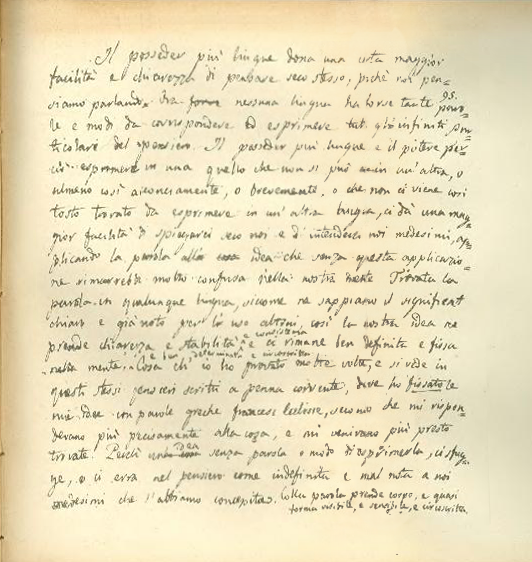
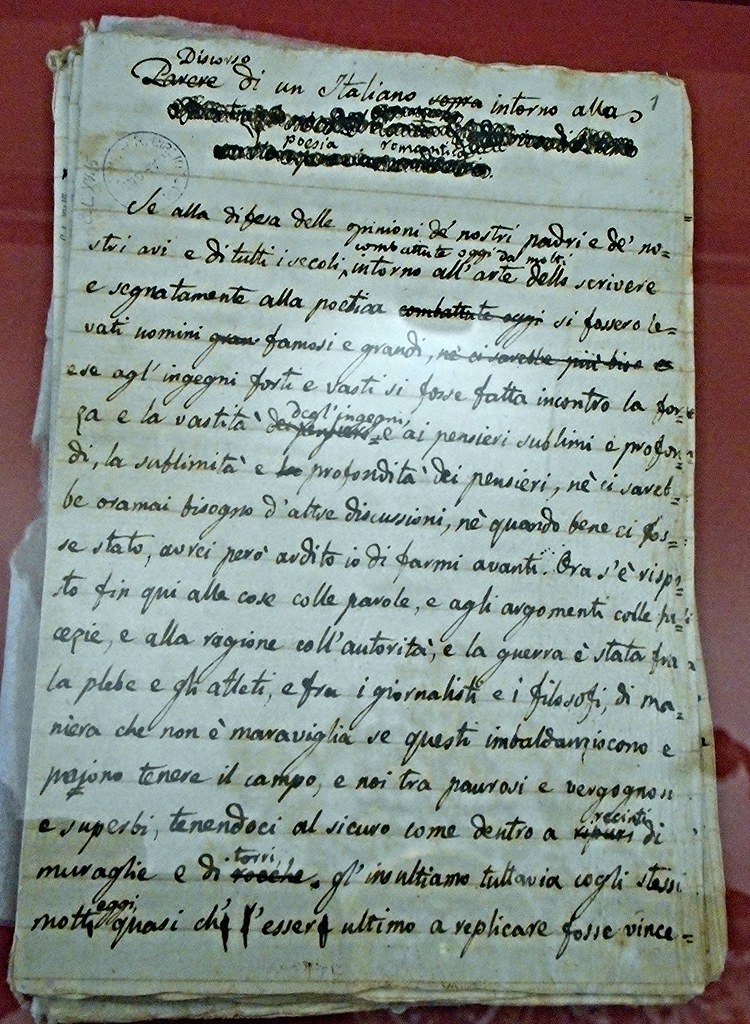



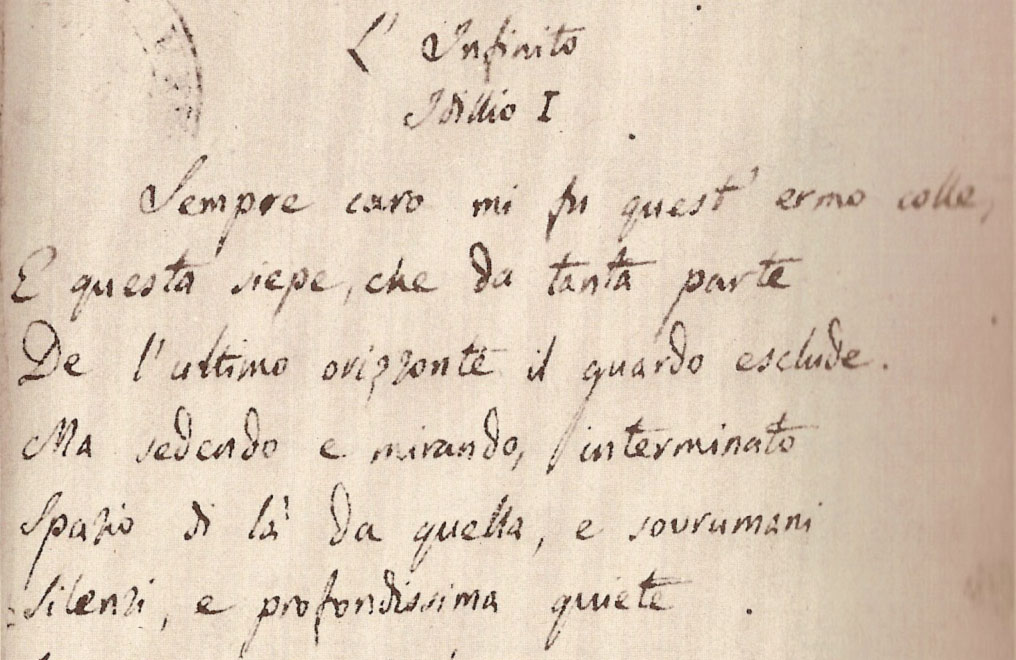




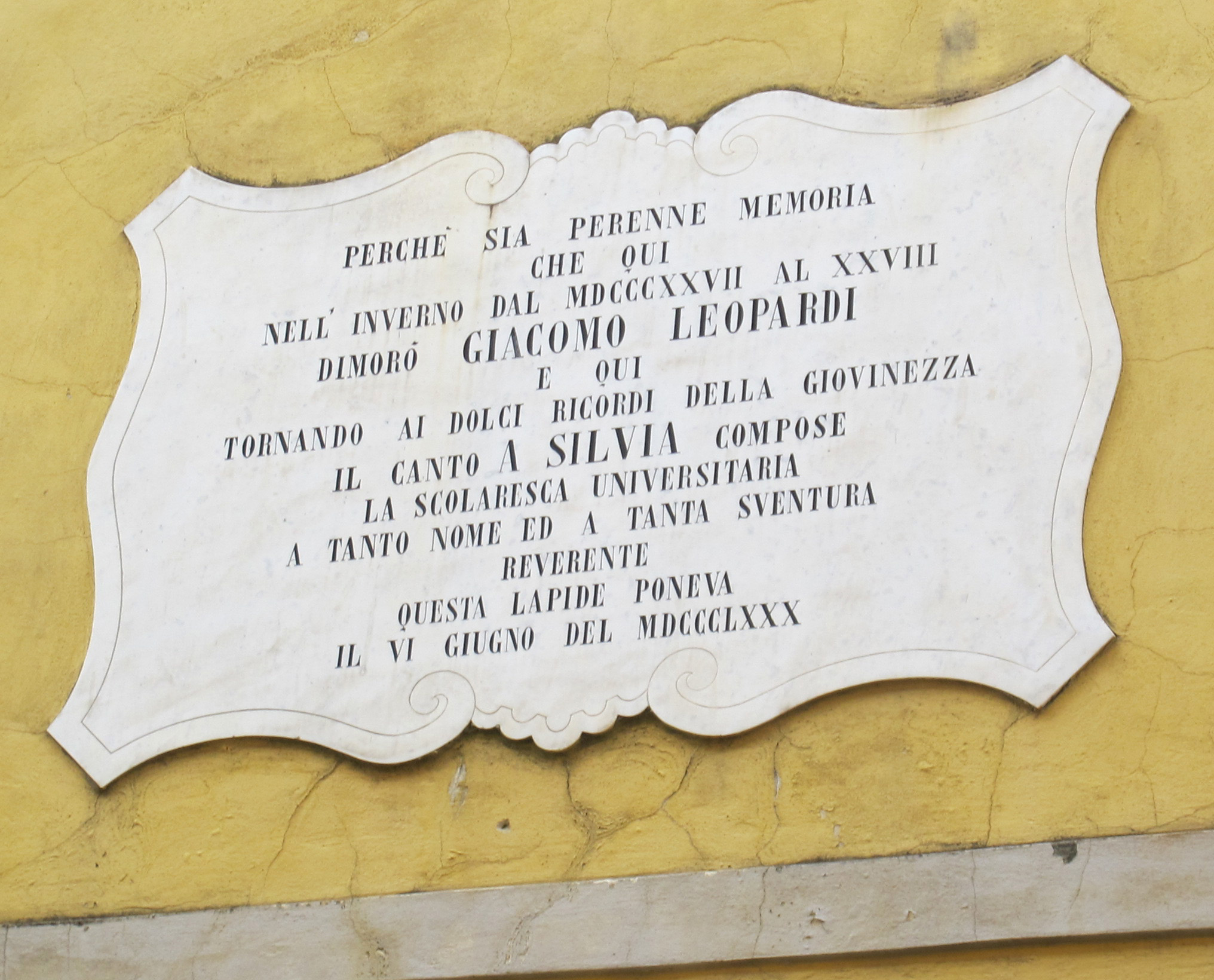

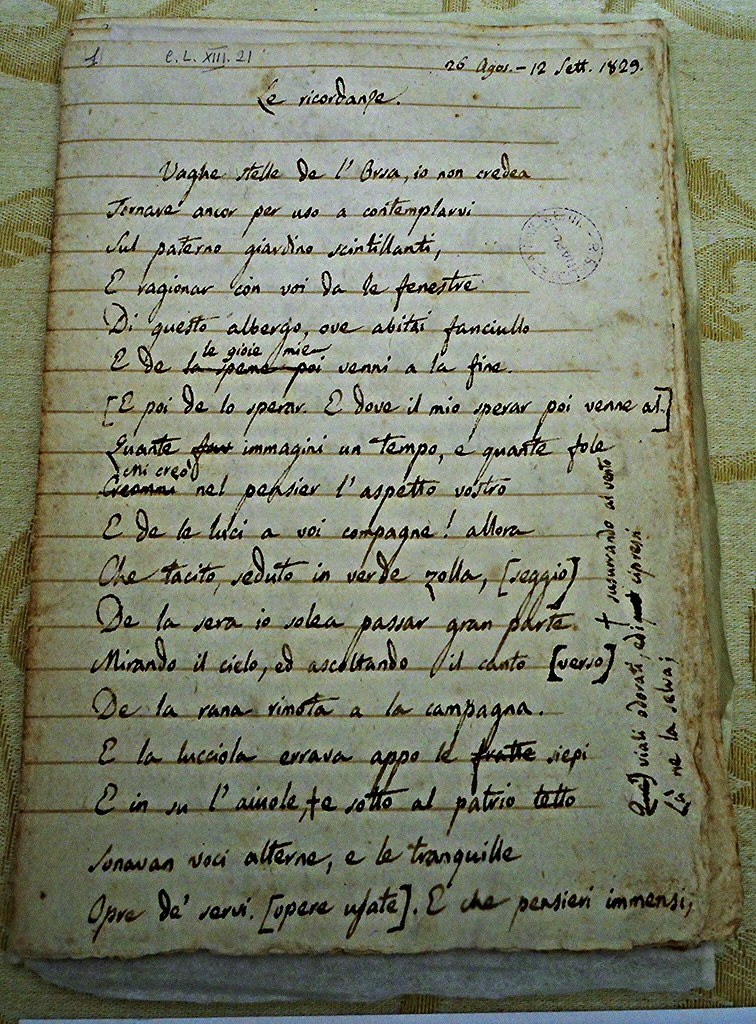



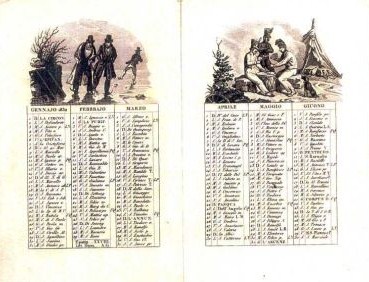















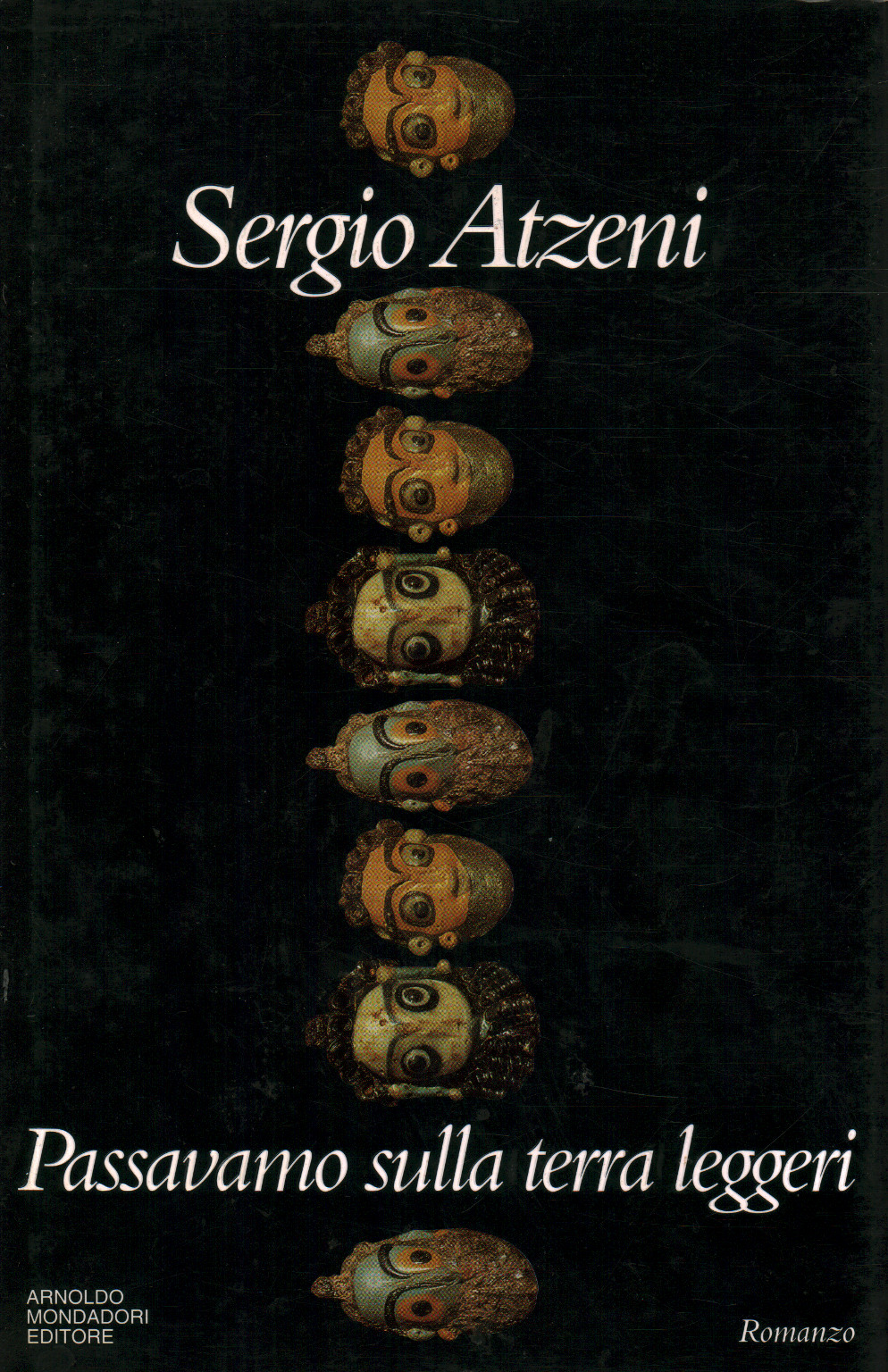

![Guarda "Bellas mariposas", Disponibile Online per la visione in Streaming [Film] • Open Live](https://www.open-live.org/it/wp-content/uploads/2017/08/bellas.jpg)
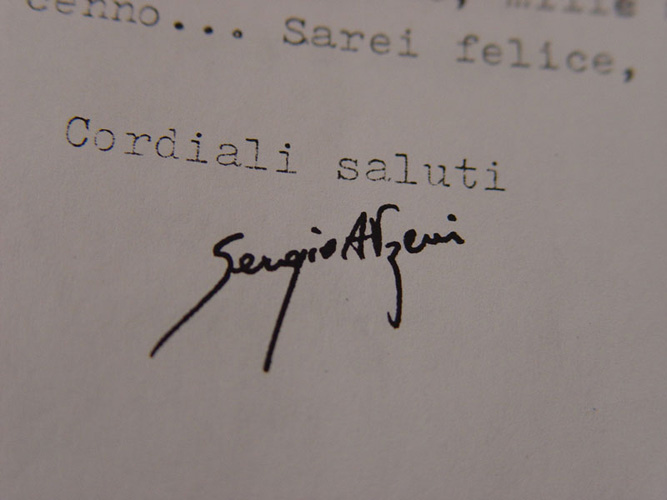
 Caratteri generali
Caratteri generali








 E’ chiaramente una canzone il cui senso apparente è quello di elogiare Mussolini (e d’altra parte lo fa). Tuttavia l’operazione di Malaparte è più sottile: la semplicità dei versi dal ritmo cantilenante non nascondono la mescolanza di parole auliche con quelle vernacolari (tipiche del dialetto senese), l’influenza letteraria di Berni, e, come un tappetto sottostante, la profonda ironia del testo. Ma fare un testo ironico sul duce poteva dar vita ad interpretazioni non proprio univoche.
E’ chiaramente una canzone il cui senso apparente è quello di elogiare Mussolini (e d’altra parte lo fa). Tuttavia l’operazione di Malaparte è più sottile: la semplicità dei versi dal ritmo cantilenante non nascondono la mescolanza di parole auliche con quelle vernacolari (tipiche del dialetto senese), l’influenza letteraria di Berni, e, come un tappetto sottostante, la profonda ironia del testo. Ma fare un testo ironico sul duce poteva dar vita ad interpretazioni non proprio univoche.
 E’ un libro pubblicato nella collana “Biblioteca dei ragazzi” della Bemporad. Racconta un episodio minimale: un bambino di otto anni viene messo in castigo in una stanza dove vi è uno specchio che riflette una scacchiera. La realtà riflessa appare al bambino più vera della realtà e ne nasce un vero e proprio dialogo tra ciò che lo specchio rimanda (in questo caso il Re Bianco) e il protagonista. Il fatto che il racconto sia omodiegetico, fa assumere allo stile il carattere veritiero che un bambino può vedere, mescolando appunto realtà e fantasia. D’altra parte il suo mondo è così scevro da ogni elemento dei doveri dell’adultità, facendogli reclamare la sua non confinabile libertà. Il modo di scrivere, come fosse quello di un bambino, fa sì che la tonalità infantile ed il fantastico si armonizzino tra loro, dando vita, così, al suo “realismo magico”.
E’ un libro pubblicato nella collana “Biblioteca dei ragazzi” della Bemporad. Racconta un episodio minimale: un bambino di otto anni viene messo in castigo in una stanza dove vi è uno specchio che riflette una scacchiera. La realtà riflessa appare al bambino più vera della realtà e ne nasce un vero e proprio dialogo tra ciò che lo specchio rimanda (in questo caso il Re Bianco) e il protagonista. Il fatto che il racconto sia omodiegetico, fa assumere allo stile il carattere veritiero che un bambino può vedere, mescolando appunto realtà e fantasia. D’altra parte il suo mondo è così scevro da ogni elemento dei doveri dell’adultità, facendogli reclamare la sua non confinabile libertà. Il modo di scrivere, come fosse quello di un bambino, fa sì che la tonalità infantile ed il fantastico si armonizzino tra loro, dando vita, così, al suo “realismo magico”.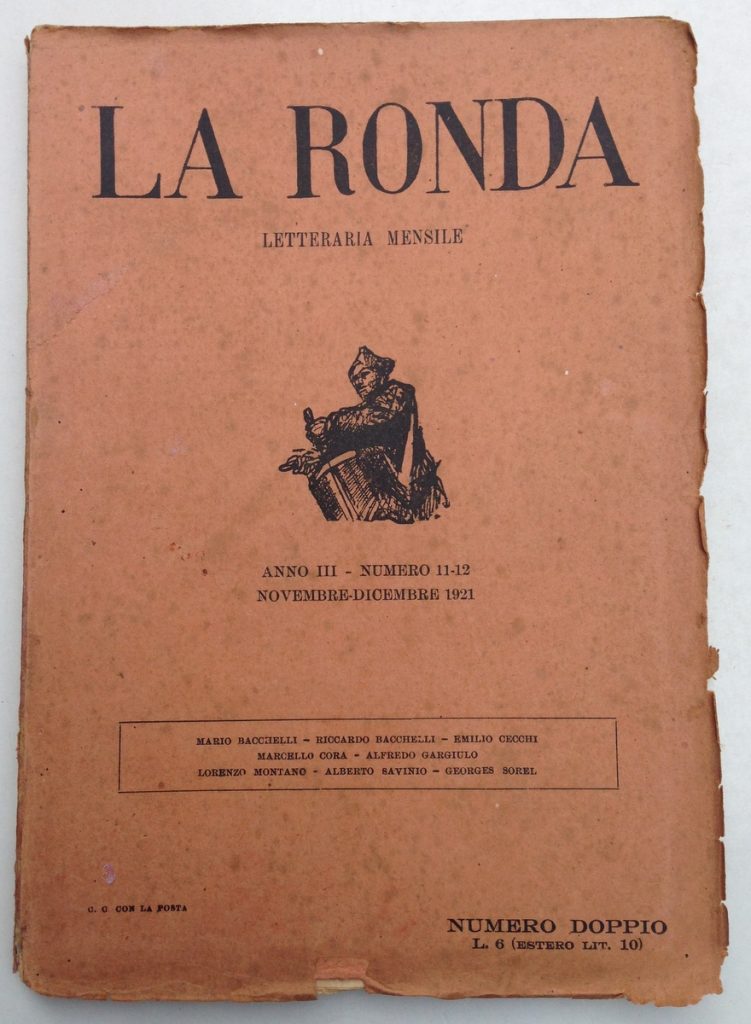 La rivista La Ronda (1919 – 1923), anche in ottemperanza del suo nome che si richiama alla vigilanza e al controllo, affinché si riacquistasse il senso dell’ordine, si pone in netta antitesi contro le esperienze sia dannunziane che pascoliane, quanto dall’intemperanze futuriste. Per i redattori di tale rivista vi è la necessità di un ritorno alla classicità del dettato, ad una prosa “elegante” e alla purezza dello stile. Innamoratosi della prosa leopardiana (dedicarono ben tre numeri allo Zibaldone) non furono nemmeno contrari al frammentarismo. Tenendo ben distanti la politica con l’arte, essi promossero sia la poesia con Vincenzo Cardarelli che la prosa con Emilio Cecchi, ambedue fondatori della rivista.
La rivista La Ronda (1919 – 1923), anche in ottemperanza del suo nome che si richiama alla vigilanza e al controllo, affinché si riacquistasse il senso dell’ordine, si pone in netta antitesi contro le esperienze sia dannunziane che pascoliane, quanto dall’intemperanze futuriste. Per i redattori di tale rivista vi è la necessità di un ritorno alla classicità del dettato, ad una prosa “elegante” e alla purezza dello stile. Innamoratosi della prosa leopardiana (dedicarono ben tre numeri allo Zibaldone) non furono nemmeno contrari al frammentarismo. Tenendo ben distanti la politica con l’arte, essi promossero sia la poesia con Vincenzo Cardarelli che la prosa con Emilio Cecchi, ambedue fondatori della rivista. Vincenzo Cardarelli (1887 – 1959), partecipò attivamente alla vita culturale romana, prendendo parte alla redazione e fondazione di alcune tra le riviste più importanti del primo Novecento. La sua poesia parla dello scorrere del tempo, della dolorosa memoria e adotta forme metriche libere di ascendenza leopardiana, che servono ad alleggerire la tensione emotiva.
Vincenzo Cardarelli (1887 – 1959), partecipò attivamente alla vita culturale romana, prendendo parte alla redazione e fondazione di alcune tra le riviste più importanti del primo Novecento. La sua poesia parla dello scorrere del tempo, della dolorosa memoria e adotta forme metriche libere di ascendenza leopardiana, che servono ad alleggerire la tensione emotiva. E’ un testo che, come il precedente, parla del tempo, qui mettendolo al centro già dal titolo “Adolescenza”, il passare della giovinezza. La donna adolescente vive con leggerezza forse consapevole di quando sboccerà per diventare donna. Per ora ella non sa, non conosce, ma arriverà il momento in cui qualcuno si interesserà a lei e sarà la stessa che si perderà ed il tempo, che ama l’attimo in cui la gioia è ancora intorno a lei, e non il tempo che aspetta.
E’ un testo che, come il precedente, parla del tempo, qui mettendolo al centro già dal titolo “Adolescenza”, il passare della giovinezza. La donna adolescente vive con leggerezza forse consapevole di quando sboccerà per diventare donna. Per ora ella non sa, non conosce, ma arriverà il momento in cui qualcuno si interesserà a lei e sarà la stessa che si perderà ed il tempo, che ama l’attimo in cui la gioia è ancora intorno a lei, e non il tempo che aspetta.


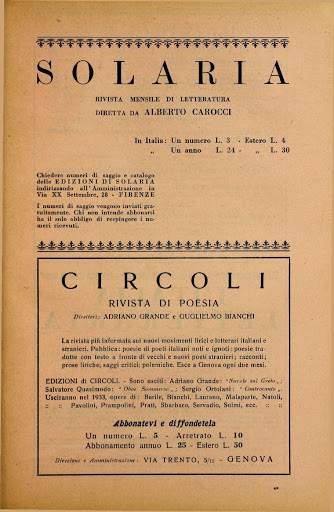 Esaurita l’esperienza rondesca, le sue istanze furono proseguite da Solaria (1926 – 1936): se La Ronda aveva puntato il suo interesse sulla ripresa classica della tradizione (basti l’esempio di Bacchelli), questa rivista intendeva allargare lo sguardo verso le grandi forme letterarie europee nate tra l’Ottocento e il Novecento. Essi infatti guardarono con interesse alla narrativa russa di Dostoevskij, alla francese di Proust, alla tedesca di Mann e, d’estremo interesse per il nostro discorso (si ricordi che siamo all’interno del fascismo) quella ebraica di Kafka. Se la rivista poté – pur guardata con sospetto dalle gerarchie del regime – passare indenne dieci anni, fu il suo chiudersi all’interno della letteratura, censurando ogni forma d’interesse verso l’esterno.
Esaurita l’esperienza rondesca, le sue istanze furono proseguite da Solaria (1926 – 1936): se La Ronda aveva puntato il suo interesse sulla ripresa classica della tradizione (basti l’esempio di Bacchelli), questa rivista intendeva allargare lo sguardo verso le grandi forme letterarie europee nate tra l’Ottocento e il Novecento. Essi infatti guardarono con interesse alla narrativa russa di Dostoevskij, alla francese di Proust, alla tedesca di Mann e, d’estremo interesse per il nostro discorso (si ricordi che siamo all’interno del fascismo) quella ebraica di Kafka. Se la rivista poté – pur guardata con sospetto dalle gerarchie del regime – passare indenne dieci anni, fu il suo chiudersi all’interno della letteratura, censurando ogni forma d’interesse verso l’esterno.